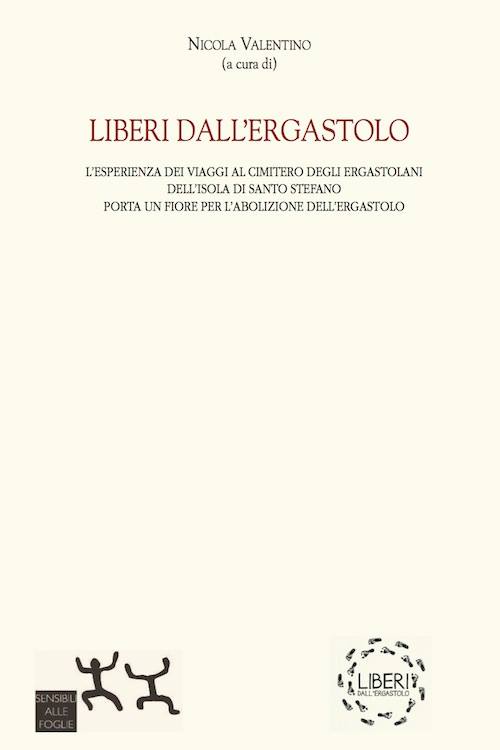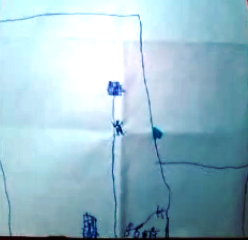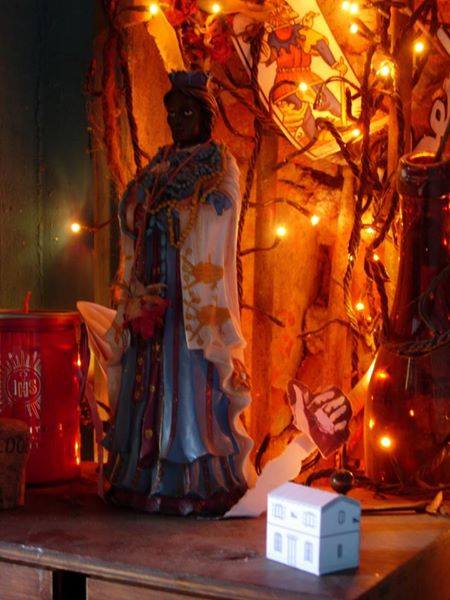13 giugno.
Quest’anno mi sono preparato alla partenza leggendo un libro di Ilario Amendolia, pubblicato da Sensibili alle foglie: Lettere dalla Locride. La Costituzione tradita. Il testo spazia dalla storia all’attualità, evidenziando come, intorno alla lotta al brigantaggio ed oggi alla ‘ndrangheta, si sia criminalizzato il popolo della Calabria, anche attraverso la diffusione mediatica di tesi diffamatorie e razziste. Il testo può, a mio parere, anche aiutare a comprendere il perché, ai giorni nostri, fra i reclusi con cittadinanza italiana, il 63% provenga da regioni del sud Italia e che, fra le 1583 persone all’ergastolo o le 717 sottoposte al regime di isolamento del 41 bis, la percentuale sfiori la totalità. Ho annotato, durante la lettura, una drammatica similitudine fra due eventi, che distano tra loro due secoli.

Il 15 agosto del 1863 viene promulgata la legge Pica, dal nome del deputato abruzzese che la propone. La legge, intitolata “procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle Province infette”, sospendeva di fatto i diritti costituzionali, con l’obiettivo di sottrarre i sospettati di brigantaggio ai tribunali civili in favore di quelli militari. Il reato di brigantaggio si applicava ai “componenti comitiva o banda armata composta almeno da tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, ed i loro complici”. Le pene andavano dalla fucilazione all’incarcerazione ai lavori forzati a vita. La legge Pica eliminò nell’arco di pochi anni dai paesi e dalle campagne del sud circa 14000 persone. (Mi chiedo se l’ergastolo di Santo Stefano ed il suo cimitero non conservino traccia anche di questa memoria).
14 novembre 2003, il comune di Platì viene circondato da un migliaio di carabinieri e preso d’assalto di notte. Circa centocinquanta arresti, perquisizioni a tappeto, bambini terrorizzati, perché, secondo l’accusa, i cittadini di Platì sarebbero stati all’ordine delle ‘ndrine. Per i cittadini di Platì fu una notte d’inferno a cui seguirono anni di passione. Alla fine tutto si concluderà in una bolla di sapone, ma ormai si era data all’opinione pubblica nazionale – e non solo – l’immagine di un paese mafioso.
Ricordo che una delle persone tutt’ora all’ergastolo di origine siciliana, osservava in un suo scritto: “la condizione necessaria per riannodare i fili di una terra ferita come il sud è quella di stabilire la definizione di cosa deve intendersi esattamente per criminalità organizzata, diversamente l’attribuzione sarà sempre arbitraria ed applicata in base al luogo dove si nasce, e questo aggiunge una connotazione di razzismo al reato”.
Per una strana coincidenza Peppe, che viaggerà con me da Tivoli verso santo Stefano, mi ha chiesto di portargli questo stesso libro. Anche Peppe, come Amendolia, è originario di un paese della provincia di Reggio Calabria. Ha letto una recensione del libro e mi ha chiesto di procurarglielo. Ho conosciuto Peppe durante i suoi mandati di assessore alla cultura del comune di Tivoli. Collaborando con il suo assessorato ho portato nelle scuole il lavoro di Sensibili alle foglie sull’esperienza della reclusione, presentando il mio libro sull’ergastolo e attraverso piccole mostre di opere pittoriche, scritti, disegni di persone recluse. Un lavoro importante, che è poi approdato, su spinta degli studenti, anche a narrazioni riguardanti le difficoltà, le insofferenze e i malesseri all’interno dell’istituzione scolastica.
E’ mezzogiorno, Peppe mi porge un panino con la frittata, che sua moglie ha preparato per entrambi, a malincuore devo declinare l’invito, perché durante la notte ho avuto dei dolori di pancia.
Gusterà il mio panino Antonio, che incontriamo a Roma, proveniente da Milano. Antonio è al suo secondo viaggio e con lui ho organizzato l’alloggio per 12 persone a Ventotene, nella pensione dove siamo stati lo scorso anno. Mentre io mi rifocillo con una banana e del pane senza companatico, commentiamo, facendo ad occhio un po’ di conti, che quest’anno ad intraprendere il viaggio siamo sicuramente in numero maggiore delle trenta persone del 2013.
Questa notte ho sognato Nicola. Nicola era di Napoli, era stato un militante dei Nuclei Armati Proletari, una formazione che negli anni settanta è stata molto attiva contro il carcere e il manicomio giudiziario. Con Nicola ho condiviso la cella nelle carceri di massima sicurezza per diversi anni.
L’ ho incontrato alcune volte anche da libero, è morto non molto tempo fa, in seguito ad una lunga malattia. Si è presentato in sogno e mi piace pensare che lo abbia fatto per augurarmi buon viaggio. Mi telefona anche mia sorella, per dirmi che è con noi in spirito anche se non di persona, e che per esserlo davvero sta vedendo dal sito “liberi dall’ergastolo”, i filmati e le immagini dei viaggi precedenti.
Alla stazione incontriamo Luca, un artista che ora vive in Salento. Anche lui con il trolley per venire a Santo Stefano. Prenderà il treno regionale che parte dopo il nostro intercity. L’appuntamento, con tutte le persone che oggi sbarcheranno a Ventotene, è al porto di Formia per l’aliscafo delle 18. In borsa ho una piantina grassa: una rosa del deserto, comperata al mercatino di Tivoli, che poggerò anche quest’anno sulla prima tomba a sinistra dove è sepolto il detenuto Montalbano.
Al porto di Formia, dove arriviamo con largo anticipo, c’è già ad aspettarci Gennaro, un amico di Antonio, che è venuto da Napoli, ma vive a Milano e fa parte del centro sociale Baraonda.
Il sole picchia, c’è un angolo d’ombra intorno al bar del porto. Seduto sul marciapiede mi preparo la sigaretta dell’attesa, mentre ascolto Peppe che è una miniera di narrazioni sulla sua terra. Mi sembra che in questo viaggio pur essendo partiti da Tivoli, con l’immaginario si sia partiti dalla Calabria. Ma la seconda sigaretta non riesco ad accenderla perché vengo risucchiato in una vertigine di calore umano: ciao, fatti abbracciare,… come stai, … ti presento, …. veniamo da Belluno,… loro da Roma, … lei da Firenze,… loro in macchina da Milano ma passando da Lucca per viaggiare con altri amici,… prendiamoci un caffè, … sono arrivata giusto in tempo, una corsa a Roma per non perdere la coincidenza…, scusa, saluto una persona…che bello vederti,… finalmente ce l’abbiamo fatta a venire …
Mi sposto da un lato all’altro delle biglietterie per salutare tutti e comincio a dare i numeri: solo ora al porto saremo una quarantina, qualcuno è sbarcato sull’isola già questa mattina, e poi altri arriveranno domani con la nave delle nove… chissà, forse arriviamo ad una cinquantina.
Mi viene fame, condivido con Michèle la mia seconda banana. Michèle ha portato con sé, per le tombe di Santo Stefano, una piantina di nepitella, ovvero mentuccia, raccolta nel suo giardino. Ne approfittiamo per abbinare una fogliolina di mentuccia con una caramella alla cannella.
All’arrivo a Ventotene, Beppe e Laura, che hanno preso l’aliscafo all’ultimo minuto, mi presentano Maria Luisa, direttrice del carcere di Benevento e Luigi che in passato è stato direttore ad Avellino… saluto anche Vincenzo, che fa il cappellano nel carcere di Sollicciano ma gestisce anche Casa Caciolle un luogo per detenuti in uscita dal carcere, che non hanno più una casa fuori dove andare.
In sei ci dirigiamo verso la nostra pensione per sistemarci nelle stanze e decidere dove cenare.
Siamo in dodici allo stesso tavolo. Il ristorante è a ridosso della spiaggia, in alto una luna velata. Io mangio spaghetti con olio e formaggio, per cautela verso il mio stomaco, ma arricchisco il piatto con finocchietto selvatico raccolto per strada da Michèle, che oltre ad essere insegnante di yoga mi appare anche come la Signora delle erbe. Ricevo in regalo da Vladislav e Silvia alcuni cataloghi. Vladis ha collaborato alla cura di una mostra sullo spazio della prigione e sui sistemi di sorveglianza, prodotta da una fondazione di Mosca. La mostra si tiene a Venezia, alla Casa dei Tre Oci, nella zona della Giudecca. All’iniziativa hanno aderito diversi artisti da tutto il mondo. Anche Rossella, che arriverà domattina a Ventotene, è presente alla mostra con una istallazione sonora di voci delle detenute del carcere della Giudecca che con lei hanno fatto nel 2013 una esperienza di narrazione dei loro sogni notturni. Rossella ha dichiarato lo spazio espositivo libero dall’ergastolo. Il logo Liberi dall’ergastolo, connota anche un’altra mostra che Rossella espone attualmente, al centro d’arte contemporanea Wiels di Bruxelles, dove sono presenti sia i filmati dei viaggi a Santo Stefano che il suo intervento artistico all’interno del carcere borbonico del 2011. Ma il dono di Vladis e Silvia riguarda le riproduzioni di due quaderni di bozzetti di Nicolay Lanceray (1879 – 1942), artista e architetto russo, arrestato nel 1931 e morto nei lager sovietici. I bozzetti presenti nei due quaderni si riferiscono alla prigione di Leningrado che ospitava coloro che venivano reclutati a lavorare nelle “sharashki”, che sfruttavano il lavoro di scienziati, ingegneri e tecnici per le industrie militari e spaziali sovietiche. Gran parte dei disegni tratteggiano in dettaglio spazi e momenti della vita carceraria. (Immagine 1 e 2)
Dico a Vladis che la cura minuziosa con cui Nicolay descive gli spazi, mi fa venire in mente la meticolosità con cui una persona attualmente all’ergastolo da trentacinque anni, Mario Trudu, disegna e racconta la rimodellazione degli oggetti della cella, per immaginare e realizzare cose che in carcere si possono solo sognare, come un forno o una yogurtiera. Ho ricevuto da un amico, che fa parte dell’associazione Il Viandante di Roma, alcune fotocopie dei disegni di Trudu, che documentano la vena creativa che ti soccorre in carcere nonostante il confinamento del corpo e dell’immaginario. (Immagine 3)
14 giugno
Alle nove invadiamo il negozio della fioraia di Ventotene, comperando tutte le piantine grasse esposte. La fioraia è preoccupata perché il primo luglio il parroco dirà una messa nel cimitero degli ergastolani e lei non sa se ce la farà ad arrampicarsi fin lassù. La incoraggiamo, così rivedrà sulle tombe le piantine che ci sta vendendo. In piazza incontriamo Giuliano e Maria Cristina. Facciamo il punto della situazione. Loro hanno parlato di buon mattino con Salvatore, la guida e il custode di Santo Stefano. Salvatore è un po’ contrariato perché lo abbiamo avvisato in ritardo che quest’anno anticipavamo il viaggio di una decina di giorni, e quindi ha avuto tempi più stretti per preparare il luogo ai visitatori. Conveniamo che è una trascuratezza che non bisogna ripetere. Salvatore ci ha dato un appuntamento a Santo Stefano per l’una, dicendoci anche che raggiungeremo l’isolotto insieme a cinquanta studenti di un corso di diritto penitenziario dell’università di Pisa. Il nostro piano per la giornata subisce quindi lo slittamento di un’ora. La persone che avevano previsto di partire al pomeriggio cominciano a preoccuparsi. Ci diamo un appuntamento al porto per le 11, ma il concentramento decisivo è intorno all’una meno un quarto ai gommoni per la traversata.
Il bar del porto ha i tavolini su un balconcino proprio in corrispondenza dell’approdo della nave. Sono lì a far colazione un po’ di persone che alloggiano in varie case, quindi, carta e penna alla mano, cominciamo a fare un conto preciso del nostro gruppo già sull’isola, perché a chi dovrà preparare i gommoni serve il numero preciso di persone da traghettare. Risultato: sull’isola siamo già in 35. Prendo un caffè con Roberto e Vittoria. Roberto indossa la giacca dello Zen Peacemaker Order. Sono felice che quest’anno sia qui con Vittoria, perché nel maggio del 1998, quando ero ancora in semilibertà, ho partecipato al mio primo viaggio verso il carcere di Santo Stefano organizzato proprio da Roberto, con lo scopo di meditare, in un luogo decisamente emblematico, sulle varie forme che può assumere la reclusione nella vita quotidiana. Roberto aveva partecipato ad esperienze analoghe di meditazione per immersione, nel campo di concentramento di Auschwitz organizzate dallo Zen Peacemaker Order con la partecipazione di persone provenienti da tutto il mondo. A Santo Stefano meditammo in silenzio, ma anche attraverso scambi narrativi, all’interno dei passeggi dell’ergastolo che a quel tempo erano ancora praticabili. Ricordo che ciascuno poteva aiutarsi nella riflessione anche attraverso un foglio con la traccia della linea della vita, su cui annotare i momenti in cui aveva vissuto esperienze sociali o relazionali che lo avevano visto recluso, e quelli in cui aveva agito come reclusore, e poi poteva, se voleva, condividerli. Quest’anno Roberto proporrà una breve cerimonia di raccoglimento e meditazione all’interno del cimitero.
La nave sta attraccando. Scendiamo dal terrazzino del bar per accogliere le persone in arrivo. Abbraccio Valentina, i suoi capelli cambiano di colore ogni anno: questa volta hanno i riflessi di un azzurro celestiale, è insieme a Paolo che finalmente ha finito di scontare tutta la pena, anche il periodo di affidamento sociale. Mi vedo piacevolmente circondato da sorrisi conosciuti e volti nuovi. Nella vertigine di strette di mano e di nomi da ricordare, esorto chi è arrivato a contarsi, per capire quanti siamo in totale. Sono arrivate ventinove persone, più trentacinque, sessantaquattro. In tutto siamo sessantaquattro. In quattro anni, da un pellegrinaggio iniziato in quattro persone, siamo diventati sessantaquattro. Piacevolmente sorpreso vado ad abbracciare Nadia e Robertino, anche loro hanno trascorso una parte della vita in carcere. Nei viaggi precedenti ad aver fatto l’esperienza del carcere eravamo solo io e Beppe dell’associazione Liberarsi, quest’anno invece il carcere è ben presente anche nel vissuto di alcuni di noi.
Ore 13.30. Sia noi, che gli studenti di diritto penitenziario con il loro docente, siamo finalmente sbarcati all’approdo della madonnina. Carla mi chiede alcuni adesivi con il logo liberi dall’ergastolo per darli ad alcuni studenti. Questo mescolamento è proficuo, il loro è un viaggio didattico, sono approdati qui dopo aver visitato il carcere di Regina Coeli, Carla ha invece raccontato ad alcuni degli studenti lo scopo diverso del nostro viaggio. Giuliano conversa con il professore che li accompagna e me lo presenta. Salvatore imposta la voce per una chiamata a raccolta. Quest’anno ha un compito più impegnativo, gestire un gruppo di più di cento persone con esigenze diverse, infatti inizia la sua lunga guida narrativa già dall’approdo.
Ci incamminiamo molto lentamente, quasi in fila indiana, lungo il sentiero che porta al carcere.
“.. Non si può dire che tumulto di affetti sente il condannato prima di entrarvi: con che ansia dolorosa si sofferma a guardare i campi, il verde, le erbe e tutto il mare, e tutto il cielo, e la natura che non dovrà più vedere, con che frequenza respira e beve per l’ultima volta quell’aria pura..” Così Luigi Settembrini nelle sue memorie descrive gli ultimi sguardi del condannato. Rossella mi racconta che, ricordando queste parole di Settembrini, ha percorso il sentiero verso il carcere insieme a Veronica che le indicava i nomi delle piante, delle erbe, dei fiori. Un cammino con un’attenzione pensata alla natura e al paesaggio, come l’ultima cosa che resta prima dell’ingresso in carcere. E aggiunge: chissà?! potrebbe essere un’idea da proporre collettivamente per il prossimo anno.
Entriamo nel carcere, dopo il corridoio di ingresso, si spalanca l’anfiteatro a cielo aperto, e anche questa volta ho la sensazione di trovarmi in un’arena e di sentirmi sovrastato.

Quest’anno Salvatore, vista la grandezza dei numeri, e la fragilità e pericolosità del posto, ci spiega che chiuderà il cancello del carcere per sentirsi tranquillo durante la sua illustrazione. Mi accovaccio in un posto all’ombra, la trattazione di Salvatore si muove su diversi piani: storico, architettonico, delle politiche penitenziarie, di microsociologia del carcere. Due secoli raccontati con passione. Con lui che non batte ciglio sotto un sole a picco, e noi a spostarci lungo le strisce d’ombra. Ogni anno aggiunge qualcosa di nuovo e arricchisce il suo racconto. Ha inserito nella sua narrazione anche la storia del cimitero ed il nostro intervento, che ha ridato i nomi ad alcune delle persone sepolte.
Vladis fotografa con cura ogni angolo del penitenziario, è talmente preso che non si cura del sole che lo scotta. Mi dirà poi, immaginandosi dal lato dell’architetto, di essersi trovato al cospetto di un’ideazione unica al mondo, considerato anche il luogo impervio dove è stata immaginata.
Vittoria, che lavora nel campo editoriale, mi suggerisce che sarebbe importante organizzare con Salvatore una pubblicazione del suo racconto, e della documentazione fotografica, unica, di cui lui dispone, basterebbe registrarlo e poi rifinire il testo. Bisognerà pensarci seriamente, parlarne con lui. Usciamo, per recarci al cimitero.
Alcune croci sono cadute. Le ancoriamo nuovamente alla terra e le fissiamo con alcune pietre. Comincio a depositare alcune piantine sulle prime tombe che incontro. Man mano che entrano le persone del nostro gruppo si attivano per interrare le piantine. Max, che è partito da solo dalla provincia di Bologna, mi scriverà, a viaggio concluso, che è rimasto sorpreso per la forza che gli ha dato adagiare nella terra secca le piantine, farlo con cura, sentirlo un atto voluto… come se il toccare quella terra fosse anche prendere contatto con un senso di responsabilità individuale. Viviana, come lo scorso hanno, è partita da Roma con una scatola di piantine raccolte sulla terrazza di casa. Le distribuisce. Ne prendo alcune dalla sua scatola. Michèle ha acceso degli incensi, Peppe semina del miglio. Si narra infatti in un romanzo che in punto di morte, un personaggio, convinto anarchico, avesse chiesto alla figlia, di non portargli sulla tomba fiori ma miglio, affinché gli uccelli, che si sarebbero posati per beccarlo, gli tenessero compagnia.
Roberto ha scelto un angolo del cimitero leggermente in ombra, con Paolo, un nostro comune amico di Roma, mi avvicino. Ci inginocchiamo. Anche altre persone si dispongono intorno. Con il primo rintocco della piccola campana della consapevolezza che Roberto ha tra le mani, inizia la cerimonia. “Ci inchiniamo alla Terra, ci inginocchiamo o ci sdraiamo profondamente, il più lentamente possibile e tocchiamo la Terra con la fronte, ci svuotiamo in modo da diventare tutt’uno con la Terra…”
Quando mi sollevo mi vedo parte di un piccolo cerchio di persone in raccoglimento. I rintocchi scandiscono l’inizio e la fine di ciascuna prosternazione sulla terra del cimitero. Con l’ultimo rintocco per l’ultima prostrazione, Roberto legge una poesia dal titolo: “Chiamatemi con i miei veri nomi”, di Thich Nhat Hanh, monaco vietnamita, fondatore del “buddhismo impegnato”, che è stato esponente, negli anni sessanta-settanta, del movimento per la pace in Vietnam. Alcuni monaci di quel movimento arrivarono a bruciarsi vivi per far sapere al mondo che non volevano quella guerra. “……
Il ritmo del mio cuore è la nascita e la morte di tutto ciò che è vivo.
Io sono un insetto che muta la sua forma sulla superficie di un fiume.
E io sono l’uccello che, a primavera, arriva a mangiare l’insetto.
Io sono una rana che nuota felice nell’acqua chiara di uno stagno.
E io sono il serpente che, avvicinandosi in silenzio, divora la rana.
Sono un bambino in Uganda, tutto pelle e ossa, le mie gambe esili come canne di bambù,
e io sono il mercante che vende armi mortali all’Uganda.
Io sono la bambina dodicenne profuga su una barca,
che si getta in mare dopo essere stata violentata da un pirata.
E io sono il pirata, il mio cuore ancora incapace di vedere e di amare.
Io sono un membro del Politburo, con tanto potere a disposizione.
E io sono l’uomo che deve pagare il “debito di sangue” alla mia gente,
morendo lentamente in un campo di lavori forzati.
La mia gioia è come la primavera, così splendente che fa sbocciare i fiori su tutti i sentieri della vita.
Il mio dolore è come un fiume in lacrime, così gonfio che riempie tutti i quattro oceani.
Per favore chiamatemi con i miei veri nomi, cosicché io possa udire tutti i miei pianti e tutte le mie risa insieme,
cosicché io possa vedere che la mia gioia e il mio dolore sono una cosa sola.
Per favore, chiamatemi con i miei veri nomi, cosicché io mi possa svegliare
E cosicché la porta del mio cuore sia lasciata aperta, la porta della compassione”.
Uscendo dal cimitero scorgo un gruppo di amici che conversano tra loro, seduti intorno alla tomba di Gaetano Bresci. Mentre Michèle mi racconta la sua sensazione di cupezza e oppressione all’interno del carcere e invece di serenità quando siamo entrati nel cimitero.
E’ più tardi del solito, le persone che devono prendere l’aliscafo delle sei partono per prime con gli studenti di Pisa, noi arriveremo un po’ dopo all’approdo di Ventotene.
Anche quest’anno avevamo previsto un incontro fra tutti i partecipanti, in una sala nella piazza principale, per condividere in gruppo l’esperienza. Sarebbe già ora di incontrarci, ci consultiamo, ma giustamente, ognuno vuol correre verso una doccia, un tuffo in mare, prepararsi una cena, e siamo anche molto stanchi. L’assenza di questo momento d’insieme mi resta come l’aspetto mancante di questo viaggio.
Va detto anche che siamo rientrati a Ventotene giusto in tempo. Durante la sosta al bar scoppia infatti un temporale che trasforma il primo tratto di strada verso la pensione che devo raggiungere, in un torrente d’acqua. Non resta che aspettare che spiova.
Dopo la bufera l’arcobaleno che appare, mentre con Silvia salgo verso l’interno dell’isola, nasce dal mare per rituffarsi in mare. L’isolotto di Santo Stefano vi si trova al centro, sospeso sull’acqua in una foschia rosa. Cessata la nostra ansia fotografica è lo spettacolo che fotografa il nostro stupore.
La sfida. Gennaro, che fa il cuoco di professione, lancia una sfida al ristorante dove abbiamo cenato la sera prima, promettendo di prepararci, in casa, un pranzetto da leccarci i baffi e con un costo minimo di condivisione della spesa. Ma, al di là della sfida, il suo desiderio vero era quello di creare un momento conviviale. La tavola è imbandita per 15 persone, abbiamo esteso l’invito ad altri viaggiatori e viaggiatrici. Ha cenato con noi anche Franchino, il proprietario della pensione. Paccheri con gamberi e cozze, oppure pasta con melanzane a funghetto per commensali vegani, mozzarelle, insalata di pomodori, macedonia di frutta, vini. Siamo troppo affamati per applaudire Gennaro dopo la prima forchettata, dovrà aspettare che il primo piatto finisca per assaporare il nostro plateale entusiasmo. L’aspetto conviviale si prolunga fino alle due di notte, quando l’ultimo gruppetto rimasto, su sollecitazione di Vladis, che è vissuto dall’altra parte del muro, si effonde in una libera conversazione su cosa abbiamo pensato dopo la caduta del muro di Berlino.

15 giugno
L’aliscafo delle 9e45, si è rotto, partiamo con un altro aliscafo, due ore dopo. Mentre mi allontano da Ventotene cerco di non lasciarmi sfuggire, annotandola sul mio quaderno, una conversazione avuta, durante l’attesa, con Cesare, Mattia, Davide, Caterina, Vladis, Silvia, e altri artisti che hanno partecipato al viaggio. Si commentava l’unicità dell’esperienza vissuta, soprattutto da chi era al suo primo viaggio, e il gruppo rifletteva sul dispositivo architettonico del carcere borbonico, e sulla relazione di potere che quel dispositivo cristallizza. Come anche Salvatore, la nostra guida, ci fa osservare, il meccanismo architettonico del carcere borbonico è immaginato sia per consentire a chi gestisce il potere, di osservare costantemente il recluso (cosa tipica del dispositivo panottico), ma anche per offrire uno spettacolo del potere. Infatti l’architetto Carpi, costruì Santo Stefano per volere dei Borboni, tenendo presente la struttura del teatro San Carlo di Napoli. Questo spettacolo del potere si svolgeva sia attraverso le punizioni pubbliche che venivano inflitte al detenuto nella piazzale del carcere, con gli altri reclusi che guardavano dagli spalti, sia attraverso la cappella posta al centro del piazzale dove veniva effettuata la messa. Dove quindi il potere religioso della Chiesa si rappresentava. Cesare osservava che il restauro della cappella, l’unico fatto di recente, ne ha purtroppo stravolto la forma originaria perché ha chiuso le aperture che essa aveva in origine, che consentivano ai detenuti di guardare dalle celle l’interno della cappella e al cappellano di stare come in un palcoscenico. Ci siamo chiesti se fosse reperibile una documentazione su come operava la Chiesa nel carcere Borbonico. Si conveniva che il carcere di Santo Stefano ha delle particolarità che andrebbero conosciute e valorizzate a livello internazionale. Inoltre, se il carcere di Santo Stefano fa vedere la stratificazione dei dispositivi di potere che lo hanno caratterizzato nei secoli e che ancora caratterizzano i sistemi reclusivi, il cimitero ci mette di fronte alla natura dell’ergastolo come pena. In gergo carcerario quando si viene condannati all’ergastolo si dice avere preso l’erba, avere l’erba sul groppone, cioè essere sepolti vivi in attesa della sepoltura definitiva. Questa natura dell’ergastolo non è riferibile solo alla pena a vita fino agli anni cinquanta e sessanta, come si ricava dalle targhette che siamo riusciti a mettere sulle tombe di alcuni dei defunti di Santo Stefano, ma riguarda anche l’ergastolo contemporaneo. L’ultimo ergastolano morto in carcere di cui si ha notizia si chiamava Giovanni Pollari, 65 anni siciliano, stroncato da un infarto il 3 maggio di quest’anno, nel carcere di Sulmona dove sono reclusi altri 200 ergastolani che hanno visto, nella sua morte, il loro futuro. (Maria Trozzi, http://www.quiquotidiano.it, 4 maggio 2014)
Nicola Valentino