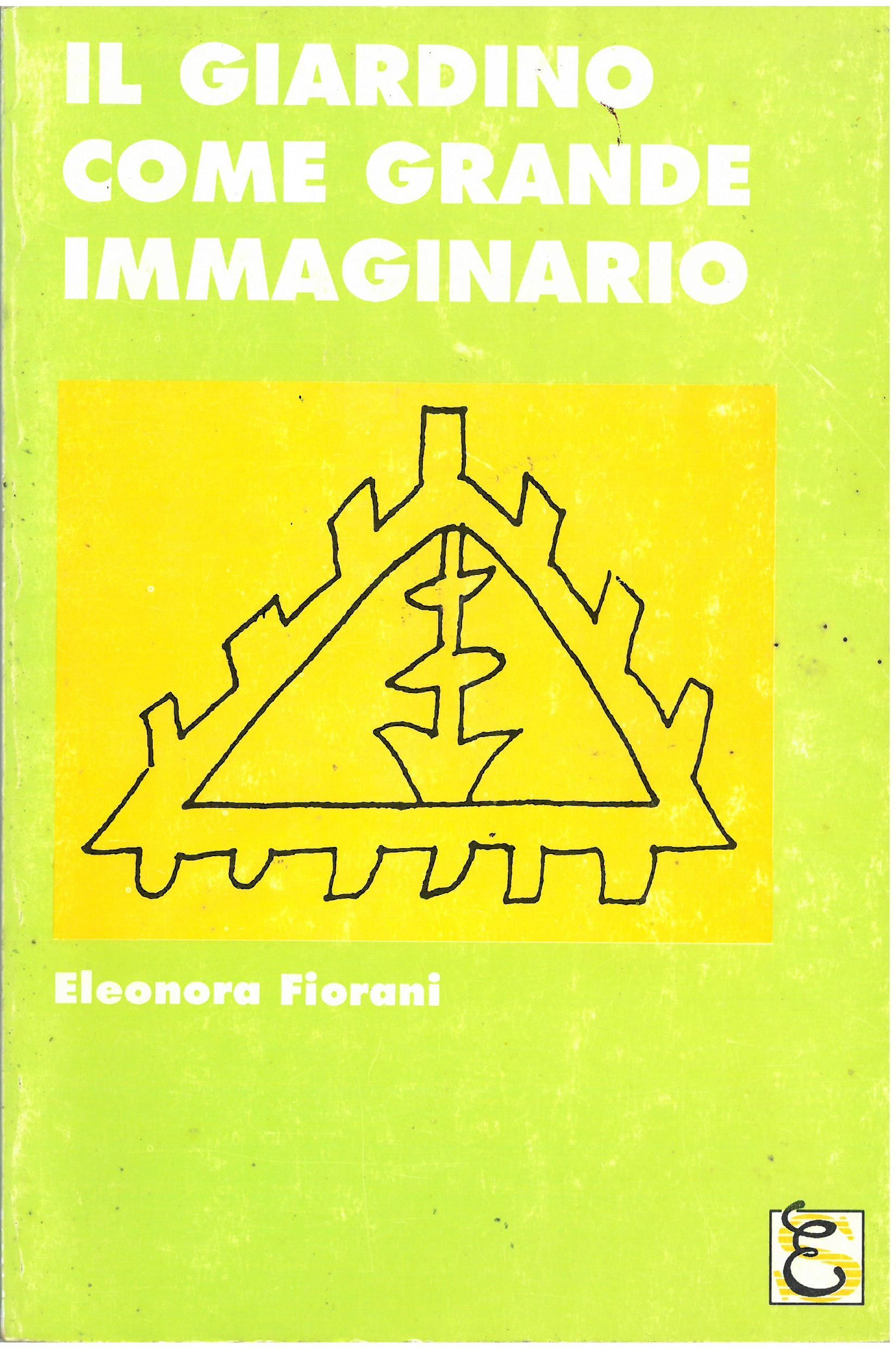Oggi nel mediterraneo: il giardino delle acque

Di Eleonora Fiorani
Estratto da “Il giardino come grande immaginario”(1998) editore Edigroup-Synergon
Il Negombo è un parco idrotermale, nella baia di San Montano Ischia, una baia profonda e avvolgente, racchiusa tra il monte Vico e il promontorio di Zaro. Stupisce per la sua misura e la concentrazione in essa dei due aspetti contrastanti della realtà ischitana, quello arido e aspro della nuda roccia e quello ricco di selva. Qui infatti la roccia può essere selvaggia e brulla e proiettata in esterno dalle antiche eruzioni vulcaniche con le ferite ancora aperte, nelle concrezioni materiche, che come straordinarie sculture naturali di ergono nel mare, o in esso si precipitano. E può essere, anche, come suo altro aspetto, la folta vegetazione della macchia mediterranea che interessa tutta una parte dell'isola. San Montano è anche una delle zone più ricche di acque calde sotterranee.

Qui il duca Luigi Silvestro Camerini, grande viaggiatore, umanista e orientalista, nel 1947, decise di fermarsi e scelse il suo luogo. Vi costruì un magico giardino botanico, dotandolo di un ingegnoso sistema di irrigazione tramite vasche, e tracciò i sentieri su per il monte Vico intagliando gradinate nella roccia.
Vi fece trasportare via mare palme, cicas, cocos, zamie, ficus, riconoscibili presenze all' interno dell' attuale giardino, dando anche al luogo il suo nome attuale, che è quello di una baia di Ceylon. Vi giunse allora il maestoso ficus, albero antico e sacro, che si erge immenso e solitario nello spiazzo del viale d'entrata con il suo tronco intricato dalle radici.
In seguito, e tuttora, vi operarono i suoi familiari ed eredi, e oggi, particolarmente Paolo Fulceri, con i suoi collaboratori. Per salvare il giardino dalla rovina, hanno realizzato l'attuale parco idrotermale, in cui dal 1988 agisce, con orientamento decisivo, il paesaggista Ermanno Casasco.
Il parco del Negombo unisce strettamente, in uno straordinario giardino delle acque, l'elemento marino e quello termale che non troviamo di solito insieme neppure qui a Ischia dove sono contigui spazialmente e stanno gomito a gomito, eppure sono separati da barriere reali o invisibili o stanno l'uno accanto all'altro nella loro irriducibile differenza di mondi, da una parte il mare, dall'altra le terme che un giardino ornamentale avvolge e "decora".

Questo giardino invece coglie nell'acqua la presenza multiforme e pervasiva che caratterizza questo luogo, e unisce in esso le acque profonde del mare con quelle sotterranee e ribollenti che lo fecondano. e diviene un mondo dalle molte presenze.
Subito, all'entrata lo annunciano i profumi dei fiori e il canto degli uccelli in un paesaggio di canne e oleandri. L'entrata è a oriente e immette con uno stretto passaggio a imbuto nella zona di confine tra la parte bassa, dove si trovano le grandi piscine marine e termali e altre di diverse dimensioni, forme e temperature, e la parte alta, più segreta e "selvaggia" delle balze, dove pure, lungo i sentieri che si fanno sempre più stretti, si aprono piccole piscine e pozze. All' orizzonte appare il mare nella baia, immenso e aperto all'infinito.
Gli specchi d'acqua si aprono a livello della superficie. Così, percorrendo il giardino, ci accorgiamo che, tratta in superficie, l'acqua delle sorgenti abita le piscine, vi si materializza, sgorgando dalle rocce a ciò disposte, più che esservi contenuta, e se si alzano gli occhi verso gli alberi che vi si affacciano, dove gioca il reticolo dei riflessi, l'acqua abita anch'essi, vi riverbera la propria presenza attiva e vivente. Casasco ha qui unito acqua e roccia, con rimando a profondi significati simbolici, mentre vale anche in senso estetico di gioco sui contrasti tra l'immobilità e la solidità materica della roccia e l'elemento sempre mobile e dolce vitale dell'acqua. E ha messo in atto soluzioni inaspettate che si raccordano alla millenaria storia contadina, ristrutturando le piscine già esistenti, e altre ha ideate, sulle balze, trasformando il sistema di irrigazione o ispirandosi ad esso. Così, per esempio, la vasca in cemento ricorda i vasconi di raccolta dell'acqua piovana, la vasca in ardesia ripropone i salti d'acqua, la "cascata" si ispira alle cadute di ossigenazione.
L'acqua è qui più che mai presenza strutturale e costitutiva del giardino. E ci ricorda che nei miti troviamo l'immagine favolosa dell'albero - fontana, proiezione dell' albero antropogenetico, che abbevera gli uomini e gli animali. L'acqua è la sostanza prima, principio di tutte le cose, elemento del sottosuolo, umido nascosto e opaco. Ed è a sua volta vivificata dallo spirito vegetativo, la forza generativa nascosta fra i rami e nel piede dell'albero, come fallo cosmico che distilla liquidi vitali.
La presenza vegetale costituisce la valenza terrestre e sensuale del giardino che è sempre un luogo inquietante. Il giardino è sempre un giardino delle delizie, un paradiso del piacere, che i valori religiosi pudicamente ricoprono, e quelli filosofici sublimano nell'etica e nella conoscenza, rivelando così anche il carattere erotico, passionale di ogni sapere e di ogni agire.
Il primo lieve turbamento nasce dalla sensazione di essere entrati in un area separata, che, quando non c'è nessuna recinzione, è protetta da invisibili mura.

L'altro ci viene dalle piante, i silenziosi organismi viventi che, nel giardino del Negombo, regnano signore. Anche al nostro sguardo semicieco giungono i loro enigmatici e indecifrabili messaggi. Viene naturale abbassare la voce in un giardino o contemplare, diventando muti noi stessi, questi signori della terra. Avvertiamo nel nostro profondo la presenza viva di questi simboli della fecondità. Ne avvertiamo l'energia vitale che presiede alle mille forme e colori. E ci accorgiamo allora che non sono né muti né immobili. Parlano con la voce del vento, coi colori, con i profumi, con le forme, e si muovono a loro modo, camminando con le radici, utilizzando gli insetti per l'impollinazione. Alberi parlanti sono presenti in tutte le mitologie antiche. Tutte le culture conoscono gli alberi sapienti e profetici, del sole e della luna. Gli alberi sono simboli solari e insieme hanno una potente carica di terrestrità. E come tali hanno a che fare col tempo e lo strutturano. Sono l'immagine della continuità e dell'infinito non conchiuso. Sono come i giardini simboli di immortalità, promessa di rinascita. Forse per questo nei santuari alberati dell'Oriente si va per sognare.
Sensuosità e narratività vengono così a intrecciarsi e costituiscono gli elementi costanti e peculiari del parco attuale, così come l' ha ideato Casasco. Il giardino del Negombo è infatti costruito da un disegno che struttura ambienti e zone, in un susseguirsi narrativo interno di giardini e di paesaggi, giocando con le forme e i colori e i profumi delle piante, delle foglie, dei fiori e l'immissione di piani e vuoti per bilanciare, e pietre. Casasco recupera in profondo la macchia mediterranea nei suoi stessi arbusti ed essenze, la ricostruisce e la reinventa, e accompagna i fiori di campo alle piante preziose, porta le piante degli orti nel giardino e inserisce l'esotico e l'immaginario di altri mondi.
Così il giardino delle acque è un multiverso dalle mille presenze: accanto alla vegetazione mediterranea ospita alberi provenienti da più diversi paesi e continenti, dall' Australia, dal Giappone, dall'Africa, dal Brasile: unica condizione è la loro perfetta ambientazione e la coerenza con il disegno del giardino. Con essi Casasco non ha costruito un orto botanico, ma paesaggi o giardini nel paesaggio, paesaggi fantastici, giardini delle delizie. Ha strutturato una narrazione, che si dipana attraverso i percorsi che ci conducono in punti privilegiati di esperienza e osservazione, che ci portano oltre il giardino, nel paesaggio del mare, della baia, del monte e del bosco.
Il Negombo, è anche un giardino del tempo. Le fioriture accentuano le differenze stagionali, e introducono l'effimero e il ritornante, e fanno del giardino un luogo mutevole e sempre diverso.
La parte più profonda e selvaggia del giardino è quella che è stata ricostruita e reinventata e si distende sulle balze, sulla roccia scavata a gradini e a terrazzamenti secondo l'antico modulo contadino, messo in atto già dal duca Camerini. Qui la macchia è più fitta e i sentieri mai squadrati sono attraversati dagli arbusti, le piscine sono piccole, a vasca di raccolta d'acqua come la Kneipp e a pozza con grotta come la recente " Buco Nero". Mentre il " labirinto", con citazione colta, rammemora il segno dell' Irrgarten.
Qui, sulle balze, Casasco ha voluto un proprio segno forte: una doppia lastra o scultura totemica, una rammemorazione maya, che presiede a una doppia caduta d'acqua. All'esistenza di un giardino, che non rinuncia alla naturalità nell'artefatto e con essa coabita, dobbiamo la presenza dei piccoli animali. La presenza dolce delle lucertole e delle farfalle, dappertutto, e di una colonia di falchetti sulla cima del monte Vico.
Il giardino del Negombo è tuttora in costruzione o meglio è opera in progress. Le balze sfumano nella macchia boscosa del Monte Vico e verso di esso il giardino continua a salire.
All' inizio delle balze, è stato collocata una scultura di Arnaldo Pomodoro. L'Arco in cielo. E' situata trasversalmente e perpendicolarmente al percorso del sole, ne enfatizza la nascita e il tramonto o, se si vuole, enigmaticamente li guarda, mentre il sole la investe in pieno al suo culmine. La scrittura criptica e misteriosa dell' Arco, fatta di spigoli, di linee spezzate, di punte, di triangoli e di cunei si dispiega e muta di continuo con il percorso del sole, con la sua stessa lentezza. Il gioco delle ombre e delle luci esalta le forme che costituiscono l'arco e che trasbordano e intrigano la regolarità delle formelle e della stessa curva arcuata.
"L'Arco in cielo" , di 10 metri di base e 5 metri di altezza, è costituito da 31 formelle per ciascuno dei due filari, disposte da sinistra a destra, in senso orario. Sono 31 momenti diversi di una narrazione, di un percorso temporale, 31 eventi in cui la fittezza dei segni e la loro esplosione è inframmezzata da pause, da rotture, da riflessioni e da momenti di quiete.
Un cuneo-freccia apre la narrazione - percorso; due frecce incrociate con la punta verso l'interno la chiudono. E' un percorso-tempo che si raccoglie su se stesso e può essere letto nei suoi due sensi o anche in senso inverso da chi attraversa l'arco - soglia. A dire la condizione umana attuale che è appunto quella di abitare la soglia. Così colui che passa o sosta trova scritta, sull'arco come sulle sue colonne, in una lingua sconosciuta, la sua vicenda umana e quella degli altri e si riconosce essere del tempo.
Un Arco e per di più di ceramica innova l'idea della porta, ne amplia e dilata i sensi: la porta non è più solo portale e apertura, ma è soglia, che è transito, passaggio e insieme sosta, o anche è linea di unione e insieme di separazione fra le cose.
Soglia è un concetto problematico e ambiguo. La soglia è linea di confine, che gli antichi esprimevano con la figura di Giano, la potenza dai due volti, che ha due chiavi, una d'oro e una d'argento, e ha un terzo misterioso volto nascosto che corrisponde all'occhio di Shiva, al terzo occhio, quello della mente. I due volti di Giano erano il simbolo delle due porte solstiziali e delle due fasi del ciclo annuale del sole, ascendente e discendente.
L'Arco di Pomodoro oltre che soglia, è sole nascente e/o tramontante, o arcobaleno che attraversa il cielo e si inserisce con la propria scrittura e voce dialogante nel giardino delle acque. Vi risuona all'interno aggiungendo i suoi messaggi indecifrati a quelli profondi delle piante e delle acque e vi esplicita i suoi valori cosmici e solari. Un disco-sole fuoriesce dalla curva dell'Arco e rammemora a suo modo i monumenti astrali, quali sono il circolo magico di Stonehenge, con la sua successione di porte di ingresso del sole e della luna, o il Sese Grande di Pantelleria. Il sole, luce dell'universo, è occhio e sguardo, è apertura al mondo. E' anche germe sferico del cielo, della terra e delle acque, è il sole del firmamento e il loto delle acque. In esso si materializza la vitalità di tutte le cose.
Così l'Arco unisce il proprio colore e la propria forma ai molti colori e forme del giardino e la sua terrestrità sensuosa e dionisiaca, aggiungendovi un'eccedenza di senso, quella del gesto e dell'evento creativo umano, e il proprio occhio visionario.
Qui al Negombo si avverte bene come il giardino è parte integrante dell'elemento dionisiaco che domina questo luogo e viene dalla radioattività presente nell'atmosfera, nella terra, nelle acque. Ed è connesso alla storia profonda dell'isola, che è più densa e ricca di quello che in superficie si può vedere, come se anche la storia avesse qui camminato in punta di piedi o ne avesse subito il potere di fascinazione.
Si sa che gli antichi Greci (come Nietzsche ha riscoperto) attribuivano coralità, coerenza sociale autentica, ai riti del dionisismo. L'elemento dionisiaco è quello dell'eccitazione, della rottura delle regole, da riferire non solo all'uomo, ma anche alle piante e agli animali. Da esso viene la ricchezza della vegetazione, con la sua esuberanza piena.
I Greci Eubei qui a San Montano costruirono la prima colonia occidentale; e più particolarmente i Romani furono costruttori e frequentatori delle terme come luogo di riposo salutare e intelligente. Il ritrovamento di importanti reperti archeologici a Barano, presso la fonte Nitrodi, di ex voto di marmo dedicati ad Apollo e alle ninfe Nitrodi, e di una sezione di altarino dedicata a Eros, documentano, insieme ai reperti provenienti da ville romane di Lacco Ameno e del promontorio di monte Vico e ai testi letterari e alle corrispondenze, la presenza a Ischia di un importante centro termale. E le terme romane erano luoghi straordinari, immersi in giardini, con alberi, statue, fontane, non ospitavano solo grandiosi bagni, ma erano luoghi di ritrovo, di lettura, di conferenze, di gare sportive.
Pur decadendo, dopo la fine dell'impero, il termalismo a Ischia non venne mai del tutto meno. Già con il Rinascimento riprese l'interesse per le terme. Il primo testo sui rimedi naturali dell'isola d'Ischia è del medico Giulio Iasolino da Tarsia (1588). E' una ripresa lenta, la valorizzazione piena è piuttosto novecentesca e recente, nel secondo dopoguerra.
Gli accertamenti scientifici attuali documentano e valorizzano pienamente la straordinaria ricchezza idrotermale di Ischia per le sue acque calde ricche di sali e i suoi propri effetti terapeutici, che gli antichi ben conoscevano. Sono, secondo M. Mancioli, 69 i gruppi fumarolici, 29 i bacini idrotermali, con 103 emergenze sorgive. Gli studiosi distinguono le sorgenti in due grandi gruppi: quelle, prevalenti, cloruro-sodiche, e quelle bicarbonato-alcaline. Tutti questi sono elementi di base per l'attività dell'organismo vivente.
E mettono in rilievo la presenza anche nelle acque minerali di oligoelementi, cioè di elementi contenuti in quantità infinitesimale e tuttavia attivi e capaci di agire come catalizzatori dei processi organici dei tessuti, o con parole più semplici, capaci di creare uno stato di benessere che non riguarda la malattia semplicemente lo stato generale e la vitalità dell'organismo vivente e quindi interessa un modo di vivere e di essere.

Alle acque va aggiunta la presenza della radioattività: qui a Ischia, ci ricorda M. Mancioli, nel 1917 il Premio Nobel M. Curie ha scoperto la radioattività naturale e chiamato Radon il gas nobile che la produce. E va aggiunta infine la straordinaria variabilità del clima e del paesaggio, della temperatura, dell'umidità, della ventilazione, del contesto dunque, che dilata all'ambiente nel suo complesso l'effetto portentoso sull'organismo sano come su quello malato. Per tutto ciò oggi si parla di ecologia termale, che sta diventando sempre più importante, come componente di un più vasto discorso di recupero della naturalità, e di ecologia del corpo e della mente.
E ciò induce a considerare presente nel Negombo una consapevole costruzione unitaria di motivazioni peculiari alla nostra lunga e complessa civiltà, che si incontrano con le istanze attuali della necessità di recupero del rapporto con la natura, che è in primo luogo recupero di noi stessi, della nostra corporeità e terrestrità nell'ideale di fare del giardino il nostro mondo.
Per questo, oggi il ritorno al giardino e alle terme non vale solo come ritorno all'innocenza, non è viaggio regressivo, ma ripresa, nella modernità, dei valori vitali e gioiosi dell'esistenza. E' riscoperta delle virtù delle erbe e dei fiori, delle arie e delle acque, che, come gli antichi sapevano, hanno tutto ciò che aiuta non solo a guarire le malattie, ma più globalmente favorisce la salute e suscita sensazioni piacevoli e voluttuose. E dunque è giusto parlare di dionisismo come possibile modo di abitare la terra.