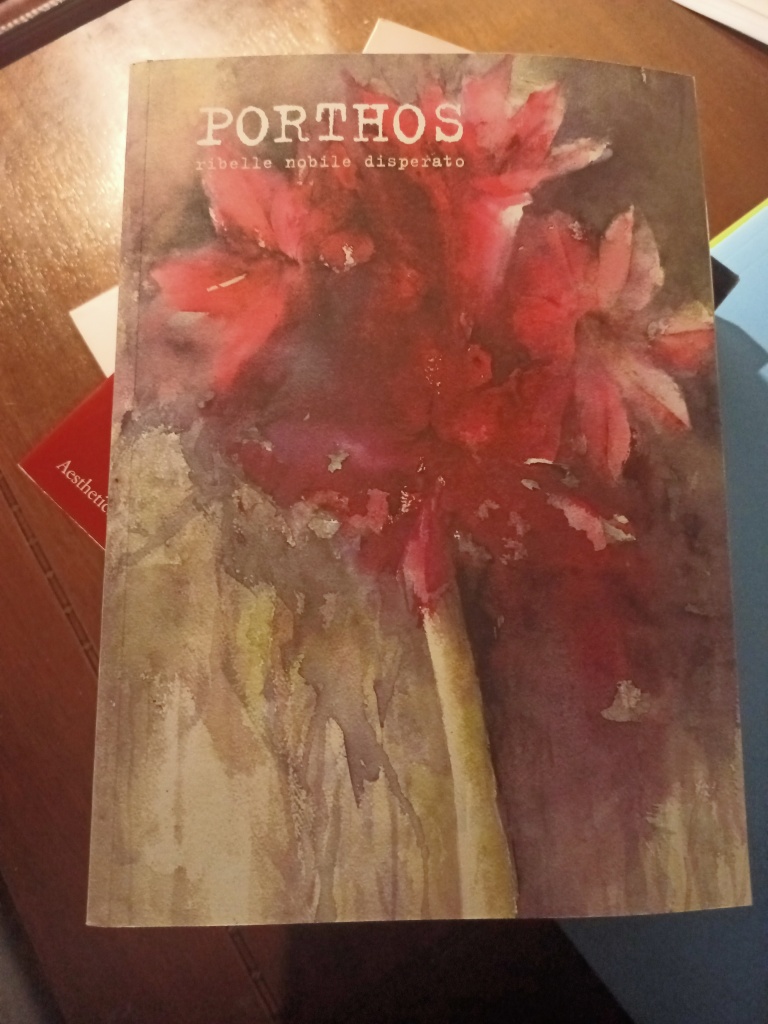Di Internet Archive Book Images – No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43779382
Origine, identità e qualità. Tutti termini che rimandano inequivocabilmente ad archetipi primordiali e ipotesi indiscusse di natura divina. La formula peggiore, dunque, sarebbe quella di fornire un prontuario di ricette “apri e gusta” dove inserire qualche vecchia foto di paese o di colline, due canzoni popolari, tre balli, qualche parola in dialetto, un bagnet vèrd per il bollito, il tutto sapientemente diluito con un buon bicchiere di grignolino (vino che amo molto). Perché un’identità territoriale costruita a tavolino, come se fosse una sommatoria e combinatoria di elementi presi qua e là da un baule del passato a cui si aggiungono coriandoli di modernità tecnologizzata, sa di parrucchino posticcio: basta un colpo di vento o uno starnuto ben dato e vola via. E poi sta male. Il mondo ne è pieno: ogni territorio, ogni luogo ne produce qualcuna: vuoi per una pubblicità muraria o per via giornalistica, vuoi per qualche redazionale, vuoi per qualche video più o meno commerciale, vuoi per qualche sito internet o blog in attesa di commenti che non verranno mai.
Ed è da qui che vorrei partire: un’identità, qualunque essa sia, è un fenomeno storico e negoziale. Implacabilmente plurale. Il primo ancoraggio ideale ancorché semantico del concetto “identità” si usa farlo con un’altra parola anch’essa utilizzata sino allo stordimento, per non dire alla nausea: “tradizione”. Nel suo significato etimologico della parola “tradizione” il vocabolario dice:
tradizióne s. f. [dal lat. traditio -onis, propr. «consegna, trasmissione», der. di tradĕre «consegnare»; nel lat. tardo anche «tradimento», dapprima con riferimento alla consegna dei libri sacri (v. traditore, in etim.), poi con uso assol.: di qui il raro sign.
Sorpresa: tradizione e tradimento, che nel nostro immaginario sono due parole molto distanti fra loro, derivano entrambe dal verbo latino “tradĕre”, letteralmente “consegnare”.
Nel primo caso, dunque, la consegna riguarda tutto ciò che passa dalle mani di una generazione a quelle di un’altra, per salvaguardarlo dallo scorrere del tempo; nel secondo caso, invece, la consegna riguarda qualcosa che dovrebbe essere protetto. Il verbo tradire (il latino tradĕre), porta con sé il significato di “consegnare” un ordine precostituito, un sistema preesistente, “in nome di una nuova consegna, di un nuovo ordine, di un nuovo sistema. Esso sancisce dunque il dramma del passaggio dal vecchio al nuovo e quindi in sostanza l’eterno dramma del processo evolutivo. Il tradimento ha dunque sempre a che fare con l’abbandono da parte di un sistema di precedenti regole o configurazioni a favore della novità”.
Non esistono quindi delle identità identiche a sé che si ergono immutabili a discapito di quanto muta incessantemente. Sono genovese di adozione e torinese di nascita. Mio nonno veniva da un paese ai piedi della Langa e dopo l’androne del bollito: Farigliano. L’androne del bollito è Carrù. Se qualcuno mi chiedesse di definire l’identità di quei luoghi, me ne starei zitto per un po’. Dovrei pensarci, insomma. Non sono più i luoghi che lungo i suoi novant’anni di vita conobbe mio nonno, ma non sono più neppure i luoghi di quando ero ragazzo. Troppe, tante cose sono cambiate: le piazze e le strade vuote, i bar, gli sguardi miei e quelli della gente, le parole al vento, i dialetti e le lingue parlate (quante se ne parlano nelle vostre campagne e nelle vostre vigne?), i lavori, i vestiti e i cappelli della domenica, le feste, gli smartphone e potrei continuare. Forse la morfologia del territorio è cambiata meno: qualche casa e qualche parcheggio in più, due villette a schiera qua e là, il Tanaro che si è ripreso le sue rive. Ma io so che non è più quello che avevo vissuto sino a poco tempo fa: non so se sia diventato una grande periferia di un centro urbano di chissà dove, o soltanto una delle tante sedi suburbane all’interno della grande rete delle connessioni informatiche.
Così “origine”, non da meno di “identità”, e forse negli stessi termini, è un concetto che crea qualche problema. Riprendo qui un brano di Foucault: «Perché Nietzsche genealogista rifiuta, almeno in certe occasioni, la ricerca dell’origine (Ursprung)? Innanzitutto perché in essa ci si sforza di raccogliere l’essenza esatta della cosa, la sua possibilità più pura, la sua identità accuratamente ripiegata su se stessa, la sua forma immobile ed anteriore a tutto ciò che è esterno, accidentale e successivo. Ricercare una tale origine, è tentare di ritrovare “quel che era già”, lo “stesso” d’un immagine esattamente adeguata a sé; è considerare avventizie tutte le peripezie che hanno potuto aver luogo, tutte le astuzie e tutte le simulazioni; è cominciare a togliere tutte le maschere, per svelare infine un’identità originaria. Ora, se il genealogista prende cura d’ascoltare la storia piuttosto che prestare fede alla metafisica, cosa apprende? Che dietro le cose c’è “tutt’altra cosa”: non il loro segreto essenziale e senza data, ma il segreto che sono senza essenza, o che la loro essenza fu costruita pezzo per pezzo a partire da figure che le erano estranee. La ragione? Ma è nata in modo del tutto “ragionevole” – dal caso. L’attaccamento alla verità e il rigore dei metodi scientifici? Dalla passione dei dotti, dal loro odio reciproco, dalle loro discussioni fanatiche e sempre riprese, dal bisogno di prevalere, – armi lentamente forgiate nel corso di lotte personali. E la libertà, sarebbe forse, alla radice dell’uomo, quello che lo lega all’essere e alla verità? Nei fatti, non è che “un’invenzione delle classi dirigenti”. Là dove le cose iniziano la loro storia, quel che si trova non è l’identità ancora preservata della loro origine, – ma la discordia delle altre cose, il disparato». M. Foucault, Nietzsche, la genealogia, la storia, in Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977 (ed. orig. Hommage à J. Hyppolite, Paris 1971), ora in Id., Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969-1984, a cura di M. Bertani, Einaudi, Torino 2001, pp. 45-46.
Dunque nulla da fare? Se sono veri i presupposti e i fondamenti dai quali sono partito, allora sarà necessario che la comunicazione su ciò che l’identità di un territorio significa, o le sue plurali identità, venga descritta ed analizzata per quello che è, sia nelle modalità in cui si dispiega concretamente e sia nelle modalità in cui essa viene rappresentata: servono, dunque, interviste, mappe mentali che coinvolgano gli abitanti così da evitare una forma di etnicizzazione politica della costruzione identitaria (ad essa contribuiscono le vecchie famiglie, i nuovi nati e i nuovi venuti). La memoria storica, prodotto della ricerca storiografica, che utilizza fonti scritte, orali, materiali e materie di ogni genere e forma si deve intersecare con la memoria individuale e collettiva, con la continua interpretazione e reinterpretazione narrativa di coloro che in quei luoghi dimorano. E poi, dall’altra parte, mappe, carte storiche e tematiche, elaborazioni GIS (Geographic Information System), dati statistici, iconografici e visuali: insomma tutti materiali di indagine quantitativa così come vengono definiti in sociologia.
Ecco che allora, e solo in quel momento, potremmo dire che l’unità del paesaggio è data da uno “spazio dell’azione”, da un “contesto” e da uno “sfondo”. E solo allora potremmo dire che ciò che rimandiamo agli altri (immagini, prodotti o storie di vita…) non è soltanto un artefatto posticcio di un collage di luoghi comuni o una foto sbiadita di un mondo irrimediabilmente scomparso.