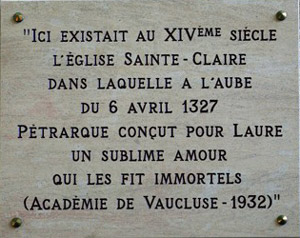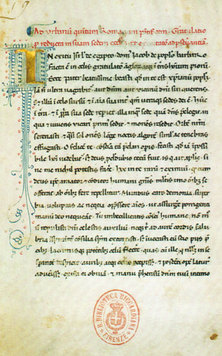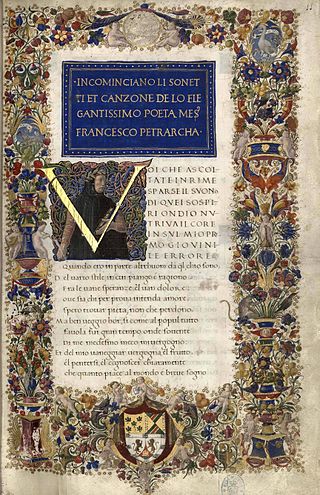Il periodo giovanile
Alessandro Manzoni nasce a Milano nel 1785 dal conte Pietro e da Giulia Beccaria, (matrimonio d’interesse: lui in seconde nozze di 46 anni, lei, le cui fortune di casa erano piuttosto precarie, di appena 20). Visto il carattere un po’ esuberante della giovane donna, si vocifera, sin dall’inizio, e non senza ragione, che il padre naturale di Alessandro sia Giovanni Verri, fratello minore di Pietro, anche se Alessandro lo negherà sempre.

Giulia Beccaria
Tuttavia la voce (fondata o no) ci dimostra, al di là del mero fatto biografico, come i rapporti dello scrittore milanese con l’illuminismo lombardo non furono soltanto culturali, ma anche e soprattutto “familiari”. Infatti non è solo per la discendenza dell’ipotetico vero padre, ma anche per quella della madre, figlia del celeberrimo Cesare Beccaria, autore di quel testo fondamentale dell’Illuminismo italiano ed europeo Dei delitti e delle pene, che tale rapporto non verrà mai meno.
Il giovane Alessandro viene educato sotto il rigido controllo paterno che lo indirizzerà ad una cultura tradizionale cattolica confinandolo nei collegi dei padri Somaschi (in Svizzera) e poi dei Bernabiti a Milano dove sarà costretto ad assimilare una cultura retriva e bigotta da cui prenderà sin da giovane le distanze, avvicinandosi al giacobinismo e al neoclassicismo. Scriverà sin dal 1801 opere di scarsa importanza, fra le quali ricordiamo l’epillio Adda (dedicato a Vincenzo Monti) e il poemetto Urania, tutte improntate sull’insegnamento neoclassico.
Nel 1792 Giulia si divide ufficialmente dal marito, per andare dapprima a Londra e poi a Parigi, nel 1795, dove convivrà con il nuovo compagno Carlo Imbonati (intanto fa notizia e scandalo che l’Imbonati nomini Giulia sua erede universale). Quest’ultimo inviterà il giovane Alessandro a raggiungere la madre a Parigi, città cui giungerà nel 1805; ma nel frattempo muore l’Imbonati; ciò determinerà la prima svolta poetica scrivendo per lui il poemetto, sotto forma di visione, In morte di Carlo Imbonati. In questo scritto, elaborato ispirandosi a Parini, possiamo già cogliere alcuni punti fondamentali dell’esperienza matura di Manzoni.
Apparsogli in sogno, il compagno della madre offre questi consigli al giovane scrittore:
IN MORTE DI CARLO IMBONATI
“Sentir”, riprese, “e meditar: di poco
esser contento: da la meta mai
non torcer gli occhi: conservar la mano
pura e la mente: de le umane cose
tanto sperimentar, quanto ti basti
per non curarle: non ti far mai servo:
non far tregua coi vili: il santo Vero
mai non tradir: né proferir mai verbo,
che plauda al vizio, o la virtù derida.
“Sentire (la vita)” riprese a dire “e meditare su di essa. Accontentarsi di poco: non distogliere mai lo sguardo: conservare la purezza sia da un punto di vista economico che intellettuale: sperimenta le cose umane, quanto ti basti, per non preoccuparti di esse: non diventare mai servo dei potenti: non accompagnarti con i vigliacchi: non tradire mai la santa verità, né dire una parola che sia d’approvazione al vizio e di derisione alla virtù.
E’ chiaro che il sottofondo dell’ispirazione manzoniana in questa opera sia fondamentalmente morale, assegnando un compito “preciso” alla poesia che, come proprio Milano aveva offerto con il magistero di Parini, non deve solo affermarsi in quanto “esteticamente” bella, ma, senza negare la bellezza, in quanto proprietà intrinseca del dettato poetico, non può esimersi dall’essere anche “utile”. Ma se per Parini è un compito, per il giovane Manzoni è un progetto. Il testo, in endecasillabi liberi, non sono esenti tuttavia da una certa ricercatezza (perlomeno nei versi riportati); si noti l’insistito enjambement e l’aspetto fonico ottenuto con “servo:vero:verbo”, che non toglie, tuttavia, un tono dimesso e mite, da allievo verso il maestro.

Il giovane Manzoni e Claude Fauriel
Parigi e la “conversione” al cattolicesimo
Una volta a Parigi il rapporto che s’istituì fra madre e figlio sarà ricco ed estremamente intenso. Infatti Giulia Beccaria lo inserirà negli ambienti intellettuali francesi. Fra i molti conosciuti, particolare importanza assunse l’amicizia con Claude Fauriel, il quale lo introdurrà agli studi storici, dando a questi ultimi un’importanza non soltanto “materiale”, ma anche e soprattutto spirituale.
Quando sta tornando a Milano, gli giunge la notizia della morte del conte Pietro. Si ferma quindi nella villa di Brusuglio (ereditata dalla madre dal conte Imbonati).
Conosciuta la ginevrina Enrichetta Blondel la sposa nel 1808 con rito calvinista, nella residenza della famiglia della sposa. Il pio atteggiamento della giovane moglie, intanto, sembra minare l’atteggiamento indifferente di Alessandro verso la religione. Rientra quello stesso anno a Parigi dove gli nasce la prima figlia, Giulia, che, fra la sorpresa generale, farà battezzare. Quindi scriverà una supplica al pontefice Pio VII affinché autorizzi una nuova celebrazione del matrimonio con rito cattolico.

Enrichetta Blondel e Alessandro Manzoni
Il 2 Aprile del 1810, durante i festeggiamenti per il matrimonio tra Napoleone e Maria Luisa d’Asburgo, Manzoni ebbe la sua prima crisi di nervi, determinata dalla momentanea scomparsa dagli occhi tra la folla della moglie. Rifugiatosi in Chiesa, secondo tradizione, sembra si convertisse al cattolicesimo.
Al di là del fatto aneddotico, come ci ha tramandato una certa biografia di tipo apologetico, si può facilmente desumere come l’avvicinamento alla fede cattolica da parte di Manzoni, sia un fatto maturato pian piano nella sua coscienza, frutto di una lunga meditazione e non un improvviso “cambiamento”. D’altra parte il problema critico sulla sua conversione è ancora fortemente dibattuto, anche perché il nostro non vi ha mai fatto cenno.
Appena tornato a Milano, aprì la sua casa ad importantissimi intellettuali come Berchet, Grossi, Porta (protagonisti del dibattito culturale lombardo) e lì elaborò il progetto di una nuova poesia, lontana dalle esperienze neoclassiche allora imperanti.
Inni sacri
Il primo progetto, post-conversione, dell’attività poetica del nostro, vede il Manzoni fortemente impegnato a testimoniare, attraverso la poesia, la sua fede. Decide, pertanto, di scrivere 12 inni sacri, ognuno di essi corrispondente ad una festività liturgica. Ne compone solo cinque: La Resurrezione, Il Nome di Maria, Il Natale, La Passione (questi quattro composti tra il 1810 ed il 1815) ed infine La Pentecoste iniziata nel 1817, ma portata a termine nella grande stagione creativa del Manzoni, il 1822.
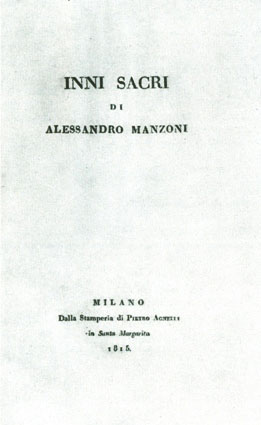
Prima edizione degli Inni Sacri del 1815
La difficoltà con cui Manzoni si dovette misurare nell’elaborazione della nuova materia, l’interesse per la forma tragica che cominciò a maturare in lui, fecero in modo che il progetto originario non venne completato. Infatti si trattava non soltanto di ripercorrere le festività liturgiche su un piano dottrinale-teologico, quanto di calarle nella realtà “quotidiana” della massa dei credenti. Per far questo era necessario operare su due fronti: quello linguistico-formale e quello tematico.
Per la struttura si trattava di ricorrere ad un metro facilmente memorizzabile come il settenario con ripetizioni e rime interne; per il tema bisognava ricorrere a una ripresa di immagini ben conosciute dalla massa dei credenti in quanto tratta dalla Bibbia, ma allo stesso tempo nuove nella tradizione poetica italiana.
All’inizio sembra che prevalga in lui una lettura cristiana che si richiama al giansenismo, come possiamo vedere ne Il Natale:
IL NATALE
Qual masso che dal vertice
di lunga erta montana,
abbandonato all’impeto
di rumorosa frana,
per lo scheggiato calle
precipitando a valle,
batte sul fondo e sta;
là dove cadde, immobile
giace in sua lenta mole;
né, per mutar di secoli,
fia che riveda il sole
della sua cima antica,
se una virtude amica
in alto nol trarrà:
tal si giaceva il misero
figliol del fallo primo,
dal dì che un’ineffabile
ira promessa all’imo
d’ogni malor gravollo,
donde il superbo collo
più non potea levar.
Qual mai tra i nati all’odio,
quale era mai persona,
che al Santo inaccessibile
potesse dir: perdona?
Far novo patto eterno?
Al vincitore inferno
la preda sua strappar?
Ecco ci è nato un Parvolo,
ci fu largito un Figlio:
le avverse forze tremano
al mover del suo ciglio:
all’uom la mano Ei porge,
che si ravviva, e sorge
oltre l’antico onor.
Dalle magioni eteree
sgorga una fonte, e scende,
e nel borron de’ triboli
vivida si distende:
stillano mèle i tronchi
dove copriano i bronchi,
ivi germoglia il fior.
O Figlio, o Tu cui genera
l’Eterno, eterno seco;
qual ti può dir de’ secoli:
Tu cominciasti meco?
Tu sei: del vasto empireo
non ti comprende il giro:
la tua parola il fe’.
E Tu degnasti assumere
questa creata argilla?
Qual merto suo, qual grazia
a tanto onor sortilla?
Se in suo consiglio ascoso
vince il perdon, pietoso
immensamente Egli è.
Oggi Egli è nato: ad Efrata,
vaticinato ostello,
ascese un’alma Vergine,
la gloria d’Israello,
grave di tal portato:
da cui promise è nato,
donde era atteso uscì.
La mira Madre in poveri
panni il Figliol compose,
e nell’umil presepio
soavemente il pose;
e l’adorò: beata!
Innanzi al Dio prostrata,
che il puro sen le aprì.
L’Angiol del cielo, agli uomini
nunzio di tanta sorte,
non de’ potenti volgesi
alle vegliate porte;
ma tra i pastor devoti,
al duro mondo ignoti,
subito in luce appar.
E intorno a Lui, per l’ampia
notte calati a stuolo,
mille celesti strinsero
il fiammeggiante volo;
E accesi in dolce zelo,
come si canta in cielo,
a Dio gloria cantar.
L’allegro inno seguirono,
tornando al firmamento:
tra le varcate nuvole
allontanossi, e lento
il suon sacrato ascese,
fin che più nulla intese
la compagnia fedel.
Senza indugiar, cercarono
l’albergo poveretto
que’ fortunati, e videro,
siccome a lor fu detto,
videro in panni avvolto,
in un presepe accolto,
vagire il Re del Ciel.
Dormi, o Fanciul; non piangere;
dormi, o Fanciul celeste:
sovra il tuo capo stridere
non osin le tempeste,
use sull’empia terra,
come cavalli in guerra,
correr davanti a Te.
Dormi, o Celeste: i popoli
chi nato sia non sanno;
ma il dì verrà che nobile
retaggio tuo saranno;
che in quell’umil riposo,
che nella polve ascoso,
conosceranno il Re.
Come un masso dalla vetta lungo il ripido pendio l’uomo giace in terra che, caduto, lungo l’irregolare solco precipita a valle e resta // là dove è caduto sta immobile nel suo inerte peso; non accadrà nel tempo che egli possa ritornare a vedere il sole della sua antica altezza se non per un intervento benevolo che lo riporti in alto. // Così giaceva l’uomo, figlio del peccato originale dal giorno che un’inesprimibile punizione promessa (ai primi uomini) oppresse l’uomo fino al fondo di ogni male, per cui non poteva più sollevare il superbo collo. // Quale tra i nati dopo il peccato originale quale qualsiasi persona poteva rivolgersi a Dio per chiedere perdono, fare un nuovo patto e strappare all’inferno vincitore la sua preda. // All’umanità peccatrice è nato un bimbo, un figlio, al cui muovere delle ciglia tremano le forze avverse a Dio. Questo bimbo porge la mano all’uomo, lo risolleva dal peccato e lo riconcilia con Dio facendolo tornare all’antica considerazione. // Dalle sedi celesti sgorga una fonte (della Grazia), e come l’acqua scorre nel burrone irto di rovi: stillano miele i tronchi degli alberi e dove gli sterpi ricoprivano tutto fa crescere frutti e fiori. // O figlio (di Dio), tu generato da Dio eterno ed eterno tu stesso; chi mai, potrà vantarsi di essere nato assieme a te? Tu esisti e nemmeno l’estensione del cielo più ampio può comprenderti. Il cielo stesso è creato dalla tua parola. // E tu ti sei umiliato a incarnarti nella carne dell’uomo? Quale merito o quale atto gradito a Dio la elesse ad un così grande onore? Se nei giudizi imperscrutabili di Dio il perdono vince allora la sua pietà è veramente infinita. // Oggi Egli è nato a Betlemme, luogo indicato nella profezia come luogo natale del Messia, salì una donatrice di vita vergine (la Vergine Maria), gloria d’Israele, gravida di tale figlio; dalla stirpe da cui aveva promesso di nascere è nato e nella quale era atteso. // L’ammirabile madre ravvolse il figlio in poveri panni e nell’umile presepe lo adagiò e l’adorò: beata! Prostrata davanti a Dio che le dischiuse il seno verginale. // L’angelo che annuncia un così grande, non si rivolge alle sorvegliate porte dei potenti ma ai pastori devoti, ignorati dal mondo insensibile, all’improvviso appare illuminato dalla luce divina. // E attorno a lui nella notte scesero dal cielo in gran numero migliaia di angeli che si strinsero intorno a lui in quel volo di luce e accesi di dolce gioia cantarono gloria a Dio come la si canta in cielo. // Continuarono il lieto inno tornando in cielo: attraversando le nuvole si allontanarono e lentamente la musica sacra si affievolì salendo finché i pastori devoti non udirono più nulla. // Senza indugiare cercarono la capanna quei fortunati e videro avvolto nei panni, adagiato in un presepe il pianto del Re del cielo // Dormi fanciullo, non piangere; dormi o fanciullo divino: non osino sopra il tuo capo sibilare le tempeste abituali sulla terra empia, come cavalli in guerra che corrono davanti a te. // Dormi, o creatura celeste: i popoli non sanno chi è nato ma verrà il giorno in cui saranno tutti tuoi sudditi; e in quel misero rifugio ora riposa e si nasconde nella polvere colui nel quale riconosceranno il Cristo Re.
Da come si può desumere da questo testo l’immagine prevalente è quella della “grazia” che come un masso dall’alto della montagna precipita a donare loro la fede: pertanto la fede non diventa “cattolicamente” una conquista grazie alle opere, ma una continua testimonianza in quanto posseduta. Tale grazia infatti apparirà ai poveri, i primi testimoni della nascita di Cristo e saranno loro i promotori di una Ecclesiae renovatio in senso pauperistico e quindi, di conseguenza, morale. Come è stato già detto, infatti, in questo inno prevale la visione giansenista, nella quale l’uomo è visto, pessimisticamente, come prostrato e a cui serve una grazia divina che permette lui di sollevarsi e giungere così a Dio. Doveva, questo, nel progetto originario i Manzoni, apparire come il primo inno, ma non ricevette il successo sperato, determinato forse dalla non perfetta aderenza della lingua al dettato e da una certa meccanicità che fa sì che ogni strofe venga chiusa da un concetto; si noti ad esempio la persistenza dell’immagine tratta dall’egloga IV virgiliana nella 6° strofe.
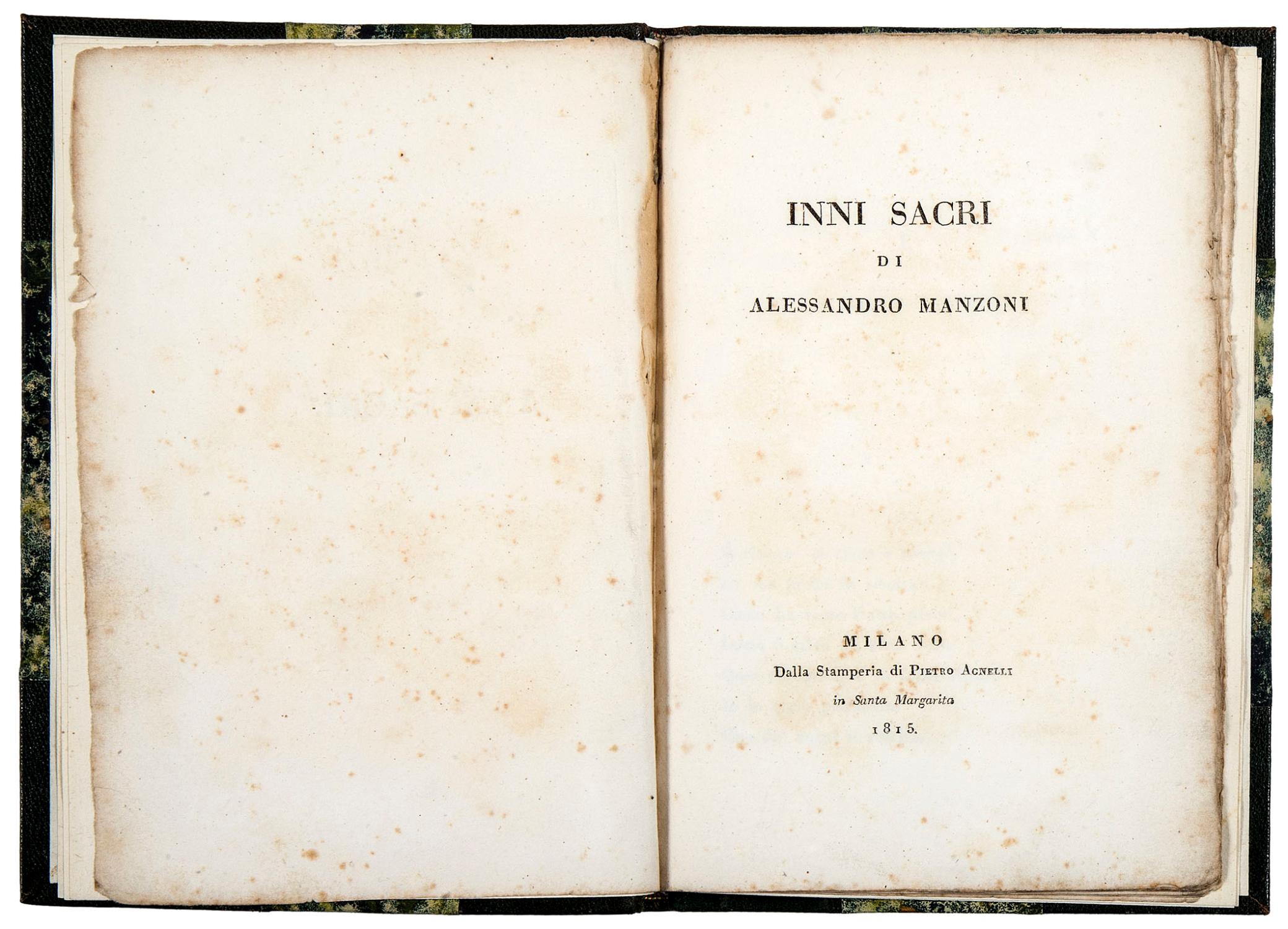
Ma l’Inno Sacro decisamente più importante è certamente l’ultimo scritto, La Pentecoste, scritto nel 1822, durante la grande stagione creativa di Manzoni:
LA PENTECOSTE
Madre de’ Santi; immagine
della città superna;
del Sangue incorruttibile
conservatrice eterna;
tu che, da tanti secoli,
soffri, combatti e preghi
che le tue tende spieghi
dall’uno all’altro mar;
campo di quei che sperano,
chiesa del Dio vivente;
dov’eri mai? qual angolo
ti raccogliea nascente,
quando il tuo Re, dai perfidi
tratto a morir sul colle,
imporporò le zolle
del suo sublime altar?
E allor che dalle tenebre
la diva spoglia uscita,
mise il potente anelito
della seconda vita;
e quando, in man recandosi
il prezzo del perdono,
da questa polve al trono
del Genitor salì;
compagna del suo gemito,
conscia dei suoi misteri,
tu, della sua vittoria
figlia immortal, dov’eri?
In tuo terror sol vigile,
sol nell’oblio secura,
stavi in riposte mura,
fino a quel sacro dì,
quando su te lo Spirito
lrinnovator discese,
e l’inconsunta fiaccola
nella tua destra accese;
quando, segnal de’ popoli.
ti collocò sul monte
e ne’ tuoi labbri il fonte
della parola aprì.
Come la luce rapida
piove di cosa in cosa,
e i colori suscita
dovunque si riposa;
tal risonò molteplice
la voce dello Spiro:
l’Arabo, il Parto, il Siro
in suo sermon l’udì.
Adorator degl’idoli,
sparso per ogni lido,
volgi lo sguardo a Solima,
odi quel santo grido:
stanca del vile ossequio,
la terra a LUI ritorni:
e voi che aprite i giorni
di più felice età,
spose che desta il subito
balzar del pondo ascoso;
voi già vicine a sciogliere
il grembo doloroso;
alla bugiarda pronuba
non sollevate il canto:
cresce serbato al Santo
quel che nel sen vi sta.
Perché, baciando i pargoli
la schiava ancor sospira?
e il sen che nutri i liberi
invidiando mira?
Non sa che al regno i miseri
seco il Signor solleva?
che a tutti i figli d’Eva
nel suo dolor pensò?
Nova franchigia annunziano
i cieli, e genti nove;
nove conquiste, e gloria
vinta in più belle prove;
nova, ai terrori immobile
e alle lusinghe infide,
pace, che il mondo irride,
ma che rapir non può.
O Spirto! supplichevoli
a’ tuoi solenni altari;
soli per selve inospite;
vaghi in deserti mari;
dall’Ande algenti al Libano
d’Erina all’irta Haiti,
sparsi per tutti i liti,
uni per Te di cor.
Noi t’imploriam! Placabile
Spirto discendi ancora,
a’ tuoi cultor propizio,
propizio a chi T’ignora;
scendi e ricrea; rianima
i cor nel dubbio estinti;
e sia divina ai vinti
mercede il vincitor.
Discendi Amor; negli animi
l’ire superbe attuta:
dona i pensier che il memore
ultimo dì non muta:
i doni tuoi benefica
nutra la tua virtude;
siccome il sol che schiude
dal pigro germe il fior;
che lento poi sull’umili
erbe morrà non colto,
né sorgerà coi fulgidi
color del lembo sciolto,
se fuso a lui nell’etere
non tornerà quel mite
lume dator di vite,
e infaticato altor.
Noi t’imploriam! Ne’ languidi
pensier dell’infelice
scendi piacevol alito,
aura consolatrice:
scendi bufera ai tumidi
pensier del violento;
vi spira uno sgomento
che insegni la pietà.
Per Te sollevi il povero
al ciel, ch’è suo, le ciglia,
volga i lamenti in giubilo
pensando a cui somiglia:
cui fu donato in copia
doni con volto amico,
con quel tacer pudico,
che accetto il don ti fa.
Spira dei nostri bamboli
nell’ineffabil riso;
spargi la casta porpora
alle donzelle in viso;
manda alle ascose vergini
le pure gioie ascose;
consacra delle spose
il verecondo amor.
Tempra dei baldi giovani
il confidente ingegno;
reggi il viril proposito
ad ineffabil segno;
adorna le canizie
di liete voglie sante;
brilla nel guardo errante
di chi sperando muor.
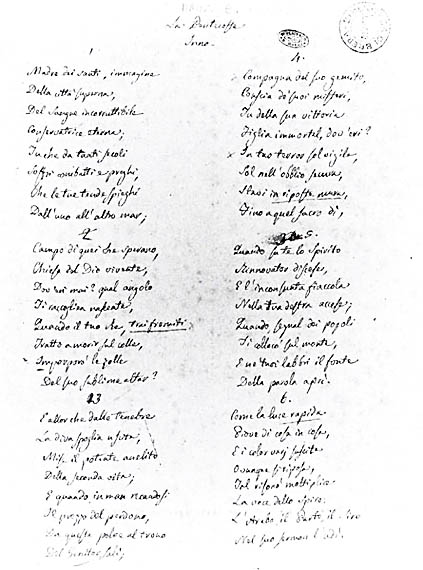
La Pentecoste (autografa)
(Tu Chiesa) che sei la madre dei Santi, l’immagine della città di Dio, conservatrice eterna del sangue di Cristo che mai si corrompe (attraverso l’Eucarestia), tu che, da tanti secoli, soffri, combatti e preghi; che distendi le tue tende dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico, // tu che sei la sede di quelli che sperano nella Salvezza, Chiesa del Dio vivente; dov’eri?, quale angolo del mondo ti accoglieva mentre nascevi, quando il tuo Re Cristo, portato a morire sul monte Golgota dai malvagi, rese rosse col suo sangue le zolle del suo altare sublime? // E quando il corpo divino di Cristo, uscito dall’oscurità del sepolcro, emise il respiro della vita eterna, e quando, portando con sé la croce (simbolo del perdono di Dio per il peccato originale dell’uomo), da questo mondo salì verso il trono di Dio Padre; // (Tu Chiesa) compagna del suo dolore, consapevole del suo mistero, tu, figlia immortale, dov’eri? Vigile soltanto nel terrore della tua sorte, sicura soltanto se ignorata, rimanevi nascosta in luoghi appartati fino a quel sacro giorno // quando su te discese lo Spirito Santo rinnovatore e accese nella tua mano la fiaccola che mai si consuma, quando, guida per tutti i popoli, ti mise in alto su un monte, e aprì la fonte della parola evangelica nelle tue labbra // Come la luce, sempre identica a se stessa, posandosi su corpi diversi, suscita vari colori, dovunque posi, allo stesso modo risuonò la voce dello Spirito Santo, e nello loro lingua lo udirono gli Arabi, i Parti ed i Siriani // Adoratore degli dei pagani, sparso in ogni luogo della terra, volgi lo sguardo a Gerusalemme (Solima), ascolta quel santo grido: la terra, stanca del vigliacco ossequio verso gli dei, torni a Dio: e voi, giovani spose, che partorirete in giorni di un’età più felice (perché rinnovata dallo Spirito Santo), // spose svegliate all’improvviso dai movimenti del feto; voi che siete già vicine al doloroso parto, non innalzate il canto alla bugiarda (in quanto pagana) Giunone, cresce soltanto riservato a Cristo Santo ciò che vi sta nel grembo. // Perché baciando i suoi figli la schiava tuttavia sospira (preoccupata per la loro sorte) e osserva, con invidia, il seno che nutre i figli delle donne libere? Non sa il Signore solleva nel suo regno i poveri? Che nel suo sacrificio riscattò tutti gli uomini indistintamente? // I cieli annunciano una nuova libertà e un’umanità rinnovata dalla fede; nuove conquiste ed una gloria vinta in prove più belle (di qualsiasi azione militare), una nuova pace, ferma di fronte al terrore e alle infide lusinghe, (pace) che il mondo può deridere, ma non può rapire. // O Spirito! Supplichevoli ai tuoi solenni altari, soli in mezzo a foreste selvagge, vaganti solitari in mezzo al mare, dalle Ande freddissime al Libano, dall’Irlanda alla scogliosa Haiti, sparsi in ogni luogo della terra, uniti per Te nel cuore // Noi t’imploriamo! Spirito scendi ancora incline al perdono, propizio a chi ha fede in te, propizio a chi non crede in Te, scendi e rinnova; rianima i cuori morti alla fede, e sia un divino premio il vincitore Spirito. // Scendi Amore, placa le ire superbe, dona i pensieri santi che l’ultimo giorno memore di tutta la vita non muta, benefica i tuoi stessi doni, nutri la tua virtù, come il sole che schiude il fiore dal pigro germe; // che poi afflosciato sulle basse erbe morrà non colto, né sorgerà con gli splendidi colori della corolla aperta, se diffuso nell’aria non tornerà la luce del sole, che dà la vita, e infaticabile alimentatore. // Noi t’imploriamo! Scendi piacevole soffio, aria consolatrice negli sfiduciati pensieri dell’infelice: scendi come una bufera ai pensieri gonfi d’ira del violento, e ispiragli un timor di Dio che gli insegni la pietà. // Per mezzo tuo sollevi il povero gli occhi al cielo che gli appartiene, rivolga quindi la sua disperazione in gioia pensando che è stato creato a somiglianza di Dio, a chi è stato donato in abbondanza, doni a sua volta con solidarietà, con quel piacere non appariscente che rende il dono bene accettato. // Soffia nell’ineffabile riso dei fanciulli, spargi quel casto rossore nei volti delle ragazze; manda alle suore di clausura le nascoste e pure gioie, rendi sacro il pudico amore delle spose. // Governa l’ingegno troppo sicuro di sé nei giovani, guida il proposito coraggioso a raggiungere un buon fine; adorna la vecchiaia di liete gioie sante, risplendi nello sguardo smarrito di chi muore nella speranza (di ricongiungersi a Dio).
Nella Pentecoste si matura il passaggio secondo cui soltanto la grazia, data dal Signore, prelude alla salvezza a quello della Provvidenza che guida la storia (tema fondamentale del romanzo). La festa liturgica della Pentecoste ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli dopo cinquanta giorni dalla Resurrezione di Cristo. E’ un canto quindi fondato sulla Chiesa, parola iniziale dell’Inno, che diventa protagonista come mezzo di comunicazione tra l’uomo e Dio. Essa per questo non deve isolarsi in uno sterile sguardo che ignora il mondo per inseguire il divino, ma, viceversa, un elemento della storia il cui compito non è solo testimoniare Cristo, ma vivificarlo nella vita degli uomini. Per questo si parla di “Chiesa militante”, per questo nella seconda parte dell’inno, la vediamo efficacemente entrare negli uomini per celebrare l’amore verso i figli, per le spose, per temperare i caratteri iracondi, per avvicinare i vecchi a Dio. Questi elementi si armonizzano efficacemente nel dettato poetico in cui vengono veicolati messaggi estremamente innovativi nella cultura nazionale: si veda il concetto di “popolarità” (facilità di linguaggio, contabilità, repertorio tematico conosciuto dai credenti), l’attenzione per gli umili, che il messaggio della Chiesa ha liberato dalla schiavitù tipica della struttura sociale del mondo classico; ma, è importante sottolinearlo ancora, si veda il concetto di “Chiesa militante” (sono ricorrenti all’interno del testo le metafore belliche), cioè di una Chiesa che deve entrare nella storia per trasformare la storia stessa.
E’ a Milano quando assiste, con orrore, all’uccisione del ministro Prina, nominato da Napoleone nel Regno d’Italia da lui fondato. In quell’occasione Manzoni scrive Aprile 1814 e, l’anno successivo il Proclama di Rimini (incompiuto). Al di là della validità artistica di tali odi, ciò che interessa è l’attenzione con cui Manzoni si misura con il reale e con lo sviluppo storico (che di lì a poco darà origine al vero e proprio Risorgimento italiano). La sconfitta di Napoleone nel 1815 accentuò infatti la sua preoccupazione che sfociò in un intensificarsi delle sue crisi nervose.
Le Tragedie
Le tragedie manzoniane sono due: Il conte di Carmagnola (1819) e l’Adelchi (1822). La prima viene iniziata nel 1816 durante la composizione degli Inni; l’altra mentre già era balenata in lui l’idea del romanzo. Inoltre vi è da sottolineare come l’idea di avvicinarsi a tale genere avesse anche lo scopo di raccogliere l’invito di Madame De Staël, vero ispiratore del nostro Romanticismo.
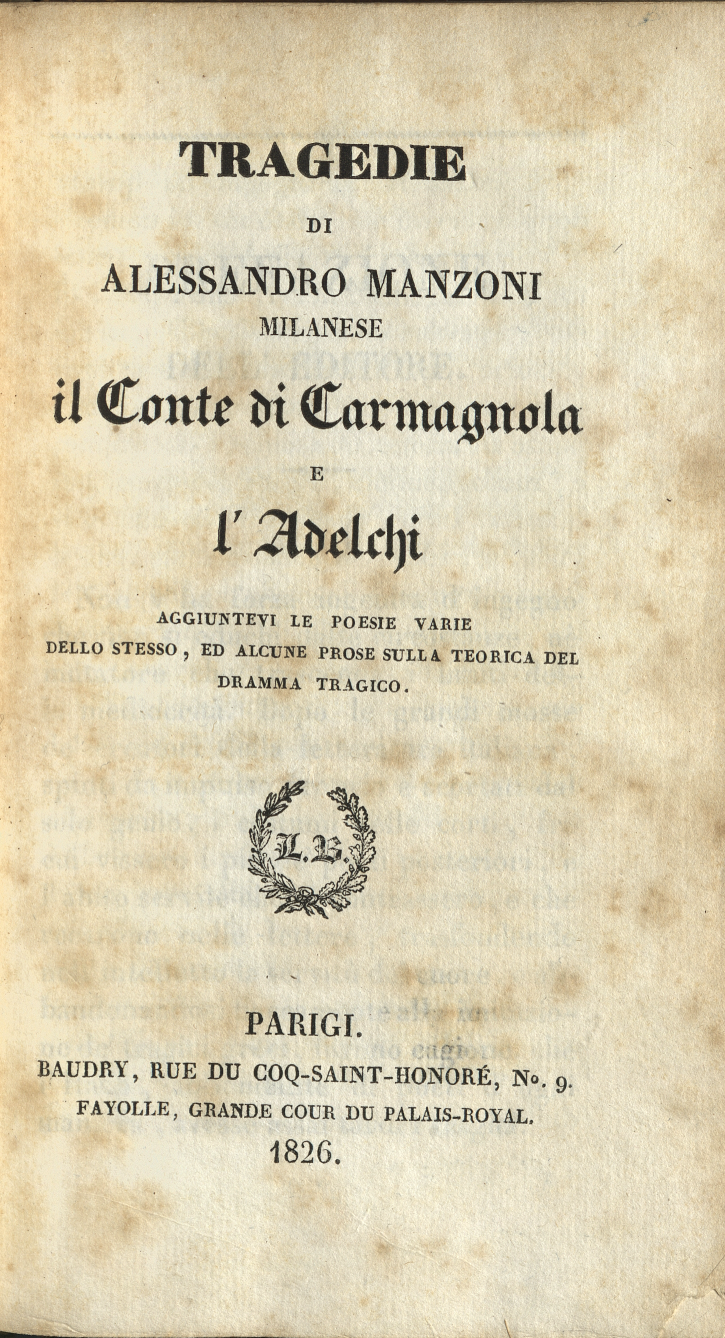
L’opera, una volta scritta, viene mandata per essere tradotta a monsieur Chauvet, facendola precedere da un interessante scritto in cui il poeta milanese sottolinea la differenza che vi è tra storia, poesia e romanzesco, individuando così il nuovo atteggiamento che egli intende perseguire per questo genere letterario:
LA STORIA NELLA TRAGEDIA
Ma, si dirà forse, se si toglie al poeta ciò che lo distingue dallo storico, cioè il diritto di inventare i fatti, che cosa gli resta? Che cosa gli resta? la poesia; sì, la poesia. Perché infine che cosa ci dà la storia? degli eventi che non sono, per così dire, conosciuti che dall’esterno; ciò che gli uomini hanno fatto; ma ciò che hanno pensato, i sentimenti che hanno accompagnato le loro decisioni e i loro progetti, i loro risultati fortunati e sfortunati, i discorsi coi quali hanno fatto o cercato di fare prevalere la loro passione e la loro volontà su altre passioni o altre volontà, per mezzo dei quali hanno espresso la loro collera, effuso la loro tristezza, in una parola hanno rivelato la loro individualità: tutto questo e qualcos’altro ancora è passato sotto silenzio dagli storici; e tutto questo è dominio della poesia.[…] Tutto ciò che la volontà umana ha di forte e misterioso, tutto ciò che la sventura ha di religioso e di profondo, il poeta può indovinarlo, o, per dir meglio, può vederlo, comprenderlo ed esprimerlo.
Se il tema dev’essere storico è evidente che il progetto di poesia tragica di Manzoni non può che essere anticlassico, proprio perché l’evento storico non può essere compreso con la presenza delle tre unità aristoteliche e la comprensione dello spettatore non più emotiva ma che si ponga come fine la reale conoscenza dell’uomo, ha bisogno anche di una sottolineatura che il Manzoni ripropone con il coro (a dispetto del lavoro tragico alfieriano), non più come nella tragedia greca, in cui assumeva la voce dell’intera collettività, ma “cantuccio”, della riflessione del poeta.
Il conte di Carmagnola mette in scena un episodio storico avvenuto verso la metà del XV secolo:

Francesco Hayez: Il Conte di Carmagnola (studio)
Goffredo di Buglione, conte di Carmagnola, capitano di ventura, dopo aver combattuto per i Visconti di Milano, passa al soldo della Repubblica di Venezia. Durante la battaglia di Maclodio fra le due potenze regionali il conte, dopo aver vinto, non infierisce sui nemici e ciò suscita il sospetto di tradimento verso il Consiglio dei Dieci della Repubblica lagunare. Viene difeso soltanto da Marco, nobile veneziano a lui amico, ma tale difesa risulterà vana e sarà condannato a morte.
ATTO II, CORO
(vv. 1-56)
S’ode a destra uno squillo di tromba;
a sinistra risponde uno squillo:
d’ambo i lati calpesto rimbomba
da cavalli e da fanti il terren.
Quinci spunta per l’aria un vessillo;
quindi un altro s’avanza spiegato:
ecco appare un drappello schierato;
ecco un altro che incontro gli vien.
Già di mezzo sparito è il terreno;
già le spade rispingon le spade;
l’un dell’altro le immerge nel seno;
ronda il sangue; raddoppia il ferir.
– Chi son essi? Alle belle contrade
qual ne venne straniero a far guerra?
Qual è quei che ha giurato la terra
dove nacque far salva, o morir?
D’una terra son tutti: un linguaggio
parlan tutti: fratelli li dice
lo straniero: il comune lignaggio
a ognun d’essi dal volto traspar.
Questa terra fu a tutti nudrice,
questa terra di sangue ora intrisa,
che natura dall’altre ha divisa,
e ricinta con l’alpe e col mar.
– Ahi! Qual d’essi il sacrilego brando
trasse il primo il fratello a ferire?
Oh terror! Del conflitto esecrando
la cagione esecranda qual è?
– Non la sanno: a dar morte, a morire
qui senz’ira ognun d’essi è venuto;
e venduto ad un duce venduto,
con lui pugna, e non chiede il perché.
– Ahi sventura! Ma spose non hanno,
non han madri gli stolti guerrieri?
Perché tutte i lor cari non vanno
dall’ignobile campo a strappar?
E i vegliardi che ai casti pensieri
della tomba già schiudon la mente,
ché non tentan la turba furente
con prudenti parole placar?
– Come assiso talvolta il villano
sulla porta del cheto abituro,
segna il nembo che scende lontano
sopra i campi che arati ei non ha;
così udresti ciascun che sicuro
vede lungi le armate coorti,
raccontar le migliaia de’ morti,
e la pieta dell’arse città.
Là, pendenti dal labbro materno
vedi i figli che imparano intenti
a distinguer con nomi di scherno
quei che andranno ad uccidere un dì;
qui le donne alle veglie lucenti
de’ monili far pompa e de’ cinti,
che alle donne diserte de’ vinti
il marito o l’amante rapì.
Si sente a destra uno squillo di tromba; ne risponde a sinistra un altro squillo: da ambo le parti rimbomba il terreno calpestato dai cavalli e dalla fanteria. Da una parte avanza un insegna, in seguito un altro si avanza, dietro lui un drappello di uomini schierato alle sue spalle, eccone un altro che gli viene incontro // Il terreno di mezzo è sparito ormai le spade si oppongono a spade, uno le immerge nel petto di un altro; il sangue gronda, aumenta il ferire. – Chi sono loro? Quale straniero giunse alle belle contrade (italiane) a portare guerra? Chi è colui che ha giurato di salvare la propria terra in cui nacque o morire? // Sono tutti di una stessa terra: tutti parlano la stessa lingua: lo straniero li definisce fratelli: la comune discendenza si legge nei loro volti. Questa terra, l’Italia, diede a tutti il suo nutrimento, questa terra ora ricoperta di sangue, che la natura stessa ha diviso dalle altre e ha racchiuso con le Alpi e con il mare. // Ahimè Chi di loro trasse la sacrilega spada a ferire il fratello? Che orrore! Qual è il motivo esecrabile di quella guerra altrettanto esecrabile? Nessuno sa più quale sua l’origine del conflitto intestino: non vi è collera né risentimento nel loro combattere; ognuno serve per denaro un capo che (a sua volta) serve qualcuno per denaro: combatte al suo fianco senza chiedere perché. // Che disgrazia! Ma questi scellerati soldati non hanno mogli e madri! Perché queste non si recano nei campi di battaglia per sottrarli a quella vergognosa guerra? E i loro vecchi che si preparano serenamente ad accogliere la morte, perché non cercano di calmare gli spiriti della folla con discorsi saggi? // Come talvolta il contadino quando, stando sulla soglia della propria modesta abitazione, nota la nube scura che scende sul terreno che ancora gli resta da arare, questi soldati, mentre scrutano in lontananza l’esercito armato, raccontano tutte le morti provocate in guerra e le città saccheggiate e bruciate. // Da una parte là vedi bimbi che, ascoltando le parole della madre, imparano ad affibbiare nomi irridenti a coloro che andranno a uccidere un giorno; dall’altra vedi le donne alle veglie far mostra dei gioielli sfarzosi e dei monili che il marito o l’amante hanno sottratto alle donne senza più protezione dei vinti.
 Francesco Bassano: La battaglia di Maclodio (affresco, 1590)
Francesco Bassano: La battaglia di Maclodio (affresco, 1590)
L’episodio si riferisce alla battaglia di Maclodio, nella lotta tra Milanesi e Veneziani i cui eserciti si fronteggiano. Il coro si presenza come un momento lirico (quasi fosse una poesia staccata dal contesto), in cui prevale l’elemento “politico” su quello riflessivo. Non è casuale che il riferimento letterario sia qui tutto petrarchesco, modulato sulla canzone All’Italia (la battaglia fra eserciti formati da soldati e comandanti italiani, le “frontiere geografiche”, le Alpi e il mare) ma quanto l’operosità che tale concetti cominceranno a registrare nella storia, al fine di raggiungere l’unità d’Italia (sogno, ricordiamo, fortemente sentito anche da Foscolo). A tal fine l’argomentazione viene scandita da un ritmo incalzante, fatto di decasillabi martellanti a richiamare il suono guerresco; la struttura paratattica, la coincidenza tra strofe poetica e sintassi, per cui ogni concetto si conclude nella strofe. Richiami che certamente riportano in mente certe soluzioni tipiche del melodramma ottocentesco, in specie verdiano.
La mancata riuscita dell’opera sta soprattutto nella eccessiva dilatazione del tempo (1425-1432) che seppur obbedisce alla rottura dell’unità di tempo, non riesce a legare in modo coeso i vari momenti della tragedia. Inoltre Il conte di Carmagnola sembra difettare proprio là dove voleva riuscire: è sì un’opera di rottura, ma maturata più letterariamente (il linguaggio resta quello della tradizione) che poeticamente.
Decisamente più riuscita l’Adelchi; quest’opera nasce dalla suggestione che un romanzo, come Ivanhoe ebbe sull’autore e sulla decisa riscoperta che il Romanticismo italiano fece del Medioevo. L’elaborazione non fu semplice: iniziata nel ’20 e più volta interrotta, la difficoltà era tutta nella ricerca di fonti. Lo sforzo di Manzoni era tutto nel voler rendere “verisimile” l’opera, per questo il reale svolgimento storico era fondamentale, ma non era facile da reperire visto il tempo enorme di differenza tra quello degli avvenimenti storici e quello in cui l’autore scrisse. Fu tale la ricerca che, quando l’opera fu edita, nel 1822, venne accompagnata dal Discorso sopra alcuni punti di storia longobardica in Italia.
Carlo, re dei Franchi, ha ripudiato Ermengarda, figlia dei Longobardi; quest’ultimi meditano vendetta e progettano di costringere papa Adriano a consacrare re di Francia i figli di Carlomanno, riparati alla sua corte con la madre Gerberga. Adelchi, figlio di Desiderio, re longobardo, suggerisce di cercare un accordo con Adriano. Ermengarda torna dal padre e gli chiede di potersi chiudere in convento per trovare conforto nella preghiera. Un messo di Carlo intima a Desiderio di restituire le terre tolte al pontefice. Il re risponde sdegnosamente e la guerra è dichiarata. Ma alcuni duchi longobardi sono pronti a tradire. Nel campo dei Franchi giunge il diacono Martino a rivelare l’esistenza di un valico che consente a Carlo di prendere di sorpresa i Longobardi attestati alle Chiuse di Susa. Adelchi si difende strenuamente con un valore accentuato dalla codardia che lo circonda. Intanto Ermengarda, straziata dall’“amor tremendo” per Carlo, muore in convento, a Brescia. Il traditore Guntigi apre ai Franchi le porte di Pavia, ultimo rifugio di Desiderio, il quale, prigioniero, chiede a Carlo di lasciare libero Adelchi. Ma Adelchi giunge dinanzi a loro morente: ha preferito battersi fino all’ultimo, fedele al suo dovere, anche se nutre più l’illusione di poter separare il giusto dall’ingiusto nella concatenazione delle azioni umane, e infine offre a Dio la sua “anima stanca”.
Il tema fondamentale che in quest’opera emerge è la distanza netta che vi è fra chi fa la storia e chi la subisce, fra i Longobardi e i Franchi da una parte e gli Italici, silenti ed oppressi:

CORO DELL’ATTO TERZO
Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti,
dai boschi, dall’arse fucine stridenti,
dai solchi bagnati di servo sudor,
un volgo disperso repente si desta;
intende l’orecchio, solleva la testa
percosso da novo crescente romor.
Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti,
qual raggio di sole da nuvoli folti,
traluce de’ padri la fiera virtù:
ne’ guardi, ne’ volti confuso ed incerto
si mesce e discorda lo spregio sofferto
col misero orgoglio d’un tempo che fu.
S’aduna voglioso, si sperde tremante,
per torti sentieri, con passo vagante,
fra tema e desire, s’avanza e ristà;
e adocchia e rimira scorata e confusa
de’ crudi signori la turba diffusa,
che fugge dai brandi, che sosta non ha.
Ansanti li vede, quai trepide fere,
irsuti per tema le fulve criniere,
le note latèbre del covo cercar;
e quivi, deposta l’usata minaccia,
le donne superbe, con pallida faccia,
i figli pensosi pensose guatar.
E sopra i fuggenti, con avido brando,
quai cani disciolti, correndo, frugando,
da ritta, da manca, guerrieri venir:
li vede, e rapito d’ignoto contento,
con l’agile speme precorre l’evento,
e sogna la fine del duro servir.
Udite! Quei forti che tengono il campo,
che ai vostri tiranni precludon lo scampo,
son giunti da lunge, per aspri sentier:
sospeser le gioie dei prandi festosi,
assursero in fretta dai blandi riposi,
chiamati repente da squillo guerrier.
Lasciar nelle sale del tetto natio
le donne accorate, tornanti all’addio,
a preghi e consigli che il pianto troncò:
han carca la fronte de’ pesti cimieri,
han poste le selle sui bruni corsieri,
volaron sul ponte che cupo sonò.
A torme, di terra passarono in terra,
cantando giulive canzoni di guerra,
ma i dolci castelli pensando nel cor:
per valli petrose, per balzi dirotti,
vegliaron nell’arme le gelide notti,
membrando i fidati colloqui d’amor.
Gli oscuri perigli di stanze incresciose,
per greppi senz’orma le corse affannose,
il rigido impero, le fami durâr;
si vider le lance calate sui petti;
a canto agli scudi, rasente agli elmetti,
udiron le frecce fischiando volar.
E il premio sperato, promesso a quei forti,
sarebbe, o delusi, rivolger le sorti,
d’un volgo straniero por fine al dolor?
Tornate alle vostre superbe ruine,
all’opere imbelli dell’arse officine,
ai solchi bagnati di servo sudor.
Il forte si mesce col vinto nemico,
col novo signore rimane l’antico;
l’un popolo e l’altro sul collo vi sta.
Dividono i servi, dividon gli armenti;
si posano insieme sui campi cruenti
d’un volgo disperso che nome non ha.
Dagli atri degli antichi palazzi, ricoperti di muschio, dalle piazze e dai monumenti antichi in rovina, dai boschi, dalle officine riarse dal fuoco, dai campi bagnati dal sudore i Latini dispersi improvvisamente si destano, tendono l’orecchio e sollevano la testa, colpiti da un suono inaudito e crescente. Dagli sguardi dubbiosi e dai volti impauriti come un raggio di sole sommerso dalle folti nubi traluce il fiero valore dei guerrieri antichi: negli sguardi, nei volti si mescola e contrasta l’umiliazione sofferta con il misero orgoglio del tempo lontano. I Latini si radunano mossi dalla speranza del nuovo, ma subito si disperde timoroso per i sentieri tortuosi con un passo incerto, combattuto fra paura e desiderio, avanza e si ferma, guardano continuare la turba disfatta dei padroni, che fugge senza sosta dalle spade nemiche. Li vede ansanti come fiere trepidanti con il pelo rossiccio irto dalla paura, cercano i noti nascondigli dei loro covi, e qui, deposto l’atteggiamento minaccioso, le donne prima superbe con la faccia pallida addosso guardano preoccupate i loro figli. E sopra i longobardi in fuga, con le spade avide di sangue colpire, come cani disciolti, inseguono, giungere i guerrieri da destra e da sinistra, correndo e cercando; (i Latini) li vedono; presi di una gioia mai provata prima con la speranza che, veloce, percorre gli eventi e sogna la fine della dura schiavitù. Udite! I Franchi vittoriosi, che sono rimasti padroni del campo di battaglia, che impediscono da ogni parte la fuga, sono giunti da lontano per difficili sentieri: sospesero le gioie dei festosi conviti, si levarono in fretta dei dolci riposi, chiamati dagli squilli delle trombe. Lasciarono nelle sale donne addolorate che rinnovano continuamente gli adii, le preghiere e le raccomandazioni finché il pianto troncò ogni parola, hanno messo sulla fronte gli elmi ammaccati, posto sulla sella sui bruni cavalli (attraversano il ponte che risuonò cupo. Passarono di terra in terra, a schiera, cantando festose canzoni di guerra, pensando nel cuore ai loro dolci castelli; per valli petrose e suoli scoscesi vegliarono armati durante le gelide notti, ricordando gli intimi colloqui d’amore. Gli ignoti pericoli di soggiorni pericolosi, le corse affannose per dirupi senza traccia umana, il comando imperioso, la fame sopportarono; videro le lance scagliate contro i loro petti, accanto ai loro scudi udirono le frecce volare fischiando vicinissime ai loro elmi. E il premio sperato e promesso a quei forti, dovrebbe, o Latini delusi, mutare la vostra sorte, porre fine al dolore d’un volgo ad essi straniero? Tornate alle vostre superbe rovine, alle opere degne della schiavitù delle officine riarse e ai campi bagnati dal sudore di un popolo servo. Il vincitore si mescola con il (signore) vinto, col nuovo signore rimane l’antico, l’uno e l’altro popolo vi opprime. Dividono fra loro i servi, il bestiame, si posano insieme sui campi insanguinati dalla guerra, di un volgo disperso che non ha nessun nome.
Il coro ha l’andamento di una ballata romantica, in dodecasillabi (o doppi senari) rimati fra loro (AABCCB). Il tema è fortemente contemporaneo, basta voler riconoscere nei Longobardi gli attuali austriaci e nei Francesi l’esercito napoleonico. Il testo, allora, sembra alludere alle speranze precedenti il trattato di Compoformio e la delusione dopo la cessione di Venezia. Interessante è la struttura circolare, come voler racchiudere la storia d’Italia entro i confini di una storica schiavitù dalla quale non riesce a liberarsi e il termine volgo a dirci che il termine “popolo” si può usare solo quando ci è consapevolezza della propria forza e valore, cosa che sembra mancare, appunto, alle genti d’Italia. Non si può dimenticare come in Manzoni già da adesso, in passi così fortemente patriottici, non venga meno lo sguardo del cattolico e di chi vede la storia come storia di “persone”: guerrieri che lasciano i letti d’amore e donne imploranti che piangono i figli che vanno in guerra. Vi è, come sempre in Manzoni, come vedremo anche nell’Ode Marzo 1821, un certo compiacimento che si traduce in una poesia più letteraria che sentita (ripetizioni di parole e di concetti), che tuttavia riesce a conservare, per i lettori dell’epoca un forte impatto emotivo.

Giuseppe Bezzuoli: La morte di Ermengarda
Più famoso e il coro dell’atto IV:
CORO DELL’ATTO QUARTO
Sparsa le trecce morbide
sull’affannoso petto,
lenta le palme, e rorida
di morte il bianco aspetto,
giace la pia, col tremolo
sguardo cercando il ciel.
Cessa il compianto: unanime
s’innalza una preghiera:
calata in su la gelida
fronte, una man leggiera
sulla pupilla cerula
stende l’estremo vel.
Sgombra, o gentil, dall’ansia
mente i terrestri ardori;
leva all’Eterno un candido
pensier d’offerta, e muori:
fuor della vita è il termine
del lungo tuo martir.
Tal della mesta, immobile
era quaggiuso il fato:
sempre un obblio di chiedere
che le saria negato;
e al Dio de’ santi ascendere
santa del suo patir.
Ahi! nelle insonni tenebre,
pei claustri solitari,
tra il canto delle vergini,
ai supplicati altari,
sempre al pensier tornavano
gl’irrevocati dì;
Quando ancor cara, improvida
d’un avvenir mal fido,
ebbra spirò le vivide
aure del Franco lido,
e tra le nuore Saliche
invidiata uscì:
quando da un poggio aereo,
il biondo crin gemmata,
vedea nel pian discorrere
la caccia affaccendata,
e sulle sciolte redini
chino il chiomato sir;
E dietro a lui la furia
de’ corridor fumanti;
e lo sbandarsi, e il rapido
redir de’ veltri ansanti;
e dai tentati triboli
l’irto cinghiale uscir;
e la battuta polvere
riga di sangue, colto
dal regio stral: la tenera
alle donzelle il volto
volgea repente, pallida
d’amabile terror.
Oh Mosa errante! oh tepidi
lavacri d’Aquisgrano!
Ove, deposta l’orrida
maglia, il guerrier sovrano
scendea del campo a tergere
il nobile sudor!
Come rugiada al cespite
dell’erba inaridita,
fresca negli arsi calami
fa rifluir la vita,
che verdi ancor risorgono
nel temperato albor;
tale al pensier, cui l’empia
virtù d’amor fatica,
discende il refrigerio
d’una parola amica,
e il cor diverte ai placidi
gaudii d’un altro amor.
Ma come il sol che, reduce,
l’erta infocata ascende,
e con la vampa assidua
l’immobil aura incende,
risorti appena i gracili
steli riarde al suol;
ratto così dal tenue
obblio torna immortale
l’amor sopito, e l’anima
impaurita assale,
e le sviate immagini
richiama al noto duol.
Sgombra, o gentil, dall’ansia
mente i terrestri ardori;
leva all’Eterno un candido
pensier d’offerta, e muori:
nel suol che dee la tenera
tua spoglia ricoprir,
Altre infelici dormono,
che il duol consunse; orbate
spose dal brando, e vergini
indarno fidanzate;
madri che i nati videro
trafitti impallidir.
Te, dalla rea progenie
degli oppressor discesa,
cui fu prodezza il numero,
cui fu ragion l’offesa,
e dritto il sangue, e gloria
il non aver pietà,
te collocò la provida
sventura in fra gli oppressi:
muori compianta e placida;
scendi a dormir con essi:
alle incolpate ceneri
nessuno insulterà.
Muori; e la faccia esanime
si ricomponga in pace;
com’era allor che improvida
d’un avvenir fallace,
Lievi pensier virginei
solo pingea. Così
dalle squarciate nuvole
si svolge il sol cadente,
e, dietro il monte, imporpora
il trepido occidente;
al pio colono augurio
di più sereno dì.
Con le trecce sciolte sul petto ansimante, con le mani abbandonate, con il volto madido del sudore di morte e pallido, giace la donna fedele, che rivolge gli occhi tremanti al cielo. Finisce il compianto: viene innalzata una preghiera con cuore concorde: una mano delicata, calata sulla fronte fredda stende il velo della morte sugli occhi azzurri (di Ermengarda). O donna gentile, sgombra la mente affannata dalle passioni terrestri; eleva a Dio un puro pensiero di offerta, e muori: il senso della tua agonia è al di fuori di questa vita. Allo stesso modo, di questa donna triste, il destino immutabile era segnato in terra: di chiedere l’oblio, che le è sempre stato negato; e di salire al Dio dei santi, santa del suo dolore. Ahi! Nelle notti insonni, per i chiostri solitari, tra il canto delle suore, agli altari dove pregava, sempre i ricordi tornavano involontari alla mente; quando ancora amata (da Carlo), inconsapevole di un destino che non avrebbe mantenuto le promesse, respirò esaltata l’aria francese, e tra le spose alla corte franca era quella invidiata da tutte: quando da un colle elevato, incoronato il suo capo di capelli biondi da gemme, vedeva la caccia movimentata avvenuta nella piana, e vedeva il re con il suo ciuffo al vento chinato sulle redini sciolte; e dietro di lui la foga dei cavalli che sbuffavano; e l’inseguimento e il veloce ritorno dei cani ansimanti; e l’uscire dell’irto cinghiale dai cespugli frugati e battuti; e (vedeva) il sangue bagnare la polvere calpestata, colpito dalla freccia del re: e la donna gentile volgeva continuamente lo sguardo alle ancelle, pallida per una paura amabile. Oh Mosa dal corso sinuoso! Oh caldi bagni di Acquisgrano! Dove, deposta l’appuntita maglia di ferro, il re guerriero andava a tergere il nobile sudore del campo di battaglia! Come la rugiada su un ciuffo d’erba inaridita, fresca per gli steli riarsi, fa rifluire la vita, facendoli risollevare verdi nell’albore tiepido; così discende il ristoro di una parola amica al pensiero che la potenza dell’amore affatica, profanamente spietata, e rivolge il cuore alle tranquille gioie di un altro tipo di amore. ma come il sole che, al suo ritorno, risale l’orbita infuocata, e con una fiamma costante incendia l’aria immobile torna a inaridire i gracili steli appena risollevati, piegandoli al suolo; così l’amore prima assopito dal leggero oblio ritorna immortale, e assale l’anima impaurita, e richiama al ben conosciuto dolore le immagini che erano state scansate. O donna gentile, sgombra la mente affannata dalle passioni terrestri; eleva a Dio un puro pensiero di offerta, e muori: nello stesso suolo in cui il tuo corpo deve essere ricoperto dalla morbida terra, altre infelici sono morte consumate dal dolore; spose vedove a causa della spada, e vergini fidanzate invano; madri che hanno visto impallidire i loro figli trafitti. Tu, discesa dall’empia stirpe degli oppressori per i quali il numero di morti fu motivo di vanto, per cui l’offesa recata agli altri popoli fu norma di ragione e il sangue fu diritto, e il non avere pietà motivo di gloria, tu, che la provvida sventura collocò tra gli oppressi: muori compianta e lieta; discendi a dormire in eterno con loro: nessuno maledirà le ceneri di chi non ha colpe. Muori; e il volto senza più l’anima dentro nella pace ritorni com’era prima quando, inconsapevole di un destino illusorio, si figurava solo pensieri lievi e puri. Così il sole calante si libera delle nuvole squarciate, e, dietro al monte, colora l’occidente tremante: al pio augurio straniero di un giorno più sereno.
Il coro è in settenari e presenta il tema che verrà ripreso poi nell’ode dedicata a Napoleone. Infatti quello che qui emerge è la quasi necessità della “caduta” per sollevarsi a Dio. Controlliamo il lemma improvida così come si presenta per la prima volta nella sesta stanza: inconsapevole del destino che dal potere la porta al ripudio; improvida così come invece nella 19° stanza, dopo la morte, che la porta nell’aura della purezza e della semplicità. Il centro ideologico del coro è infatti la provida sventura che permea il suo cattolicesimo. Vediamo infatti com’è costruito il passo: nelle prime tre stanze ci viene presentata Ermengarda agonizzante, nell’attesa d’esser chiamata da Dio; quindi nella quarta e quinta è presentato il suo destino di donna incapace di dimenticare; segue il momento dove pudicizia e amore per Carlo convivono insieme; ma dopo il ripudio l’amore per il re si deve trasformare in quello per il Cristo: ma solo attraverso il dolore esso giunge pienamente e consapevolmente e risorge come un fiore baciato dal sole.
Odi
Le opere politiche manzoniane sono 4: Aprile 1814, Il Proclama di Rimini, Marzo 1821 e il 5 Maggio. La differenza fra la loro composizione e quella degli altri scritti manzoniani è nell’immediatezza: infatti esse nascono sempre da un avvenimento preciso. La prima canzone nasce dopo l’esilio napoleonico ad Elba e la speranza di una rinnovata libertà; il frammento de Il Proclama di Rimini è la risposta positiva a Gioacchino Murat, che esorta alla lotta per l’indipendenza.
Ma le uniche riconosciute come letterariamente maggiori sono due:

Il poeta Teodoro Koerner, morto per la libertà, a cui Manzoni dedica l’ode
Marzo 1821: il contesto per cui nasce l’ode è quello delle insurrezioni per il rilascio della Costituzione nel Regno di Sardegna e nel lombardo veneto. E’ in questo clima che nasce l’ode manzoniana: dedicata al poeta tedesco Teodoro Koerner, morto per la libertà germanica, essa mostra l’imprescindibilità di un’unione politica per il raggiungimento dell’indipendenza, ma soprattutto sottolinea in modo definitivo il concetto di patria:
MARZO 1821
ALLA ILLUSTRE MEMORIA
DI
TEODORO KOERNER
POETA E SOLDATO
DELLA INDIPENDENZA GERMANICA
MORTO SUL CAMPO DI LIPSIA
IL GIORNO XVIII D’OTTOBRE MDCCCXIII
NOME CARO A TUTTI I POPOLI
CHE COMBATTONO PER DIFENDERE
O PER RICONQUISTARE
UNA PATRIA
Soffermàti sull’arida sponda,
vòlti i guardi al varcato Ticino,
tutti assorti nel nuovo destino,
certi in cor dell’antica virtù,
han giurato: Non fia che quest’onda
scorra più tra due rive straniere;
non fia loco ove sorgan barriere
tra l’Italia e l’Italia, mai più!
L’han giurato: altri forti a quel giuro
rispondean da fraterne contrade,
affilando nell’ombra le spade
che or levate scintillano al sol.
Già le destre hanno strette le destre;
già le sacre parole son porte:
o compagni sul letto di morte,
o fratelli su libero suol.
Chi potrà della gemina Dora,
della Bormida al Tanaro sposa,
del Ticino e dell’Orba selvosa
scerner l’onde confuse nel Po;
chi stornargli del rapido Mella
e dell’Oglio le miste correnti,
chi ritogliergli i mille torrenti
che la foce dell’Adda versò,
quello ancora una gente risorta
potrà scindere in volghi spregiati,
e a ritroso degli anni e dei fati,
risospingerla ai prischi dolor:
una gente che libera tutta,
o fia serva tra l’Alpe ed il mare;
una d’arme, di lingua, d’altare,
di memorie, di sangue e di cor.
Con quel volto sfidato e dimesso,
con quel guardo atterrato ed incerto,
con che stassi un mendico sofferto
per mercede nel suolo stranier,
star doveva in sua terra il Lombardo;
l’altrui voglia era legge per lui;
il suo fato, un segreto d’altrui;
la sua parte servire e tacer.
O stranieri, nel proprio retaggio
torna Italia, e il suo suolo riprende;
o stranieri, strappate le tende
da una terra che madre non v’è.
Non vedete che tutta si scote,
dal Cenisio alla balza di Scilla?
Non sentite che infida vacilla
sotto il peso de’ barbari piè?
O stranieri! sui vostri stendardi
sta l’obbrobrio d’un giuro tradito;
un giudizio da voi proferito
v’accompagna all’iniqua tenzon;
voi che a stormo gridaste in quei giorni:
Dio rigetta la forza straniera;
ogni gente sia libera, e pèra
della spada l’iniqua ragion.
Se la terra ove oppressi gemeste
preme i corpi de’ vostri oppressori,
se la faccia d’estranei signori
tanto amara vi parve in quei dì;
chi v’ha detto che sterile, eterno
saria il lutto dell’itale genti?
Chi v’ha detto che ai nostri lamenti
saria sordo quel Dio che v’udì?
Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia
chiuse il rio che inseguiva Israele,
quel che in pugno alla maschia Giaele
pose il maglio, ed il colpo guidò;
quel che è Padre di tutte le genti,
che non disse al Germano giammai:
va, raccogli ove arato non hai;
spiega l’ugne; l’Italia ti do.
Cara Italia! dovunque il dolente
grido uscì del tuo lungo servaggio;
dove ancor dell’umano lignaggio,
ogni speme deserta non è:
dove già libertade è fiorita,
dove ancor nel segreto matura,
dove ha lacrime un’alta sventura
non c’è cor che non batta per te.
Quante volte sull’Alpe spïasti
l’apparir d’un amico stendardo!
Quante volte intendesti lo sguardo
ne’ deserti del duplice mar!
Ecco alfin dal tuo seno sboccati,
stretti intorno a’ tuoi santi colori,
forti, armati de’ propri dolori,
i tuoi figli son sorti a pugnar.
Oggi, o forti, sui volti baleni
il furor delle menti segrete:
per l’Italia si pugna, vincete!
Il suo fato sui brandi vi sta.
O risorta per voi la vedremo
al convito de’ popoli assisa,
o più serva, più vil, più derisa,
sotto l’orrida verga starà.
Oh giornate del nostro riscatto!
Oh dolente per sempre colui
che da lunge, dal labbro d’altrui,
come un uomo straniero, le udrà!
Che a’ suoi figli narrandole un giorno
dovrà dir sospirando: io non c’era;
che la santa vittrice bandiera
salutata quel dì non avrà.
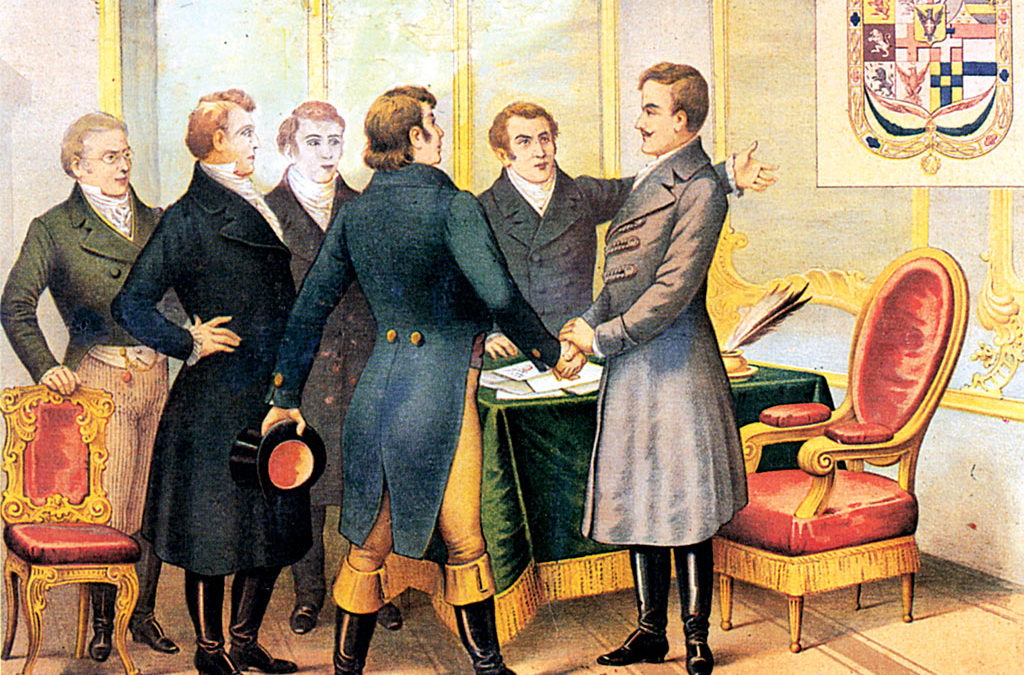 Carlo Alberto incontra i congiurati del ’21
Carlo Alberto incontra i congiurati del ’21
Fermati sulla sponda asciutta, rivolti gli sguardi al Ticino appena passato, tutti presi dal nuovo destino, sicuri nell’animo dell’antico coraggio, hanno giurato: non accada che questo fiume scorra più tra rive straniere; non ci sia luogo dove vengano erette barriere tra tra territori italiani, mai più! // Lo hanno giurato: altri valorosi hanno risposto al giuramento dalle altre regioni italiane. Preparando la congiura in silenzio, si sono poi sollevati alla luce del sole; quindi si sono scambiate le parole di libertà. Oh compagni morti per la libertà, oh fratelli distesi sul suolo reso libero (dalla vostra ribellione) // Chi potrà distinguere dalle acque mescolate nel Po, della doppia Dora (Baltea e Riparia), dalla Bormida, affluente del Tanaro, del Ticino, dell’Orba che scorre fra i boschi. Chi potrà deviare le correnti del rapido Mella e dell’Oglio (impedendo loro di confluirvi), chi potrà riprendere al Po i mille torrenti riversati dalla foce dell’Adda (che nella parte superiore raccoglie le acque di numerosi torrenti della Valtellina) // quello potrà dividere in vogo spregiato un popolo che ha riacquistato un’identità nazionale, e risospingerla indietro negli antichi dolori, un popolazione che sia o tutta libera o tutta sciava dalle Alpi al mare; unita nell’esercito, nella lingua, nella religione, nella tradizione, nell’etnia, nei sentimenti. // Con quel volto sfiduciato e dimesso, con quello sguardo rivolto in terra ed insicuro, con cui sta un mendicante sofferente per elemosina sulla terra straniera, doveva stare sulla propria terra il Lombardo, la volontà dell’Austriaco era legge per lui; il suo destino, nelle mani di un altro, il suo compito, servire ed obbedire. // O stranieri, l’Italia si riprende la propria eredità ed il suo territorio; o stranieri, andate via da una terra che non è vostra. Non vedete che vi è un generale ribollimento, dal Piemonte alla Calabria. Non percepite che si fa insidiosa sotto il peso della presenza straniera? // O stranieri! Sulle vostre bandiere vi è la vergogna di un giuramento tradito; una deliberazione da voi proferita (L’indipendenza italiana in cambio di una ribellione a Napoleone) vi accompagna ad una ingiusta guerra; voi che tutti insieme avete gridato che Dio rifiuta l’oppressione straniera, che ogni popolazione sia libera e muoia l’ingiusta ragione basata sulla forza. // Se la terra dove oppressi gemeste ricopre i corpi dei vostri oppressori, se la faccia di dominatori stranieri (Francesi) tanto amara vi è parsa in quei giorni, chi vi ha detto che senza frutto, eterno, sarà il lutto della popolazione italiana? chi vi ha detto che Dio rimarrebbe sordo a nostri lamenti? // Sì, quel Dio che richiuse il Mar Rosso agli Egiziani (per permettere agli Ebrei il ritorno alla terra promessa), che nella mano della virile Gioele pose il martello con cui conficcò un chiodo nella testa del generale canaaneo; colui che è padre di tutti, che non ha mai detto ai Tedeschi: va’ e raccogli dove non hai arato, allarga gli artigli, l’Italia ti do. // Cara Italia! dappertutto un grido pieno di dolore è uscito dalla tua lunga servitù, dove non è ancora perduta del tutto la speranza del genere umano, dove già si è conquistata la libertà, dove segretamente si trama per raggiungerla, dove si soffre ancora profondamente per la sua mancanza, dappertutto batte un cuore per te. // Quante volte sulle Alpi hai spiato l’apparire di uno stendardo amico, quante volte hai gettato lo sguardo nelle vaste distese spopolate dei tuo mari. Ecco alfine, nati dal tuo seno, stretti intorno al Tricolore, forti, armati dai propri dolori, i tuoi figli sono nati per combattere. // Oggi, o forti, sui vostri volti rifulga la rabbia di menti a lungo nascoste: si combatte per l’Italia: vincete! Il suo destino sta nelle vostre spade. La vedremo grazie a voi risorta stare seduta in mezzo alle altre nazioni, o dovrà stare sotto l’orrido scettro della dominazione straniera più serva, più vile, più derisa. // O giorni della nostro riscatto! Infelice chi udrà il racconto di queste giornate da lontano, dai racconti altrui, come se fosse uno straniero in patria. Dovrà dire, con un sospiro, raccontandoli ai suoi figli, io non c’ero; che quel giorno non avrà salutato la santa vincitrice bandiera.
L’Ode manzoniana si può definire parenetica (atto ad esortare), prendendo spunto dalla lotta di Santorre di Santarosa che, ottenuta la Costituzione da Carlo Alberto (poi ritirata per volontà del padre Vittorio Emanuele), apre i moti del 21 in nord Italia. Essa può essere divisa in tre momenti:
- (ottave 1-5): si descrive il passaggio dei Piemontesi in Lombardia e quindi, cambiando prospettiva, come questi si preparino alla lotta ed uniti combattino per la libertà. Utilizza infatti l’adynaton (affermare una situazione impossibile) per sottolineare l’irreversibilità del processo nazionale, di cui offre l’importante definizione (una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor). Quindi rievoca, nel volto di un lombardo la lunga servitù al popolo straniero;
- (ottave 6-9): allocuzione rivolta ai “tedeschi” (austriaci); è assurdo, lo dice la dedica a Teodoro Korner, combattere e morire per la libertà della propria patria e poi sottometterne un’altra negandone l’indipendenza; il Manzoni parla proprio di tradimento, del tradimento dell’accordo politico sancito tra Austria, Inghilterra e le popolazioni italiane. Ma tale tradimento viene letto anche in funzione religiosa: Dio non è sordo ai lamenti di chi è privato della patria, operando Lui come garante di giustizia e libertà.
- (ottave 10-13): allocuzione rivolta all’Italia che deve ora combattere e ribellarsi, additando le popolazioni solidali con lei; è inutile aspettarsi la libertà da popoli stranieri, è dal suo seno che deve prorompere la forza, armando i propri figli per l’indipendenza dell’intera Italia.

Anonimo: Incisione, Napoleone sul letto di morte
Scritta in soli due giorni, dopo aver ricevuto la notizia della morte di Napoleone:
5 MAGGIO
Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percossa, attonita
la terra al nunzio sta,
muta pensando all’ultima
ora dell’uom fatale;
nè sa quando una simile
orma di piè mortale
la sua cruenta polvere
a calpestar verrà.
Lui folgorante in solio
vide il mio genio e tacque;
quando, con vece assidua,
cadde, risorse e giacque,
di mille voci al sonito
mista la sua non ha:
vergin di servo encomio
e di codardo oltraggio,
sorge or commosso al subito
sparir di tanto raggio:
e scioglie all’urna un cantico
che forse non morrà.
Dall’Alpi alle Piramidi,
dal Manzanarre al Reno,
di quel securo il fulmine
tenea dietro al baleno;
scoppiò da Scilla al Tanai,
dall’uno all’altro mar.
Fu vera gloria? Ai posteri
l’ardua sentenza: nui
chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui
del creator suo spirito
più vasta orma stampar.
La procellosa e trepida
gioia d’un gran disegno,
l’ansia d’un cor che indocile
serve, pensando al regno;
e il giunge, e tiene un premio
ch’era follia sperar;
tutto ei provò: la gloria
maggior dopo il periglio,
la fuga e la vittoria,
la reggia e il tristo esiglio:
due volte nella polvere,
due volte sull’altar.
Ei si nomò: due secoli,
l’un contro l’altro armato,
sommessi a lui si volsero,
come aspettando il fato;
ei fe’ silenzio, ed arbitro
s’assise in mezzo a lor.
E sparve, e i dì nell’ozio
chiuse in sì breve sponda,
segno d’immensa invidia
e di pietà profonda,
d’inestinguibil odio
e d’indomato amor.
Come sul capo al naufrago
l’onda s’avvolve e pesa,
l’onda su cui del misero,
alta pur dianzi e tesa,
scorrea la vista a scernere
prode remote invan;
tal su quell’alma il cumulo
delle memorie scese!
Oh quante volte ai posteri
narrar se stesso imprese,
e sull’eterne pagine
cadde la stanca man!
Oh quante volte, al tacito
morir d’un giorno inerte,
chinati i rai fulminei,
le braccia al sen conserte,
stette, e dei dì che furono
l’assalse il sovvenir!
E ripensò le mobili
tende, e i percossi valli,
e il lampo de’ manipoli,
e l’onda dei cavalli,
e il concitato imperio,
e il celere ubbidir.
Ahi! forse a tanto strazio
cadde lo spirto anelo,
e disperò: ma valida
venne una man dal cielo,
e in più spirabil aere
pietosa il trasportò;
e l’avviò, pei floridi
sentier della speranza,
ai campi eterni, al premio
che i desidéri avanza,
dov’è silenzio e tenebre
la gloria che passò.
Bella Immortal! Benefica
fede ai trionfi avvezza!
scrivi ancor questo, allegrati;
chè più superba altezza
al disonor del Golgota
giammai non si chinò.
Tu dalle stanche ceneri
sperdi ogni ria parola:
il Dio che atterra e suscita,
che affanna e che consola,
sulla deserta coltrice
accanto a lui posò.

Egli è stato. Come sta immobile, esalato l’ultimo respiro, il corpo senza memoria, privato di un’anima tanto grande, così sta (ora) la terra a quella notizia: colpita attonita, pensando alla morte di quell’uomo mandato dal destino; né sa quando un’orma di un piede di uomo verrà (nuovamente) a calpestare la sua polvere insanguinata. Il mio ingegno lo (Napoleone) vide nel momento del suo massimo splendore, sul trono imperiale, ma tacque. Allo stesso modo si astenne dal mescolare la sua voce al frastuono di mille altri voci, quando in un continuo avvicendamento, cadde, si risollevò, ricadde definitivamente; non contaminato da elogi servili o da vili oltraggi, si leva ora con commozione, all’improvvisa scomparsa di tanto splendore, e innalza alla sua tomba un canto che forse rimarrà immortale. Dalle Alpi all’Egitto, dalla Spagna alla Germania, l’azione veloce di quell’uomo risoluto seguiva subito la sua decisione, altrettanto rapida. Rapidità che si manifestò dalla Calabria alla Russia, dal Mediterraneo all’Atlantico. Fu vera gloria? Ai posteri la difficile decisione: noi chiniamo la fronte a Dio, che ha voluto imprimere in lui la sua più vasta capacità creatrice. La gioia tempestosa e trepidante di chi concepisce un grande progetto e l’ansia di un cuore indomito, che si piega ad obbedire agli altri solo per attuare la sua ambizione, finché non la realizza e ottiene un premio che all’inizio sembrava folle sperare. Egli sperimentò ogni cosa: la gloria, tanto più grande quanto più grande è il pericolo corso; la fuga e l’esaltazione della vittoria, la regalità e la tristezza dell’esilio: due volte sconfitto, due volte sul trono. Egli si nominò (apparve sulla scena della storia): due secoli in lotta tra loro guardarono a lui, sottomessi alla sua volontà, come aspettandosi il compiersi di un destino; egli impose il silenzio e si pose arbitro tra loro. Eppure scomparve; e racchiuse i giorni in una isola sperduta, (ancora) oggetto di un incredibile invidia e profonda pietà, inestinguibile odio e indomato amor. Come l’onda si abbatte e si richiude sul naufrago sommergendolo, la stessa onda su cui, poco prima, lo sguardo del misero si è allungato invano alla ricerca di terra così sull’anima di Napoleone piomba il cumulo delle memorie. Quante volte tentò di narrare le sua storia ai lettori futuri, tante volte rinunciò, lasciando cadere la stanca mano sulle innumerevoli pagine. Oh, quante volte, al tramonto di un giorno inattivo, abbassati gli occhi una volta fulminei, con le braccia conserte nel petto, ristette, e l’avvolse il ricordo dei giorni passati! E ricordò i mobili accampamenti, le trincee assalite, il galoppo dei cavalieri, lo slancio dei cavalli, il comando concitato ed il rapido ubbidire. Ah, forse a tanto dolore il suo animo non resse e disperò, ma provvidenzialmente venne una mano dal Cielo e pietosa lo trasportò in un’aria più pura (scevra dai tristi ricordi) e lo avviò attraverso i sentieri della speranza, verso la vita eterna del Paradiso, in cui ciascun uomo può trovare un premio che supera ogni umano desiderio e dove la gloria terrena non ha più alcun senso. Oh bella, immortale fede, abituata ai trionfi! Scrivi anche questo, rallegrati: dal momento che mai uomo più superbo si è chinato di fronte alla Croce di Cristo. Tu, fede, da queste ceneri stanche, allontana ogni malvagia parola: il Dio che abbatte i potenti e consola gli umili, che punisce e consola si è posato accanto a lui.
L’ode può, ideologicamente, richiamarsi al coro dell’atto IV dell’Adelchi, in quanto lo stessa moglie di Carlo, poi ripudiata, è dapprima sollevata fra le regine, poi ridimensionata tra le suore in cui si era rifugiata. Ma qui il concetto si ampia in una maggiore complessità storico/teologica; vediamone la struttura, suddividendola in quattro parti:
- (vv.1-24): il poeta non descrive l’imperatore, ma il modo in cui il mondo recepisce la notizia della sua morte ed il modo in cui lui, finora scevro da ogni apoteosi o denigrazione, sente giunto il momento di “parlare” di lui;
- (vv. 25-60): vengono rievocate le grandi imprese militari di Napoleone, le conquiste, il coraggio, la determinazione. Ma Manzoni, sospende il giudizio: egli è strumento provvidenziale nelle mani di Dio per il suo disegno;
- (vv. 61-90): l’esilio di Napoleone, l’impotenza e il riavvicinamento alla fede;
- (vv. 91-108): riflessione morale teologica in cui si celebra il potere della fede, della misericordia e dell’imperscrutabilità del volere di Dio.
L’intervento di Napoleone nella storia (vv. 49-54) porta la meditazione manzoniana sulla presenza di Dio nella storia. La vita dell’imperatore manifesta un disegno divino di cui bisogna accettare l’imperscrutabilità, ma non metterne in dubbio la finalità; essa si attua attraverso la provvidenza, che tende verso il trionfo di Cristo nella storia stessa (si veda l’esaltazione alla fede).
Napoleone si configura un po’ come l’Anticristo che ha avuto l’ardire di sostituirsi a lui; novello Adamo che dà il nome alle cose (termine scritturale Ei si nomò) paga l’ambizione e l’orgoglio che non ha saputo piegarsi all’unica potenza che è Dio. Per questo Napoleone non viene mai “nominato”: chi ha voluto prendersi il nome di Dio, non ha diritto ad un nome.
Il romanzo
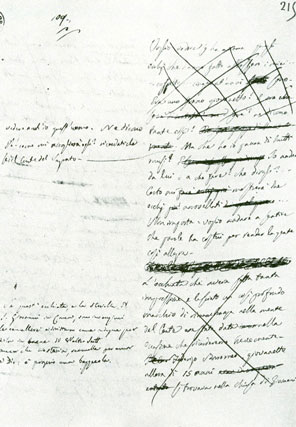
“Fermo e Lucia”, tomo II, cap. X, f. 109, con postilla di Ermes Visconti
Non si può parlare di un romanzo manzoniano: tanta è la differenza tra la prima redazione elaborata tra il ’21/’23 e quella del ’27 (un ulteriore edizione del ’40 avrà solo una puntigliosa elaborazione linguistica) che i critici individuano quasi la composizione di due diverse opere una dal titolo Fermo e Lucia e l’altra I promessi sposi. La vicenda è nota:
La vicenda si svolge in Lombardia tra il 1628 e il 1630, al tempo della dominazione spagnola. Don Abbondio, curato di un paesino posto sulle rive del lago di Como, sta facendo la sua passeggiatina serale quando viene avvicinato da due “bravi” di Don Rodrigo, il signorotto del luogo, che gli intimano di non celebrare il matrimonio di Renzo Tramaglino con Lucia Mondella. Don Abbondio, che solo un’infinita prudenza ha tenuto finora lontano dagli innumerevoli pericoli di un secolo di privilegi e di prepotenze, si affretta, il giorno dopo, a mandar via Renzo, venuto a prendere gli ultimi accordi. Renzo, dopo aver interrogato la serva di Don Abbondio, Perpetua, riesce finalmente a sapere che Don Rodrigo ha proibito le nozze perché incapricciato di Lucia. Il giovane pensa bene di rivolgersi all’avvocato Azzeccagarbugli, che al nome del signorotto si tira precipitosamente indietro. Si tenta il matrimonio a sorpresa, ma Don Abbondio frustra il tentativo. Intanto i bravi, guidati dal Griso, sono andati a rapire la ragazza: non c’è più da indugiare, i poveri “promessi” devono lasciare il paese. Con l’aiuto di un buon frate, Cristoforo, Lucia e la madre Agnese si rifugiano in un monastero di Monza; Renzo si reca a Milano con una lettera per un confratello di Cristoforo. Al monastero di Monza si occupa delle due donne Gertrude, che, fatta monaca a forza, è legata da turpi vincoli a un nobilotto, Egidio; costui, con l’aiuto dell’Innominato – altro signore prepotente e rotto a tutti i delitti – fa rapire Lucia per Don Rodrigo. Ma già da tempo rimorsi e pentimenti agitano l’animo dell’Innominato: la vista di Lucia, così ingiustamente tormentata, e l’arrivo del buon cardinale Borromeo provocano la crisi. Invece di consegnare Lucia a Don Rodrigo, l’Innominato la libera. Insieme con la madre, la ragazza è affidata a donna Prassede, moglie del dotto don Ferrante. Intanto Renzo è arrivato a Milano in un momento assai poco felice; mentre il popolo tumultua per la carestia, Renzo, che in un’osteria ha bevuto un po’ troppo, comincia a farfugliare contro i prepotenti: preso per uno dei capintesta della rivolta viene arrestato da due sbirri. Viene però liberato a furor di popolo e può così lasciare Milano e si rifugia a Bergamo, da un cugino, Bortolo. La Lombardia è straziata dalla guerra: calano i lanzichenecchi, le popolazioni fuggono. A Milano scoppia la peste. Renzo torna in città, avendo saputo che Lucia è ospite di don Ferrante; ma la giovane ha preso il morbo e si trova al lazzaretto. Qui, finalmente, Renzo la incontra. Ma c’è un nuovo intoppo: Lucia, al castello dell’Innominato, aveva fatto voto di castità alla Vergine se fosse riuscita a scampare al pericolo. Fra Cristoforo, che al lazzaretto si prodiga a curare gli appestati, la scioglie dal voto. Lucia guarisce, la peste si placa, dopo aver mietuto innumerevoli vittime, tra cui Don Rodrigo e Fra Cristoforo. Dopo tante vicissitudini, i due “promessi” possono diventare finalmente marito e moglie.
La differenza non sta nella fabula, che conserva nelle due edizioni l’idea di fondo, ma il modo di svolgerla e di strutturazione del racconto.
Le differenze fondamentali riguardano:
- una maggiore trattazione della storia o di alcuni episodi (la situazione politica del ’600 in Lombardia, la storia della monaca di Monza e via discorrendo) che rendevano il racconto non unitario;
- la lingua non rispondeva a quelle esigenze “classiche” di uniformità tali da rendere il dettato estremamente armonico, ma era pieno di lombardismi e francesismi (per alcuni critici, tuttavia, ciò lo rendeva maggiormente espressionistico)
Gli antecedenti letterari manzoniani sono certamente il genere romanzo nato in Inghilterra alla fine del ’700: ma se esso era nato come forma di un’epopea borghese (secondo la definizione hegeliana), in Italia, mancando una classe borghese numerosa e progressista, non poteva essere che il romanzo storico, il cui antecedente più immediato è certamente l’Ivanhoe di Walter Scott (da cui, come già detto, prende l’idea di presentare un medioevo meno di maniera dello scrittore inglese). Ma si erge su tale genere descrivendo per la prima volta la storia di “genti meccaniche” come mai era successo, nel genere romanzo di stile tragico (presenti invece in quello comico).
L’edizione cui facciamo riferimento è quella definitiva del ’40, che come già detto, risulterà armonicamente costruito, facendo alternare alla storia, macrosequenze che nell’edizione del Fermo e Lucia inficiavano la linearità dell’opera. Questa, già nel ’27 è così strutturata:
- Capitoli I – VIII: Storia di Renzo e Lucia
- Capitoli IX – X: prima macrosequenza: Gertrude
- Capitoli XI – XVII: Carestia e storia di Renzo
- Capitoli XVIII – XIX: Raccordo: Incontro fra il Conte zio e Padre provinciale
- Capitoli XX – XXI: seconda macrosequenza: Innominato
- Capitoli XII – XXX: Storia di Lucia
- Capitolo XXXI – XXXII: terza macrosequenza: la peste
- Capotolo XXXIII – XXXVIII: Reincontro e fine della storia
infatti, come vediamo schematicamente possiamo vedere come i quattro nuclei narrativi principali vengano interrotti da episodi dal massimo di due capitoli e mezzo, tanto da non far perdere contatto con la storia principale: anch’essa è distribuita secondo uno schema ben preciso: infatti alle storie dei due promessi insieme nel primo blocco, corrispondono il secondo e il terzo, rispettivamente Renzo il primo e Lucia il secondo, per poi ritrovarsi nell’ultimo blocco.
Il romanzo inizia con un’importantissima introduzione:
INTRODUZIONE
«L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo, perché togliendoli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaueri, li richiama in vita, li passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia. Ma gl’illustri Campioni che in tal Arringo fanno messe di Palme e d’Allori, rapiscono solo che le sole spoglie più sfarzose e brillanti, imbalsamando co’ loro inchiostri le Imprese de Prencipi e Potentati, e qualificati Personaggj, e trapontando coll’ago finissimo dell’ingegno i fili d’oro e di seta, che formano un perpetuo ricamo di Attioni gloriose. Però alla mia debolezza non è lecito solleuarsi a tal’argomenti, e sublimità pericolose, con aggirarsi tra Labirinti de’ Politici maneggj, et il rimbombo de’ bellici Oricalchi: solo che hauendo hauuto notitia di fatti memorabili, se ben capitorno a gente meccaniche, e di piccol affare, mi accingo di lasciarne memoria a Posteri, con far di tutto schietta e genuinamente il Racconto, ouuero sia Relatione. Nella quale si vedrà in angusto Teatro luttuose Traggedie d’horrori, e Scene di malvaggità grandiosa, con intermezi d’Imprese virtuose e buontà angeliche, opposte alle operationi diaboliche. E veramente, considerando che questi nostri climi sijno sotto l’amparo del Re Cattolico nostro Signore, che è quel Sole che mai tramonta, e che sopra di essi, con riflesso Lume, qual Luna giamai calante, risplenda l’Heroe di nobil Prosapia che pro tempore ne tiene le sue parti, e gl’Amplissimi Senatori quali Stelle fisse, e gl’altri Spettabili Magistrati qual’erranti Pianeti spandino la luce per ogni doue, venendo così a formare un nobilissimo Cielo, altra causale trouar non si può del vederlo tramutato in inferno d’atti tenebrosi, malvaggità e sevitie che dagl’huomini temerarij si vanno moltiplicando, se non se arte e fattura diabolica, attesoché l’humana malitia per sé sola bastar non dourebbe a resistere a tanti Heroi, che con occhij d’Argo e braccj di Briareo, si vanno trafficando per li pubblici emolumenti. Per locché descriuendo questo Racconto auuenuto ne’ tempi di mia verde staggione, abbenché la più parte delle persone che vi rappresentano le loro parti, sijno sparite dalla Scena del Mondo, con rendersi tributarij delle Parche, pure per degni rispetti, si tacerà li loro nomi, cioè la parentela, et il medesmo si farà de’ luochi, solo indicando li Territorij generaliter. Né alcuno dirà questa sij imperfettione del Racconto, e defformità di questo mio rozzo Parto, a meno questo tale Critico non sij persona affatto diggiuna della Filosofia: che quanto agl’huomini in essa versati, ben vederanno nulla mancare alla sostanza di detta Narratione. Imperciocché, essendo cosa evidente, e da verun negata non essere i nomi se non puri purissimi accidenti…»
«Ma, quando io avrò durata l’eroica fatica di trascriver questa storia da questo dilavato e graffiato autografo, e l’avrò data, come si suol dire, alla luce, si troverà poi chi duri la fatica di leggerla?» Questa riflessione dubitativa, nata nel travaglio del decifrare uno scarabocchio che veniva dopo accidenti, mi fece sospender la copia, e pensar più seriamente a quello che convenisse di fare. «Ben è vero, dicevo tra me, scartabellando il manoscritto, ben è vero che quella grandine di concettini e di figure non continua così alla distesa per tutta l’opera. Il buon secentista ha voluto sul principio mettere in mostra la sua virtù; ma poi, nel corso della narrazione, e talvolta per lunghi tratti, lo stile cammina ben più naturale e più piano. Sì; ma com’è dozzinale! com’è sguaiato! com’è scorretto! Idiotismi lombardi a iosa, frasi della lingua adoperate a sproposito, grammatica arbitraria, periodi sgangherati. E poi, qualche eleganza spagnola seminata qua e là; e poi, ch’è peggio, ne’ luoghi più terribili o più pietosi della storia, a ogni occasione d’eccitar maraviglia, o di far pensare, a tutti que’ passi insomma che richiedono bensì un po’ di rettorica, ma rettorica discreta, fine, di buon gusto, costui non manca mai di metterci di quella sua così fatta del proemio. E allora, accozzando, con un’abilità mirabile, le qualità più opposte, trova la maniera di riuscir rozzo insieme e affettato, nella stessa pagina, nello stesso periodo, nello stesso vocabolo. Ecco qui: declamazioni ampollose, composte a forza di solecismi pedestri, e da per tutto quella goffaggine ambiziosa, ch’è il proprio carattere degli scritti di quel secolo, in questo paese. In vero, non è cosa da presentare a lettori d’oggigiorno: son troppo ammaliziati, troppo disgustati di questo genere di stravaganze. Meno male, che il buon pensiero m’è venuto sul principio di questo sciagurato lavoro: e me ne lavo le mani». Nell’atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che una storia così bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta; perché, in quanto storia, può essere che al lettore ne paia altrimenti, ma a me era parsa bella, come dico; molto bella. «Perché non si potrebbe, pensai, prender la serie de’ fatti da questo manoscritto, e rifarne la dicitura?» Non essendosi presentato alcuna obiezion ragionevole, il partito fu subito abbracciato. Ed ecco l’origine del presente libro, esposta con un’ingenuità pari all’importanza del libro medesimo.
Taluni però di que’ fatti, certi costumi descritti dal nostro autore, c’eran sembrati così nuovi, così strani, per non dir peggio, che, prima di prestargli fede, abbiam voluto interrogare altri testimoni; e ci siam messi a frugar nelle memorie di quel tempo, per chiarirci se veramente il mondo camminasse allora a quel modo. Una tale indagine dissipò tutti i nostri dubbi: a ogni passo ci abbattevamo in cose consimili, e in cose più forti: e, quello che ci parve più decisivo, abbiam perfino ritrovati alcuni personaggi, de’ quali non avendo mai avuto notizia fuor che dal nostro manoscritto, eravamo in dubbio se fossero realmente esistiti. E, all’occorrenza, citeremo alcuna di quelle testimonianze, per procacciar fede alle cose, alle quali, per la loro stranezza, il lettore sarebbe più tentato di negarla.
Ma, rifiutando come intollerabile la dicitura del nostro autore, che dicitura vi abbiam noi sostituita? Qui sta il punto.
Chiunque, senza esser pregato, s’intromette a rifar l’opera altrui, s’espone a rendere uno stretto conto della sua, e ne contrae in certo modo l’obbligazione: è questa una regola di fatto e di diritto, alla quale non pretendiam punto di sottrarci. Anzi, per conformarci ad essa di buon grado, avevam proposto di dar qui minutamente ragione del modo di scrivere da noi tenuto; e, a questo fine, siamo andati, per tutto il tempo del lavoro, cercando d’indovinare le critiche possibili e contingenti, con intenzione di ribatterle tutte anticipatamente. Né in questo sarebbe stata la difficoltà; giacché (dobbiam dirlo a onor del vero) non ci si presentò alla mente una critica, che non le venisse insieme una risposta trionfante, di quelle risposte che, non dico risolvon le questioni, ma le mutano. Spesso anche, mettendo due critiche alle mani tra loro, le facevam battere l’una dall’altra; o, esaminandole ben a fondo, riscontrandole attentamente, riuscivamo a scoprire e a mostrare che, così opposte in apparenza, eran però d’uno stesso genere, nascevan tutt’e due dal non badare ai fatti e ai principi su cui il giudizio doveva esser fondato; e, messele, con loro gran sorpresa, insieme, le mandavamo insieme a spasso. Non ci sarebbe mai stato autore che provasse così ad evidenza d’aver fatto bene. Ma che? quando siamo stati al punto di raccapezzar tutte le dette obiezioni e risposte, per disporle con qualche ordine, misericordia! venivano a fare un libro. Veduta la qual cosa, abbiam messo da parte il pensiero, per due ragioni che il lettore troverà certamente buone: la prima, che un libro impiegato a giustificarne un altro, anzi lo stile d’un altro, potrebbe parer cosa ridicola: la seconda, che di libri basta uno per volta, quando non è d’avanzo.
 L’introduzione è di fondamentale importanza per introdurci nel clima ideologico, morale e politico del nostro: egli finge di aver trovato un manoscritto del ‘600 in cui erano narrate storie di picciol affare. Ma chi è l’erudito uomo secentesco che ha riportato la vicenda? Probabilmente uno che l’aveva raccolta dalla stessa bocca di Renzo (come ci dice lo stesso Manzoni) e l’aveva riscritta: Renzo, quindi, narratore ignorante, riporta la sua storia ad un dotto del Seicento, un, potremmo dire, Don Ferrante (personaggio secondario, ma la descrizione della sua biblioteca ci offre la misura della distanza e della durezza con cui Manzoni guardava alla cultura del ‘600). Ma qui la polemica contro la cultura barocca si fa pregnante: se infatti Don Ferrante, con tutta la sua conoscenza scientifica, ha potuto dichiarare che la peste non esiste per poi morirvi, bisogna fare a pezzi quella cultura per fondarne un’altra, bypassandola e tornando all’integrità “morale” dell’umile Renzo. Egli non ha voce, a dargliela ci penserà Manzoni. Sorge il problema della lingua: problema assai dibattuto allora e di difficilissima soluzione per via della mancanza di una lingua letteraria media (l’unica adatta per un romanzo) figlia della disunione politica italiana. La soluzione dello scrittore lombardo sarà ovvia e disegnerà la volontà politica di fondare una lingua media colta per la futura borghesia italiana (non è un caso che il testo diventerà obbligatorio nella scuola): il fiorentino parlato dalle persone colte, l’unico in cui la prosa narrativa, seppur trecentesca col Boccaccio, aveva saputo raccontare.
L’introduzione è di fondamentale importanza per introdurci nel clima ideologico, morale e politico del nostro: egli finge di aver trovato un manoscritto del ‘600 in cui erano narrate storie di picciol affare. Ma chi è l’erudito uomo secentesco che ha riportato la vicenda? Probabilmente uno che l’aveva raccolta dalla stessa bocca di Renzo (come ci dice lo stesso Manzoni) e l’aveva riscritta: Renzo, quindi, narratore ignorante, riporta la sua storia ad un dotto del Seicento, un, potremmo dire, Don Ferrante (personaggio secondario, ma la descrizione della sua biblioteca ci offre la misura della distanza e della durezza con cui Manzoni guardava alla cultura del ‘600). Ma qui la polemica contro la cultura barocca si fa pregnante: se infatti Don Ferrante, con tutta la sua conoscenza scientifica, ha potuto dichiarare che la peste non esiste per poi morirvi, bisogna fare a pezzi quella cultura per fondarne un’altra, bypassandola e tornando all’integrità “morale” dell’umile Renzo. Egli non ha voce, a dargliela ci penserà Manzoni. Sorge il problema della lingua: problema assai dibattuto allora e di difficilissima soluzione per via della mancanza di una lingua letteraria media (l’unica adatta per un romanzo) figlia della disunione politica italiana. La soluzione dello scrittore lombardo sarà ovvia e disegnerà la volontà politica di fondare una lingua media colta per la futura borghesia italiana (non è un caso che il testo diventerà obbligatorio nella scuola): il fiorentino parlato dalle persone colte, l’unico in cui la prosa narrativa, seppur trecentesca col Boccaccio, aveva saputo raccontare.
Il luogo
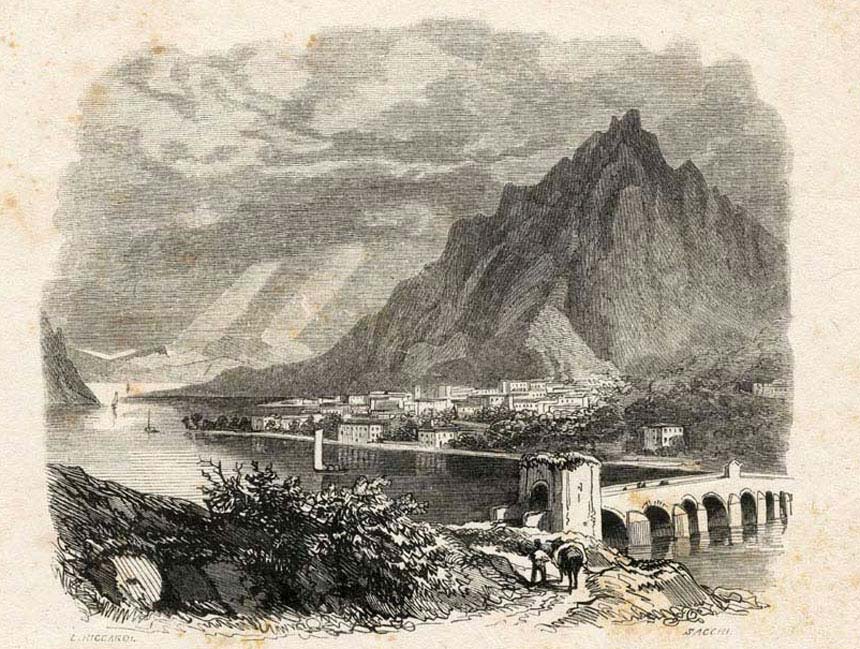
CAPITOLO I
Descrizione del luogo
Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l’uno detto di san Martino, l’altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa sale con un pendìo lento e continuo; poi si rompe in poggi e in valloncelli, in erte e in ispianate, secondo l’ossatura de’ due monti, e il lavoro dell’acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci de’ torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali; in qualche parte boschi, che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa: un gran borgo al giorno d’oggi, e che s’incammina a diventar città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello, e aveva perciò l’onore d’alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli, che insegnavan la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavan di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre; e, sul finir dell’estate, non mancavan mai di spandersi nelle vigne, per diradar l’uve, e alleggerire a’ contadini le fatiche della vendemmia. Dall’una all’altra di quelle terre, dall’alture alla riva, da un poggio all’altro, correvano, e corrono tuttavia, strade e stradette, più o men ripide, o piane; ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non iscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte; ogni tanto elevate su terrapieni aperti: e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti piglian più o meno della vasta scena circostante, e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell’acqua; di qua lago, chiuso all’estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano, a uno a uno, allo sguardo, e che l’acqua riflette capovolti, co’ paesetti posti sulle rive; di là braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra’ monti che l’accompagnano, degradando via via, e perdendosi quasi anch’essi nell’orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate que’ vari spettacoli, vi fa spettacolo da ogni parte: il monte di cui passeggiate le falde, vi svolge, al di sopra, d’intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che v’era sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa: e l’ameno, il domestico di quelle falde tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell’altre vedute.
La descrizione non vuol essere una dimostrazione dell’efficacia narrativa del romanziere, ma risponde innanzitutto all’esigenza di circoscrivere il luogo, dal generale al particolare (si è parlato quasi di uno zoom cinematografico), quindi a rispondere alla richiesta romantica per cui ogni fatto dev’essere collocato oggettivamente, con rigorosa esattezza, in una realtà storicamente e geograficamente controllabile, senza alcuna invenzione fantastica. Non è certamente fantastico, ma figlio anche di una capacità “tecnica”, narrativamente parlando, l’intervento antifrastico, ad interrompere la “scientificità” della descrizione, quando, riferendosi ai soldati spagnoli, li loda per “accarezzare le spalle” agli uomini e aiutarli nel lavoro della vendemmia. In un piccolo passaggio disegna già il clima di violenza presente nell’Italia di allora.
I personaggi

CAPITOLO I
PRESENTAZIONE DI DON ABBONDIO
Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato d’una delle terre accennate di sopra: il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trovan nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l’altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, l’indice della mano destra, e, messa poi questa nell’altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi all’intorno, li fissava alla parte d’un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta, dov’era solito d’alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un sessanta passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia d’un ipsilon: quella a destra saliva verso il monte, e menava alla cura: l’altra scendeva nella valle fino a un torrente; e da questa parte il muro non arrivava che all’anche del passeggiero. I muri interni delle due viottole, in vece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, sul quale eran dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che, nell’intenzion dell’artista, e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevan dir fiamme; e, alternate con le fiamme, cert’altre figure da non potersi descrivere, che volevan dire anime del purgatorio: anime e fiamme a color di mattone, sur un fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là. Il curato, voltata la stradetta, e dirizzando, com’era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s’aspettava, e che non avrebbe voluto vedere.
La descrizione del primo personaggio offertaci da Manzoni è costruita dinamicamente, attraverso le azioni; lo vediamo infatti mentre allontana i ciottoli dalla strada, recita noiosamente il rosario, guarda svogliatamente il paesaggio. Sono le azioni a dirci chi è: scansa i problemi, svolge il suo compito pastorale senza passione, non s’interessa della bellezza. E’ quindi un personaggio che, così presentatoci, non è positivo, anzi, a dirla tutta, la sua “inazione” sarà la conseguenza dei pericoli e dell’allontanamento dei due innamorati. Ma Manzoni sembra voler dire che non è colpa sua, ma della storia che con la sua violenza vessa chi, nella storia, non vuole entrare. Aggiunge infatti:
 Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor di leone. Ma, fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l’uomo tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui.
Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor di leone. Ma, fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l’uomo tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui.
e
Il nostro Abbondio non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s’era dunque accorto, prima quasi di toccar gli anni della discrezione, d’essere, in quella società, come un vaso di terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro.
Comunque la storia entra, in questo anzianotto bonario, e Manzoni ce la rappresenta simbolicamente: il tabernacolo con le lingue di fuoco, il pericolo imminente ed i bravi: la prepotenza del secolo lo ha investito (prepotenza che tuttavia, sembra sottolineare Manzoni, viene esercitata contro i più deboli)
CAPITOLO II
RENZO
Era, fin dall’adolescenza, rimasto privo de’ parenti, ed esercitava la professione di filatore di seta, ereditaria, per dir così, nella sua famiglia; professione, negli anni indietro, assai lucrosa; allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando; ma l’emigrazione continua de’ lavoranti, attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavora-va egli stesso, quando il filatoio stava fermo; di modo che, per la sua condizione, poteva dirsi agiato. E quantunque quell’annata fosse ancor più scarsa delle antecedenti, e già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che, da quando aveva messi gli occhi addosso a Lucia, era di-venuto massaio, si trovava provvisto bastantemente, e non aveva a contrastar con la fame. Comparve davanti a don Abbondio, in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale del manico bello, nel taschino de’ calzoni, con una cert’aria di festa e nello stesso tempo di braverìa, comune allora anche agli uomini più quieti
 Renzo ci dà l’opportunità di sottolineare un punto di fondamentale importanza per comprendere l’ideologia di Manzoni: per lo scrittore lombardo gli umili non sono poveri. Troviamo, infatti, la rappresentazione di piccolo proprietario terriero e con un piccolo capitale accumulato negli anni. Ma ciò non toglie allo storico Manzoni la possibilità di rimarcare l’inefficienza del governo spagnolo che, con la sua esosa politica fiscale e l’accaparramento di terre, aveva costretto molti filatori di seta, attività che permetteva un buon guadagno, ad emigrare nel territorio veneto.
Renzo ci dà l’opportunità di sottolineare un punto di fondamentale importanza per comprendere l’ideologia di Manzoni: per lo scrittore lombardo gli umili non sono poveri. Troviamo, infatti, la rappresentazione di piccolo proprietario terriero e con un piccolo capitale accumulato negli anni. Ma ciò non toglie allo storico Manzoni la possibilità di rimarcare l’inefficienza del governo spagnolo che, con la sua esosa politica fiscale e l’accaparramento di terre, aveva costretto molti filatori di seta, attività che permetteva un buon guadagno, ad emigrare nel territorio veneto.
CAPITOLO II
LUCIA
Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa, e le facevan forza perché si lasciasse vedere; e lei s’andava schermendo, con quella modestia un po’ guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto, e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s’apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura, si ravvolgevan, dietro il capo, in cerchi moltiplici di trecce, trapassate da lunghi spilli d’argento, che si dividevano all’intorno, quasi a guisa de’ raggi d’un’aureola, come ancora usano le contadine nel Milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d’oro a filigrana: portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastri: una corta gonnella di filaticcio di seta, a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle, di seta anch’esse, a ricami. Oltre a questo, ch’era l’ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano d’una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevan sul viso: una gioia temperata da un turbamento leggiero, quel placido accoramento che si mostra di quand’in quando sul volto delle spose, e, senza scompor la bellezza, le dà un carattere particolare.
 Con Lucia Manzoni sembra aver voluto raffigurare quasi un personaggio che riprendesse il cantico evangelico del Magnificat: Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. Infatti quello che emerge in questo ritratto è la pudicizia. Ma sembra, inoltre, che qui Manzoni abbia voluto esprimere il suo concetto di beltà femminile, che vedeva in Enrichetta, sua moglie. Infatti a caratterizzare la figura di Lucia, quello che emerge è certamente ritrosia, non scevra tuttavia da una certa forza (guerriera, viene definita) che appartiene alle contadine, donne lavoratrici.
Con Lucia Manzoni sembra aver voluto raffigurare quasi un personaggio che riprendesse il cantico evangelico del Magnificat: Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. Infatti quello che emerge in questo ritratto è la pudicizia. Ma sembra, inoltre, che qui Manzoni abbia voluto esprimere il suo concetto di beltà femminile, che vedeva in Enrichetta, sua moglie. Infatti a caratterizzare la figura di Lucia, quello che emerge è certamente ritrosia, non scevra tuttavia da una certa forza (guerriera, viene definita) che appartiene alle contadine, donne lavoratrici.
CAPITOLO IV
FRA CRISTOFORO

Il padre Cristoforo da *** era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant’anni. Il suo capo raso, salvo la piccola corona di capelli, che vi girava intorno, secondo il rito cappuccinesco, s’alzava di tempo in tempo, con un movimento che lasciava trasparire un non so che d’altero e d’inquieto; e subito s’abbassava, per riflessione d’umiltà. La barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento, faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un’astinenza, già da gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d’espressione. Due occhi incavati eran per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano, con vivacità repentina; come due cavalli bizzarri, condotti a mano da un cocchiere, col quale sanno, per esperienza, che non si può vincerla, pure fanno, di tempo in tempo, qualche sgambetto, che scontan subito, con una buona tirata di morso.
Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo: il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliuolo d’un mercante di *** (questi asterischi vengon tutti dalla circospezione del mio anonimo) che, ne’ suoi ultim’anni, trovandosi assai fornito di beni, e con quell’unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico, e s’era dato a viver da signore.
Nel suo nuovo ozio, cominciò a entrargli in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva speso a far qualcosa in questo mondo. Predominato da una tal fantasia, studiava tutte le maniere di far dimenticare ch’era stato mercante: avrebbe voluto poterlo dimenticare anche lui. Ma il fondaco, le balle, il libro, il braccio, gli comparivan sempre nella memoria, come l’ombra di Banco a Macbeth, anche tra la pompa delle mense, e il sorriso de’ parassiti. E non si potrebbe dire la cura che dovevano aver que’ poveretti, per schivare ogni parola che potesse parere allusiva all’antica condizione del convitante. Un giorno, per raccontarne una, un giorno, sul finir della tavola, ne’ momenti della più viva e schietta allegria, che non si sarebbe potuto dire chi più godesse, o la brigata di sparecchiare, o il padrone d’aver apparecchiato, andava stuzzicando, con superiorità amichevole, uno di que’ commensali, il più onesto mangiatore del mondo. Questo, per corrispondere alla celia, senza la minima ombra di malizia, proprio col candore d’un bambino, rispose: – eh! io fo l’orecchio del mercante –. Egli stesso fu subito colpito dal suono della parola che gli era uscita di bocca: guardò, con faccia incerta, alla faccia del padrone, che s’era rannuvolata: l’uno e l’altro avrebber voluto riprender quella di prima; ma non era possibile. Gli altri convitati pensavano, ognun da sé, al modo di sopire il piccolo scandolo, e di fare una diversione; ma, pensando, tacevano, e, in quel silenzio, lo scandolo era più manifesto. Ognuno scansava d’incontrar gli occhi degli altri; ognuno sentiva che tutti eran occupati del pensiero che tutti volevan dissimulare. La gioia, per quel giorno, se n’andò; e l’imprudente o, per parlar con più giustizia, lo sfortunato, non ricevette più invito. Così il padre di Lodovico passò gli ultimi suoi anni in angustie continue, temendo sempre d’essere schernito, e non riflettendo mai che il vendere non è cosa più ridicola che il comprare, e che quella professione di cui allora si vergognava, l’aveva pure esercitata per tant’anni, in presenza del pubblico, e senza rimorso. Fece educare il figlio nobilmente, secondo la condizione de’ tempi, e per quanto gli era concesso dalle leggi e dalle consuetudini; gli diede maestri di lettere e d’esercizi cavallereschi; e morì, lasciandolo ricco e giovinetto.
Lodovico aveva contratte abitudini signorili; e gli adulatori, tra i quali era cresciuto, l’avevano avvezzato ad esser trattato con molto rispetto. Ma, quando volle mischiarsi coi principali della sua città, trovò un fare ben diverso da quello a cui era accostumato; e vide che, a voler esser della lor compagnia, come avrebbe desiderato, gli conveniva fare una nuova scuola di pazienza e di sommissione, star sempre al di sotto, e ingozzarne una, ogni momento. Una tal maniera di vivere non s’accordava, né con l’educazione, né con la natura di Lodovico. S’allontanò da essi indispettito. Ma poi ne stava lontano con rammarico; perché gli pareva che questi veramente avrebber dovuto essere i suoi compagni; soltanto gli avrebbe voluti più trattabili. Con questo misto d’inclinazione e di rancore, non potendo frequentarli famigliarmente, e volendo pure aver che far con loro in qualche modo, s’era dato a competer con loro di sfoggi e di magnificenza, comprandosi così a contanti inimicizie, invidie e ridicolo. La sua indole, onesta insieme e violenta, l’aveva poi imbarcato per tempo in altre gare più serie. Sentiva un orrore spontaneo e sincero per l’angherie e per i soprusi: orrore reso ancor più vivo in lui dalla qualità delle persone che più ne commettevano alla giornata; ch’erano appunto coloro coi quali aveva più di quella ruggine. Per acquietare, o per esercitare tutte queste passioni in una volta, prendeva volentieri le parti d’un debole sopraffatto, si piccava di farci stare un soverchiatore, s’intrometteva in una briga, se ne tirava addosso un’altra; tanto che, a poco a poco, venne a costituirsi come un protettor degli oppressi, e un vendicatore de’ torti. L’impiego era gravoso; e non è da domandare se il povero Lodovico avesse nemici, impegni e pensieri. Oltre la guerra esterna, era poi tribolato continuamente da contrasti interni; perché, a spuntarla in un impegno (senza parlare di quelli in cui restava al di sotto), doveva anche lui adoperar raggiri e violenze, che la sua coscienza non poteva poi approvare. Doveva tenersi intorno un buon numero di bravacci; e, così per la sua sicurezza, come per averne un aiuto più vigoroso, doveva scegliere i più arrischiati, cioè i più ribaldi; e vivere co’ birboni, per amor della giustizia. Tanto che, più d’una volta, o scoraggito, dopo una trista riuscita, o inquieto per un pericolo imminente, annoiato del continuo guardarsi, stomacato della sua compagnia, in pensiero dell’avvenire, per le sue sostanze che se n’andavan, di giorno in giorno, in opere buone e in braverie, più d’una volta gli era saltata la fantasia di farsi frate; che, a que’ tempi, era il ripiego più comune, per uscir d’impicci. Ma questa, che sarebbe forse stata una fantasia per tutta la sua vita, divenne una risoluzione, a causa d’un accidente, il più serio che gli fosse ancor capitato.
Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due bravi, e accompagnato da un tal Cristoforo, altre volte giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di casa. Era un uomo di circa cinquant’anni, affezionato, dalla gioventù, a Lodovico, che aveva veduto nascere, e che, tra salario e regali, gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntar da lontano un signor tale, arrogante e soverchiatore di professione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico, e al quale rendeva, pur di cuore, il contraccambio: giacché è uno de’ vantaggi di questo mondo, quello di poter odiare ed esser odiati, senza conoscersi. Costui, seguito da quattro bravi, s’avanzava diritto, con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all’alterigia e allo sprezzo. Tutt’e due camminavan rasente al muro; ma Lodovico (notate bene) lo strisciava col lato destro; e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto (dove mai si va a ficcare il diritto!) di non istaccarsi dal detto muro, per dar passo a chi si fosse; cosa della quale allora si faceva gran caso. L’altro pretendeva, all’opposto, che quel diritto competesse a lui, come a nobile, e che a Lodovico toccasse d’andar nel mezzo; e ciò in forza d’un’altra consuetudine. Perocché, in questo, come accade in molti altri affari, erano in vigore due consuetudini contrarie, senza che fosse deciso qual delle due fosse la buona; il che dava opportunità di fare una guerra, ogni volta che una testa dura s’abbattesse in un’altra della stessa tempra. Que’ due si venivano incontro, ristretti alla muraglia, come due figure di basso rilievo ambulanti. Quando si trovarono a viso a viso, il signor tale, squadrando Lodovico, a capo alto, col cipiglio imperioso, gli disse, in un tono corrispondente di voce: «fate luogo.»
«Fate luogo voi,» – rispose Lodovico. – La diritta è mia.
«Co’ vostri pari, è sempre mia.»
«Sì, se l’arroganza de’ vostri pari fosse legge per i pari miei.»
I bravi dell’uno e dell’altro eran rimasti fermi, ciascuno dietro il suo padrone, guardandosi in cagnesco, con le mani alle daghe, preparati alla battaglia. La gente che arrivava di qua e di là, si teneva in distanza, a osservare il fatto; e la presenza di quegli spettatori animava sempre più il puntiglio de’ contendenti.
«Nel mezzo, vile meccanico; o ch’io t’insegno una volta come si tratta co’ gentiluomini.»
«Voi mentite ch’io sia vile.» «Tu menti ch’io abbia mentito.» Questa risposta era di prammatica. «E, se tu fossi cavaliere, come son io,» aggiunse quel signore, «ti vorrei far vedere, con la spada e con la cappa, che il mentitore sei tu.»
«È un buon pretesto per dispensarvi di sostener co’ fatti l’insolenza delle vostre parole.»
«Gettate nel fango questo ribaldo,» disse il gentiluomo, voltandosi a’ suoi.
Vediamo!» disse Lodovico, dando subitamente un passo indietro, e mettendo mano alla spada.
«Temerario!» gridò l’altro, sfoderando la sua: «io spezzerò questa, quando sarà macchiata del tuo vil sangue.»
Così s’avventarono l’uno all’altro; i servitori delle due parti si slanciarono alla difesa de’ loro padroni. Il combattimento era disuguale, e per il numero, e anche perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi, e a disarmare il nemico, che ad ucciderlo; ma questo voleva la morte di lui, a ogni costo. Lodovico aveva già ricevuta al braccio sinistro una pugnalata d’un bravo, e una sgraffiatura leggiera in una guancia, e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo; quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell’estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista, Lodovico, come fuor di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo, quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto ch’era finita, si diedero alla fuga, malconci: quelli di Lodovico, tartassati e sfregiati anche loro, non essendovi più a chi dare, e non volendo trovarsi impicciati nella gente, che già accorreva, scantonarono dall’altra parte: e Lodovico si trovò solo, con que’ due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla.
«Com’è andata?» «È uno.» «Son due.» «Gli ha fatto un occhiello nel ventre.» «Chi è stato ammazzato?» «Quel prepotente.» «Oh santa Maria, che sconquasso!» «Chi cerca trova.» «Una le paga tutte.» «Ha finito anche lui.» «Che colpo!» «Vuol essere una faccenda seria.» «E quell’altro disgraziato!» «Misericordia! che spettacolo!» «Salvatelo, salvatelo.» «Sta fresco anche lui.» «Vedete com’è concio! butta sangue da tutte le parti.» «Scappi, scappi. Non si lasci prendere.»
Queste parole, che più di tutte si facevan sentire nel frastono confuso di quella folla, esprimevano il voto comune; e, col consiglio, venne anche l’aiuto. Il fatto era accaduto vicino a una chiesa di cappuccini, asilo, come ognun sa, impenetrabile allora a’ birri, e a tutto quel complesso di cose e di persone, che si chiamava la giustizia. L’uccisore ferito fu quivi condotto o portato dalla folla, quasi fuor di sentimento; e i frati lo ricevettero dalle mani del popolo, che glielo raccomandava, dicendo: «è un uomo dabbene che ha freddato un birbone superbo: l’ha fatto per sua difesa: c’è stato tirato per i capelli.»
Lodovico non aveva mai, prima d’allora, sparso sangue; e, benché l’omicidio fosse, a que’ tempi, cosa tanto comune, che gli orecchi d’ognuno erano avvezzi a sentirlo raccontare, e gli occhi a vederlo, pure l’impressione ch’egli ricevette dal veder l’uomo morto per lui, e l’uomo morto da lui, fu nuova e indicibile; fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Il cadere del suo nemico, l’alterazione di quel volto, che passava, in un momento, dalla minaccia e dal furore, all’abbattimento e alla quiete solenne della morte, fu una vista che cambiò, in un punto, l’animo dell’uccisore. Strascinato al convento, non sapeva quasi dove si fosse, né cosa si facesse; e, quando fu tornato in sé, si trovò in un letto dell’infermeria, nelle mani del frate chirurgo (i cappuccini ne avevano ordinariamente uno in ogni convento), che accomodava faldelle e fasce sulle due ferite ch’egli aveva ricevute nello scontro. Un padre, il cui impiego particolare era d’assistere i moribondi, e che aveva spesso avuto a render questo servizio sulla strada, fu chiamato subito al luogo del combattimento. Tornato, pochi minuti dopo, entrò nell’infermeria, e, avvicinatosi al letto dove Lodovico giaceva, «consolatevi» gli disse: «almeno è morto bene, e m’ha incaricato di chiedere il vostro perdono, e di portarvi il suo». Questa parola fece rinvenire affatto il povero Lodovico, e gli risvegliò più vivamente e più distintamente i sentimenti ch’eran confusi e affollati nel suo animo: dolore dell’amico, sgomento e rimorso del colpo che gli era uscito di mano, e, nello stesso tempo, un’angosciosa compassione dell’uomo che aveva ucciso. «E l’altro?» – domandò ansiosamente al frate.
«L’altro era spirato, quand’io arrivai.»
Frattanto, gli accessi e i contorni del convento formicolavan di popolo curioso: ma, giunta la sbirraglia, fece smaltir la folla, e si postò a una certa distanza dalla porta, in modo però che nessuno potesse uscirne inosservato. Un fratello del morto, due suoi cugini e un vecchio zio, vennero pure, armati da capo a piedi, con grande accompagnamento di bravi; e si misero a far la ronda intorno, guardando, con aria e con atti di dispetto minaccioso, que’ curiosi, che non osavan dire: gli sta bene; ma l’avevano scritto in viso.
Appena Lodovico ebbe potuto raccogliere i suoi pensieri, chiamato un frate confessore, lo pregò che cercasse della vedova di Cristoforo, le chiedesse in suo nome perdono d’essere stato lui la cagione, quantunque ben certo involontaria, di quella desolazione, e, nello stesso tempo, l’assicurasse ch’egli prendeva la famiglia sopra di sé. Riflettendo quindi a’ casi suoi, sentì rinascere più che mai vivo e serio quel pensiero di farsi frate, che altre volte gli era passato per la mente: gli parve che Dio medesimo l’avesse messo sulla strada, e datogli un segno del suo volere, facendolo capitare in un convento, in quella congiuntura; e il partito fu preso. Fece chiamare il guardiano, e gli manifestò il suo desiderio. N’ebbe in risposta, che bisognava guardarsi dalle risoluzioni precipitate; ma che, se persisteva, non sarebbe rifiutato. Allora, fatto venire un notaro, dettò una donazione di tutto ciò che gli rimaneva (ch’era tuttavia un bel patrimonio) alla famiglia di Cristoforo: una somma alla vedova, come se le costituisse una contraddote, e il resto a otto figliuoli che Cristoforo aveva lasciati.
La risoluzione di Lodovico veniva molto a proposito per i suoi ospiti, i quali, per cagion sua, erano in un bell’intrigo. Rimandarlo dal convento, ed esporlo così alla giustizia, cioè alla vendetta de’ suoi nemici, non era partito da metter neppure in consulta. Sarebbe stato lo stesso che rinunziare a’ propri privilegi, screditare il convento presso il popolo, attirarsi il biasimo di tutti i cappuccini dell’universo, per aver lasciato violare il diritto di tutti, concitarsi contro tutte l’autorità ecclesiastiche, le quali si consideravan come tutrici di questo diritto. Dall’altra parte, la famiglia dell’ucciso, potente assai, e per sé, e per le sue aderenze, s’era messa al punto di voler vendetta; e dichiarava suo nemico chiunque s’attentasse di mettervi ostacolo. La storia non dice che a loro dolesse molto dell’ucciso, e nemmeno che una lagrima fosse stata sparsa per lui, in tutto il parentado: dice soltanto ch’eran tutti smaniosi d’aver nell’unghie l’uccisore, o vivo o morto. Ora questo, vestendo l’abito di cappuccino, accomodava ogni cosa. Faceva, in certa maniera, un’emenda, s’imponeva una penitenza, si chiamava implicitamente in colpa, si ritirava da ogni gara; era in somma un nemico che depon l’armi. I parenti del morto potevan poi anche, se loro piacesse, credere e vantarsi che s’era fatto frate per disperazione, e per terrore del loro sdegno. E, ad ogni modo, ridurre un uomo a spropriarsi del suo, a tosarsi la testa, a camminare a piedi nudi, a dormir sur un saccone, a viver d’elemosina, poteva parere una punizione competente, anche all’offeso il più borioso.
Il padre guardiano si presentò, con un’umiltà disinvolta, al fratello del morto, e, dopo mille proteste di rispetto per l’illustrissima casa, e di desiderio di compiacere ad essa in tutto ciò che fosse fattibile, parlò del pentimento di Lodovico, e della sua risoluzione, facendo garbatamente sentire che la casa poteva esserne contenta, e insinuando poi soavemente, e con maniera ancor più destra, che, piacesse o non piacesse, la cosa doveva essere. Il fratello diede in ismanie, che il cappuccino lasciò svaporare, dicendo di tempo in tempo: «è un troppo giusto dolore». Fece intendere che, in ogni caso, la sua famiglia avrebbe saputo prendersi una soddisfazione: e il cappuccino, qualunque cosa ne pensasse, non disse di no. Finalmente richiese, impose come una condizione, che l’uccisor di suo fratello partirebbe subito da quella città. Il guardiano, che aveva già deliberato che questo fosse fatto, disse che si farebbe, lasciando che l’altro credesse, se gli piaceva, esser questo un atto d’ubbidienza: e tutto fu concluso. Contenta la famiglia, che ne usciva con onore; contenti i frati, che salvavano un uomo e i loro privilegi, senza farsi alcun nemico; contenti i dilettanti di cavalleria, che vedevano un affare terminarsi lodevolmente; contento il popolo, che vedeva fuor d’impiccio un uomo ben voluto, e che, nello stesso tempo, ammirava una conversione; contento finalmente, e più di tutti, in mezzo al dolore, il nostro Lodovico, il quale cominciava una vita d’espiazione e di servizio, che potesse, se non riparare, pagare almeno il mal fatto, e rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso. Il sospetto che la sua risoluzione fosse attribuita alla paura, l’afflisse un momento; ma si consolò subito, col pensiero che anche quell’ingiusto giudizio sarebbe un gastigo per lui, e un mezzo d’espiazione. Così, a trent’anni, si ravvolse nel sacco; e, dovendo, secondo l’uso, lasciare il suo nome, e prenderne un altro, ne scelse uno che gli rammentasse, ogni momento, ciò che aveva da espiare: e si chiamò fra Cristoforo.
Appena compita la cerimonia della vestizione, il guardiano gl’intimò che sarebbe andato a fare il suo noviziato a ***, sessanta miglia lontano, e che partirebbe all’indomani. Il novizio s’inchinò profondamente, e chiese una grazia. «Permettetemi, padre,» disse, «che, prima di partir da questa città, dove ho sparso il sangue d’un uomo, dove lascio una famiglia crudelmente offesa, io la ristori almeno dell’affronto, ch’io mostri almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno, col chiedere scusa al fratello dell’ucciso, e gli levi, se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall’animo». Al guardiano parve che un tal passo, oltre all’esser buono in sé, servirebbe a riconciliar sempre più la famiglia col convento; e andò diviato da quel signor fratello, ad esporgli la domanda di fra Cristoforo. A proposta così inaspettata, colui sentì, insieme con la maraviglia, un ribollimento di sdegno, non però senza qualche compiacenza. Dopo aver pensato un momento, «venga domani,» disse; e assegnò l’ora. Il guardiano tornò, a portare al novizio il consenso desiderato.
Il gentiluomo pensò subito che, quanto più quella soddisfazione fosse solenne e clamorosa, tanto più accrescerebbe il suo credito presso tutta la parentela, e presso il pubblico; e sarebbe (per dirla con un’eleganza moderna) una bella pagina nella storia della famiglia. Fece avvertire in fretta tutti i parenti che, all’indomani, a mezzogiorno, restassero serviti (così si diceva allora) di venir da lui, a ricevere una soddisfazione comune. A mezzogiorno, il palazzo brulicava di signori d’ogni età e d’ogni sesso: era un girare, un rimescolarsi di gran cappe, d’alte penne, di durlindane pendenti, un moversi librato di gorgiere inamidate e crespe, uno strascico intralciato di rabescate zimarre. Le anticamere, il cortile e la strada formicolavan di servitori, di paggi, di bravi e di curiosi. Fra Cristoforo vide quell’apparecchio, ne indovinò il motivo, e provò un leggier turbamento; ma, dopo un istante, disse tra sé: “sta bene: l’ho ucciso in pubblico, alla presenza di tanti suoi nemici: quello fu scandalo, questa è riparazione”. Così, con gli occhi bassi, col padre compagno al fianco, passò la porta di quella casa, attraversò il cortile, tra una folla che lo squadrava con una curiosità poco cerimoniosa; salì le scale, e, di mezzo all’altra folla signorile, che fece ala al suo passaggio, seguito da cento sguardi, giunse alla presenza del padron di casa; il quale, circondato da’ parenti più prossimi, stava ritto nel mezzo della sala, con lo sguardo a terra, e il mento in aria, impugnando, con la mano sinistra, il pomo della spada, e stringendo con la destra il bavero della cappa sul petto.
C’è talvolta, nel volto e nel contegno d’un uomo, un’espressione così immediata, si direbbe quasi un’effusione dell’animo interno, che, in una folla di spettatori, il giudizio sopra quell’animo sarà un solo. Il volto e il contegno di fra Cristoforo disser chiaro agli astanti, che non s’era fatto frate, né veniva a quell’umiliazione per timore umano: e questo cominciò a concigliarglieli tutti. Quando vide l’offeso, affrettò il passo, gli si pose inginocchioni ai piedi, incrociò le mani sul petto, e, chinando la testa rasa, disse queste parole: «io sono l’omicida di suo fratello. Sa Iddio se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue; ma, non potendo altro che farle inefficaci e tarde scuse, la supplico d’accettarle per l’amor di Dio». Tutti gli occhi erano immobili sul novizio, e sul personaggio a cui egli parlava; tutti gli orecchi eran tesi. Quando fra Cristoforo tacque, s’alzò, per tutta la sala, un mormorìo di pietà e di rispetto. Il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata, e d’ira compressa, fu turbato da quelle parole; e, chinandosi verso l’inginocchiato, «alzatevi,» disse, con voce alterata: «l’offesa… il fatto veramente… ma l’abito che portate… non solo questo, ma anche per voi… S’alzi, padre… Mio fratello… non lo posso negare… era un cavaliere… era un uomo… un po’ impetuoso… un po’ vivo. Ma tutto accade per disposizion di Dio. Non se ne parli più… Ma, padre, lei non deve stare in codesta positura». E, presolo per le braccia, lo sollevò. Fra Cristoforo, in piedi, ma col capo chino, rispose: «io posso dunque sperare che lei m’abbia concesso il suo perdono! E se l’ottengo da lei, da chi non devo sperarlo? Oh! s’io potessi sentire dalla sua bocca questa parola, perdono!»
«Perdono?» disse il gentiluomo. «Lei non ne ha più bisogno. Ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io le perdono di cuore, e tutti…»
«Tutti! tutti!» gridarono, a una voce, gli astanti. Il volto del frate s’aprì a una gioia riconoscente, sotto la quale traspariva però ancora un’umile e profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da quell’aspetto, e trasportato dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo, e gli diede e ne ricevette il bacio di pace.
Un «bravo! bene!» scoppiò da tutte le parti della sala; tutti si mossero, e si strinsero intorno al frate. Intanto vennero servitori, con gran copia di rinfreschi. Il gentiluomo si raccostò al nostro Cristoforo, il quale faceva segno di volersi licenziare, e gli disse: «padre, gradisca qualche cosa; mi dia questa prova d’amicizia«. E si mise per servirlo prima d’ogni altro; ma egli, ritirandosi, con una certa resistenza cordiale, «queste cose,» disse,» non fanno più per me; ma non sarà mai ch’io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio: si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire d’aver goduto la sua carità, d’aver mangiato il suo pane, e avuto un segno del suo perdono». Il gentiluomo, commosso, ordinò che così si facesse; e venne subito un cameriere, in gran gala, portando un pane sur un piatto d’argento, e lo presentò al padre; il quale, presolo e ringraziato, lo mise nella sporta. Chiese quindi licenza; e, abbracciato di nuovo il padron di casa, e tutti quelli che, trovandosi più vicini a lui, poterono impadronirsene un momento, si liberò da essi a fatica; ebbe a combatter nell’anticamere, per isbrigarsi da’ servitori, e anche da’ bravi, che gli baciavano il lembo dell’abito, il cordone, il cappuccio; e si trovò nella strada, portato come in trionfo, e accompagnato da una folla di popolo, fino a una porta della città; d’onde uscì, cominciando il suo pedestre viaggio, verso il luogo del suo noviziato.
Il fratello dell’ucciso, e il parentado, che s’erano aspettati d’assaporare in quel giorno la trista gioia dell’orgoglio, si trovarono in vece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza. La compagnia si trattenne ancor qualche tempo, con una bonarietà e con una cordialità insolita, in ragionamenti ai quali nessuno era preparato, andando là. In vece di soddisfazioni prese, di soprusi vendicati, d’impegni spuntati, le lodi del novizio, la riconciliazione, la mansuetudine furono i temi della conversazione. E taluno, che, per la cinquantesima volta, avrebbe raccontato come il conte Muzio suo padre aveva saputo, in quella famosa congiuntura, far stare a dovere il marchese Stanislao, ch’era quel rodomonte che ognun sa, parlò in vece delle penitenze e della pazienza mirabile d’un fra Simone, morto molt’anni prima. Partita la compagnia, il padrone, ancor tutto commosso, riandava tra sé, con maraviglia, ciò che aveva inteso, ciò ch’egli medesimo aveva detto; e borbottava tra i denti: «diavolo d’un frate!» (bisogna bene che noi trascriviamo le sue precise parole) «diavolo d’un frate! se rimaneva lì in ginocchio, ancora per qualche momento, quasi quasi gli chiedevo scusa io, che m’abbia ammazzato il fratello». La nostra storia nota espressamente che, da quel giorno in poi, quel signore fu un po’ men precipitoso, e un po’ più alla mano.

Se gli umili Manzoni ce li mostra nel loro agire, aprendo piccoli squarci ad indicarci chi sono (Don Abbondio che incontra i bravi, Renzo che si reca da Don Abbondio per prendere accordi, Lucia che si prepara al matrimonio), per i grandi, nel bene e nel male, che fanno da contorno alla storia principale, sia che si presentino come oppositori, come sarà Gertrude, sia come aiutanti, Fra Cristoforo appunto, o l’Innominato, vi è bisogno di pausare e far sì che la storia passata del personaggio mostri la sua capacità d’azione o forza nella storia dei due giovani. Se dunque di passato si tratta ecco che emerge, come vero protagonista, il secolo del Seicento, con le sue vuote convinzioni, lo sfarzo, le illogiche consuetudini. Ed in questo clima che si inserisce la storia di Ludovico, figlio di un padre che si vergogna d’esser stato mercante, ed educato come un nobile pur non essendolo. Ecco che per il razionalista, di educazione illuminista, la forma che cancella il contenuto (da ricordare il concetto di metafora del barocco), dev’essere vinta dalla possibilità di denudarsi completamente. Ed è quello che fa Ludovico, cui la provvidenza offre la possibilità di spogliarsi di ricchezze, abiti, false ideologie, per impossessarsi, come Francesco, della verità di Cristo.
 Interessante è il tratto psicologico: egli è nato combattente, colui che sfida con lo sguardo (cavalli imbizzarriti, definisce Manzoni i suoi occhi), non muta, non è un personaggio in fieri, porta la sua combattività che già andava contro i soprusi, là dove essa è opportuna. Fra Cristoforo diventa pertanto l’emblema di quella chiesa militante che aveva già cantato ne La Pentecoste.
Interessante è il tratto psicologico: egli è nato combattente, colui che sfida con lo sguardo (cavalli imbizzarriti, definisce Manzoni i suoi occhi), non muta, non è un personaggio in fieri, porta la sua combattività che già andava contro i soprusi, là dove essa è opportuna. Fra Cristoforo diventa pertanto l’emblema di quella chiesa militante che aveva già cantato ne La Pentecoste.
CAPITOLO IX-X
LA MONACA DI MONZA

Era essa l’ultima figlia del principe ***, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi della città. Ma l’alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parer le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro; e tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli avesse, la storia non lo dice espressamente; fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell’uno e dell’altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a conservar la famiglia, a procrear cioè de’ figliuoli, per tormentarsi a tormentarli nella stessa maniera. La nostra infelice era ancor nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca; decisione per la quale faceva bisogno, non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l’idea del chiostro, e che fosse stato portato da una santa d’alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano; poi santini che rappresentavan monache; e que’ regali eran sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto; come cosa preziosa, e con quell’interrogare affermativo: «bello eh?» Quando il principe, o la principessa o il principino, che solo de’ maschi veniva allevato in casa, volevano lodar l’aspetto prosperoso della fanciullina, pareva che non trovasser modo d’esprimer bene la loro idea, se non con le parole: «che madre badessa!» Nessuno però le disse mai direttamente: tu devi farti monaca. Era un’idea sottintesa e toccata incidentemente, in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascorreva a qualche atto un po’ arrogante e imperioso, al che la sua indole la portava molto facilmente, «tu sei una ragazzina,» le si diceva: «queste maniere non ti convengono: quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso». Qualche altra volta il principe, riprendendola di cert’altre maniere troppo libere e famigliari alle quali essa trascorreva con uguale facilità, «ehi! ehi!» le diceva; «non è questo il fare d’una par tua: se vuoi che un giorno ti si porti il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d’ora a star sopra di te: ricordati che tu devi essere, in ogni cosa, la prima del monastero; perché il sangue si porta per tutto dove si va.»
Tutte le parole di questo genere stampavano nel cervello della fanciullina l’idea che già lei doveva esser monaca; ma quelle che venivan dalla bocca del padre, facevan più effetto di tutte l’altre insieme. Il contegno del principe era abitualmente quello d’un padrone austero; ma quando si trattava dello stato futuro de’ suoi figli, dal suo volto e da ogni sua parola traspariva un’immobilità di risoluzione, una ombrosa gelosia di comando, che imprimeva il sentimento d’una necessità fatale.
A sei anni, Gertrude fu collocata, per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale, nel monastero dove l’abbiamo veduta: e la scelta del luogo non fu senza disegno. Il buon conduttore delle due donne ha detto che il padre della signora era il primo in Monza: e, accozzando questa qualsisia testimonianza con alcune altre indicazioni che l’anonimo lascia scappare sbadatamente qua e là, noi potremmo anche asserire che fosse il feudatario di quel paese. Comunque sia, vi godeva d’una grandissima autorità; e pensò che lì, meglio che altrove, la sua figlia sarebbe trattata con quelle distinzioni e con quelle finezze che potesser più allettarla a scegliere quel monastero per sua perpetua dimora. Né s’ingannava: la badessa e alcune altre monache faccendiere, che avevano, come si suol dire, il mestolo in mano, esultarono nel vedersi offerto il pegno d’una protezione tanto utile in ogni occorrenza, tanto gloriosa in ogni momento; accettaron la proposta, con espressioni di riconoscenza, non esagerate, per quanto fossero forti; e corrisposero pienamente all’intenzioni che il principe aveva lasciate trasparire sul collocamento stabile della figliuola: intenzioni che andavan così d’accordo con le loro. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata per antonomasia la signorina; posto distinto a tavola, nel dormitorio; la sua condotta proposta all’altre per esemplare; chicche e carezze senza fine, e condite con quella famigliarità un po’ rispettosa, che tanto adesca i fanciulli, quando la trovano in coloro che vedon trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità. Non che tutte le monache fossero congiurate a tirar la poverina nel laccio; ce n’eran molte delle semplici e lontane da ogni intrigo, alle quali il pensiero di sacrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo; ma queste, tutte attente alle loro occupazioni particolari, parte non s’accorgevan bene di tutti que’ maneggi, parte non distinguevano quanto vi fosse di cattivo, parte s’astenevano dal farvi sopra esame, parte stavano zitte, per non fare scandoli inutili. Qualcheduna anche, rammentandosi d’essere stata, con simili arti, condotta a quello di cui s’era pentita poi, sentiva compassione della povera innocentina, e si sfogava col farle carezze tenere e malinconiche: ma questa era ben lontana dal sospettare che ci fosse sotto mistero; e la faccenda camminava. Sarebbe forse camminata così fino alla fine, se Gertrude fosse stata la sola ragazza in quel monastero. Ma, tra le sue compagne d’educazione, ce n’erano alcune che sapevano d’esser destinate al matrimonio. Gertrudina, nudrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente de’ suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero, voleva a ogni conto esser per le altre un soggetto d’invidia; e vedeva con maraviglia e con dispetto, che alcune di quelle non ne sentivano punto. All’immagini maestose, ma circoscritte e fredde, che può somministrare il primato in un monastero, contrapponevan esse le immagini varie e luccicanti, di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, come dicevano allora, di villeggiature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichìo che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti, messo davanti a un alveare. I parenti e l’educatrici avevan coltivata e accresciuta in lei la vanità naturale, per farle piacere il chiostro; ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più omogenee ad essa, si gettò su quelle, con un ardore ben più vivo e più spontaneo. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne, e per condiscendere nello stesso tempo al suo nuovo genio, rispondeva che, alla fin de’ conti, nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, abitare un palazzo, godersi il mondo, e meglio di tutte loro; che lo poteva, pur che l’avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva; e lo voleva in fatti. L’idea della necessità del suo consenso, idea che, fino a quel tempo, era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua mente, si sviluppò allora, e si manifestò, con tutta la sua importanza. Essa la chiamava ogni momento in aiuto, per godersi più tranquillamente l’immagini d’un avvenire gradito. Dietro questa idea però, ne compariva sempre infallibilmente un’altra: che quel consenso si trattava di negarlo al principe padre, il quale lo teneva già, o mostrava di tenerlo per dato; e, a questa idea, l’animo della figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole. Si paragonava allora con le compagne, ch’erano ben altrimenti sicure, e provava per esse dolorosamente l’invidia che, da principio, aveva creduto di far loro provare. Invidiandole, le odiava: talvolta l’odio s’esalava in dispetti, in isgarbatezze, in motti pungenti; talvolta l’uniformità dell’inclinazioni e delle speranze lo sopiva, e faceva nascere un’intrinsichezza apparente e passeggiera. Talvolta, volendo pure godersi intanto qualche cosa di reale e di presente, si compiaceva delle preferenze che le venivano accordate, e faceva sentire all’altre quella sua superiorità; talvolta, non potendo più tollerar la solitudine de’ suoi timori e de’ suoi desidèri, andava, tutta buona, in cerca di quelle, quasi ad implorar benevolenza, consigli, coraggio. Tra queste deplorabili guerricciole con sé e con gli altri, aveva varcata la puerizia, e s’inoltrava in quell’età così critica, nella quale par che entri nell’animo quasi una potenza misteriosa, che solleva, adorna, rinvigorisce tutte l’inclinazioni, tutte l’idee, e qualche volta le trasforma, o le rivolge a un corso impreveduto. Ciò che Gertrude aveva fino allora più distintamente vagheggiato in que’ sogni dell’avvenire, era lo splendore esterno e la pompa: un non so che di molle e d’affettuoso, che da prima v’era diffuso leggermente e come in nebbia, cominciò allora a spiegarsi e a primeggiare nelle sue fantasie. S’era fatto, nella parte più riposta della mente, come uno splendido ritiro: ivi si rifugiava dagli oggetti presenti, ivi accoglieva certi personaggi stranamente composti di confuse memorie della puerizia, di quel poco che poteva vedere del mondo esteriore, di ciò che aveva imparato dai discorsi delle compagne; si tratteneva con essi, parlava loro, e si rispondeva in loro nome; ivi dava ordini, e riceveva omaggi d’ogni genere. Di quando in quando, i pensieri della religione venivano a disturbare quelle feste brillanti e faticose. Ma la religione, come l’avevano insegnata alla nostra poveretta, e come essa l’aveva ricevuta, non bandiva l’orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva come l’altre. Negl’intervalli in cui questa larva prendeva il primo posto, e grandeggiava nella fantasia di Gertrude, l’infelice, sopraffatta da terrori confusi, e compresa da una confusa idea di doveri, s’immaginava che la sua ripugnanza al chiostro, e la resistenza all’insinuazioni de’ suoi maggiori, nella scelta dello stato, fossero una colpa; e prometteva in cuor suo d’espiarla, chiudendosi volontariamente nel chiostro.
Era legge che una giovine non potesse venire accettata monaca, prima d’essere stata esaminata da un ecclesiastico, chiamato il vicario delle monache, o da qualche altro deputato a ciò, affinché fosse certo che ci andava di sua libera scelta: e questo esame non poteva aver luogo, se non un anno dopo ch’ella avesse esposto a quel vicario il suo desiderio, con una supplica in iscritto. Quelle monache che avevan preso il tristo incarico di far che Gertrude s’obbligasse per sempre, con la minor possibile cognizione di ciò che faceva, colsero un de’ momenti che abbiam detto, per farle trascrivere e sottoscrivere una tal supplica. E a fine d’indurla più facilmente a ciò, non mancaron di dirle e di ripeterle, che finalmente era una mera formalità, la quale (e questo era vero) non poteva avere efficacia, se non da altri atti posteriori, che dipenderebbero dalla sua volontà. Con tutto ciò, la supplica non era forse ancor giunta al suo destino, che Gertrude s’era già pentita d’averla sottoscritta. Si pentiva poi d’essersi pentita, passando così i giorni e i mesi in un’incessante vicenda di sentimenti contrari. Tenne lungo tempo nascosto alle compagne quel passo, ora per timore d’esporre alle contraddizioni una buona risoluzione, ora per vergogna di palesare uno sproposito. Vinse finalmente il desiderio di sfogar l’animo, e d’accattar consiglio e coraggio. C’era un’altra legge, che una giovine non fosse ammessa a quell’esame della vocazione, se non dopo aver dimorato almeno un mese fuori del monastero dove era stata in educazione. Era già scorso l’anno da che la supplica era stata mandata; e Gertrude fu avvertita che tra poco verrebbe levata dal monastero, e condotta nella casa paterna, per rimanervi quel mese, e far tutti i passi necessari al compimento dell’opera che aveva di fatto cominciata. Il principe e il resto della famiglia tenevano tutto ciò per certo, come se fosse già avvenuto; ma la giovine aveva tutt’altro in testa: in vece di far gli altri passi pensava alla maniera di tirare indietro il primo. In tali angustie, si risolvette d’aprirsi con una delle sue compagne, la più franca, e pronta sempre a dar consigli risoluti. Questa suggerì a Gertrude d’informar con una lettera il padre della sua nuova risoluzione; giacché non le bastava l’animo di spiattellargli sul viso un bravo: non voglio. E perché i pareri gratuiti, in questo mondo, son molto rari, la consigliera fece pagar questo a Gertrude, con tante beffe sulla sua dappocaggine. La lettera fu concertata tra quattro o cinque confidenti, scritta di nascosto, e fatta ricapitare per via d’artifizi molto studiati. Gertrude stava con grand’ansietà, aspettando una risposta che non venne mai. Se non che, alcuni giorni dopo, la badessa, la fece venir nella sua cella, e, con un contegno di mistero, di disgusto e di compassione, le diede un cenno oscuro d’una gran collera del principe, e d’un fallo ch’ella doveva aver commesso, lasciandole però intendere che, portandosi bene, poteva sperare che tutto sarebbe dimenticato. La giovinetta intese, e non osò domandar più in là.
Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quantunque Gertrude sapesse che andava a un combattimento, pure l’uscir di monastero, il lasciar quelle mura nelle quali era stata ott’anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l’aperta campagna, il riveder la città, la casa, furon sensazioni piene d’una gioia tumultuosa. In quanto al combattimento, la poveretta, con la direzione di quelle confidenti, aveva già prese le sue misure, e fatto, com’ora si direbbe, il suo piano. “O mi vorranno forzare”, pensava, “e io starò dura; sarò umile, rispettosa, ma non acconsentirò: non si tratta che di non dire un altro sì; e non lo dirò. Ovvero mi prenderanno con le buone; e io sarò più buona di loro; piangerò, pregherò, li moverò a compassione: finalmente non pretendo altro che di non esser sacrificata”. Ma, come accade spesso di simili previdenze, non avvenne né una cosa né l’altra. I giorni passavano, senza che il padre né altri le parlasse della supplica, né della ritrattazione, senza che le venisse fatta proposta nessuna, né con carezze, né con minacce. I parenti eran seri, tristi, burberi con lei, senza mai dirne il perché. Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come un’indegna: un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei, e la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quanto bisognava per farle sentire la sua suggezione. Di rado, e solo a certe ore stabilite, era ammessa alla compagnia de’ parenti e del primogenito. Tra loro tre pareva che regnasse una gran confidenza, la quale rendeva più sensibile e più doloroso l’abbandono in cui era lasciata Gertrude. Nessuno le rivolgeva il discorso; e quando essa arrischiava timidamente qualche parola, che non fosse per cosa necessaria, o non attaccava, o veniva corrisposta con uno sguardo distratto, o sprezzante, o severo. Che se, non potendo più soffrire una così amara e umiliante distinzione, insisteva, e tentava di famigliarizzarsi; se implorava un po’ d’amore, si sentiva subito toccare, in maniera indiretta ma chiara, quel tasto della scelta dello stato; le si faceva copertamente sentire che c’era un mezzo di riacquistar l’affetto della famiglia. Allora Gertrude, che non l’avrebbe voluto a quella condizione, era costretta di tirarsi indietro, di rifiutar quasi i primi segni di benevolenza che aveva tanto desiderati, di rimettersi da sé al suo posto di scomunicata; e per di più, vi rimaneva con una certa apparenza del torto.

Tali sensazioni d’oggetti presenti facevano un contrasto doloroso con quelle ridenti visioni delle quali Gertrude s’era già tanto occupata, e s’occupava tuttavia, nel segreto della sua mente. Aveva sperato che, nella splendida e frequentata casa paterna, avrebbe potuto godere almeno qualche saggio reale delle cose immaginate; ma si trovò del tutto ingannata. La clausura era stretta e intera, come nel monastero; d’andare a spasso non si parlava neppure; e un coretto che, dalla casa, guardava in una chiesa contigua, toglieva anche l’unica necessità che ci sarebbe stata d’uscire. La compagnia era più trista, più scarsa, meno variata che nel monastero. A ogni annunzio d’una visita, Gertrude doveva salire all’ultimo piano, per chiudersi con alcune vecchie donne di servizio: e lì anche desinava, quando c’era invito. I servitori s’uniformavano, nelle maniere e ne’ discorsi, all’esempio e all’intenzioni de’ padroni: e Gertrude, che, per sua inclinazione, avrebbe voluto trattarli con una famigliarità signorile, e che, nello stato in cui si trovava, avrebbe avuto di grazia che le facessero qualche dimostrazione d’affetto, come a una loro pari, e scendeva anche a mendicarne, rimaneva poi umiliata, e sempre più afflitta di vedersi corrisposta con una noncuranza manifesta, benché accompagnata da un leggiero ossequio di formalità. Dovette però accorgersi che un paggio, ben diverso da coloro, le portava un rispetto, e sentiva per lei una compassione d’un genere particolare. Il contegno di quel ragazzotto era ciò che Gertrude aveva fino allora visto di più somigliante a quell’ordine di cose tanto contemplato nella sua immaginativa, al contegno di quelle sue creature ideali. A poco a poco si scoprì un non so che di nuovo nelle maniere della giovinetta: una tranquillità e un’inquietudine diversa dalla solita, un fare di chi ha trovato qualche cosa che gli preme, che vorrebbe guardare ogni momento, e non lasciar vedere agli altri. Le furon tenuti gli occhi addosso più che mai: che è che non è, una mattina, fu sorpresa da una di quelle cameriere, mentre stava piegando alla sfuggita una carta, sulla quale avrebbe fatto meglio a non iscriver nulla. Dopo un breve tira tira, la carta rimase nelle mani della cameriera, e da queste passò in quelle del principe.
Il terrore di Gertrude, al rumor de’ passi di lui, non si può descrivere né immaginare: era quel padre, era irritato, e lei si sentiva colpevole. Ma quando lo vide comparire, con quel cipiglio, con quella carta in mano, avrebbe voluto esser cento braccia sotto terra, non che in un chiostro. Le parole non furon molte, ma terribili: il gastigo intimato subito non fu che d’esser rinchiusa in quella camera, sotto la guardia della donna che aveva fatta la scoperta; ma questo non era che un principio, che un ripiego del momento; si prometteva, si lasciava vedere per aria, un altro gastigo oscuro, indeterminato, e quindi più spaventoso. Il paggio fu subito sfrattato, com’era naturale; e fu minacciato anche a lui qualcosa di terribile, se, in qualunque tempo, avesse osato fiatar nulla dell’avvenuto. Nel fargli questa intimazione, il principe gli appoggiò due solenni schiaffi, per associare a quell’avventura un ricordo, che togliesse al ragazzaccio ogni tentazion di vantarsene. Un pretesto qualunque, per coonestare la licenza data a un paggio, non era difficile a trovarsi; in quanto alla figlia, si disse ch’era incomodata.
Rimase essa dunque col batticuore, con la vergogna, col rimorso, col terrore dell’avvenire, e con la sola compagnia di quella donna odiata da lei, come il testimonio della sua colpa, e la cagione della sua disgrazia. Costei odiava poi a vicenda Gertrude, per la quale si trovava ridotta, senza saper per quanto tempo, alla vita noiosa di carceriera, e divenuta per sempre custode d’un segreto pericoloso.
Il primo confuso tumulto di que’ sentimenti s’acquietò a poco a poco; ma tornando essi poi a uno per volta nell’animo, vi s’ingrandivano, e si fermavano a tormentarlo più distintamente e a bell’agio. Che poteva mai esser quella punizione minacciata in enimma? Molte e varie e strane se ne affacciavano alla fantasia ardente e inesperta di Gertrude. Quella che pareva più probabile, era di venir ricondotta al monastero di Monza, di ricomparirvi, non più come la signorina, ma in forma di colpevole, e di starvi rinchiusa, chi sa fino a quando! chi sa con quali trattamenti! Ciò che una tale immaginazione, tutta piena di dolori, aveva forse di più doloroso per lei, era l’apprensione della vergogna.
Le frasi, le parole, le virgole di quel foglio sciagurato, passavano e ripassavano nella sua memoria: le immaginava osservate, pesate da un lettore tanto impreveduto, tanto diverso da quello a cui eran destinate; si figurava che avesser potuto cader sotto gli occhi anche della madre o del fratello, o di chi sa altri: e, al paragon di ciò, tutto il rimanente le pareva quasi un nulla. L’immagine di colui ch’era stato la prima origine di tutto lo scandolo, non lasciava di venire spesso anch’essa ad infestar la povera rinchiusa: e pensate che strana comparsa doveva far quel fantasma, tra quegli altri così diversi da lui, seri, freddi, minacciosi. Ma, appunto perché non poteva separarlo da essi, né tornare un momento a quelle fuggitive compiacenze, senza che subito non le s’affacciassero i dolori presenti che n’erano la conseguenza, cominciò a poco a poco a tornarci più di rado, a rispingerne la rimembranza, a divezzarsene. Né più a lungo, o più volentieri, si fermava in quelle liete e brillanti fantasie d’una volta: eran troppo opposte alle circostanze reali, a ogni probabilità dell’avvenire. Il solo castello nel quale Gertrude potesse immaginare un rifugio tranquillo e onorevole, e che non fosse in aria, era il monastero, quando si risolvesse d’entrarci per sempre. Una tal risoluzione (non poteva dubitarne) avrebbe accomodato ogni cosa, saldato ogni debito, e cambiata in un attimo la sua situazione. Contro questo proposito insorgevano, è vero, i pensieri di tutta la sua vita: ma i tempi eran mutati; e, nell’abisso in cui Gertrude era caduta, e al paragone di ciò che poteva temere in certi momenti, la condizione di monaca festeggiata, ossequiata, ubbidita, le pareva uno zuccherino. Due sentimenti di ben diverso genere contribuivan pure a intervalli a scemare quella sua antica avversione: talvolta il rimorso del fallo, e una tenerezza fantastica di divozione; talvolta l’orgoglio amareggiato e irritato dalle maniere della carceriera, la quale (spesso, a dire il vero, provocata da lei) si vendicava, ora facendole paura di quel minacciato gastigo, ora svergognandola del fallo. Quando poi voleva mostrarsi benigna, prendeva un tono di protezione, più odioso ancora dell’insulto. In tali diverse occasioni, il desiderio che Gertrude sentiva d’uscir dall’unghie di colei, e di comparirle in uno stato al di sopra della sua collera e della sua pietà, questo desiderio abituale diveniva tanto vivo e pungente, da far parere amabile ogni cosa che potesse condurre ad appagarlo.
In capo a quattro o cinque lunghi giorni di prigionia, una mattina, Gertrude stuccata ed invelenita all’eccesso, per un di que’ dispetti della sua guardiana, andò a cacciarsi in un angolo della camera, e lì, con la faccia nascosta tra le mani, stette qualche tempo a divorar la sua rabbia. Sentì allora un bisogno prepotente di vedere altri visi, di sentire altre parole, d’esser trattata diversamente. Pensò al padre, alla famiglia: il pensiero se ne arretrava spaventato. Ma le venne in mente che dipendeva da lei di trovare in loro degli amici; e provò una gioia improvvisa. Dietro questa, una confusione e un pentimento straordinario del suo fallo, e un ugual desiderio d’espiarlo. Non già che la sua volontà si fermasse in quel proponimento, ma giammai non c’era entrata con tanto ardore. S’alzò di lì, andò a un tavolino, riprese quella penna fatale, e scrisse al padre una lettera piena d’entusiasmo e d’abbattimento, d’afflizione e di speranza, implorando il perdono, e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo.
Vi son de’ momenti in cui l’animo, particolarmente de’ giovani, è disposto in maniera che ogni poco d’istanza basta a ottenerne ogni cosa che abbia un’apparenza di bene e di sacrifizio: come un fiore appena sbocciato, s’abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla prim’aria che gli aliti punto d’intorno. Questi momenti, che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, son quelli appunto che l’astuzia interessata spia attentamente, e coglie di volo, per legare una volontà che non si guarda.
Al legger quella lettera, il principe *** vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui; e aspettandola, si dispose a batter il ferro, mentre era caldo. Gertrude comparve, e, senza alzar gli occhi in viso al padre, gli si buttò in ginocchioni davanti, ed ebbe appena fiato di dire: «perdono!» Egli le fece cenno che s’alzasse; ma, con una voce poco atta a rincorare, le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo; ch’era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque sia trovato in colpa, e tema la punizione; che in somma bisognava meritarlo. Gertrude domandò, sommessamente e tremando, che cosa dovesse fare. Il principe (non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre) non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude: e quelle parole frizzavano sull’animo della poveretta, come lo scorrere d’una mano ruvida sur una ferita. Continuò dicendo che, quand’anche… caso mai… che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile; giacché a un cavalier d’onore, com’era lui, non sarebbe mai bastato l’animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilata: allora il principe, raddolcendo a grado a grado la voce e le parole, proseguì dicendo che però a ogni fallo c’era rimedio e misericordia; che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato: ch’essa doveva vedere, in questo tristo accidente, come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei…
«Ah sì!» esclamò Gertrude, scossa dal timore, preparata dalla vergogna, e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea.
«Ah! lo capite anche voi,» riprese incontanente il principe. «Ebbene, non si parli più del passato: tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole, conveniente, che vi rimanesse; ma perché l’avete preso di buona voglia, e con buona maniera, tocca a me a farvelo riuscir gradito in tutto e per tutto: tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi. Ne prendo io la cura». Così dicendo, scosse un campanello che stava sul tavolino, e al servitore che entrò, disse: «la principessa e il principino subito». E seguitò poi con Gertrude: «voglio metterli subito a parte della mia consolazione; voglio che tutti comincin subito a trattarvi come si conviene. Avete sperimentato in parte il padre severo; ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso.»
A queste parole, Gertrude rimaneva come sbalordita. Ora ripensava come mai quel sì che le era scappato, avesse potuto significar tanto, ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo, di ristringerne il senso; ma la persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la benignità così condizionata, che Gertrude non osò proferire una parola che potesse turbarle menomamente.

Dopo pochi momenti, vennero i due chiamati, e vedendo lì Gertrude, la guardarono in viso, incerti e maravigliati. Ma il principe, con un contegno lieto e amorevole, che ne prescriveva loro un somigliante, «ecco,» disse, «la pecora smarrita: e sia questa l’ultima parola che richiami triste memorie. Ecco la consolazione della famiglia. Gertrude non ha più bisogno di consigli; ciò che noi desideravamo per suo bene, l’ha voluto lei spontaneamente. È risoluta, m’ha fatto intendere che è risoluta…» A questo passo, alzò essa verso il padre uno sguardo tra atterrito e supplichevole, come per chiedergli che sospendesse, ma egli proseguì francamente: «che è risoluta di prendere il velo.»
«Brava! bene!» esclamarono, a una voce, la madre e il figlio, e l’uno dopo l’altra abbracciaron Gertrude; la quale ricevette queste accoglienze con lacrime, che furono interpretate per lacrime di consolazione. Allora il principe si diffuse a spiegar ciò che farebbe per render lieta e splendida la sorte della figlia. Parlò delle distinzioni di cui goderebbe nel monastero e nel paese; che, là sarebbe come una principessa, come la rappresentante della famiglia; che, appena l’età l’avrebbe permesso, sarebbe innalzata alla prima dignità; e, intanto, non sarebbe soggetta che di nome. La principessa e il principino rinnovavano, ogni momento, le congratulazioni e gli applausi: Gertrude era come dominata da un sogno.
«Converrà poi fissare il giorno, per andare a Monza, a far la richiesta alla badessa,» disse il principe. «Come sarà contenta! Vi so dire che tutto il monastero saprà valutar l’onore che Gertrude gli fa. Anzi… perché non ci andiamo oggi? Gertrude prenderà volentieri un po’ d’aria.»
«Andiamo pure,» disse la principessa. «Vo a dar gli ordini, – disse il principino.»
«Ma…» proferì sommessamente Gertrude.
«Piano, piano,» riprese il principe: «lasciam decidere a lei: forse oggi non si sente abbastanza disposta, e le piacerebbe più aspettar fino a domani. Dite: volete che andiamo oggi o domani?»
«Domani,» rispose, con voce fiacca, Gertrude, alla quale pareva ancora di far qualche cosa, prendendo un po’ di tempo.
«Domani,» – disse solennemente il principe: «ha stabilito che si vada domani. Intanto io vo dal vicario delle monache, a fissare un giorno per l’esame.» Detto fatto, il principe uscì, e andò veramente (che non fu piccola degnazione) dal detto vicario; e concertarono che verrebbe di lì a due giorni.
In tutto il resto di quella giornata, Gertrude non ebbe un minuto di bene. Avrebbe desiderato riposar l’animo da tante commozioni, lasciar, per dir così, chiarire i suoi pensieri, render conto a se stessa di ciò che aveva fatto, di ciò che le rimaneva da fare, sapere ciò che volesse, rallentare un momento quella macchina che, appena avviata, andava così precipitosamente; ma non ci fu verso. L’occupazioni si succedevano senza interruzione, s’incastravano l’una con l’altra. Subito dopo partito il principe, fu condotta nel gabinetto della principessa, per essere, sotto la sua direzione, pettinata e rivestita dalla sua propria cameriera. Non era ancor terminato di dar l’ultima mano, che furon avvertite ch’era in tavola. Gertrude passò in mezzo agl’inchini della servitù, che accennava di congratularsi per la guarigione, e trovò alcuni parenti più prossimi, ch’erano stati invitati in fretta, per farle onore, e per rallegrarsi con lei de’ due felici avvenimenti, la ricuperata salute, e la spiegata vocazione.
La sposina (così si chiamavan le giovani monacande, e Gertrude, al suo apparire, fu da tutti salutata con quel nome), la sposina ebbe da dire e da fare a rispondere a’ complimenti che le fioccavan da tutte le parti. Sentiva bene che ognuna delle sue risposte era come un’accettazione e una conferma; ma come rispondere diversamente? Poco dopo alzati da tavola, venne l’ora della trottata. Gertrude entrò in carrozza con la madre, e con due zii ch’erano stati al pranzo. Dopo un solito giro, si riuscì alla strada Marina, che allora attraversava lo spazio occupato ora dal giardin pubblico, ed era il luogo dove i signori venivano in carrozza a ricrearsi delle fatiche della giornata. Gli zii parlarono anche a Gertrude, come portava la convenienza in quel giorno: e uno di loro, il qual pareva che, più dell’altro, conoscesse ogni persona, ogni carrozza, ogni livrea, e aveva ogni momento qualcosa da dire del signor tale e della signora tal altra, si voltò a lei tutt’a un tratto, e le disse: «ah furbetta! voi date un calcio a tutte queste corbellerie; siete una dirittona voi; piantate negl’impicci noi poveri mondani, vi ritirate a fare una vita beata, e andate in paradiso in carrozza.»
Sul tardi, si tornò a casa; e i servitori, scendendo in fretta con le torce, avvertirono che molte visite stavano aspettando. La voce era corsa; e i parenti e gli amici venivano a fare il loro dovere. S’entrò nella sala della conversazione. La sposina ne fu l’idolo, il trastullo, la vittima. Ognuno la voleva per sé: chi si faceva prometter dolci, chi prometteva visite, chi parlava della madre tale sua parente, chi della madre tal altra sua conoscente, chi lodava il cielo di Monza, chi discorreva, con gran sapore, della gran figura ch’essa avrebbe fatta là. Altri, che non avevan potuto ancora avvicinarsi a Gertrude così assediata, stavano spiando l’occasione di farsi innanzi, e sentivano un certo rimorso, fin che non avessero fatto il loro dovere. A poco a poco, la compagnia s’andò dileguando; tutti se n’andarono senza rimorso, e Gertrude rimase sola co’ genitori e il fratello.
«Finalmente,» disse il principe, «ho avuto la consolazione di veder mia figlia trattata da par sua. Bisogna però confessare che anche lei s’è portata benone, e ha fatto vedere che non sarà impicciata a far la prima figura, e a sostenere il decoro della famiglia.
Si cenò in fretta, per ritirarsi subito, ed esser pronti presto la mattina seguente.
Gertrude contristata, indispettita e, nello stesso tempo, un po’ gonfiata da tutti que’ complimenti, si rammentò in quel punto ciò che aveva patito dalla sua carceriera; e, vedendo il padre così disposto a compiacerla in tutto, fuor che in una cosa, volle approfittare dell’auge in cui si trovava, per acquietare almeno una delle passioni che la tormentavano. Mostrò quindi una gran ripugnanza a trovarsi con colei, lagnandosi fortemente delle sue maniere.
«Come!» disse il principe: «v’ha mancato di rispetto colei! Domani, domani, le laverò il capo come va. Lasciate fare a me, che le farò conoscere chi è lei, e chi siete voi. E a ogni modo, una figlia della quale io son contento, non deve vedersi intorno una persona che le dispiaccia». Così detto, fece chiamare un’altra donna, e le ordinò di servir Gertrude; la quale intanto, masticando e assaporando la soddisfazione che aveva ricevuta, si stupiva di trovarci così poco sugo, in paragone del desiderio che n’aveva avuto. Ciò che, anche suo malgrado, s’impossessava di tutto il suo animo, era il sentimento de’ gran progressi che aveva fatti, in quella giornata, sulla strada del chiostro, il pensiero che a ritirarsene ora ci vorrebbe molta più forza e risolutezza di quella che sarebbe bastata pochi giorni prima, e che pure non s’era sentita d’avere.
La donna che andò ad accompagnarla in camera, era una vecchia di casa, stata già governante del principino, che aveva ricevuto appena uscito dalle fasce, e tirato su fino all’adolescenza, e nel quale aveva riposte tutte le sue compiacenze, le sue speranze, la sua gloria. Era essa contenta della decisione fatta in quel giorno, come d’una sua propria fortuna; e Gertrude, per ultimo divertimento, dovette succiarsi le congratulazioni, le lodi, i consigli della vecchia, e sentir parlare di certe sue zie e prozie, le quali s’eran trovate ben contente d’esser monache, perché, essendo di quella casa, avevan sempre goduto i primi onori, avevan sempre saputo tenere uno zampino di fuori, e, dal loro parlatorio, avevano ottenuto cose che le più gran dame, nelle loro sale, non c’eran potute arrivare. Le parlò delle visite che avrebbe ricevute: un giorno poi, verrebbe il signor principino con la sua sposa, la quale doveva esser certamente una gran signorona; e allora, non solo il monastero, ma tutto il paese sarebbe in moto. La vecchia aveva parlato mentre spogliava Gertrude, quando Gertrude era a letto; parlava ancora, che Gertrude dormiva. La giovinezza e la fatica erano state più forti de’ pensieri. Il sonno fu affannoso, torbido, pieno di sogni penosi, ma non fu rotto che dalla voce strillante della vecchia, che venne a svegliarla, perché si preparasse per la gita di Monza.
«Andiamo, andiamo, signora sposina: è giorno fatto; e prima che sia vestita e pettinata, ci vorrà un’ora almeno. La signora principessa si sta vestendo; e l’hanno svegliata quattr’ore prima del solito. Il signor principino è già sceso alle scuderie, poi è tornato su, ed è all’ordine per partire quando si sia. Vispo come una lepre, quel diavoletto: ma! è stato così fin da bambino; e io posso dirlo, che l’ho portato in collo. Ma quand’è pronto, non bisogna farlo aspettare, perché, sebbene sia della miglior pasta del mondo, allora s’impazientisce e strepita. Poveretto! bisogna compatirlo: è il suo naturale; e poi questa volta avrebbe anche un po’ di ragione, perché s’incomoda per lei. Guai chi lo tocca in que’ momenti! non ha riguardo per nessuno, fuorché per il signor principe. Ma finalmente non ha sopra di sé che il signor principe, e un giorno, il signor principe sarà lui; più tardi che sia possibile, però. Lesta, lesta, signorina! Perché mi guarda così incantata? A quest’ora dovrebbe esser fuor della cuccia.»
All’immagine del principino impaziente, tutti gli altri pensieri che s’erano affollati alla mente risvegliata di Gertrude, si levaron subito, come uno stormo di passere all’apparir del nibbio. Ubbidì, si vestì in fretta, si lasciò pettinare, e comparve nella sala, dove i genitori e il fratello eran radunati. Fu fatta sedere sur una sedia a braccioli, e le fu portata una chicchera di cioccolata: il che, a que’ tempi, era quel che già presso i Romani il dare la veste virile. Quando vennero a avvertir ch’era attaccato, il principe tirò la figlia in disparte, e le disse: «orsù, Gertrude, ieri vi siete fatta onore: oggi dovete superar voi medesima. Si tratta di fare una comparsa solenne nel monastero e nel paese dove siete destinata a far la prima figura. V’aspettano…» È inutile dire che il principe aveva spedito un avviso alla badessa, il giorno avanti. «V’aspettano, e tutti gli occhi saranno sopra di voi. Dignità e disinvoltura. La badessa vi domanderà cosa volete: è una formalità. Potete rispondere che chiedete d’essere ammessa a vestir l’abito in quel monastero, dove siete stata educata così amorevolmente, dove avete ricevute tante finezze: che è la pura verità. Dite quelle poche parole, con un fare sciolto: che non s’avesse a dire che v’hanno imboccata, e che non sapete parlare da voi. Quelle buone madri non sanno nulla dell’accaduto: è un segreto che deve restar sepolto nella famiglia; e perciò non fate una faccia contrita e dubbiosa, che potesse dar qualche sospetto. Fate vedere di che sangue uscite: manierosa, modesta; ma ricordatevi che, in quel luogo, fuor della famiglia, non ci sarà nessuno sopra di voi.»
Senza aspettar risposta, il principe si mosse; Gertrude, la principessa e il principino lo seguirono; scesero tutti le scale, e montarono in carrozza. Gl’impicci e le noie del mondo, e la vita beata del chiostro, principalmente per le giovani di sangue nobilissimo, furono il tema della conversazione, durante il tragitto. Sul finir della strada, il principe rinnovò l’istruzioni alla figlia, e le ripeté più volte la formola della risposta. All’entrare in Monza, Gertrude si sentì stringere il cuore; ma la sua attenzione fu attirata per un istante da non so quali signori che, fatta fermar la carrozza, recitarono non so qual complimento. Ripreso il cammino, s’andò quasi di passo al monastero, tra gli sguardi de’ curiosi, che accorrevano da tutte le parti sulla strada. Al fermarsi della carrozza, davanti a quelle mura, davanti a quella porta, il cuore si strinse ancor più a Gertrude. Si smontò tra due ale di popolo, che i servitori facevano stare indietro. Tutti quegli occhi addosso alla poveretta l’obbligavano a studiar continuamente il suo contegno: ma più di tutti quelli insieme, la tenevano in suggezione i due del padre, a’ quali essa, quantunque ne avesse così gran paura, non poteva lasciar di rivolgere i suoi, ogni momento. E quegli occhi governavano le sue mosse e il suo volto, come per mezzo di redini invisibili. Attraversato il primo cortile, s’entrò in un altro, e lì si vide la porta del chiostro interno, spalancata e tutta occupata da monache. Nella prima fila, la badessa circondata da anziane; dietro, altre monache alla rinfusa, alcune in punta di piedi; in ultimo le converse ritte sopra panchetti. Si vedevan pure qua e là luccicare a mezz’aria alcuni occhietti, spuntar qualche visino tra le tonache: eran le più destre, e le più coraggiose tra l’educande, che, ficcandosi e penetrando tra monaca e monaca, eran riuscite a farsi un po’ di pertugio, per vedere anch’esse qualche cosa. Da quella calca uscivano acclamazioni; si vedevan molte braccia dimenarsi, in segno d’accoglienza e di gioia. Giunsero alla porta; Gertrude si trovò a viso a viso con la madre badessa. Dopo i primi complimenti, questa, con una maniera tra il giulivo e il solenne, le domandò cosa desiderasse in quel luogo, dove non c’era chi le potesse negar nulla.
«Son qui…,» cominciò Gertrude; ma, al punto di proferir le parole che dovevano decider quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò un momento, e rimase con gli occhi fissi sulla folla che le stava davanti. Vide, in quel momento, una di quelle sue note compagne, che la guardava con un’aria di compassione e di malizia insieme, e pareva che dicesse: “ah! la c’è cascata la brava.” Quella vista, risvegliando più vivi nell’animo suo tutti gli antichi sentimenti, le restituì anche un po’ di quel poco antico coraggio: e già stava cercando una risposta qualunque, diversa da quella che le era stata dettata; quando, alzato lo sguardo alla faccia del padre, quasi per esperimentar le sue forze, scorse su quella un’inquietudine così cupa, un’impazienza così minaccevole, che, risoluta per paura, con la stessa prontezza che avrebbe preso la fuga dinanzi un oggetto terribile, proseguì: «son qui a chiedere d’esser ammessa a vestir l’abito religioso, in questo monastero, dove sono stata allevata così amorevolmente». La badessa rispose subito, che le dispiaceva molto, in una tale occasione, che le regole non le permettessero di dare immediatamente una risposta, la quale doveva venire dai voti comuni delle suore, e alla quale doveva precedere la licenza de’ superiori. Che però Gertrude, conoscendo i sentimenti che s’avevan per lei in quel luogo, poteva preveder con certezza qual sarebbe questa risposta; e che intanto nessuna regola proibiva alla badessa e alle suore di manifestare la consolazione che sentivano di quella richiesta. S’alzò allora un frastono confuso di congratulazioni e d’acclamazioni. Vennero subito gran guantiere colme di dolci, che furon presentati, prima alla sposina, e dopo ai parenti. Mentre alcune monache facevano a rubarsela, e altre complimentavan la madre, altre il principino, la badessa fece pregare il principe che volesse venire alla grata del parlatorio, dove l’attendeva. Era accompagnata da due anziane; e quando lo vide comparire, «signor principe,» disse: «per ubbidire alle regole… per adempire una formalità indispensabile, sebbene in questo caso… pure devo dirle… che, ogni volta che una figlia chiede d’essere ammessa a vestir l’abito,… la superiora, quale io sono indegnamente,… è obbligata d’avvertire i genitori… che se, per caso… forzassero la volontà della figlia, incorrerebbero nella scomunica. Mi scuserà…»
«Benissimo, benissimo, reverenda madre. Lodo la sua esattezza: è troppo giusto… Ma lei non può dubitare…» –
«Oh! pensi, signor principe,… ho parlato per obbligo preciso,… del resto…»
«Certo, certo, madre badessa.»
Barattate queste poche parole, i due interlocutori s’inchinarono vicendevolmente, e si separarono, come se a tutt’e due pesasse di rimaner lì testa testa; e andarono a riunirsi ciascuno alla sua compagnia, l’uno fuori, l’altra dentro la soglia claustrale. Dato luogo a un po’ d’altre ciarle, «Oh via,» disse il principe: «Gertrude potrà presto godersi a suo bell’agio la compagnia di queste madri. Per ora le abbiamo incomodate abbastanza». Così detto, fece un inchino; la famiglia si mosse con lui; si rinnovarono i complimenti, e si partì.
Gertrude, nel tornare, non aveva troppa voglia di discorrere. Spaventata del passo che aveva fatto, vergognosa della sua dappocaggine, indispettita contro gli altri e contro sé stessa, faceva tristamente il conto dell’occasioni, che le rimanevano ancora di dir di no; e prometteva debolmente e confusamente a sé stessa che, in questa, o in quella, o in quell’altra, sarebbe più destra e più forte. Con tutti questi pensieri, non le era però cessato affatto il terrore di quel cipiglio del padre; talché, quando, con un’occhiata datagli alla sfuggita, poté chiarirsi che sul volto di lui non c’era più alcun vestigio di collera, quando anzi vide che si mostrava soddisfattissimo di lei, le parve una bella cosa, e fu, per un istante, tutta contenta.
Appena arrivati, bisognò rivestirsi e rilisciarsi; poi il desinare, poi alcune visite, poi la trottata, poi la conversazione, poi la cena. Sulla fine di questa, il principe mise in campo un altro affare, la scelta della madrina. Così si chiamava una dama, la quale, pregata da’ genitori, diventava custode e scorta della giovane monacanda, nel tempo tra la richiesta e l’entratura nel monastero; tempo che veniva speso in visitar le chiese, i palazzi pubblici, le conversazioni, le ville, i santuari: tutte le cose in somma più notabili della città e de’ contorni; affinché le giovani, prima di proferire un voto irrevocabile, vedessero bene a cosa davano un calcio. «Bisognerà pensare a una madrina,» disse il principe: «perché domani verrà il vicario delle monache, per la formalità dell’esame, e subito dopo, Gertrude verrà proposta in capitolo, per esser accettata dalle madri». Nel dir questo, s’era voltato verso la principessa; e questa, credendo che fosse un invito a proporre, cominciava: «ci sarebbe…» Ma il principe interruppe: «No, no, signora principessa: la madrina deve prima di tutto piacere alla sposina; e benché l’uso universale dia la scelta ai parenti, pure Gertrude ha tanto giudizio, tanta assennatezza, che merita bene che si faccia un’eccezione per lei.» E qui, voltandosi a Gertrude, in atto di chi annunzia una grazia singolare, continuò: «ognuna delle dame che si son trovate questa sera alla conversazione, ha quel che si richiede per esser madrina d’una figlia della nostra casa; non ce n’è nessuna, crederei, che non sia per tenersi onorata della preferenza: scegliete voi.»
Gertrude vedeva bene che far questa scelta era dare un nuovo consenso; ma la proposta veniva fatta con tanto apparato, che il rifiuto, per quanto fosse umile, poteva parer disprezzo, o almeno capriccio e leziosaggine. Fece dunque anche quel passo; e nominò la dama che, in quella sera, le era andata più a genio; quella cioè che le aveva fatto più carezze, che l’aveva più lodata, che l’aveva trattata con quelle maniere famigliari, affettuose e premurose, che, ne’ primi momenti d’una conoscenza, contraffanno una antica amicizia. «Ottima scelta,» disse il principe, che desiderava e aspettava appunto quella. Fosse arte o caso, era avvenuto come quando il giocator di bussolotti facendovi scorrere davanti agli occhi le carte d’un mazzo, vi dice che ne pensiate una, e lui poi ve la indovinerà; ma le ha fatte scorrere in maniera che ne vediate una sola. Quella dama era stata tanto intorno a Gertrude tutta la sera, l’aveva tanto occupata di sé, che a questa sarebbe bisognato uno sforzo di fantasia per pensarne un’altra. Tante premure poi non eran senza motivo: la dama aveva, da molto tempo, messo gli occhi addosso al principino, per farlo suo genero: quindi riguardava le cose di quella casa come sue proprie; ed era ben naturale che s’interessasse per quella cara Gertrude, niente meno de’ suoi parenti più prossimi.
Il giorno dopo, Gertrude si svegliò col pensiero dell’esaminatore che doveva venire; e mentre stava ruminando se potesse cogliere quella occasione così decisiva, per tornare in-dietro, e in qual maniera, il principe la fece chiamare. «Orsù, figliuola,» le disse: «finora vi siete portata egregiamente: oggi si tratta di coronar l’opera. Tutto quel che s’è fatto finora, s’è fatto di vostro consenso. Se in questo tempo vi fosse nato qualche dubbio, qualche pentimentuccio, grilli di gioventù, avreste dovuto spiegarvi; ma al punto a cui sono ora le cose, non è più tempo di far ragazzate. Quell’uomo dabbene che deve venire stamattina, vi farà cento domande sulla vostra vocazione: e se vi fate monaca di vostra volontà, e il perché e il per come, e che so io? Se voi titubate nel rispondere, vi terrà sulla corda chi sa quanto. Sarebbe un’uggia, un tormento per voi; ma ne potrebbe anche venire un altro guaio più serio. Dopo tutte le dimostrazioni pubbliche che si son fatte, ogni più piccola esitazione che si vedesse in voi, metterebbe a repentaglio il mio onore, potrebbe far credere ch’io avessi presa una vostra leggerezza per una ferma risoluzione, che avessi precipitato la cosa, che avessi… che so io? In questo caso, mi troverei nella necessità di scegliere tra due partiti dolorosi: o lasciar che il mondo formi un tristo concetto della mia condotta: partito che non può stare assolutamente con ciò che devo a me stesso. O svelare il vero motivo della vostra risoluzione e…» Ma qui, vedendo che Gertrude era diventata scarlatta, che le si gonfiavan gli occhi, e il viso si contraeva, come le foglie d’un fiore, nell’afa che precede la burrasca, troncò quel discorso, e, con aria serena, riprese: «via, via, tutto dipende da voi, dal vostro buon giudizio. So che n’avete molto, e non siete ragazza da guastar sulla fine una cosa fatta bene; ma io doveva preveder tutti i casi. Non se ne parli più; e restiam d’accordo che voi risponderete con franchezza, in maniera di non far nascer dubbi nella testa di quell’uomo dabbene. Così anche voi ne sarete fuori più presto». E qui, dopo aver suggerita qualche risposta all’interrogazioni più probabili, entrò nel solito discorso delle dolcezze e de’ godimenti ch’eran preparati a Gertrude nel monastero; e la trattenne in quel-lo, fin che venne un servitore ad annunziare il vicario. Il principe rinnovò in fretta gli avvertimenti più importanti, e lasciò la figlia sola con lui, com’era prescritto.
L’uomo dabbene veniva con un po’ d’opinione già fatta che Gertrude avesse una gran vocazione al chiostro: perché così gli aveva detto il principe, quando era stato a invitarlo. È vero che il buon prete, il quale sapeva che la diffidenza era una delle virtù più necessarie nel suo ufizio, aveva per massima d’andar adagio nel credere a simili proteste, e di stare in guardia contro le preoccupazioni; ma ben di rado avviene che le parole affermative e sicure d’una persona autorevole, in qualsivoglia genere, non tingano del loro colore la mente di chi le ascolta. Dopo i primi complimenti, «signorina,» le disse, «io vengo a far la parte del diavolo; vengo a mettere in dubbio ciò che, nella sua supplica lei ha dato per certo; vengo a metterle davanti agli occhi le difficoltà, e ad accertarmi se le ha ben considerate. Si contenti ch’io le faccia qualche interrogazione.»
«Dica pure,» rispose Gertrude.
Il buon prete cominciò allora a interrogarla, nella forma prescritta dalle regole. «Sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate minacce, o lusinghe? Non s’è fatto uso di nessuna autorità, per indurla a questo? Parli senza riguardi, e con sincerità, a un uomo il cui dovere è di conoscere la sua vera volontà, per impedire che non le venga usata violenza in nessun modo.»
La vera risposta a una tale domanda s’affacciò subito alla mente di Gertrude, con un’evidenza terribile. Per dare quella risposta, bisognava venire a una spiegazione, dire di che era stata minacciata, raccontare una storia… L’infelice rifuggì spaventata da questa idea; cercò in fretta un’altra risposta; ne trovò una sola che potesse liberarla presto e sicuramente da quel supplizio, la più contraria al vero. «Mi fo monaca,» disse, nascondendo il suo turbamento, «mi fo monaca, di mio genio, liberamente.»
Da quanto tempo le è nato codesto pensiero? «domandò ancora il buon prete.»
«L’ho sempre avuto,» rispose Gertrude, divenuta, dopo quel primo passo, più franca a mentire contro se stessa.
«Ma quale è il motivo principale che la induce a farsi monaca?» Il buon prete non sapeva che terribile tasto toccasse; e Gertrude si fece una gran forza per non lasciar trasparire sul viso l’effetto che quelle parole le producevano nell’animo. «Il motivo,» disse, «è di servire a Dio, e di fuggire i pericoli del mondo.»
«Non sarebbe mai qualche disgusto? qualche… mi scusi… capriccio? Alle volte, una cagione momentanea può fare un’impressione che par che deva durar sempre; e quando poi la cagione cessa, e l’animo si muta, allora…»
«No, no,» rispose precipitosamente Gertrude: «la cagione è quella che le ho detto.»
Il vicario, più per adempire interamente il suo obbligo, che per la persuasione che ce ne fosse bisogno, insistette con le domande; ma Gertrude era determinata d’ingannarlo. Oltre il ribrezzo che le cagionava il pensiero di render consapevole della sua debolezza quel grave e dabben prete, che pareva così lontano dal sospettar tal cosa di lei; la poveretta pensava poi anche ch’egli poteva bene impedire che si facesse monaca; ma lì finiva la sua autorità sopra di lei, e la sua protezione. Partito che fosse, essa rimarrebbe sola col principe. E qualunque cosa avesse poi a patire in quella casa, il buon prete non n’avrebbe saputo nulla, o sapendolo, con tutta la sua buona intenzione, non avrebbe potuto far altro che aver compassione di lei, quella compassione tranquilla e misurata, che, in generale, s’accorda, come per cortesia, a chi abbia dato cagione o pretesto al male che gli fanno.
L’esaminatore fu prima stanco d’interrogare, che la sventurata di mentire: e, sentendo quelle risposte sempre conformi, e non avendo alcun motivo di dubitare della loro schiettezza, mutò finalmente linguaggio; si rallegrò con lei, le chiese, in certo modo, scusa d’aver tardato tanto a far questo suo dovere; aggiunse ciò che credeva più atto a confermarla nel buon proposito; e si licenziò.
Attraversando le sale per uscire, s’abbatté nel principe, il quale pareva che passasse di là a caso; e con lui pure si congratulò delle buone disposizioni in cui aveva trovata la sua figliuola. Il principe era stato fino allora in una sospensione molto penosa: a quella notizia, respirò, e dimenticando la sua gravità consueta, andò quasi di corsa da Gertrude, la ricolmò di lodi, di carezze e di promesse, con un giubilo cordiale, con una tenerezza in gran parte sincera: così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano.
Noi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti. E neppure descriveremo, in particolare e per ordine, i sentimenti dell’animo suo in tutto quel tempo: sarebbe una storia di dolori e di fluttuazioni, troppo monotona, e troppo somigliante alle cose già dette. L’amenità de’ luoghi, la varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e in là all’aria aperta, le rendevan più odiosa l’idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l’ultima volta, per sempre. Più pungenti ancora eran l’impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle feste. La vista delle spose alle quali si dava questo titolo nel senso più ovvio e più usitato, le cagionava un’invidia, un rodimento intollerabile; e talvolta l’aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che, nel sentirsi dare quel titolo, dovesse trovarsi il colmo d’ogni felicità. Talvolta la pompa de’ palazzi, lo splendore degli addobbi, il brulichìo e il fracasso giulivo delle feste, le comunicavano un’ebbrezza, un ardor tale di viver lieto, che prometteva a se stessa di disdirsi, di soffrir tutto, piuttosto che tornare all’ombra fredda e morta del chiostro. Ma tutte quelle risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposata delle difficoltà, al solo fissar gli occhi in viso al principe. Talvolta anche, il pensiero di dover abbandonare per sempre que’ godimenti, gliene rendeva amaro e penoso quel piccol saggio; come l’infermo assetato guarda con rabbia, e quasi rispinge con dispetto il cucchiaio d’acqua che il medico gli concede a fatica. Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l’attestazione necessaria, e venne la licenza di tenere il capitolo per l’accettazione di Gertrude. Il capitolo si tenne; concorsero, com’era da aspettarsi, i due terzi de’ voti segreti ch’eran richiesti da’ regolamenti; e Gertrude fu accettata. Lei medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora d’entrar più presto che fosse possibile, nel monastero. Non c’era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà; e, condotta pomposamente al monastero, vestì l’abito. Dopo dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva, o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto; lo ripeté, e fu monaca per sempre.

E’ questa una delle pagine più “moderne” di tutto il romanzo. La radice da cui parte è certamente antecedente e si rifà alle figure del romanzo gotico inglese con la protagonista che assume il ruolo di “vergine perseguitata”, a cui risponde, nel romanzo, la monacazione forzata. Bastava questo a farne una vittima del sistema economico del Seicento basato sul maggiorascato. Succede che la monaca da perseguitata diventa persecutrice, di cui vittima, qui, è una povera novizia che intuisce gli illeciti amori tra la religiosa e una figura sfocata, un Don Rodrigo appena accennato, dal potere estremamente limitato, Egidio. Manzoni si astiene dal giudizio. Eppure commenta. Registra, in modo mirabile, la psicologia non innata, ma che prende forma in una mente plagiata dal padre, che ne ha costruito il destino, non lasciando a lei il diritto di scelta. Ma anche il padre sembra non esser colpevole: due commenti ce ne offrono la spia: quello in cui non può accettare di definirlo padre e quello in cui, dopo il colloquio con il vicario, abbraccia la figlia con affetto sincero. Egli coercizza la figlia perché è sua volta coercizzato dalla classe sociale a cui appartiene e dal sistema economico a cui deve adeguarsi. Da qui l’abile divisione di questi capitoli: il primo dedicato alla figura del padre, che, costretto ripeto, mette in atto dei ricatti psicologici verso una bambina che il potere stesso rende arrogante verso il mondo inferiore che le sta intorno; il secondo tutto dedicato a Gertrude e a come la sua spasmodica ambizione trovi il limite nelle mura del convento. L’ambizione, tuttavia, non era così diversa dalle altre figlie di buona famiglia: feste, inviti, una vita nobiliare di provincia, per riassumere. E’ che lei non può viverla: ecco allora che l’assassina di una povera novizia diventa l’infelice, la poverina, la sventurata. Sembra che Manzoni, su tale figura, si astenga dal giudizio perché in essa convergono temi religiosi e storici di grande importanza, come il rapporto tra peccato e libero arbitrio, responsabilità individuale e responsabilità collettiva, il bene ed il male, temi enormi all’interno di un romanzo e all’interno dell’animo di un religioso che non può che rimettersi a Dio.
 Francesco Hayez: L’Innominato
Francesco Hayez: L’Innominato
CAPITOLO XIX
L’INNOMINATO
Abbiamo detto che don Rodrigo, intestato più che mai di venire a fine della sua bella impresa, s’era risoluto di cercare il soccorso d’un terribile uomo. Di costui non possiam dare né il nome, né il cognome, né un titolo, e nemmeno una congettura sopra nulla di tutto ciò: cosa tanto più strana, che del personaggio troviamo memoria in più d’un libro (libri stampati, dico) di quel tempo. Che il personaggio sia quel medesimo, l’identità de’ fatti non lascia luogo a dubitarne; ma per tutto un grande studio a scansarne il nome, quasi avesse dovuto bruciar la penna, la mano dello scrittore. Francesco Rivola, nella vita del cardinal Federigo Borromeo, dovendo parlar di quell’uomo, lo chiama «un signore altrettanto potente per ricchezze, quanto nobile per nascita», e fermi lì. Giuseppe Ripamonti, che, nel quinto libro della quinta decade della sua Storia Patria, ne fa più distesa menzione, lo nomina uno, costui, colui, quest’uomo, quel personaggio. «Riferirò», dice, nel suo bel latino, da cui traduciamo come ci riesce, «il caso d’un tale che, essendo de’ primi tra i grandi della città, aveva stabilita la sua dimora in una campagna, situata sul confine; e lì, assicurandosi a forza di delitti, teneva per niente i giudizi, i giudici, ogni magistratura, la sovranità; menava una vita affatto indipendente; ricettatore di forusciti, foruscito un tempo anche lui; poi tornato, come se niente fosse…» Da questo scrittore prenderemo qualche altro passo, che ci venga in taglio per confermare e per dilucidare il racconto del nostro anonimo; col quale tiriamo avanti.
Fare ciò ch’era vietato dalle leggi, o impedito da una forza qualunque; esser arbitro, padrone negli affari altrui, senz’altro interesse che il gusto di comandare; esser temuto da tutti, aver la mano da coloro ch’eran soliti averla dagli altri; tali erano state in ogni tempo le passioni principali di costui. Fino dall’adolescenza, allo spettacolo e al rumore di tante prepotenze, di tante gare, alla vista di tanti tiranni, provava un misto sentimento di sdegno e d’invidia impaziente. Giovine, e vivendo in città, non tralasciava occasione, anzi n’andava in cerca, d’aver che dire co’ più famosi di quella professione, d’attraversarli, per provarsi con loro, e farli stare a dovere, o tirarli a cercare la sua amicizia. Superiore di ricchezze e di seguito alla più parte, e forse a tutti d’ardire e di costanza, ne ridusse molti a ritirarsi da ogni rivalità, molti ne conciò male, molti n’ebbe amici; non già amici del pari, ma, come soltanto potevan piacere a lui, amici subordinati, che si riconoscessero suoi inferiori, che gli stessero alla sinistra. Nel fatto però, veniva anche lui a essere il faccendiere, lo strumento di tutti coloro: essi non mancavano di richiedere ne’ loro impegni l’opera d’un tanto ausiliario; per lui, tirarsene indietro sarebbe stato decadere dalla sua riputazione, mancare al suo assunto. Di maniera che, per conto suo, e per conto d’altri, tante ne fece che, non bastando né il nome, né il parentado, né gli amici, né la sua audacia a sostenerlo contro i bandi pubblici, e contro tante animosità potenti, dovette dar luogo, e uscir dallo stato. Credo che a questa circostanza si riferisca un tratto notabile raccontato dal Ripamonti. «Una volta che costui ebbe a sgomberare il paese, la segretezza che usò, il rispetto, la timidezza, furon tali: attraversò la città a cavallo, con un seguito di cani, a suon di tromba; e passando davanti al palazzo di corte, lasciò alla guardia un’imbasciata d’impertinenze per il governatore».
Nell’assenza, non ruppe le pratiche, né tralasciò le corrispondenze con que’ suoi tali amici, i quali rimasero uniti con lui, per tradurre letteralmente dal Ripamonti, «in lega occulta di consigli atroci, e di cose funeste». Pare anzi che allora contraesse con più alte persone, certe nuove terribili pratiche, delle quali lo storico summentovato parla con una brevità misteriosa. «Anche alcuni principi esteri, – dice, – si valsero più volte dell’opera sua, per qualche importante omicidio, e spesso gli ebbero a mandar da lontano rinforzi di gente che servisse sotto i suoi ordini».
Finalmente (non si sa dopo quanto tempo), o fosse levato il bando, per qualche potente intercessione, o l’audacia di quell’uomo gli tenesse luogo d’immunità, si risolvette di tornare a casa, e vi tornò difatti; non però in Milano, ma in un castello confinante col territorio bergamasco, che allora era, come ognun sa, stato veneto. «Quella casa – cito ancora il Ripamonti, – era come un’officina di mandati sanguinosi: servitori, la cui testa era messa a taglia, e che avevan per mestiere di troncar teste: né cuoco, né sguattero dispensati dall’omicidio: le mani de’ ragazzi insanguinate». Oltre questa bella famiglia domestica, n’aveva, come afferma lo stesso storico, un’altra di soggetti simili, dispersi e posti come a quartiere in vari luoghi de’ due stati sul lembo de’ quali viveva, e pronti sempre a’ suoi ordini.
Tutti i tiranni, per un bel tratto di paese all’intorno, avevan dovuto, chi in un’occasione e chi in un’altra, scegliere tra l’amicizia e l’inimicizia di quel tiranno straordinario. Ma ai primi che avevano voluto provar di resistergli, la gli era andata così male, che nessuno si sentiva più di mettersi a quella prova. E neppur col badare a’ fatti suoi, con lo stare a sé, uno non poteva rimanere indipendente da lui. Capitava un suo messo a intimargli che abbandonasse la tale impresa, che cessasse di molestare il tal debitore, o cose simili: bisognava rispondere sì o no. Quando una parte, con un omaggio vassallesco, era andata a rimettere in lui un affare qualunque, l’altra parte si trovava a quella dura scelta, o di stare alla sua sentenza, o di dichiararsi suo nemico; il che equivaleva a esser, come si diceva altre volte, tisico in terzo grado. Molti, avendo il torto, ricorrevano a lui per aver ragione in effetto; molti anche, avendo ragione, per preoccupare un così gran patrocinio, e chiuderne l’adito all’avversario: gli uni e gli altri divenivano più specialmente suoi dipendenti. Accadde qualche volta che un debole oppresso, vessato da un prepotente, si rivolse a lui; e lui, prendendo le parti del debole, forzò il prepotente a finirla, a riparare il mal fatto, a chiedere scusa; o, se stava duro, gli mosse tal guerra, da costringerlo a sfrattar dai luoghi che aveva tiranneggiati, o gli fece anche pagare un più pronto e più terribile fio. E in quei casi, quel nome tanto temuto e abborrito era stato benedetto un momento: perché, non dirò quella giustizia, ma quel rimedio, quel compenso qualunque, non si sarebbe potuto, in que’ tempi, aspettarlo da nessun’altra forza né privata, né pubblica. Più spesso, anzi per l’ordinario, la sua era stata ed era ministra di voleri iniqui, di soddisfazioni atroci, di capricci superbi. Ma gli usi così diversi di quella forza producevan sempre l’effetto medesimo, d’imprimere negli animi una grand’idea di quanto egli potesse volere e eseguire in onta dell’equità e dell’iniquità, quelle due cose che metton tanti ostacoli alla volontà degli uomini, e li fanno così spesso tornare indietro. La fama de’ tiranni ordinari rimaneva per lo più ristretta in quel piccolo tratto di paese dov’erano i più ricchi e i più forti: ogni distretto aveva i suoi; e si rassomigliavan tanto, che non c’era ragione che la gente s’occupasse di quelli che non aveva a ridosso. Ma la fama di questo nostro era già da gran tempo diffusa in ogni parte del milanese: per tutto, la sua vita era un soggetto di racconti popolari; e il suo nome significava qualcosa d’irresistibile, di strano, di favoloso. Il sospetto che per tutto s’aveva de’ suoi collegati e de’ suoi sicari, contribuiva anch’esso a tener viva per tutto la memoria di lui. Non eran più che sospetti; giacché chi avrebbe confessata apertamente una tale dipendenza? ma ogni tiranno poteva essere un suo collegato, ogni malandrino, uno de’ suoi; e l’incertezza stessa rendeva più vasta l’opinione, e più cupo il terrore della cosa. E ogni volta che in qualche parte si vedessero comparire figure di bravi sconosciute e più brutte dell’ordinario, a ogni fatto enorme di cui non si sapesse alla prima indicare o indovinar l’autore, si proferiva, si mormorava il nome di colui che noi, grazie a quella benedetta, per non dir altro, circospezione de’ nostri autori, saremo costretti a chiamare l’Innominato.
La descrizione dell’Innominato sembra rispondere ad una duplice esigenza:
- nella sua straordinaria “malvagità”, maggiore appare la “vittoria” del cardinale a riportarlo alla religione;
- estetica romantica a cui piace la rappresentazione a tutto tondo, di eroi, per quanto malvagi.
Ma quello che qui emerge è che l’Innominato è un uomo solo: è il primus inter pares, non c’è assassino, rapinatore, delinquente che può stargli alla pari, mortifica il potere per affermare il suo io. Novello Napoleone relegato a Sant’Elena, anche l’Innominato è sommerso dalle sue colpe. Questo lo predispone ad ascoltare dapprima le campane, poi la felicità degli umili, quindi la presenza di Dio, per intercessione di Lucia, che qui diventa figura Christi.

«Dio, Dio,» interruppe l’innominato: «sempre Dio: coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre han questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi…?» e lasciò la frase a mezzo.
«Oh Signore! pretendere! Cosa posso pretendere io meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia! Mi lasci andare; per carità mi lasci andare! Non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patir tanto una povera creatura. Oh! lei che può comandare, dica che mi lascino andare! M’hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna a *** dov’è mia madre. Oh Vergine santissima! mia madre! mia madre, per carità, mia madre! Forse non è lontana di qui… ho veduto i miei monti! Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei, tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Oh ecco! vedo che si move a compassione: dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia!»
ed infine il Cardinal Federico Borromeo

CAPITOLO XXII
CARDINAL FEDERIGO
Federigo Borromeo, nato nel 1564, fu degli uomini rari in qualunque tempo, che abbiano impiegato un ingegno egregio, tutti i mezzi d’una grand’opulenza, tutti i vantaggi d’una condizione privilegiata, un intento continuo, nella ricerca e nell’esercizio del meglio. La sua vita è come un ruscello che, scaturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né intorbidarsi mai, in un lungo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume. Tra gli agi e le pompe, badò fin dalla puerizia a quelle parole d’annegazione e d’umiltà, a quelle massime intorno alla vanità de’ piaceri, all’ingiustizia dell’orgoglio, alla vera dignità e a’ veri beni, che, sentite o non sentite ne’ cuori, vengono trasmesse da una generazione all’altra, nel più elementare insegnamento della religione. Badò, dico, a quelle parole, a quelle massime, le prese sul serio, le gustò, le trovò vere; vide che non potevan dunque esser vere altre parole e altre massime opposte, che pure si trasmettono di generazione in generazione, con la stessa sicurezza, e talora dalle stesse labbra; e propose di prender per norma dell’azioni e de’ pensieri quelle che erano il vero. Persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso per molti, e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno renderà conto, cominciò da fanciullo a pensare come potesse render la sua utile e santa.
Nel 1580 manifestò la risoluzione di dedicarsi al ministero ecclesiastico, e ne prese l’abito dalle mani di quel suo cugino Carlo, che una fama, già fin d’allora antica e universale, predicava santo. Entrò poco dopo nel collegio fondato da questo in Pavia, e che porta ancora il nome del loro casato; e lì, applicandosi assiduamente alle occupazioni che trovò prescritte, due altre ne assunse di sua volontà; e furono d’insegnar la dottrina cristiana ai più rozzi e derelitti del popolo, e di visitare, servire, consolare e soccorrere gl’infermi. Si valse dell’autorità che tutto gli conciliava in quel luogo, per attirare i suoi compagni a secondarlo in tali opere; e in ogni cosa onesta e profittevole esercitò come un primato d’esempio, un primato che le sue doti personali sarebbero forse bastate a procacciargli, se fosse anche stato l’infimo per condizione. I vantaggi d’un altro genere, che la sua gli avrebbe potuto procurare, non solo non li ricercò, ma mise ogni studio a schivarli. Volle una tavola piuttosto povera che frugale, usò un vestiario piuttosto povero che semplice; a conformità di questo, tutto il tenore della vita e il contegno. Né credette mai di doverlo mutare, per quanto alcuni congiunti gridassero e si lamentassero che avvilisse così la dignità della casa. Un’altra guerra ebbe a sostenere con gl’istitutori, i quali, furtivamente e come per sorpresa, cercavano di mettergli davanti, addosso, intorno, qualche suppellettile più signorile, qualcosa che lo facesse distinguer dagli altri, e figurare come il principe del luogo: o credessero di farsi alla lunga ben volere con ciò; o fossero mossi da quella svisceratezza servile che s’invanisce e si ricrea nello splendore altrui; o fossero di que’ prudenti che s’adombrano delle virtù come de’ vizi, predicano sempre che la perfezione sta nel mezzo; e il mezzo lo fissan giusto in quel punto dov’essi sono arrivati, e ci stanno comodi. Federigo, non che lasciarsi vincere da que’ tentativi, riprese coloro che li facevano; e ciò tra la pubertà e la giovinezza.
Che, vivente il cardinal Carlo, maggior di lui di ventisei anni, davanti a quella presenza grave, solenne, ch’esprimeva così al vivo la santità, e ne rammentava le opere, e alla quale, se ce ne fosse stato bisogno, avrebbe aggiunto autorità ogni momento l’ossequio manifesto e spontaneo de’ circostanti, quali e quanti si fossero, Federigo fanciullo e giovinetto cercasse di conformarsi al contegno e al pensare d’un tal superiore, non è certamente da farsene maraviglia; ma è bensì cosa molto notabile che, dopo la morte di lui, nessuno si sia potuto accorgere che a Federigo, allor di vent’anni, fosse mancata una guida e un censore. La fama crescente del suo ingegno, della sua dottrina e della sua pietà, la parentela e gl’impegni di più d’un cardinale potente, il credito della sua famiglia, il nome stesso, a cui Carlo aveva quasi annessa nelle menti un’idea di santità e di preminenza, tutto ciò che deve, e tutto ciò che può condurre gli uomini alle dignità ecclesiastiche, concorreva a pronosticargliele. Ma egli, persuaso in cuore di ciò che nessuno il quale professi cristianesimo può negar con la bocca, non ci esser giusta superiorità d’uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio, temeva le dignità, e cercava di scansarle; non certamente perché sfuggisse di servire altrui; che poche vite furono spese in questo come la sua; ma perché non si stimava abbastanza degno né capace di così alto e pericoloso servizio. Perciò, venendogli, nel 1595, proposto da Clemente VIII l’arcivescovado di Milano, apparve fortemente turbato, e ricusò senza esitare. Cedette poi al comando espresso del papa.
Tali dimostrazioni, e chi non lo sa? non sono né difficili né rare; e l’ipocrisia non ha bisogno d’un più grande sforzo d’ingegno per farle, che la buffoneria per deriderle a buon conto, in ogni caso. Ma cessan forse per questo d’esser l’espressione naturale d’un sentimento virtuoso e sapiente? La vita è il paragone delle parole: e le parole ch’esprimono quel sentimento, fossero anche passate sulle labbra di tutti gl’impostori e di tutti i beffardi del mondo, saranno sempre belle, quando siano precedute e seguite da una vita di disinteresse e di sacrifizio.
In Federigo arcivescovo apparve uno studio singolare e continuo di non prender per sé, delle ricchezze, del tempo, delle cure, di tutto se stesso in somma, se non quanto fosse strettamente necessario. Diceva, come tutti dicono, che le rendite ecclesiastiche sono patrimonio de’ poveri: come poi intendesse infatti una tal massima, si veda da questo. Volle che si stimasse a quanto poteva ascendere il suo mantenimento e quello della sua servitù; e dettogli che seicento scudi (scudo si chiamava allora quella moneta d’oro che, rimanendo sempre dello stesso peso e titolo, fu poi detta zecchino), diede ordine che tanti se ne contasse ogni anno dalla sua cassa particolare a quella della mensa; non credendo che a lui ricchissimo fosse lecito vivere di quel patrimonio. Del suo poi era così scarso e sottile misuratore a se stesso, che badava di non ismettere un vestito, prima che fosse logoro affatto: unendo però, come fu notato da scrittori contemporanei, al genio della semplicità quello d’una squisita pulizia: due abitudini notabili infatti, in quell’età sudicia e sfarzosa. Similmente, affinché nulla si disperdesse degli avanzi della sua mensa frugale, gli assegnò a un ospizio di poveri; e uno di questi, per suo ordine, entrava ogni giorno nella sala del pranzo a raccoglier ciò che fosse rimasto. Cure, che potrebbero forse indur concetto d’una virtù gretta, misera, angustiosa, d’una mente impaniata nelle minuzie, e incapace di disegni elevati; se non fosse in piedi questa biblioteca ambrosiana, che Federigo ideò con sì animosa lautezza, ed eresse, con tanto dispendio, da’ fondamenti; per fornir la quale di libri e di manoscritti, oltre il dono de’ già raccolti con grande studio e spesa da lui, spedì otto uomini, de’ più colti ed esperti che poté avere, a farne incetta, per l’Italia, per la Francia, per la Spagna, per la Germania, per le Fiandre, nella Grecia, al Libano, a Gerusalemme. Così riuscì a radunarvi circa trentamila volumi stampati, e quattordicimila manoscritti. Alla biblioteca unì un collegio di dottori (furon nove, e pensionati da lui fin che visse; dopo, non bastando a quella spesa l’entrate ordinarie, furon ristretti a due); e il loro ufizio era di coltivare vari studi, teologia, storia, lettere, antichità ecclesiastiche, lingue orientali, con l’obbligo ad ognuno di pubblicar qualche lavoro sulla materia assegnatagli; v’unì un collegio da lui detto trilingue, per lo studio delle lingue greca, latina e italiana; un collegio d’alunni, che venissero istruiti in quelle facoltà e lingue, per insegnarle un giorno; v’unì una stamperia di lingue orientali, dell’ebraica cioè, della caldea, dell’arabica, della persiana, dell’armena; una galleria di quadri, una di statue, e una scuola delle tre principali arti del disegno. Per queste, poté trovar professori già formati; per il rimanente, abbiam visto che da fare gli avesse dato la raccolta de’ libri e de’ manoscritti; certo più difficili a trovarsi dovevano essere i tipi di quelle lingue, allora molto men coltivate in Europa che al presente; più ancora de’ tipi, gli uomini. Basterà il dire che, di nove dottori, otto ne prese tra i giovani alunni del seminario; e da questo si può argomentare che giudizio facesse degli studi consumati e delle riputazioni fatte di quel tempo: giudizio conforme a quello che par che n’abbia portato la posterità, col mettere gli uni e le altre in dimenticanza.
Nelle regole che stabilì per l’uso e per il governo della biblioteca, si vede un intento d’utilità perpetua, non solamente bello in sé, ma in molte parti sapiente e gentile molto al di là dell’idee e dell’abitudini comuni di quel tempo. Prescrisse al bibliotecario che mantenesse commercio con gli uomini più dotti d’Europa, per aver da loro notizie dello stato delle scienze, e avviso de’ libri migliori che venissero fuori in ogni genere, e farne acquisto; gli prescrisse d’indicare agli studiosi i libri che non conoscessero, e potesser loro esser utili; ordinò che a tutti, fossero cittadini o forestieri, si desse comodità e tempo di servirsene, secondo il bisogno. Una tale intenzione deve ora parere ad ognuno troppo naturale, e immedesimata con la fondazione d’una biblioteca: allora non era così. E in una storia dell’ambrosiana, scritta (col costrutto e con l’eleganze comuni del secolo) da un Pierpaolo Bosca, che vi fu bibliotecario dopo la morte di Federigo, vien notato espressamente, come cosa singolare, che in questa libreria, eretta da un privato, quasi tutta a sue spese, i libri fossero esposti alla vista del pubblico, dati a chiunque li chiedesse, e datogli anche da sedere, e carta, penne e calamaio, per prender gli appunti che gli potessero bisognare; mentre in qualche altra insigne biblioteca pubblica d’Italia, i libri non erano nemmen visibili, ma chiusi in armadi, donde non si levavano se non per gentilezza de’ bibliotecari, quando si sentivano di farli vedere un momento; di dare ai concorrenti il comodo di studiare, non se n’aveva neppur l’idea. Dimodoché arricchir tali biblioteche era un sottrar libri all’uso comune: una di quelle coltivazioni, come ce n’era e ce n’è tuttavia molte, che isteriliscono il campo.
Non domandate quali siano stati gli effetti di questa fondazione del Borromeo sulla coltura pubblica: sarebbe facile dimostrare in due frasi, al modo che si dimostra, che furon miracolosi, o che non furon niente; cercare e spiegare, fino a un certo segno, quali siano stati veramente, sarebbe cosa di molta fatica, di poco costrutto, e fuor di tempo. Ma pensate che generoso, che giudizioso, che benevolo, che perseverante amatore del miglioramento umano, dovesse essere colui che volle una tal cosa, la volle in quella maniera, e l’eseguì, in mezzo a quell’ignorantaggine, a quell’inerzia, a quell’antipatia generale per ogni applicazione studiosa, e per conseguenza in mezzo ai “cos’importa? e c’era altro da pensare? e che bell’invenzione! e mancava anche questa,” e simili; che saranno certissimamente stati più che gli scudi spesi da lui in quell’impresa; i quali furon centocinquemila, la più parte de’ suoi.
Per chiamare un tal uomo sommamente benefico e liberale, può parer che non ci sia bisogno di sapere se n’abbia spesi molt’altri in soccorso immediato de’ bisognosi; e ci son forse ancora di quelli che pensano che le spese di quel genere, e sto per dire tutte le spese, siano la migliore e la più utile elemosina. Ma Federigo teneva l’elemosina propriamente detta per un dovere principalissimo; e qui, come nel resto, i suoi fatti furon consentanei all’opinione. La sua vita fu un continuo profondere ai poveri; e a proposito di questa stessa carestia di cui ha già parlato la nostra storia, avremo tra poco occasione di riferire alcuni tratti, dai quali si vedrà che sapienza e che gentilezza abbia saputo mettere anche in questa liberalità. De’ molti esempi singolari che d’una tale sua virtù hanno notati i suoi biografi, ne citeremo qui un solo. Avendo risaputo che un nobile usava artifizi e angherie per far monaca una sua figlia, la quale desiderava piuttosto di maritarsi, fece venire il padre; e cavatogli di bocca che il vero motivo di quella vessazione era il non avere quattromila scudi che, secondo lui, sarebbero stati necessari a maritar la figlia convenevolmente, Federigo la dotò di quattromila scudi. Forse a taluno parrà questa una larghezza eccessiva, non ben ponderata, troppo condiscendente agli stolti capricci d’un superbo; e che quattromila scudi potevano esser meglio impiegati in cent’altre maniere. A questo non abbiamo nulla da rispondere, se non che sarebbe da desiderarsi che si vedessero spesso eccessi d’una virtù così libera dall’opinioni dominanti (ogni tempo ha le sue), così indipendente dalla tendenza generale, come, in questo caso, fu quella che mosse un uomo a dar quattromila scudi, perché una giovine non fosse fatta monaca.
La carità inesausta di quest’uomo, non meno che nel dare, spiccava in tutto il suo contegno. Di facile abbordo con tutti, credeva di dovere specialmente a quelli che si chiamano di bassa condizione, un viso gioviale, una cortesia affettuosa; tanto più, quanto ne trovan meno nel mondo. E qui pure ebbe a combattere co’ galantuomini del ne quid nimis*, i quali, in ogni cosa, avrebbero voluto farlo star ne’ limiti, cioè ne’ loro limiti. Uno di costoro, una volta che, nella visita d’un paese alpestre e salvatico, Federigo istruiva certi poveri fanciulli, e, tra l’interrogare e l’insegnare, gli andava amorevolmente accarezzando, l’avvertì che usasse più riguardo nel far tante carezze a que’ ragazzi, perché eran troppo sudici e stomacosi: come se supponesse, il buon uomo, che Federigo non avesse senso abbastanza per fare una tale scoperta, o non abbastanza perspicacia, per trovar da sé quel ripiego così fino. Tale è, in certe condizioni di tempi e di cose, la sventura degli uomini costituiti in certe dignità: che mentre così di rado si trova chi gli avvisi de’ loro mancamenti, non manca poi gente coraggiosa a riprenderli del loro far bene. Ma il buon vescovo, non senza un certo risentimento, rispose: «sono mie anime, e forse non vedranno mai più la mia faccia; e non volete che gli abbracci?»
Ben raro però era il risentimento in lui, ammirato per la soavità de’ suoi modi, per una pacatezza imperturbabile, che si sarebbe attribuita a una felicità straordinaria di temperamento; ed era l’effetto d’una disciplina costante sopra un’indole viva e risentita.
Se qualche volta si mostrò severo, anzi brusco, fu co’ pastori suoi subordinati che scoprisse rei d’avarizia o di negligenza o d’altre tracce specialmente opposte allo spirito del loro nobile ministero. Per tutto ciò che potesse toccare o il suo interesse, o la sua gloria temporale, non dava mai segno di gioia, né di rammarico, né d’ardore, né d’agitazione: mirabile se questi moti non si destavano nell’animo suo, più mirabile se vi si destavano. Non solo da’ molti conclavi ai quali assistette, riportò il concetto di non aver mai aspirato a quel posto così desiderabile all’ambizione, e così terribile alla pietà; ma una volta che un collega, il quale contava molto, venne a offrirgli il suo voto e quelli della sua fazione (brutta parola, ma era quella che usavano), Federigo rifiutò una tal proposta in modo, che quello depose il pensiero, e si rivolse altrove. Questa stessa modestia, quest’avversione al predominare apparivano ugualmente nell’occasioni più comuni della vita. Attento e infaticabile a disporre e a governare, dove riteneva che fosse suo dovere il farlo, sfuggì sempre d’impicciarsi negli affari altrui; anzi si scusava a tutto potere dall’ingerirvisi ricercato: discrezione e ritegno non comune, come ognuno sa, negli uomini zelatori del bene, qual era Federigo.
Se volessimo lasciarci andare al piacere di raccogliere i tratti notabili del suo carattere, ne risulterebbe certamente un complesso singolare di meriti in apparenza opposti, e certo difficili a trovarsi insieme. Però non ometteremo di notare un’altra singolarità di quella bella vita: che, piena come fu d’attività, di governo, di funzioni, d’insegnamento, d’udienze, di visite diocesane, di viaggi, di contrasti, non solo lo studio c’ebbe una parte, ma ce n’ebbe tanta, che per un letterato di professione sarebbe bastato. E infatti, con tant’altri e diversi titoli di lode, Federigo ebbe anche, presso i suoi contemporanei, quello d’uom dotto.
Non dobbiamo però dissimulare che tenne con ferma persuasione, e sostenne in pratica, con lunga costanza, opinioni, che al giorno d’oggi parrebbero a ognuno piuttosto strane che mal fondate; dico anche a coloro che avrebbero una gran voglia di trovarle giuste. Chi lo volesse difendere in questo, ci sarebbe quella scusa così corrente e ricevuta, ch’erano errori del suo tempo, piuttosto che suoi: scusa che, per certe cose, e quando risulti dall’esame particolare de’ fatti, può aver qualche valore, o anche molto; ma che applicata così nuda e alla cieca, come si fa d’ordinario, non significa proprio nulla. E perciò, non volendo risolvere con formole semplici questioni complicate, né allungar troppo un episodio, tralasceremo anche d’esporle; bastandoci d’avere accennato così alla sfuggita che, d’un uomo così ammirabile in complesso, noi non pretendiamo che ogni cosa lo fosse ugualmente; perché non paia che abbiam voluto scrivere un’orazion funebre.
Non è certamente fare ingiuria ai nostri lettori il supporre che qualcheduno di loro domandi se di tanto ingegno e di tanto studio quest’uomo abbia lasciato qualche monumento. Se n’ha lasciati! Circa cento son l’opere che rimangon di lui, tra grandi e piccole, tra latine e italiane, tra stampate e manoscritte, che si serbano nella biblioteca da lui fondata: trattati di morale, orazioni, dissertazioni di storia, d’antichità sacra e profana, di letteratura, d’arti e d’altro. «E come mai,» dirà codesto lettore, «tante opere sono dimenticate, o almeno così poco conosciute, così poco ricercate? Come mai, con tanto ingegno, con tanto studio, con tanta pratica degli uomini e delle cose, con tanto meditare, con tanta passione per il buono e per il bello, con tanto candor d’animo, con tant’altre di quelle qualità che fanno il grande scrittore, questo, in cento opere, non ne ha lasciata neppur una di quelle che son riputate insigni anche da chi non le approva in tutto, e conosciute di titolo anche da chi non le legge? Come mai, tutte insieme, non sono bastate a procurare, almeno col numero, al suo nome una fama letteraria presso noi posteri?»
La domanda è ragionevole senza dubbio, e la questione, molto interessante; perché le ragioni di questo fenomeno si troverebbero con l’osservar molti fatti generali: e trovate, condurrebbero alla spiegazione di più altri fenomeni simili. Ma sarebbero molte e prolisse.
* “nulla di troppo”
Alla eccezionalità del male deve narrativamente corrispondere l’eccezionalità del bene, e Manzoni lo fa con una vera e propria apologia per la figura del cardinale, affinché i due titani possano scontrarsi/incontrarsi e raggiungere il massimo pathos narrativo. Ci troviamo di fronte alla terza descrizione di personaggi religiosi, di cui l’ultimo è certamente personaggio storico. Se il primo è l’ideale religioso che si attua nella storia, attraverso l’operosità, la seconda la cui psicologia scombinata la porta a tradire le norme di comportamento della comunità ecclesiastica, con Federigo ci troviamo di fronte ad un modello. Manzoni del cardinale ci offre una biografia ideale, non calata nella storia, ma sull’esempio di una vita beata al di là della storia e del contingente. La sua operosità trascende il contingente, ma appartiene al compito che ogni religioso deve possedere, nel momento in cui abbraccia la vita ecclesiastica.
La storia

CAPITOLO XII
LA CARESTIA
Era quello il second’anno di raccolta scarsa. Nell’antecedente, le provvisioni rimaste degli anni addietro avevan supplito, fino a un certo segno, al difetto; e la popolazione era giunta, non satolla né affamata, ma, certo, affatto sprovveduta, alla messe del 1628, nel quale siamo con la nostra storia. Ora, questa messe tanto desiderata riuscì ancor più misera della precedente, in parte per maggior contrarietà delle stagioni (e questo non solo nel milanese, ma in un buon tratto di paese circonvicino); in parte per colpa degli uomini. Il guasto e lo sperperìo della guerra, di quella bella guerra di cui abbiam fatto menzione di sopra, era tale, che, nella parte dello stato più vicina ad essa, molti poderi più dell’ordinario rimanevano incolti e abbandonati da’ contadini, i quali, in vece di procacciar col lavoro pane per sé e per gli altri, eran costretti d’andare ad accattarlo per carità. Ho detto: più dell’ordinario; perché le insopportabili gravezze, imposte con una cupidigia e con un’insensatezza del pari sterminate, la condotta abituale, anche in piena pace, delle truppe alloggiate ne’ paesi, condotta che i dolorosi documenti di que’ tempi uguagliano a quella d’un nemico invasore, altre cagioni che non è qui il luogo di mentovare, andavano già da qualche tempo operando lentamente quel tristo effetto in tutto il milanese: le circostanze particolari di cui ora parliamo, erano come una repentina esacerbazione d’un mal cronico. E quella qualunque raccolta non era ancor finita di riporre, che le provvisioni per l’esercito, e lo sciupinìo che sempre le accompagna, ci fecero dentro un tal vòto, che la penuria si fece subito sentire, e con la penuria quel suo doloroso, ma salutevole come inevitabile effetto, il rincaro.
Ma quando questo arriva a un certo segno, nasce sempre (o almeno è sempre nata finora; e se ancora, dopo tanti scritti di valentuomini, pensate in quel tempo!), nasce un’opinione ne’ molti, che non ne sia cagione la scarsezza. Si dimentica d’averla temuta, predetta; si suppone tutt’a un tratto che ci sia grano abbastanza, e che il male venga dal non vendersene abbastanza per il consumo: supposizioni che non stanno né in cielo, né in terra; ma che lusingano a un tempo la collera e la speranza. Gl’incettatori di grano, reali o immaginari, i possessori di terre, che non lo vendevano tutto in un giorno, i fornai che ne compravano, tutti coloro in somma che ne avessero o poco o assai, o che avessero il nome d’averne, a questi si dava la colpa della penuria e del rincaro, questi erano il bersaglio del lamento universale, l’abbominio della moltitudine male e ben vestita. Si diceva di sicuro dov’erano i magazzini, i granai, colmi, traboccanti, appuntellati; s’indicava il numero de’ sacchi, spropositato; si parlava con certezza dell’immensa quantità di granaglie che veniva spedita segretamente in altri paesi; ne’ quali probabilmente si gridava, con altrettanta sicurezza e con fremito uguale, che le granaglie di là venivano a Milano. S’imploravan da’ magistrati que’ provvedimenti, che alla moltitudine paion sempre, o almeno sono sempre parsi finora, così giusti, così semplici, così atti a far saltar fuori il grano, nascosto, murato, sepolto, come dicevano, e a far ritornar l’abbondanza. I magistrati qualche cosa facevano: come di stabilire il prezzo massimo d’alcune derrate, d’intimar pene a chi ricusasse di vendere, e altri editti di quel genere. Siccome però tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto siano gagliardi, non hanno virtù di diminuire il bisogno del cibo, né di far venire derrate fuor di stagione; e siccome questi in ispecie non avevan certamente quella d’attirarne da dove ce ne potesse essere di soprabbondanti; così il male durava e cresceva. La moltitudine attribuiva un tale effetto alla scarsezza e alla debolezza de’ rimedi, e ne sollecitava ad alte grida de’ più generosi e decisivi. E per sua sventura, trovò l’uomo secondo il suo cuore.
Nell’assenza del governatore don Gonzalo Fernandez de Cordova, che comandava l’assedio di Casale del Monferrato, faceva le sue veci in Milano il gran cancelliere Antonio Ferrer, pure spagnolo. Costui vide, e chi non l’avrebbe veduto? che l’essere il pane a un prezzo giusto, è per sé una cosa molto desiderabile; e pensò, e qui fu lo sbaglio, che un suo ordine potesse bastare a produrla. Fissò la meta (così chiamano qui la tariffa in materia di commestibili), fissò la meta del pane al prezzo che sarebbe stato il giusto, se il grano si fosse comunemente venduto trentatre lire il moggio: e si vendeva fino a ottanta. Fece come una donna stata giovine, che pensasse di ringiovinire, alterando la sua fede di battesimo.
Ordini meno insensati e meno iniqui eran, più d’una volta, per la resistenza delle cose stesse, rimasti ineseguiti; ma all’esecuzione di questo vegliava la moltitudine, che, vedendo finalmente convertito in legge il suo desiderio, non avrebbe sofferto che fosse per celia. Accorse subito ai forni, a chieder pane al prezzo tassato; e lo chiese con quel fare di risolutezza e di minaccia, che dànno la passione, la forza e la legge riunite insieme. Se i fornai strillassero, non lo domandate. Intridere, dimenare, infornare e sfornare senza posa; perché il popolo, sentendo in confuso che l’era una cosa violenta, assediava i forni di continuo, per goder quella cuccagna fin che durava; affacchinarsi, dico, e scalmanarsi più del solito, per iscapitarci, ognun vede che bel piacere dovesse essere. Ma, da una parte i magistrati che intimavan pene, dall’altra il popolo che voleva esser servito, e, punto punto che qualche fornaio indugiasse, pressava e brontolava, con quel suo vocione, e minacciava una di quelle sue giustizie, che sono delle peggio che si facciano in questo mondo; non c’era redenzione, bisognava rimenare, infornare, sfornare e vendere. Però, a farli continuare in quell’impresa, non bastava che fosse lor comandato, né che avessero molta paura; bisognava potere: e un po’ più che la cosa fosse durata, non avrebbero più potuto. Facevan vedere ai magistrati l’iniquità e l’insopportabilità del carico imposto loro, protestavano di voler gettar la pala nel forno, e andarsene; e intanto tiravano avanti come potevano, sperando, sperando che, una volta o l’altra, il gran cancelliere avrebbe inteso la ragione. Ma Antonio Ferrer, il quale era quel che ora si direbbe un uomo di carattere, rispondeva che i fornai s’erano avvantaggiati molto e poi molto nel passato, che s’avvantaggerebbero molto e poi molto col ritornar dell’abbondanza; che anche si vedrebbe, si penserebbe forse a dar loro qualche risarcimento; e che intanto tirassero ancora avanti. O fosse veramente persuaso lui di queste ragioni che allegava agli altri, o che, anche conoscendo dagli effetti l’impossibilità di mantener quel suo editto, volesse lasciare agli altri l’odiosità di rivocarlo; giacché, chi può ora entrar nel cervello d’Antonio Ferrer? il fatto sta che rimase fermo su ciò che aveva stabilito. Finalmente i decurioni (un magistrato municipale composto di nobili, che durò fino al novantasei del secolo scorso) informaron per lettera il governatore, dello stato in cui eran le cose: trovasse lui qualche ripiego, che le facesse andare.
Don Gonzalo, ingolfato fin sopra i capelli nelle faccende della guerra, fece ciò che il lettore s’immagina certamente: nominò una giunta, alla quale conferì l’autorità di stabilire al pane un prezzo che potesse correre; una cosa da poterci campar tanto una parte che l’altra. I deputati si radunarono, o come qui si diceva spagnolescamente nel gergo segretariesco d’allora, si giuntarono; e dopo mille riverenze, complimenti, preamboli, sospiri, sospensioni, proposizioni in aria, tergiversazioni, strascinati tutti verso una deliberazione da una necessità sentita da tutti, sapendo bene che giocavano una gran carta, ma convinti che non c’era da far altro, conclusero di rincarare il pane. I fornai respirarono; ma il popolo imbestialì.
La sera avanti questo giorno in cui Renzo arrivò in Milano, le strade e le piazze brulicavano d’uomini, che trasportati da una rabbia comune, predominati da un pensiero comune, conoscenti o estranei, si riunivano in crocchi, senza essersi dati l’intesa, quasi senza avvedersene, come gocciole sparse sullo stesso pendìo. Ogni discorso accresceva la persuasione e la passione degli uditori, come di colui che l’aveva proferito. Tra tanti appassionati, c’eran pure alcuni più di sangue freddo, i quali stavano osservando con molto piacere, che l’acqua s’andava intorbidando; e s’ingegnavano d’intorbidarla di più, con que’ ragionamenti, e con quelle storie che i furbi sanno comporre, e che gli animi alterati sanno credere; e si proponevano di non lasciarla posare, quell’acqua, senza farci un po’ di pesca. Migliaia d’uomini andarono a letto col sentimento indeterminato che qualche cosa bisognava fare, che qualche cosa si farebbe. Avanti giorno, le strade eran di nuovo sparse di crocchi: fanciulli, donne, uomini, vecchi, operai, poveri, si radunavano a sorte: qui era un bisbiglio confuso di molte voci; là uno predicava, e gli altri applaudivano; questo faceva al più vicino la stessa domanda ch’era allora stata fatta a lui; quest’altro ripeteva l’esclamazione che s’era sentita risonare agli orecchi; per tutto lamenti, minacce, maraviglie: un piccol numero di vocaboli era il materiale di tanti discorsi.
Non mancava altro che un’occasione, una spinta, un avviamento qualunque, per ridurre le parole a fatti; e non tardò molto. Uscivano, sul far del giorno, dalle botteghe de’ fornai i garzoni che, con una gerla carica di pane, andavano a portarne alle solite case. Il primo comparire d’uno di que’ malcapitati ragazzi dov’era un crocchio di gente, fu come il cadere d’un salterello acceso in una polveriera. «Ecco se c’è il pane!» gridarono cento voci insieme. «Sì, per i tiranni, che notano nell’abbondanza, e voglion far morir noi di fame,» dice uno; s’accosta al ragazzetto, avventa la mano all’orlo della gerla, dà una stratta, e dice: «lascia vedere». Il ragazzetto diventa rosso, pallido, trema, vorrebbe dire: “lasciatemi andare”; ma la parola gli muore in bocca; allenta le braccia, e cerca di liberarle in fretta dalle cigne. «Giù quella gerla,» si grida intanto. Molte mani l’afferrano a un tempo: è in terra; si butta per aria il canovaccio che la copre: una tepida fragranza si diffonde all’intorno. «Siam cristiani anche noi: dobbiamo mangiar pane anche noi,» dice il primo; prende un pan tondo, l’alza, facendolo vedere alla folla, l’addenta: mani alla gerla, pani per aria; in men che non si dice, fu sparecchiato.
Coloro a cui non era toccato nulla, irritati alla vista del guadagno altrui, e animati dalla facilità dell’impresa, si mossero a branchi, in cerca d’altre gerle: quante incontrate, tante svaligiate. E non c’era neppur bisogno di dar l’assalto ai portatori: quelli che, per loro disgrazia, si trovavano in giro, vista la mala parata, posavano volontariamente il carico, e via a gambe. Con tutto ciò, coloro che rimanevano a denti secchi, erano senza paragone i più; anche i conquistatori non eran soddisfatti di prede così piccole, e, mescolati poi con gli uni e con gli altri, c’eran coloro che avevan fatto disegno sopra un disordine più co’ fiocchi. «Al forno! al forno!» si grida.
Nella strada chiamata la Corsia de’ Servi, c’era, e c’è tuttavia un forno, che conserva lo stesso nome; nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce, e in milanese è composto di parole così eteroclite, così bisbetiche, così salvatiche, che l’alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono.* A quella parte s’avventò la gente. Quelli della bottega stavano interrogando il garzone tornato scarico, il quale, tutto sbigottito e abbaruffato, riferiva balbettando la sua trista avventura; quando si sente un calpestìo e un urlìo insieme; cresce e s’avvicina; compariscono i forieri della masnada.
«Serra, serra; presto, presto»: uno corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia; gli altri chiudono in fretta la bottega, e appuntellano i battenti. La gente comincia a affollarsi di fuori, e a gridare: «pane! pane! aprite! aprite!»
Pochi momenti dopo, arriva il capitano di giustizia, con una scorta d’alabardieri. «Largo, largo, figliuoli: a casa, a casa; fate luogo al capitano di giustizia,» grida lui e gli alabardieri. La gente, che non era ancor troppo fitta, fa un po’ di luogo; dimodoché quelli poterono arrivare, e postarsi, insieme, se non in ordine, davanti alla porta della bottega.
«Ma figliuoli,» predicava di lì il capitano, «che fate qui? A casa, a casa. Dov’è il timor di Dio? Che dirà il re nostro signore? Non vogliam farvi male; ma andate a casa. Da bravi! Che diamine volete far qui, così ammontati? Niente di bene, né per l’anima, né per il corpo. A casa, a casa.»
Ma quelli che vedevan la faccia del dicitore, e sentivan le sue parole, quand’anche avessero voluto ubbidire, dite un poco in che maniera avrebber potuto, spinti com’erano, e incalzati da quelli di dietro, spinti anch’essi da altri, come flutti da flutti, via via fino all’estremità della folla, che andava sempre crescendo. Al capitano, cominciava a mancargli il respiro. «Fateli dare addietro ch’io possa riprender fiato,» diceva agli alabardieri: «ma non fate male a nessuno. Vediamo d’entrare in bottega: picchiate; fateli stare indietro.»
«Indietro! indietro!» gridano gli alabardieri, buttandosi tutti insieme addosso ai primi, e respingendoli con l’aste dell’alabarde. Quelli urlano, si tirano indietro, come possono; dànno con le schiene ne’ petti, co’ gomiti nelle pance, co’ calcagni sulle punte de’ piedi a quelli che son dietro a loro: si fa un pigìo, una calca, che quelli che si trovavano in mezzo, avrebbero pagato qualcosa a essere altrove. Intanto un po’ di vòto s’è fatto davanti alla porta: il capitano picchia, ripicchia, urla che gli aprano: quelli di dentro vedono dalle finestre, scendon di corsa, aprono; il capitano entra, chiama gli alabardieri, che si ficcan dentro anch’essi l’un dopo l’altro, gli ultimi rattenendo la folla con l’alabarde. Quando sono entrati tutti, si mette tanto di catenaccio, si riappuntella; il capitano sale di corsa, e s’affaccia a una finestra. Uh, che formicolaio!
«Figliuoli,» grida: molti si voltano in su; «figliuoli, andate a casa. Perdono generale a chi torna subito a casa.»
«Pane! pane! aprite! Aprite!» eran le parole più distinte nell’urlìo orrendo, che la folla mandava in risposta.
«Giudizio, figliuoli! badate bene! siete ancora a tempo. Via, andate, tornate a casa. Pane, ne avrete; ma non è questa la maniera. Eh!… eh! che fate laggiù! Eh! a quella porta! Oibò oibò! Vedo, vedo: giudizio! badate bene! è un delitto grosso. Or ora vengo io. Eh! eh! smettete con que’ ferri; giù quelle mani. Vergogna! Voi altri milanesi, che, per la bontà, siete nominati in tutto il mondo! Sentite, sentite: siete sempre stati buoni fi… Ah canaglia!»
Questa rapida mutazione di stile fu cagionata da una pietra che, uscita dalle mani d’uno di que’ buoni figliuoli, venne a batter nella fronte del capitano, sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica. «Canaglia! canaglia!» continuava a gridare, chiudendo presto presto la finestra, e ritirandosi. Ma quantunque avesse gridato quanto n’aveva in canna, le sue parole, buone e cattive, s’eran tutte dileguate e disfatte a mezz’aria, nella tempesta delle grida che venivan di giù. Quello poi che diceva di vedere, era un gran lavorare di pietre, di ferri (i primi che coloro avevano potuto procacciarsi per la strada), che si faceva alla porta, per sfondarla, e alle finestre, per svellere l’inferriate: e già l’opera era molto avanzata.
Intanto, padroni e garzoni della bottega, ch’erano alle finestre de’ piani di sopra, con una munizione di pietre (avranno probabilmente disselciato un cortile), urlavano e facevan versacci a quelli di giù, perché smettessero; facevan vedere le pietre, accennavano di volerle buttare. Visto ch’era tempo perso, cominciarono a buttarle davvero. Neppur una ne cadeva in fallo; giacché la calca era tale, che un granello di miglio, come si suol dire, non sarebbe andato in terra.
«Ah birboni! ah furfantoni! È questo il pane, che date alla povera gente? Ahi! Ahimè! Ohi! Ora, ora!» s’urlava di giù. Più d’uno fu conciato male; due ragazzi vi rimasero morti. Il furore accrebbe le forze della moltitudine: la porta fu sfondata, l’inferriate, svelte; e il torrente penetrò per tutti i varchi. Quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta: il capitano, gli alabardieri, e alcuni della casa stettero lì rannicchiati ne’ cantucci; altri, uscendo per gli abbaini, andavano su pe’ tetti, come i gatti.
La vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose. Si slanciano ai cassoni; il pane è messo a ruba. Qualcheduno in vece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia a manate, intasca, ed esce carico di quattrini, per tornar poi a rubar pane, se ne rimarrà. La folla si sparge ne’ magazzini. Metton mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano: chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca, e, per ridurlo a un carico da potersi portare, butta via una parte della farina: chi, gridando: «aspetta, aspetta,» si china a parare il grembiule, un fazzoletto, il cappello, per ricever quella grazia di Dio; uno corre a una madia, e prende un pezzo di pasta, che s’allunga, e gli scappa da ogni parte; un altro, che ha conquistato un burattello, lo porta per aria: chi va, chi viene: uomini, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli, e un bianco polverìo che per tutto si posa, per tutto si solleva, e tutto vela e annebbia. Di fuori, una calca composta di due processioni opposte, che si rompono e s’intralciano a vicenda, di chi esce con la preda, e di chi vuol entrare a farne.
Mentre quel forno veniva così messo sottosopra, nessun altro della città era quieto e senza pericolo. Ma a nessuno la gente accorse in numero tale da potere intraprender tutto; in alcuni, i padroni avevan raccolto degli ausiliari, e stavan sulle difese; altrove, trovandosi in pochi, venivano in certo modo a patti: distribuivan pane a quelli che s’eran cominciati a affollare davanti alle botteghe, con questo che se n’andassero. E quelli se n’andavano, non tanto perché fosser soddisfatti, quanto perché gli alabardieri e la sbirraglia, stando alla larga da quel tremendo forno delle grucce, si facevan però vedere altrove, in forza bastante a tenere in rispetto i tristi che non fossero una folla. Così il trambusto andava sempre crescendo a quel primo disgraziato forno; perché tutti coloro che gli pizzicavan le mani di far qualche bell’impresa, correvan là, dove gli amici erano i più forti, e l’impunità sicura.
A questo punto eran le cose, quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, veniva avanti per il borgo di porta orientale, e s’avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del tumulto. Andava, ora lesto, ora ritardato dalla folla; e andando, guardava e stava in orecchi, per ricavar da quel ronzìo confuso di discorsi qualche notizia più positiva dello stato delle cose. Ed ecco a un di presso le parole che gli riuscì di rilevare in tutta la strada che fece. «Ora è scoperta,» gridava uno, «l’impostura infame di que’ birboni, che dicevano che non c’era né pane, né farina, né grano. Ora si vede la cosa chiara e lampante; e non ce la potranno più dare ad intendere. Viva l’abbondanza!»
«Vi dico io che tutto questo non serve a nulla,» diceva un altro: «è un buco nell’acqua; anzi sarà peggio, se non si fa una buona giustizia. Il pane verrà a buon mercato, ma ci metteranno il veleno, per far morir la povera gente, come mosche. Già lo dicono che siam troppi; l’hanno detto nella giunta; e lo so di certo, per averlo sentito dir io, con quest’orecchi, da una mia comare, che è amica d’un parente d’uno sguattero d’uno di que’ signori.
Parole da non ripetersi diceva, con la schiuma alla bocca, un altro, che teneva con una mano un cencio di fazzoletto su’ capelli arruffati e insanguinati. E qualche vicino, come per consolarlo, gli faceva eco.
«Largo, largo, signori, in cortesia; lascin passare un povero padre di famiglia, che porta da mangiare a cinque figliuoli». Così diceva uno che veniva barcollando sotto un gran sacco di farina; e ognuno s’ingegnava di ritirarsi, per fargli largo.
«Io?» diceva un altro, quasi sottovoce, a un suo compagno: «io me la batto. Son uomo di mondo, e so come vanno queste cose. Questi merlotti che fanno ora tanto fracasso, domani o doman l’altro, se ne staranno in casa, tutti pieni di paura. Ho già visto certi visi, certi galantuomini che giran, facendo l’indiano, e notano chi c’è e chi non c’è: quando poi tutto è finito, si raccolgono i conti, e a chi tocca, tocca.»
«Quello che protegge i fornai,» gridava una voce sonora, che attirò l’attenzione di Renzo, «è il vicario di provvisione.»
«Son tutti birboni,» diceva un vicino.
«Sì; ma il capo è lui,» replicava il primo.
Il vicario di provvisione, eletto ogn’anno dal governatore tra sei nobili proposti dal Consiglio de’ decurioni, era il presidente di questo, e del tribunale di provvisione; il quale, composto di dodici, anche questi nobili, aveva, con altre attribuzioni, quella principalmente dell’annona. Chi occupava un tal posto doveva necessariamente, in tempi di fame e d’ignoranza, esser detto l’autore de’ mali: meno che non avesse fatto ciò che fece Ferrer; cosa che non era nelle sue facoltà, se anche fosse stata nelle sue idee.
«Scellerati!» esclamava un altro: «si può far di peggio? sono arrivati a dire che il gran cancelliere è un vecchio rimbambito, per levargli il credito, e comandar loro soli. Bisognerebbe fare una gran stia, e metterli dentro, a viver di vecce e di loglio, come volevano trattar noi.
«Pane eh?» diceva uno che cercava d’andar in fretta: «sassate di libbra: pietre di questa fatta, che venivan giù come la grandine. E che schiacciata di costole! Non vedo l’ora d’essere a casa mia.»
Tra questi discorsi, dai quali non saprei dire se fosse più informato o sbalordito, e tra gli urtoni, arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già molto diradata, dimodoché poté contemplare il brutto e recente soqquadro. Le mura scalcinate e ammaccate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate, diroccata la porta.
“Questa poi non è una bella cosa», disse Renzo tra sé: «se concian così tutti i forni, dove voglion fare il pane? Ne’ pozzi?”
Ogni tanto, usciva dalla bottega qualcheduno che portava un pezzo di cassone, o di madia, o di frullone, la stanga d’una gramola, una panca, una paniera, un libro di conti, qualche cosa in somma di quel povero forno; e gridando: «largo, largo,» passava tra la gente. Tutti questi s’incamminavano dalla stessa parte, e a un luogo convenuto, si vedeva. “Cos’è quest’altra storia?” pensò di nuovo Renzo; e andò dietro a uno che, fatto un fascio d’asse spezzate e di schegge, se lo mise in ispalla, avviandosi, come gli altri, per la strada che costeggia il fianco settentrionale del duomo, e ha preso nome dagli scalini che c’erano, e da poco in qua non ci son più. La voglia d’osservar gli avvenimenti non poté fare che il montanaro, quando gli si scoprì davanti la gran mole, non si soffermasse a guardare in su, con la bocca aperta. Studiò poi il passo, per raggiunger colui che aveva preso come per guida; voltò il canto, diede un’occhiata anche alla facciata del duomo, rustica allora in gran parte e ben lontana dal compimento; e sempre dietro a colui, che andava verso il mezzo della piazza. La gente era più fitta quanto più s’andava avanti, ma al portatore gli si faceva largo: egli fendeva l’onda del popolo, e Renzo, standogli sempre attaccato, arrivò con lui al centro della folla. Lì c’era uno spazio vòto, e in mezzo, un mucchio di brace, reliquie degli attrezzi detti di sopra. All’intorno era un batter di mani e di piedi, un frastono di mille grida di trionfo e d’imprecazione.
L’uomo del fascio lo buttò su quel mucchio; un altro, con un mozzicone di pala mezzo abbruciacchiato, sbracia il fuoco: il fumo cresce e s’addensa; la fiamma si ridesta; con essa le grida sorgon più forti. «Viva l’abbondanza! Moiano gli affamatori! Moia la carestia! Crepi la Provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane!»
Veramente, la distruzion de’ frulloni e delle madie, la devastazion de’ forni, e lo scompiglio de’ fornai, non sono i mezzi più spicci per far vivere il pane; ma questa è una di quelle sottigliezze metafisiche, che una moltitudine non ci arriva. Però, senza essere un gran metafisico, un uomo ci arriva talvolta alla prima, finch’è nuovo nella questione; e solo a forza di parlarne, e di sentirne parlare, diventerà inabile anche a intenderle. A Renzo in fatti quel pensiero gli era venuto, come abbiam visto, da principio, e gli tornava ogni momento. Lo tenne per altro in sé; perché, di tanti visi, non ce n’era uno che sembrasse dire: fratello, se fallo, correggimi, che l’avrò caro.
Già era di nuovo finita la fiamma; non si vedeva più venir nessuno con altra materia, e la gente cominciava a annoiarsi; quando si sparse la voce, che, al Cordusio (una piazzetta o un crocicchio non molto distante di lì), s’era messo l’assedio a un forno. Spesso, in simili circostanze, l’annunzio d’una cosa la fa essere. Insieme con quella voce, si diffuse nella moltitudine una voglia di correr là: «io vo; tu, vai? vengo; andiamo,» si sentiva per tutto: la calca si rompe, e diventa una processione. Renzo rimaneva indietro, non movendosi quasi, se non quanto era strascinato dal torrente; e teneva intanto consiglio in cuor suo, se dovesse uscir dal baccano, e ritornare al convento, in cerca del padre Bonaventura, o andare a vedere anche quest’altra. Prevalse di nuovo la curiosità. Però risolvette di non cacciarsi nel fitto della mischia, a farsi ammaccar l’ossa, o a risicar qualcosa di peggio; ma di tenersi in qualche distanza, a osservare. E trovandosi già un poco al largo, si levò di tasca il secondo pane, e attaccandoci un morso, s’avviò alla coda dell’esercito tumultuoso.
Questo, dalla piazza, era già entrato nella strada corta e stretta di Pescheria vecchia, e di là, per quell’arco a sbieco, nella piazza de’ Mercanti. E lì eran ben pochi quelli che, nel passar davanti alla nicchia che taglia il mezzo della loggia dell’edifizio chiamato allora il collegio de’ dottori, non dessero un’occhiatina alla grande statua che vi campeggiava, a quel viso serio, burbero, accipigliato, e non dico abbastanza, di don Filippo II, che, anche dal marmo, imponeva un non so che di rispetto, e, con quel braccio teso, pareva che fosse lì per dire: ora vengo io, marmaglia.
Quella statua non c’è più, per un caso singolare. Circa cento settant’anni dopo quello che stiam raccontando, un giorno le fu cambiata la testa, le fu levato di mano lo scettro, e sostituito a questo un pugnale; e alla statua fu messo nome Marco Bruto. Così accomodata stette forse un par d’anni; ma, una mattina, certuni che non avevan simpatia con Marco Bruto, anzi dovevano avere con lui una ruggine segreta, gettarono una fune intorno alla statua, la tiraron giù, le fecero cento angherie; e, mutilata e ridotta a un torso informe, la strascicarono, con gli occhi in fuori, e con le lingue fuori, per le strade, e, quando furon stracchi bene, la ruzzolarono non so dove. Chi l’avesse detto a Andrea Biffi, quando la scolpiva!
Dalla piazza de’ Mercanti, la marmaglia insaccò, per quell’altr’arco, nella via de’ fustagnai, e di lì si sparpagliò nel Cordusio. Ognuno, al primo sboccarvi, guardava subito verso il forno ch’era stato indicato. Ma in vece della moltitudine d’amici che s’aspettavano di trovar lì già al lavoro, videro soltanto alcuni starsene, come esitando, a qualche distanza della bottega, la quale era chiusa, e alle finestre gente armata, in atto di star pronti a difendersi. A quella vista, chi si maravigliava, chi sagrava, chi rideva; chi si voltava, per informar quelli che arrivavan via via; chi si fermava, chi voleva tornare indietro, chi diceva: «avanti, avanti». C’era un incalzare e un rattenere, come un ristagno, una titubazione, un ronzìo confuso di contrasti e di consulte. In questa, scoppiò di mezzo alla folla una maledetta voce: «c’è qui vicino la casa del vicario di provvisione: andiamo a far giustizia, e a dare il sacco». Parve il rammentarsi comune d’un concerto preso, piuttosto che l’accettazione d’una proposta. «Dal vicario! dal vicario!» –è il solo grido che si possa sentire. La turba si move, tutta insieme, verso la strada dov’era la casa nominata in un così cattivo punto.
* El prestin di scansc.
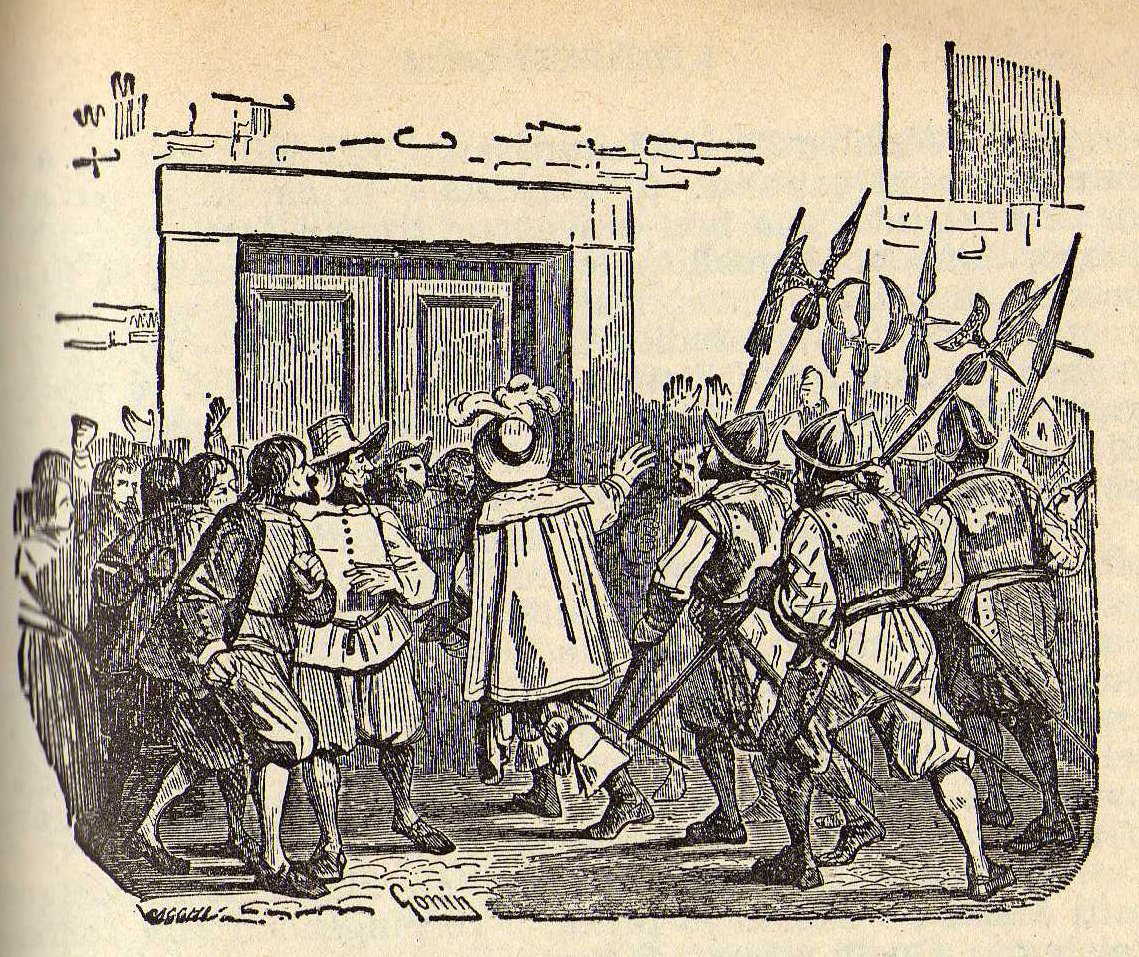
Il tumulto di San Martino, avvenuto realmente l’11 novembre del 1628, viene descritto, infatti più che da narratore da storico: dapprima infatti ne disegna la piena responsabilità alla guerra, quindi alla “insensata” politica economica, figlie ambedue della dissennata, secondo lo scrittore milanese, politica spagnola in Italia. E’ una pagina vista con gli occhi di un uomo colto, che osserva dall’alto, in modo razionale e illuministico, le storture che al posto di porre rimedio, esasperano la mancanza di pane. L’esempio più lampante è nella logicità, guidata dal buon senso, secondo cui un prezzo è determinato dalla quantità del prodotto: se pane ve n’è poco, metterlo a prezzo basso, significa “consumarlo” indiscriminatamente, tanto da ridurre la sua presenza nel mercato. Sempre da uomo colto, quindi, Manzoni volge l’attenzione al popolo, il quale, non conoscendo l’economia, ma anche privando la massa di buon senso, addita la mancanza di pane come frutto di ruberie e di profitto da parte dei fornai. Da qui la violenza. Il cattolico Manzoni teme la violenza popolare come arma politica (il giacobinismo francese è appena alle spalle) soprattutto in quanto priva di progettualità e con la capacità di porsi come guida per una rivoluzione sociale. Niente di più lontano per lo scrittore milanese. D’altra parte, nella sua prospettiva cattolica, la violenza sembra essere il frutto proprio di una istintualità, che, priva di ragione, sembra essere presieduta da Lucifero stesso:
Spiccava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vecchio mal vissuto, che, spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro gran chiodi, con che diceva di volere attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse.
d’altra parte non bisogna dimenticare che il pane ha in sé un forte valore simbolico/sacrale.
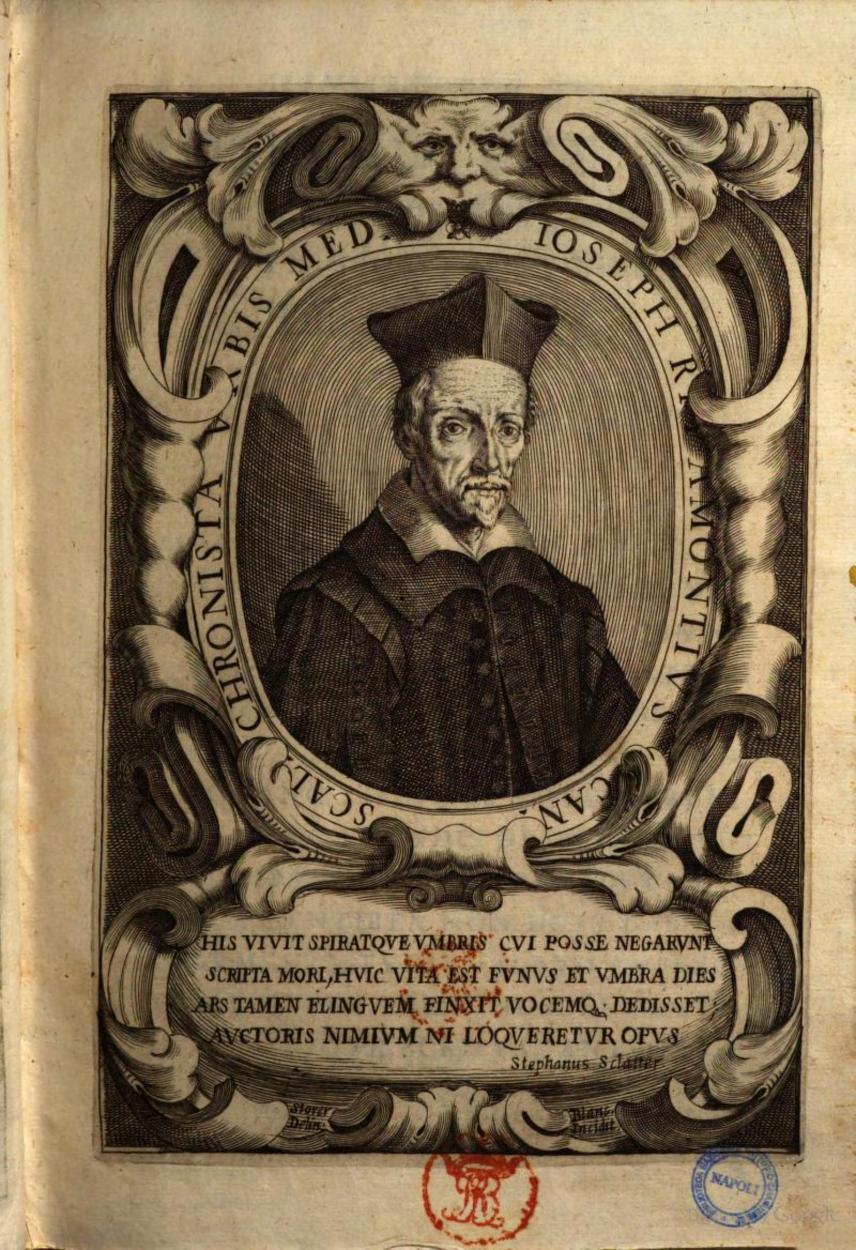
Giuseppe Ripamonti, storico milanese
CAPITOLO XXXI-XXXII
LA PESTE
La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c’era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d’Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontar gli avvenimenti principali di quella calamità; nel milanese, s’intende, anzi in Milano quasi esclusivamente: ché della città quasi esclusivamente trattano le memorie del tempo, come a un di presso accade sempre e per tutto, per buone e per cattive ragioni. E in questo racconto, il nostro fine non è, per dir la verità, soltanto di rappresentar lo stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi; ma di far conoscere insieme, per quanto si può in ristretto, e per quanto si può da noi, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto.
Delle molte relazioni contemporanee, non ce n’è alcuna che basti da sé a darne un’idea un po’ distinta e ordinata; come non ce n’è alcuna che non possa aiutare a formarla. In ognuna di queste relazioni, senza eccettuarne quella del Ripamonti, la quale le supera tutte, per la quantità e per la scelta de’ fatti, e ancor più per il modo d’osservarli, in ognuna sono omessi fatti essenziali, che son registrati in altre; in ognuna ci sono errori materiali, che si posson riconoscere e rettificare con l’aiuto di qualche altra, o di que’ pochi atti della pubblica autorità, editi e inediti, che rimangono; spesso in una si vengono a trovar le cagioni di cui nell’altra s’eran visti, come in aria, gli effetti.
In tutte poi regna una strana confusione di tempi e di cose; è un continuo andare e venire, come alla ventura, senza disegno generale, senza disegno ne’ particolari: carattere, del resto, de’ più comuni e de’ più apparenti ne’ libri di quel tempo, principalmente in quelli scritti in lingua volgare, almeno in Italia; se anche nel resto d’Europa, i dotti lo sapranno, noi lo sospettiamo. Nessuno scrittore d’epoca posteriore s’è proposto d’esaminare e di confrontare quelle memorie, per ritrarne una serie concatenata degli avvenimenti, una storia di quella peste; sicché l’idea che se ne ha generalmente, dev’essere, di necessità, molto incerta, e un po’ confusa: un’idea indeterminata di gran mali e di grand’errori (e per verità ci fu dell’uno e dell’altro, al di là di quel che si possa immaginare), un’idea composta più di giudizi che di fatti, alcuni fatti dispersi, non di rado scompagnati dalle circostanze più caratteristiche, senza distinzion di tempo, cioè senza intelligenza di causa e d’effetto, di corso, di progressione. Noi, esaminando e confrontando, con molta diligenza se non altro, tutte le relazioni stampate, più d’una inedita, molti (in ragione del poco che ne rimane) documenti, come dicono, ufiziali, abbiam cercato di farne non già quel che si vorrebbe, ma qualche cosa che non è stato ancor fatto. Non intendiamo di riferire tutti gli atti pubblici, e nemmeno tutti gli avvenimenti degni, in qualche modo, di memoria. Molto meno pretendiamo di rendere inutile a chi voglia farsi un’idea più compita della cosa, la lettura delle relazioni originali: sentiamo troppo che forza viva, propria e, per dir così, incomunicabile, ci sia sempre nell’opere di quel genere, comunque concepite e condotte. Solamente abbiam tentato di distinguere e di verificare i fatti più generali e più importanti, di disporli nell’ordine reale della loro successione, per quanto lo comporti la ragione e la natura d’essi, d’osservare la loro efficienza reciproca, e di dar così, per ora e finché qualchedun altro non faccia meglio, una notizia succinta, ma sincera e continuata, di quel disastro.
Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dall’esercito, s’era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte de’ viventi. C’era soltanto alcuni a cui non riuscissero nuovi: que’ pochi che potessero ricordarsi della peste che, cinquantatré anni avanti, aveva desolata pure una buona parte d’Italia, e in ispecie il milanese, dove fu chiamata, ed è tuttora, la peste di san Carlo. Tanto è forte la carità! Tra le memorie così varie e così solenni d’un infortunio generale, può essa far primeggiare quella d’un uomo, perché a quest’uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili ancora de’ mali; stamparlo nelle menti, come un sunto di tutti que’ guai, perché in tutti l’ha spinto e intromesso, guida, soccorso, esempio, vittima volontaria; d’una calamità per tutti, far per quest’uomo come un’impresa; nominarla da lui, come una conquista, o una scoperta.
Il protofisico Lodovico Settala, che, non solo aveva veduta quella peste, ma n’era stato uno de’ più attivi e intrepidi, e, quantunque allor giovinissimo, de’ più riputati curatori; e che ora, in gran sospetto di questa, stava all’erta e sull’informazioni, riferì, il 20 d’ottobre, nel tribunale della sanità, come, nella terra di Chiuso (l’ultima del territorio di Lecco, e confinante col bergamasco), era scoppiato indubitabilmente il contagio. Non fu per questo presa veruna risoluzione, come si ha dal Ragguaglio del Tadino.
Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano. Il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che, strada facendo, prendesse un medico a Como, e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati. Tutt’e due, “o per ignoranza o per altro, si lasciorno persuadere da un vecchio et ignorante barbiero di Bellano, che quella sorte de mali non era Peste”; ma, in alcuni luoghi, effetto consueto dell’emanazioni autunnali delle paludi, e negli altri, effetto de’ disagi e degli strapazzi sofferti, nel passaggio degli alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace.
Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti due delegati a vedere e a provvedere: il Tadino suddetto, e un auditore del tribunale. Quando questi giunsero, il male s’era già tanto dilatato, che le prove si offrivano, senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecco, la Valsassina, le coste del lago di Como, i distretti denominati il Monte di Brianza, e la Gera d’Adda; e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli all’entrature, altri quasi deserti, e gli abitanti scappati e attendati alla campagna, o dispersi: “et ci parevano, – dice il Tadino, – tante creature seluatiche, portando in mano chi l’herba menta, chi la ruta, chi il rosmarino et chi una ampolla d’aceto”. S’informarono del numero de’ morti: era spaventevole; visitarono infermi e cadaveri, e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza. Diedero subito, per lettere, quelle sinistre nuove al tribunale della sanità, il quale, al riceverle, che fu il 30 d’ottobre, “si dispose”, dice il medesimo Tadino, a prescriver le bullette, per chiuder fuori dalla Città le persone provenienti da’ paesi dove il contagio s’era manifestato; “et mentre si compilaua la grida”, ne diede anticipatamente qualche ordine sommario a’ gabellieri.
Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle misure che parver loro migliori; e se ne tornarono, con la trista persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso.
Arrivati il 14 di novembre, dato ragguaglio, a voce e di nuovo in iscritto, al tribunale, ebbero da questo commissione di presentarsi al governatore, e d’esporgli lo stato delle cose. V’andarono, e riportarono: aver lui di tali nuove provato molto dispiacere, mostratone un gran sentimento; ma i pensieri della guerra esser più pressanti: sed belli graviores esse curas. Così il Ripamonti, il quale aveva spogliati i registri della Sanità, e conferito col Tadino, incaricato specialmente della missione: era la seconda, se il lettore se ne ricorda, per quella causa, e con quell’esito. Due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emanò il governatore una grida, in cui ordinava pubbliche feste, per la nascita del principe Carlo, primogenito del re Filippo IV, senza sospettare o senza curare il pericolo d’un gran concorso, in tali circostanze: tutto come in tempi ordinari, come se non gli fosse stato parlato di nulla.
Era quest’uomo, come già s’è detto, il celebre Ambrogio Spinola, mandato per raddirizzar quella guerra e riparare agli errori di don Gonzalo, e incidentemente, a governare; e noi pure possiamo qui incidentemente rammentar che morì dopo pochi mesi, in quella stessa guerra che gli stava tanto a cuore; e morì, non già di ferite sul campo, ma in letto, d’affanno e di struggimento, per rimproveri, torti, disgusti d’ogni specie ricevuti da quelli a cui serviva. La storia ha deplorata la sua sorte, e biasimata l’altrui sconoscenza; ha descritte con molta diligenza le sue imprese militari e politiche, lodata la sua previdenza, l’attività, la costanza: poteva anche cercare cos’abbia fatto di tutte queste qualità, quando la peste minacciava, invadeva una popolazione datagli in cura, o piuttosto in balìa.
Ma ciò che, lasciando intero il biasimo, scema la maraviglia di quella sua condotta, ciò che fa nascere un’altra e più forte maraviglia, è la condotta della popolazione medesima, di quella, voglio dire, che, non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragion di temerlo. All’arrivo di quelle nuove de’ paesi che n’erano così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distante da essa non più di diciotto o venti miglia; chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d’accordo, è nell’attestare che non ne fu nulla. La penuria dell’anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d’animo, parvero più che bastanti a render ragione della mortalità: sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo iracondo. La medesima miscredenza, la medesima, per dir meglio, cecità e fissazione prevaleva nel senato, nel Consiglio de’ decurioni, in ogni magistrato.
Trovo che il cardinal Federigo, appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse, con lettera pastorale a’ parrochi, tra le altre cose, che ammonissero più e più volte i popoli dell’importanza e dell’obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente, e di consegnar le robe infette o sospette: e anche questa può essere contata tra le sue lodevoli singolarità.
Il tribunale della sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente. E nel tribunale stesso, la premura era ben lontana da uguagliare l’urgenza: erano, come afferma più volte il Tadino, e come appare ancor meglio da tutto il contesto della sua relazione, i due fisici che, persuasi della gravità e dell’imminenza del pericolo, stimolavan quel corpo, il quale aveva poi a stimolare gli altri.
Abbiam già veduto come, al primo annunzio della peste, andasse freddo nell’operare, anzi nell’informarsi: ecco ora un altro fatto di lentezza non men portentosa, se però non era forzata, per ostacoli frapposti da magistrati superiori. Quella grida per le bullette, risoluta il 30 d’ottobre, non fu stesa che il dì 23 del mese seguente, non fu pubblicata che il 29. La peste era già entrata in Milano.
Il Tadino e il Ripamonti vollero notare il nome di chi ce la portò il primo, e altre circostanze della persona e del caso: e infatti, nell’osservare i princìpi d’una vasta mortalità, in cui le vittime, non che esser distinte per nome, appena si potranno indicare all’incirca, per il numero delle migliaia, nasce una non so quale curiosità di conoscere que’ primi e pochi nomi che poterono essere notati e conservati: questa specie di distinzione, la precedenza nell’esterminio, par che faccian trovare in essi, e nelle particolarità, per altro più indifferenti, qualche cosa di fatale e di memorabile.
L’uno e l’altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna; nel resto non sono ben d’accordo, neppur sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro Antonio Lovato, di quartiere nel territorio di Lecco; secondo il Ripamonti, un Pier Paolo Locati, di quartiere a Chiavenna. Differiscono anche nel giorno della sua entrata in Milano: il primo la mette al 22 d’ottobre, il secondo ad altrettanti del mese seguente: e non si può stare né all’uno né all’altro. Tutt’e due l’epoche sono in contraddizione con altre ben più verificate. Eppure il Ripamonti, scrivendo per ordine del Consiglio generale de’ decurioni, doveva avere al suo comando molti mezzi di prender l’informazioni necessarie; e il Tadino, per ragione del suo impiego, poteva, meglio d’ogn’altro, essere informato d’un fatto di questo genere. Del resto, dal riscontro d’altre date che ci paiono, come abbiam detto, più esatte, risulta che fu, prima della pubblicazione della grida sulle bullette; e, se ne mettesse conto, si potrebbe anche provare o quasi provare, che dovette essere ai primi di quel mese; ma certo, il lettore ce ne dispensa.
Sia come si sia, entrò questo fante sventurato e portator di sventura, con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni; andò a fermarsi in una casa di suoi parenti, nel borgo di porta orientale, vicino ai cappuccini; appena arrivato, s’ammalò; fu portato allo spedale; dove un bubbone che gli si scoprì sotto un’ascella, mise chi lo curava in sospetto di ciò ch’era infatti; il quarto giorno morì.
Il tribunale della sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia; i suoi vestiti e il letto in cui era stato allo spedale, furon bruciati. Due serventi che l’avevano avuto in cura, e un buon frate che l’aveva assistito, caddero anch’essi ammalati in pochi giorni, tutt’e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo s’era avuto, fin da principio, della natura del male, e le cautele usate in conseguenza, fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più. Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminìo che non tardò a germogliare. Il primo a cui s’attaccò, fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato, un Carlo Colonna sonator di liuto. Allora tutti i pigionali di quella casa furono, d’ordine della Sanità, condotti al lazzeretto, dove la più parte s’ammalarono; alcuni morirono, dopo poco tempo, di manifesto contagio.
Nella città, quello che già c’era stato disseminato da costoro, da’ loro panni, da’ loro mobili trafugati da parenti, da pigionali, da persone di servizio, alle ricerche e al fuoco prescritto dal tribunale, e di più quello che c’entrava di nuovo, per l’imperfezion degli editti, per la trascuranza nell’eseguirli, e per la destrezza nell’eluderli, andò covando e serpendo lentamente, tutto il restante dell’anno, e ne’ primi mesi del susseguente 1630. Di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualcheduno s’attaccava, qualcheduno ne moriva: e la radezza stessa de’ casi allontanava il sospetto della verità, confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, né ci fosse stata neppure un momento. Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo (era, anche in questo caso, voce di Dio?), deridevan gli augùri sinistri, gli avvertimenti minacciosi de’ pochi; e avevan pronti nomi di malattie comuni, per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare; con qualunque sintomo, con qualunque segno fosse comparso.
Gli avvisi di questi accidenti, quando pur pervenivano alla Sanità, ci pervenivano tardi per lo più e incerti. Il terrore della contumacia e del lazzeretto aguzzava tutti gl’ingegni: non si denunziavan gli ammalati, si corrompevano i becchini e i loro soprintendenti; da subalterni del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadaveri, s’ebbero, con danari, falsi attestati.
Siccome però, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il tribunale ordinava di bruciar robe, metteva in sequestro case, mandava famiglie al lazzeretto, così è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l’ira e la mormorazione del pubblico, «della Nobiltà, delli Mercanti et della plebe», dice il Tadino; persuasi, com’eran tutti, che fossero vessazioni senza motivo, e senza costrutto. L’odio principale cadeva sui due medici; il suddetto Tadino, e Senatore Settala, figlio del protofisico: a tal segno, che ormai non potevano attraversar le piazze senza essere assaliti da parolacce, quando non eran sassi. E certo fu singolare, e merita che ne sia fatta memoria, la condizione in cui, per qualche mese, si trovaron quegli uomini, di veder venire avanti un orribile flagello, d’affaticarsi in ogni maniera a stornarlo, d’incontrare ostacoli dove cercavano aiuti, e d’essere insieme bersaglio delle grida, avere il nome di nemici della patria: pro patriae hostibus, dice il Ripamonti.
Di quell’odio ne toccava una parte anche agli altri medici che, convinti come loro, della realtà del contagio, suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza. I più discreti li tacciavano di credulità e d’ostinazione: per tutti gli altri, era manifesta impostura, cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento.
Il protofisico Lodovico Settala, allora poco men che ottuagenario, stato professore di medicina all’università di Pavia, poi di filosofia morale a Milano, autore di molte opere riputatissime allora, chiaro per inviti a cattedre d’altre università, Ingolstadt, Pisa, Bologna, Padova, e per il rifiuto di tutti questi inviti, era certamente uno degli uomini più autorevoli del suo tempo. Alla riputazione della scienza s’aggiungeva quella della vita, e all’ammirazione la benevolenza, per la sua gran carità nel curare e nel beneficare i poveri. E, una cosa che in noi turba e contrista il sentimento di stima ispirato da questi meriti, ma che allora doveva renderlo più generale e più forte, il pover’uomo partecipava de’ pregiudizi più comuni e più funesti de’ suoi contemporanei: era più avanti di loro, ma senza allontanarsi dalla schiera, che è quello che attira i guai, e fa molte volte perdere l’autorità acquistata in altre maniere. Eppure quella grandissima che godeva, non solo non bastò a vincere, in questo caso, l’opinion di quello che i poeti chiamavan volgo profano, e i capocomici, rispettabile pubblico; ma non poté salvarlo dall’animosità e dagl’insulti di quella parte di esso che corre più facilmente da’ giudizi alle dimostrazioni e ai fatti.
Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, principiò a radunarglisi intorno gente, gridando esser lui il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste; lui che metteva in ispavento la città, con quel suo cipiglio, con quella sua barbaccia: tutto per dar da fare ai medici. La folla e il furore andavan crescendo: i portantini, vedendo la mala parata, ricoverarono il padrone in una casa d’amici, che per sorte era vicina. Questo gli toccò per aver veduto chiaro, detto ciò che era, e voluto salvar dalla peste molte migliaia di persone: quando, con un suo deplorabile consulto, cooperò a far torturare, tanagliare e bruciare, come strega, una povera infelice sventurata, perché il suo padrone pativa dolori strani di stomaco, e un altro padrone di prima era stato fortemente innamorato di lei, allora ne avrà avuta presso il pubblico nuova lode di sapiente e, ciò che è intollerabile a pensare, nuovo titolo di benemerito.
Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni; morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti alla opinion del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevan deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti: miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perché, figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere, che il male s’attaccava per mezzo del contatto. I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po’ più orecchio agli avvisi, alle proposte della Sanità, a far eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale. Chiedeva esso di continuo anche danari per supplire alle spese giornaliere, crescenti, del lazzeretto, di tanti altri servizi; e li chiedeva ai decurioni, intanto che fosse deciso (che non fu, credo, mai, se non col fatto) se tali spese toccassero alla città, o all’erario regio. Ai decurioni faceva pure istanza il gran cancelliere, per ordine anche del governatore, ch’era andato di nuovo a metter l’assedio a quel povero Casale; faceva istanza il senato, perché pensassero alla maniera di vettovagliar la città, prima che dilatandovisi per isventura il contagio, le venisse negato pratica dagli altri paesi; perché trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione, a cui eran mancati i lavori. I decurioni cercavano di far danari per via d’imprestiti, d’imposte; e di quel che ne raccoglievano, ne davano un po’ alla Sanità, un po’ a’ poveri; un po’ di grano compravano: supplivano a una parte del bisogno. E le grandi angosce non erano ancor venute.
Nel lazzeretto, dove la popolazione, quantunque decimata ogni giorno, andava ogni giorno crescendo, era un’altra ardua impresa quella d’assicurare il servizio e la subordinazione, di conservar le separazioni prescritte, di mantenervi in somma o, per dir meglio, di stabilirvi il governo ordinato dal tribunale della sanità: ché, fin da’ primi momenti, c’era stata ogni cosa in confusione, per la sfrenatezza di molti rinchiusi, per la trascuratezza e per la connivenza de’ serventi. Il tribunale e i decurioni, non sapendo dove battere il capo, pensaron di rivolgersi ai cappuccini, e supplicarono il padre commissario della provincia, il quale faceva le veci del provinciale, morto poco prima, acciò volesse dar loro de’ soggetti abili a governare quel regno desolato. Il commissario propose loro, per principale, un padre Felice Casati, uomo d’età matura, il quale godeva una gran fama di carità, d’attività, di mansuetudine insieme e di fortezza d’animo, a quel che il seguito fece vedere, ben meritata; e per compagno e come ministro di lui, un padre Michele Pozzobonelli, ancor giovine, ma grave e severo, di pensieri come d’aspetto. Furono accettati con gran piacere; e il 30 di marzo, entrarono nel lazzeretto. Il presidente della Sanità li condusse in giro, come per prenderne il possesso; e, convocati i serventi e gl’impiegati d’ogni grado, dichiarò, davanti a loro, presidente di quel luogo il padre Felice, con primaria e piena autorità. Di mano in mano poi che la miserabile radunanza andò crescendo, v’accorsero altri cappuccini; e furono in quel luogo soprintendenti, confessori, amministratori, infermieri, cucinieri, guardarobi, lavandai, tutto ciò che occorresse. Il padre Felice, sempre affaticato e sempre sollecito, girava di giorno, girava di notte, per i portici, per le stanze, per quel vasto spazio interno, talvolta portando un’asta, talvolta non armato che di cilizio; animava e regolava ogni cosa; sedava i tumulti, faceva ragione alle querele, minacciava, puniva, riprendeva, confortava, asciugava e spargeva lacrime. Prese, sul principio, la peste; ne guarì, e si rimise, con nuova lena, alle cure di prima. I suoi confratelli ci lasciarono la più parte la vita, e tutti con allegrezza.
Certo, una tale dittatura era uno strano ripiego; strano come la calamità, come i tempi; e quando non ne sapessimo altro, basterebbe per argomento, anzi per saggio d’una società molto rozza e mal regolata, il veder che quelli a cui toccava un così importante governo, non sapesser più farne altro che cederlo, né trovassero a chi cederlo, che uomini, per istituto, il più alieni da ciò. Ma è insieme un saggio non ignobile della forza e dell’abilità che la carità può dare in ogni tempo, e in qualunque ordin di cose, il veder quest’uomini sostenere un tal carico così bravamente. E fu bello lo stesso averlo accettato, senz’altra ragione che il non esserci chi lo volesse, senz’altro fine che di servire, senz’altra speranza in questo mondo, che d’una morte molto più invidiabile che invidiata; fu bello lo stesso esser loro offerto, solo perché era difficile e pericoloso, e si supponeva che il vigore e il sangue freddo, così necessario e raro in que’ momenti, essi lo dovevano avere. E perciò l’opera e il cuore di que’ frati meritano che se ne faccia memoria, con ammirazione, con tenerezza, con quella specie di gratitudine che è dovuta, come in solido, per i gran servizi resi da uomini a uomini, e più dovuta a quelli che non se la propongono per ricompensa. «Che se questi Padri iui non si ritrouauano,» dice il Tadino, «al sicuro tutta la Città annichilata si trouaua; puoiché fu cosa miracolosa l’hauer questi Padri fatto in così puoco spatio di tempo tante cose per benefitio publico, che non hauendo hauuto agiutto, o almeno puoco dalla Città, con la sua industria et prudenza haueuano mantenuto nel Lazeretto tante migliaia de poueri». Le persone ricoverate in quel luogo, durante i sette mesi che il padre Felice n’ebbe il governo, furono circa cinquantamila, secondo il Ripamonti; il quale dice con ragione, che d’un uomo tale avrebbe dovuto ugualmente parlare, se in vece di descriver le miserie d’una città, avesse dovuto raccontar le cose che posson farle onore.
Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi, di mano in mano che il morbo si diffondeva, e si diffondeva per via del contatto e della pratica; e tanto più quando, dopo esser qualche tempo rimasto solamente tra’ poveri, cominciò a toccar persone più conosciute. E tra queste, come allora fu il più notato, così merita anche adesso un’espressa menzione il protofisico Settala. Avranno almen confessato che il povero vecchio aveva ragione? Chi lo sa? Caddero infermi di peste, lui, la moglie, due figliuoli, sette persone di servizio. Lui e uno de’ figliuoli n’usciron salvi; il resto morì. «Questi casi,» dice il Tadino, «occorsi nella Città in case Nobili, disposero la Nobiltà et la plebe a pensare, et gli increduli Medici, et la plebe ignorante et temeraria cominciò stringere le labra, chiudere li denti, et inarcare le ciglia».
Ma l’uscite, i ripieghi, le vendette, per dir così, della caparbietà convinta, sono alle volte tali da far desiderare che fosse rimasta ferma e invitta, fino all’ultimo, contro la ragione e l’evidenza: e questa fu bene una di quelle volte. Coloro i quali avevano impugnato così risolutamente, e così a lungo, che ci fosse vicino a loro, tra loro, un germe di male, che poteva, per mezzi naturali, propagarsi e fare una strage; non potendo ormai negare il propagamento di esso, e non volendo attribuirlo a que’ mezzi (che sarebbe stato confessare a un tempo un grand’inganno e una gran colpa), erano tanto più disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona qualunque ne venisse messa in campo.
Per disgrazia, ce n’era una in pronto nelle idee e nelle tradizioni comuni allora, non qui soltanto, ma in ogni parte d’Europa: arti venefiche, operazioni diaboliche, gente congiurata a sparger la peste, per mezzo di veleni contagiosi, di malìe. Già cose tali, o somiglianti, erano state supposte e credute in molte altre pestilenze, e qui segnatamente, in quella di mezzo secolo innanzi. S’aggiunga che, fin dall’anno antecedente, era venuto un dispaccio, sottoscritto dal re Filippo IV, al governatore, per avvertirlo ch’erano scappati da Madrid quattro francesi, ricercati come sospetti di spargere unguenti velenosi, pestiferi: stesse all’erta, se mai coloro fossero capitati a Milano. Il governatore aveva comunicato il dispaccio al senato e al tribunale della sanità; né, per allora, pare che ci si badasse più che tanto. Però, scoppiata e riconosciuta la peste, il tornar nelle menti quell’avviso poté servir di conferma al sospetto indeterminato d’una frode scellerata; poté anche essere la prima occasione di farlo nascere.
Ma due fatti, l’uno di cieca e indisciplinata paura, l’altro di non so quale cattività, furon quelli che convertirono quel sospetto indeterminato d’un attentato possibile, in sospetto, e per molti in certezza, d’un attentato positivo, e d’una trama reale. Alcuni, ai quali era parso di vedere, la sera del 17 di maggio, persone in duomo andare ungendo un assito che serviva a dividere gli spazi assegnati a’ due sessi, fecero, nella notte, portar fuori della chiesa l’assito e una quantità di panche rinchiuse in quello; quantunque il presidente della Sanità, accorso a far la visita, con quattro persone dell’ufizio, avendo visitato l’assito, le panche, le pile dell’acqua benedetta, senza trovar nulla che potesse confermare l’ignorante sospetto d’un attentato venefico, avesse, per compiacere all’immaginazioni altrui, e più tosto per abbondare in cautela, che per bisogno, avesse, dico, deciso che bastava dar una lavata all’assito. Quel volume di roba accatastata produsse una grand’impressione di spavento nella moltitudine, per cui un oggetto diventa così facilmente un argomento. Si disse e si credette generalmente che fossero state unte in duomo tutte le panche, le pareti, e fin le corde delle campane. Né si disse soltanto allora: tutte le memorie de’ contemporanei che parlano di quel fatto (alcune scritte molt’anni dopo), ne parlano con ugual sicurezza: e la storia sincera di esso, bisognerebbe indovinarla, se non si trovasse in una lettera del tribunale della sanità al governatore, che si conserva nell’archivio detto di san Fedele; dalla quale l’abbiamo cavata, e della quale sono le parole che abbiam messe in corsivo.
La mattina seguente, un nuovo e più strano, più significante spettacolo colpì gli occhi e le menti de’ cittadini. In ogni parte della città, si videro le porte delle case e le muraglie, per lunghissimi tratti, intrise di non so che sudiceria, giallognola, biancastra, sparsavi come con delle spugne. O sia stato un gusto sciocco di far nascere uno spavento più rumoroso e più generale, o sia stato un più reo disegno d’accrescer la pubblica confusione, o non saprei che altro; la cosa è attestata di maniera, che ci parrebbe men ragionevole l’attribuirla a un sogno di molti, che al fatto d’alcuni: fatto, del resto, che non sarebbe stato, né il primo né l’ultimo di tal genere. Il Ripamonti, che spesso, su questo particolare dell’unzioni, deride, e più spesso deplora la credulità popolare, qui afferma d’aver veduto quell’impiastramento, e lo descrive. Nella lettera sopraccitata, i signori della Sanità raccontan la cosa ne’ medesimi termini; parlan di visite, d’esperimenti fatti con quella materia sopra de’ cani, e senza cattivo effetto; aggiungono, esser loro opinione, che cotale temerità sia più tosto proceduta da insolenza, che da fine scelerato: pensiero che indica in loro, fino a quel tempo, pacatezza d’animo bastante per non vedere ciò che non ci fosse stato. L’altre memorie contemporanee, raccontando la cosa, accennano anche, essere stata, sulle prime, opinion di molti, che fosse fatta per burla, per bizzarria; nessuna parla di nessuno che la negasse; e n’avrebbero parlato certamente, se ce ne fosse stati; se non altro, per chiamarli stravaganti. Ho creduto che non fosse fuor di proposito il riferire e il mettere insieme questi particolari, in parte poco noti, in parte affatto ignorati, d’un celebre delirio; perché, negli errori e massime negli errori di molti, ciò che è più interessante e più utile a osservarsi, mi pare che sia appunto la strada che hanno fatta, l’apparenze, i modi con cui hanno potuto entrar nelle menti, e dominarle.
La città già agitata ne fu sottosopra: i padroni delle case, con paglia accesa, abbruciacchiavano gli spazi unti; i passeggieri si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano. I forestieri, sospetti per questo solo, e che allora si conoscevan facilmente al vestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo, e condotti alla giustizia. Si fecero interrogatòri, esami d’arrestati, d’arrestatori, di testimoni; non si trovò reo nessuno: le menti erano ancor capaci di dubitare, d’esaminare, d’intendere. Il tribunale della sanità pubblicò una grida, con la quale prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro l’autore o gli autori del fatto. Ad ogni modo non parendoci conueniente, dicono que’ signori nella citata lettera, che porta la data del 21 di maggio, ma che fu evidentemente scritta il 19, giorno segnato nella grida stampata, che questo delitto in qualsiuoglia modo resti impunito, massime in tempo tanto pericoloso e sospettoso, per consolatione e quiete di questo Popolo, e per cauare indicio del fatto, habbiamo oggi publicata grida, etc. Nella grida stessa però, nessun cenno, almen chiaro, di quella ragionevole e acquietante congettura, che partecipavano al governatore: silenzio che accusa a un tempo una preoccupazione furiosa nel popolo, e in loro una condiscendenza, tanto più biasimevole, quanto più poteva esser perniciosa.
Mentre il tribunale cercava, molti nel pubblico, come accade, avevan già trovato. Coloro che credevano esser quella un’unzione velenosa, chi voleva che la fosse una vendetta di don Gonzalo Fernandez de Cordova, per gl’insulti ricevuti nella sua partenza, chi un ritrovato del cardinal di Richelieu, per spopolar Milano, e impadronirsene senza fatica; altri, e non si sa per quali ragioni, ne volevano autore il conte di Collalto, Wallenstein, questo, quell’altro gentiluomo milanese. Non mancavan, come abbiam detto, di quelli che non vedevano in quel fatto altro che uno sciocco scherzo, e l’attribuivano a scolari, a signori, a ufiziali che s’annoiassero all’assedio di Casale. Il non veder poi, come si sarà temuto, che ne seguisse addirittura un infettamento, un eccidio universale, fu probabilmente cagione che quel primo spavento s’andasse per allora acquietando, e la cosa fosse o paresse messa in oblìo.
C’era, del resto, un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. E perché, tanto nel lazzeretto, come per la città, alcuni pur ne guarivano, «si diceua» (gli ultimi argomenti d’una opinione battuta dall’evidenza son sempre curiosi a sapersi), «si diceua dalla plebe, et ancora da molti medici partiali, non essere vera peste, perché tutti sarebbero morti». Per levare ogni dubbio, trovò il tribunale della sanità un espediente proporzionato al bisogno, un modo di parlare agli occhi, quale i tempi potevano richiederlo o suggerirlo. In una delle feste della Pentecoste, usavano i cittadini di concorrere al cimitero di San Gregorio, fuori di Porta Orientale, a pregar per i morti dell’altro contagio, ch’eran sepolti là; e, prendendo dalla divozione opportunità di divertimento e di spettacolo, ci andavano, ognuno più in gala che potesse. Era in quel giorno morta di peste, tra gli altri, un’intera famiglia. Nell’ora del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo, e a piedi, i cadaveri di quella famiglia furono, d’ordine della Sanità, condotti al cimitero suddetto, sur un carro, ignudi, affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, s’alzava per tutto dove passava il carro; un lungo mormorìo regnava dove era passato; un altro mormorìo lo precorreva. La peste fu più creduta: ma del resto andava acquistandosi fede da sé, ogni giorno più; e quella riunione medesima non dové servir poco a propagarla.
In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Non è, credo, necessario d’esser molto versato nella storia dell’idee e delle parole, per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo, che non sono molte quelle d’una tal sorte, e d’una tale importanza, e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo, e alle quali si possano attaccare accessòri d’un tal genere. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole, come nelle grandi, evitare, in gran parte, quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d’osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare.
Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po’ da compatire.

Divenendo sempre più difficile il supplire all’esigenze dolorose della circostanza, era stato, il 4 di maggio, deciso nel consiglio de’ decurioni, di ricorrer per aiuto al governatore. E, il 22, furono spediti al campo due di quel corpo, che gli rappresentassero i guai e le strettezze della città: le spese enormi, le casse vote, le rendite degli anni avvenire impegnate, le imposte correnti non pagate, per la miseria generale, prodotta da tante cause, e dal guasto militare in ispecie; gli mettessero in considerazione che, per leggi e consuetudini non interrotte, e per decreto speciale di Carlo V, le spese della peste dovevan essere a carico del fisco: in quella del 1576 avere il governatore, marchese d’Ayamonte, non solo sospese tutte le imposizioni camerali, ma data alla città una sovvenzione di quaranta mila scudi della stessa Camera; chiedessero finalmente quattro cose: che l’imposizioni fossero sospese, come s’era fatto allora; la Camera desse danari; il governatore informasse il re, delle miserie della città e della provincia; dispensasse da nuovi alloggiamenti militari il paese già rovinato dai passati. Il governatore scrisse in risposta condoglianze, e nuove esortazioni: dispiacergli di non poter trovarsi nella città, per impiegare ogni sua cura in sollievo di quella; ma sperare che a tutto avrebbe supplito lo zelo di que’ signori: questo essere il tempo di spendere senza risparmio, d’ingegnarsi in ogni maniera. In quanto alle richieste espresse, proueeré en el mejor modo que el tiempo y necesidades presentes permitieren. E sotto, un girigogolo, che voleva dire Ambrogio Spinola, chiaro come le sue promesse. Il gran cancelliere Ferrer gli scrisse che quella risposta era stata letta dai decurioni, con gran desconsuelo; ci furono altre andate e venute, domande e risposte; ma non trovo che se ne venisse a più strette conclusioni. Qualche tempo dopo, nel colmo della peste, il governatore trasferì, con lettere patenti, la sua autorità a Ferrer medesimo, avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra. La quale, sia detto qui incidentemente, dopo aver portato via, senza parlar de’ soldati, un milion di persone, a dir poco, per mezzo del contagio, tra la Lombardia, il Veneziano, il Piemonte, la Toscana, e una parte della Romagna; dopo aver desolati, come s’è visto di sopra, i luoghi per cui passò, e figuratevi quelli dove fu fatta; dopo la presa e il sacco atroce di Mantova; finì con riconoscerne tutti il nuovo duca, per escludere il quale la guerra era stata intrapresa. Bisogna però dire che fu obbligato a cedere al duca di Savoia un pezzo del Monferrato, della rendita di quindici mila scudi, e a Ferrante duca di Guastalla altre terre, della rendita di sei mila; e che ci fu un altro trattato a parte e segretissimo, col quale il duca di Savoia suddetto cedé Pinerolo alla Francia: trattato eseguito qualche tempo dopo, sott’altri pretesti, e a furia di furberie.
Insieme con quella risoluzione, i decurioni ne avevan presa un’altra: di chiedere al cardinale arcivescovo, che si facesse una processione solenne, portando per la città il corpo di san Carlo.
Il buon prelato rifiutò, per molte ragioni. Gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario, e temeva che, se l’effetto non avesse corrisposto, come pure temeva, la fiducia si cambiasse in iscandolo. Temeva di più, che, se pur c’era di questi untori, la processione fosse un’occasion troppo comoda al delitto: se non ce n’era, il radunarsi tanta gente non poteva che spander sempre più il contagio: pericolo ben più reale. Ché il sospetto sopito dell’unzioni s’era intanto ridestato, più generale e più furioso di prima.
S’era visto di nuovo, o questa volta era parso di vedere, unte muraglie, porte d’edifizi pubblici, usci di case, martelli. Le nuove di tali scoperte volavan di bocca in bocca; e, come accade più che mai, quando gli animi son preoccupati, il sentire faceva l’effetto del vedere. Gli animi, sempre più amareggiati dalla presenza de’ mali, irritati dall’insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella credenza: ché la collera aspira a punire: e, come osservò acutamente, a questo stesso proposito, un uomo d’ingegno, le piace più d’attribuire i mali a una perversità umana, contro cui possa far le sue vendette, che di riconoscerli da una causa, con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. Un veleno squisito, istantaneo, penetrantissimo, eran parole più che bastanti a spiegar la violenza, e tutti gli accidenti più oscuri e disordinati del morbo. Si diceva composto, quel veleno, di rospi, di serpenti, di bava e di materia d’appestati, di peggio, di tutto ciò che selvagge e stravolte fantasie sapessero trovar di sozzo e d’atroce. Vi s’aggiunsero poi le malìe, per le quali ogni effetto diveniva possibile, ogni obiezione perdeva la forza, si scioglieva ogni difficoltà. Se gli effetti non s’eran veduti subito dopo quella prima unzione, se ne capiva il perché; era stato un tentativo sbagliato di venefici ancor novizi: ora l’arte era perfezionata, e le volontà più accanite nell’infernale proposito. Ormai chi avesse sostenuto ancora ch’era stata una burla, chi avesse negata l’esistenza d’una trama, passava per cieco, per ostinato; se pur non cadeva in sospetto d’uomo interessato a stornar dal vero l’attenzion del pubblico, di complice, d’untore: il vocabolo fu ben presto comune, solenne, tremendo. Con una tal persuasione che ci fossero untori, se ne doveva scoprire, quasi infallibilmente: tutti gli occhi stavano all’erta; ogni atto poteva dar gelosia.
E la gelosia diveniva facilmente certezza, la certezza furore.
Due fatti ne adduce in prova il Ripamonti, avvertendo d’averli scelti, non come i più atroci tra quelli che seguivano giornalmente, ma perché dell’uno e dell’altro era stato pur troppo testimonio. Nella chiesa di sant’Antonio, un giorno di non so quale solennità, un vecchio più che ottuagenario, dopo aver pregato alquanto inginocchioni, volle mettersi a sedere; e prima, con la cappa, spolverò la panca. «Quel vecchio unge le panche!» gridarono a una voce alcune donne che vider l’atto. La gente che si trovava in chiesa (in chiesa!), fu addosso al vecchio; lo prendon per i capelli, bianchi com’erano; lo carican di pugni e di calci; parte lo tirano, parte lo spingon fuori; se non lo finirono, fu per istrascinarlo, così semivivo, alla prigione, ai giudici, alle torture. «Io lo vidi mentre lo strascinavan così,» dice il Ripamonti: «e non ne seppi più altro: credo bene che non abbia potuto sopravvivere più di qualche momento».
L’altro caso (e seguì il giorno dopo) fu ugualmente strano, ma non ugualmente funesto. Tre giovani compagni francesi, un letterato, un pittore, un meccanico, venuti per veder l’Italia, per istudiarvi le antichità, e per cercarvi occasion di guadagno, s’erano accostati a non so qual parte esterna del duomo, e stavan lì guardando attentamente. Uno che passava, li vede e si ferma; gli accenna a un altro, ad altri che arrivano: si formò un crocchio, a guardare, a tener d’occhio coloro, che il vestiario, la capigliatura, le bisacce, accusavano di stranieri e, quel ch’era peggio, di francesi. Come per accertarsi ch’era marmo, stesero essi la mano a toccare. Bastò. Furono circondati, afferrati, malmenati, spinti, a furia di percosse, alle carceri. Per buona sorte, il palazzo di giustizia è poco lontano dal duomo; e, per una sorte ancor più felice, furon trovati innocenti, e rilasciati.
Né tali cose accadevan soltanto in città: la frenesia s’era propagata come il contagio. Il viandante che fosse incontrato da de’ contadini, fuor della strada maestra, o che in quella si dondolasse a guardar in qua e in là, o si buttasse giù per riposarsi; lo sconosciuto a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel volto, nel vestito, erano untori: al primo avviso di chi si fosse, al grido d’un ragazzo, si sonava a martello, s’accorreva; gl’infelici eran tempestati di pietre, o, presi, venivan menati, a furia di popolo, in prigione. Così il Ripamonti medesimo. E la prigione, fino a un certo tempo, era un porto di salvamento.
Ma i decurioni, non disanimati dal rifiuto del savio prelato, andavan replicando le loro istanze, che il voto pubblico secondava rumorosamente. Federigo resistette ancor qualche tempo, cercò di convincerli; questo è quello che poté il senno d’un uomo, contro la forza de’ tempi, e l’insistenza di molti. In quello stato d’opinioni, con l’idea del pericolo, confusa com’era allora, contrastata, ben lontana dall’evidenza che ci si trova ora, non è difficile a capire come le sue buone ragioni potessero, anche nella sua mente, esser soggiogate dalle cattive degli altri. Se poi, nel ceder che fece, avesse o non avesse parte un po’ di debolezza della volontà, sono misteri del cuore umano. Certo, se in alcun caso par che si possa dare in tutto l’errore all’intelletto, e scusarne la coscienza, è quando si tratti di que’ pochi (e questo fu ben del numero), nella vita intera de’ quali apparisca un ubbidir risoluto alla coscienza, senza riguardo a interessi temporali di nessun genere. Al replicar dell’istanze, cedette egli dunque, acconsentì che si facesse la processione, acconsentì di più al desiderio, alla premura generale, che la cassa dov’eran rinchiuse le reliquie di san Carlo, rimanesse dopo esposta, per otto giorni, sull’altar maggiore del duomo.
Non trovo che il tribunale della sanità, né altri, facessero rimostranza né opposizione di sorte alcuna. Soltanto, il tribunale suddetto ordinò alcune precauzioni che, senza riparare al pericolo, ne indicavano il timore. Prescrisse più strette regole per l’entrata delle persone in città; e, per assicurarne l’esecuzione, fece star chiuse le porte: come pure, affine d’escludere, per quanto fosse possibile, dalla radunanza gli infetti e i sospetti, fece inchiodar gli usci delle case sequestrate: le quali, per quanto può valere, in un fatto di questa sorte, la semplice affermazione d’uno scrittore, e d’uno scrittore di quel tempo, eran circa cinquecento.
Tre giorni furono spesi in preparativi: l’undici di giugno, ch’era il giorno stabilito, la processione uscì, sull’alba, dal duomo. Andava dinanzi una lunga schiera di popolo, donne la più parte, coperte il volto d’ampi zendali, molte scalze, e vestite di sacco. Venivan poi l’arti, precedute da’ loro gonfaloni, le confraternite, in abiti vari di forme e di colori; poi le fraterie, poi il clero secolare, ognuno con l’insegne del grado, e con una candela o un torcetto in mano. Nel mezzo, tra il chiarore di più fitti lumi, tra un rumor più alto di canti, sotto un ricco baldacchino, s’avanzava la cassa, portata da quattro canonici, parati in gran pompa, che si cambiavano ogni tanto. Dai cristalli traspariva il venerato cadavere, vestito di splendidi abiti pontificali, e mitrato il teschio; e nelle forme mutilate e scomposte, si poteva ancora distinguere qualche vestigio dell’antico sembiante, quale lo rappresentano l’immagini, quale alcuni si ricordavan d’averlo visto e onorato in vita. Dietro la spoglia del morto pastore (dice il Ripamonti, da cui principalmente prendiamo questa descrizione), e vicino a lui, come di meriti e di sangue e di dignità, così ora anche di persona, veniva l’arcivescovo Federigo. Seguiva l’altra parte del clero; poi i magistrati, con gli abiti di maggior cerimonia; poi i nobili, quali vestiti sfarzosamente, come a dimostrazione solenne di culto, quali, in segno di penitenza, abbrunati, o scalzi e incappati, con la buffa sul viso; tutti con torcetti. Finalmente una coda d’altro popolo misto.
Tutta la strada era parata a festa; i ricchi avevan cavate fuori le suppellettili più preziose; le facciate delle case povere erano state ornate da de’ vicini benestanti, o a pubbliche spese; dove in luogo di parati, dove sopra i parati, c’eran de’ rami fronzuti; da ogni parte pendevano quadri, iscrizioni, imprese; su’ davanzali delle finestre stavano in mostra vasi, anticaglie, rarità diverse; per tutto lumi. A molte di quelle finestre, infermi sequestrati guardavan la processione, e l’accompagnavano con le loro preci. L’altre strade, mute, deserte; se non che alcuni, pur dalle finestre, tendevan l’orecchio al ronzìo vagabondo; altri, e tra questi si videro fin delle monache, eran saliti sui tetti, se di lì potessero veder da lontano quella cassa, il corteggio, qualche cosa.
La processione passò per tutti i quartieri della città: a ognuno di que’ crocicchi, o piazzette, dove le strade principali sboccan ne’ borghi, e che allora serbavano l’antico nome di carrobi, ora rimasto a uno solo, si faceva una fermata, posando la cassa accanto alla croce che in ognuno era stata eretta da san Carlo, nella peste antecedente, e delle quali alcune sono tuttavia in piedi: di maniera che si tornò in duomo un pezzo dopo il mezzogiorno.
Ed ecco che, il giorno seguente, mentre appunto regnava quella presontuosa fiducia, anzi in molti una fanatica sicurezza che la processione dovesse aver troncata la peste, le morti crebbero, in ogni classe, in ogni parte della città, a un tal eccesso, con un salto così subitaneo, che non ci fu chi non ne vedesse la causa, o l’occasione, nella processione medesima. Ma, oh forze mirabili e dolorose d’un pregiudizio generale! non già al trovarsi insieme tante persone, e per tanto tempo, non all’infinita moltiplicazione de’ contatti fortuiti, attribuivano i più quell’effetto; l’attribuivano alla facilità che gli untori ci avessero trovata d’eseguire in grande il loro empio disegno. Si disse che, mescolati nella folla, avessero infettati col loro unguento quanti più avevan potuto. Ma siccome questo non pareva un mezzo bastante, né appropriato a una mortalità così vasta, e così diffusa in ogni classe di persone; siccome, a quel che pare, non era stato possibile all’occhio così attento, e pur così travedente, del sospetto, di scorgere untumi, macchie di nessuna sorte, su’ muri, né altrove; così si ricorse, per la spiegazion del fatto, a quell’altro ritrovato, già vecchio, e ricevuto allora nella scienza comune d’Europa, delle polveri venefiche e malefiche; si disse che polveri tali, sparse lungo la strada, e specialmente ai luoghi delle fermate, si fossero attaccate agli strascichi de’ vestiti, e tanto più ai piedi, che in gran numero erano quel giorno andati in giro scalzi. «Vide pertanto,» dice uno scrittore contemporaneo, «l’istesso giorno della processione, la pietà cozzar con l’empietà, la perfidia con la sincerità, la perdita con l’acquisto». Ed era in vece il povero senno umano che cozzava co’ fantasmi creati da sé.
Da quel giorno, la furia del contagio andò sempre crescendo: in poco tempo, non ci fu quasi più casa che non fosse toccata: in poco tempo la popolazione del lazzeretto, al dir del Somaglia citato di sopra, montò da duemila a dodici mila: più tardi, al dir di quasi tutti, arrivò fino a sedici mila. Il 4 di luglio, come trovo in un’altra lettera de’ conservatori della sanità al governatore, la mortalità giornaliera oltrepassava i cinquecento. Più innanzi, e nel colmo, arrivò, secondo il calcolo più comune, a mille dugento, mille cinquecento; e a più di tremila cinquecento, se vogliam credere al Tadino. Il quale anche afferma che, «per le diligenze fatte», dopo la peste, si trovò la popolazion di Milano ridotta a poco più di sessantaquattro mila anime, e che prima passava le dugento cinquanta mila. Secondo il Ripamonti, era di sole dugento mila: de’ morti, dice che ne risultava cento quaranta mila da’ registri civici, oltre quelli di cui non si poté tener conto. Altri dicon più o meno, ma ancor più a caso.
Si pensi ora in che angustie dovessero trovarsi i decurioni, addosso ai quali era rimasto il peso di provvedere alle pubbliche necessità, di riparare a ciò che c’era di riparabile in un tal disastro. Bisognava ogni giorno sostituire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie specie: monatti, apparitori, commissari. I primi erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza: levar dalle case, dalle strade, dal lazzeretto, i cadaveri; condurli sui carri alle fosse, e sotterrarli; portare o guidare al lazzeretto gl’infermi, e governarli; bruciare, purgare la roba infetta e sospetta. Il nome, vuole il Ripamonti che venga dal greco monos; Gaspare Bugatti (in una descrizion della peste antecedente), dal latino monere; ma insieme dubita, con più ragione, che sia parola tedesca, per esser quegli uomini arrolati la più parte nella Svizzera e ne’ Grigioni. Né sarebbe infatti assurdo il crederlo una troncatura del vocabolo monathlich (mensuale); giacché, nell’incertezza di quanto potesse durare il bisogno, è probabile che gli accordi non fossero che di mese in mese. L’impiego speciale degli apparitori era di precedere i carri, avvertendo, col suono d’un campanello, i passeggieri, che si ritirassero. I commissari regolavano gli uni e gli altri, sotto gli ordini immediati del tribunale della sanità. Bisognava tener fornito il lazzeretto di medici, di chirurghi, di medicine, di vitto, di tutti gli attrezzi d’infermeria; bisognava trovare e preparar nuovo alloggio per gli ammalati che sopraggiungevano ogni giorno. Si fecero a quest’effetto costruire in fretta capanne di legno e di paglia nello spazio interno del lazzeretto; se ne piantò un nuovo, tutto di capanne, cinto da un semplice assito, e capace di contener quattromila persone. E non bastando, ne furon decretati due altri; ci si mise anche mano; ma, per mancanza di mezzi d’ogni genere, rimasero in tronco. I mezzi, le persone, il coraggio, diminuivano di mano in mano che il bisogno cresceva.
E non solo l’esecuzione rimaneva sempre addietro de’ progetti e degli ordini; non solo, a molte necessità, pur troppo riconosciute, si provvedeva scarsamente, anche in parole; s’arrivò a quest’eccesso d’impotenza e di disperazione, che a molte, e delle più pietose, come delle più urgenti, non si provvedeva in nessuna maniera. Moriva, per esempio, d’abbandono una gran quantità di bambini, ai quali eran morte le madri di peste: la Sanità propose che s’istituisse un ricovero per questi e per le partorienti bisognose, che qualcosa si facesse per loro; e non poté ottener nulla. «Si doueua non di meno,» dice il Tadino, «compatire ancora alli Decurioni della Città, li quali si trouauano afflitti, mesti et lacerati dalla Soldatesca senza regola, et rispetto alcuno; come molto meno nell’infelice Ducato, atteso che aggiutto alcuno, né prouisione si poteua hauere dal Gouernatore, se non che si trouaua tempo di guerra, et bisognaua trattar bene li Soldati». Tanto importava il prender Casale! Tanto par bella la lode del vincere, indipendentemente dalla cagione, dallo scopo per cui si combatta!
Così pure, trovandosi colma di cadaveri un’ampia, ma unica fossa, ch’era stata scavata vicino al lazzeretto; e rimanendo, non solo in quello, ma in ogni parte della città, insepolti i nuovi cadaveri, che ogni giorno eran di più, i magistrati, dopo avere invano cercato braccia per il tristo lavoro, s’eran ridotti a dire di non saper più che partito prendere. Né si vede come sarebbe andata a finire, se non veniva un soccorso straordinario. Il presidente della Sanità ricorse, per disperato, con le lacrime agli occhi, a que’ due bravi frati che soprintendevano al lazzeretto; e il padre Michele s’impegnò a dargli, in capo a quattro giorni, sgombra la città di cadaveri; in capo a otto, aperte fosse sufficienti, non solo al bisogno presente, ma a quello che si potesse preveder di peggio nell’avvenire. Con un frate compagno, e con persone del tribunale, dategli dal presidente, andò fuor della città, in cerca di contadini; e, parte con l’autorità del tribunale, parte con quella dell’abito e delle sue parole, ne raccolse circa dugento, ai quali fece scavar tre grandissime fosse; spedì poi dal lazzeretto monatti a raccogliere i morti; tanto che, il giorno prefisso, la sua promessa si trovò adempita.
Una volta, il lazzeretto rimase senza medici; e, con offerte di grosse paghe e d’onori, a fatica e non subito, se ne poté avere; ma molto men del bisogno. Fu spesso lì lì per mancare affatto di viveri, a segno di temere che ci s’avesse a morire anche di fame; e più d’una volta, mentre non si sapeva più dove batter la testa per trovare il bisognevole, vennero a tempo abbondanti sussidi, per inaspettato dono di misericordia privata: ché, in mezzo allo stordimento generale, all’indifferenza per gli altri, nata dal continuo temer per sé, ci furono degli animi sempre desti alla carità, ce ne furon degli altri in cui la carità nacque al cessare d’ogni allegrezza terrena; come, nella strage e nella fuga di molti a cui toccava di soprintendere e di provvedere, ce ne furono alcuni, sani sempre di corpo, e saldi di coraggio al loro posto: ci furon pure altri che, spinti dalla pietà, assunsero e sostennero virtuosamente le cure a cui non eran chiamati per impiego.
Dove spiccò una più generale e più pronta e costante fedeltà ai doveri difficili della circostanza, fu negli ecclesiastici. Ai lazzeretti, nella città, non mancò mai la loro assistenza: dove si pativa, ce n’era; sempre si videro mescolati, confusi co’ languenti, co’ moribondi, languenti e moribondi qualche volta loro medesimi; ai soccorsi spirituali aggiungevano, per quanto potessero, i temporali; prestavano ogni servizio che richiedessero le circostanze. Più di sessanta parrochi, della città solamente, moriron di contagio: gli otto noni, all’incirca.
Federigo dava a tutti, com’era da aspettarsi da lui, incitamento ed esempio. Mortagli intorno quasi tutta la famiglia arcivescovile, e facendogli istanza parenti, alti magistrati, principi circonvicini, che s’allontanasse dal pericolo, ritirandosi in qualche villa, rigettò un tal consiglio, e resistette all’istanze, con quell’animo, con cui scriveva ai parrochi: «siate disposti ad abbandonar questa vita mortale, piuttosto che questa famiglia, questa figliolanza nostra: andate con amore incontro alla peste, come a un premio, come a una vita, quando ci sia da guadagnare un’anima a Cristo.» Non trascurò quelle cautele che non gl’impedissero di fare il suo dovere (sulla qual cosa diede anche istruzioni e regole al clero); e insieme non curò il pericolo, né parve che se n’avvedesse, quando, per far del bene, bisognava passar per quello. Senza parlare degli ecclesiastici, coi quali era sempre per lodare e regolare il loro zelo, per eccitare chiunque di loro andasse freddo nel lavoro, per mandarli ai posti dove altri eran morti, volle che fosse aperto l’adito a chiunque avesse bisogno di lui. Visitava i lazzeretti, per dar consolazione agl’infermi, e per animare i serventi; scorreva la città, portando soccorsi ai poveri sequestrati nelle case, fermandosi agli usci, sotto le finestre, ad ascoltare i loro lamenti, a dare in cambio parole di consolazione e di coraggio. Si cacciò in somma e visse nel mezzo della pestilenza, maravigliato anche lui alla fine, d’esserne uscito illeso.
Così, ne’ pubblici infortuni, e nelle lunghe perturbazioni di quel qual si sia ordine consueto, si vede sempre un aumento, una sublimazione di virtù; ma, pur troppo, non manca mai insieme un aumento, e d’ordinario ben più generale, di perversità.
E questo pure fu segnalato. I birboni che la peste risparmiava e non atterriva, trovarono nella confusion comune, nel rilasciamento d’ogni forza pubblica, una nuova occasione d’attività, e una nuova sicurezza d’impunità a un tempo. Che anzi, l’uso della forza pubblica stessa venne a trovarsi in gran parte nelle mani de’ peggiori tra loro. All’impiego di monatti e d’apparitori non s’adattavano generalmente che uomini sui quali l’attrattiva delle rapine e della licenza potesse più che il terror del contagio, che ogni naturale ribrezzo. Erano a costoro prescritte strettissime regole, intimate severissime pene, assegnati posti, dati per superiori de’ commissari, come abbiam detto; sopra questi e quelli eran delegati in ogni quartiere, magistrati e nobili, con l’autorità di provveder sommariamente a ogni occorrenza di buon governo. Un tal ordin di cose camminò, e fece effetto, fino a un certo tempo; ma, crescendo, ogni giorno, il numero di quelli che morivano, di quelli che andavan via, di quelli che perdevan la testa, venner coloro a non aver quasi più nessuno che li tenesse a freno; si fecero, i monatti principalmente, arbitri d’ogni cosa. Entravano da padroni, da nemici nelle case, e, senza parlar de’ rubamenti, e come trattavano gl’infelici ridotti dalla peste a passar per tali mani, le mettevano, quelle mani infette e scellerate, sui sani, figliuoli, parenti, mogli, mariti, minacciando di strascinarli al lazzeretto, se non si riscattavano, o non venivano riscattati con danari. Altre volte, mettevano a prezzo i loro servizi, ricusando di portar via i cadaveri già putrefatti, a meno di tanti scudi. Si disse (e tra la leggerezza degli uni e la malvagità degli altri, è ugualmente malsicuro il credere e il non credere), si disse, e l’afferma anche il Tadino, che monatti e apparitori lasciassero cadere apposta dai carri robe infette, per propagare e mantenere la pestilenza, divenuta per essi un’entrata, un regno, una festa. Altri sciagurati, fingendosi monatti, portando un campanello attaccato a un piede, com’era prescritto a quelli, per distintivo e per avviso del loro avvicinarsi, s’introducevano nelle case a farne di tutte le sorte. In alcune, aperte e vote d’abitanti, o abitate soltanto da qualche languente, da qualche moribondo, entravan ladri, a man salva, a saccheggiare: altre venivan sorprese, invase da birri che facevan lo stesso, e anche cose peggiori.
Del pari con la perversità, crebbe la pazzia: tutti gli errori già dominanti più o meno, presero dallo sbalordimento, e dall’agitazione delle menti, una forza straordinaria, produssero effetti più rapidi e più vasti. E tutti servirono a rinforzare e a ingrandire quella paura speciale dell’unzioni, la quale, ne’ suoi effetti, ne’ suoi sfoghi, era spesso, come abbiam veduto, un’altra perversità. L’immagine di quel supposto pericolo assediava e martirizzava gli animi, molto più che il pericolo reale e presente. «E mentre,» dice il Ripamonti, «i cadaveri sparsi, o i mucchi di cadaveri, sempre davanti agli occhi, sempre tra’ piedi, facevano della città tutta come un solo mortorio, c’era qualcosa di più brutto, di più funesto, in quell’accanimento vicendevole, in quella sfrenatezza e mostruosità di sospetti… Non del vicino soltanto si prendeva ombra, dell’amico, dell’ospite; ma que’ nomi, que’ vincoli dell’umana carità, marito e moglie, padre e figlio, fratello e fratello, eran di terrore: e, cosa orribile e indegna a dirsi! la mensa domestica, il letto nuziale, si temevano, come agguati, come nascondigli di venefizio».
La vastità immaginata, la stranezza della trama turbavan tutti i giudizi, alteravan tutte le ragioni della fiducia reciproca. Da principio, si credeva soltanto che quei supposti untori fosser mossi dall’ambizione e dalla cupidigia; andando avanti, si sognò, si credette che ci fosse una non so quale voluttà diabolica in quell’ungere, un’attrattiva che dominasse le volontà. I vaneggiamenti degl’infermi che accusavan se stessi di ciò che avevan temuto dagli altri, parevano rivelazioni, e rendevano ogni cosa, per dir così, credibile d’ognuno. E più delle parole, dovevan far colpo le dimostrazioni, se accadeva che appestati in delirio andasser facendo di quegli atti che s’erano figurati che dovessero fare gli untori: cosa insieme molto probabile, e atta a dar miglior ragione della persuasion generale e dell’affermazioni di molti scrittori. Così, nel lungo e tristo periodo de’ processi per stregoneria, le confessioni, non sempre estorte, degl’imputati, non serviron poco a promovere e a mantener l’opinione che regnava intorno ad essa: ché, quando un’opinione regna per lungo tempo, e in una buona parte del mondo, finisce a esprimersi in tutte le maniere, a tentar tutte l’uscite, a scorrer per tutti i gradi della persuasione; ed è difficile che tutti o moltissimi credano a lungo che una cosa strana si faccia, senza che venga alcuno il quale creda di farla.
Tra le storie che quel delirio dell’unzioni fece immaginare, una merita che se ne faccia menzione, per il credito che acquistò, e per il giro che fece. Si raccontava, non da tutti nell’istessa maniera (che sarebbe un troppo singolar privilegio delle favole), ma a un di presso, che un tale, il tal giorno, aveva visto arrivar sulla piazza del duomo un tiro a sei, e dentro, con altri, un gran personaggio, con una faccia fosca e infocata, con gli occhi accesi, coi capelli ritti, e il labbro atteggiato di minaccia. Mentre quel tale stava intento a guardare, la carrozza s’era fermata; e il cocchiere l’aveva invitato a salirvi; e lui non aveva saputo dir di no. Dopo diversi rigiri, erano smontati alla porta d’un tal palazzo, dove entrato anche lui, con la compagnia, aveva trovato amenità e orrori, deserti e giardini, caverne e sale; e in esse, fantasime sedute a consiglio. Finalmente, gli erano state fatte vedere gran casse di danaro, e detto che ne prendesse quanto gli fosse piaciuto, con questo però, che accettasse un vasetto d’unguento, e andasse con esso ungendo per la città. Ma, non avendo voluto acconsentire, s’era trovato, in un batter d’occhio, nel medesimo luogo dove era stato preso. Questa storia, creduta qui generalmente dal popolo, e, al dir del Ripamonti, non abbastanza derisa da qualche uomo di peso, girò per tutta Italia e fuori. In Germania se ne fece una stampa: l’elettore arcivescovo di Magonza scrisse al cardinal Federigo, per domandargli cosa si dovesse credere de’ fatti maravigliosi che si raccontavan di Milano; e n’ebbe in risposta ch’eran sogni.
D’ugual valore, se non in tutto d’ugual natura, erano i sogni de’ dotti; come disastrosi del pari n’eran gli effetti. Vedevano, la più parte di loro, l’annunzio e la ragione insieme de’ guai in una cometa apparsa l’anno 1628, e in una congiunzione di Saturno con Giove, «inclinando,» scrive il Tadino, «la congiontione sodetta sopra questo anno 1630, tanto chiara, che ciascun la poteua intendere. Mortales parat morbos, miranda videntur». Questa predizione, cavata, dicevano, da un libro intitolato Specchio degli almanacchi perfetti, stampato in Torino, nel 1623, correva per le bocche di tutti. Un’altra cometa, apparsa nel giugno dell’anno stesso della peste, si prese per un nuovo avviso; anzi per una prova manifesta dell’unzioni. Pescavan ne’ libri, e pur troppo ne trovavano in quantità, esempi di peste, come dicevano, manufatta: citavano Livio, Tacito, Dione, che dico? Omero e Ovidio, i molti altri antichi che hanno raccontati o accennati fatti somiglianti: di moderni ne avevano ancor più in abbondanza. Citavano cent’altri autori che hanno trattato dottrinalmente, o parlato incidentemente di veleni, di malìe, d’unti, di polveri: il Cesalpino, il Cardano, il Grevino, il Salio, il Pareo, lo Schenchio, lo Zachia e, per finirla, quel funesto Delrio, il quale, se la rinomanza degli autori fosse in ragione del bene e del male prodotto dalle loro opere, dovrebb’essere uno de’ più famosi; quel Delrio, le cui veglie costaron la vita a più uomini che l’imprese di qualche conquistatore: quel Delrio, le cui Disquisizioni Magiche (il ristretto di tutto ciò che gli uomini avevano, fino a’ suoi tempi, sognato in quella materia), divenute il testo più autorevole, più irrefragabile, furono, per più d’un secolo, norma e impulso potente di legali, orribili, non interrotte carnificine.
Da’ trovati del volgo, la gente istruita prendeva ciò che si poteva accomodar con le sue idee; da’ trovati della gente istruita, il volgo prendeva ciò che ne poteva intendere, e come lo poteva; e di tutto si formava una massa enorme e confusa di pubblica follia.
Ma ciò che reca maggior maraviglia, è il vedere i medici, dico i medici che fin da principio avevan creduta la peste, dico in ispecie il Tadino, il quale l’aveva pronosticata, vista entrare, tenuta d’occhio, per dir così, nel suo progresso, il quale aveva detto e predicato che l’era peste, e s’attaccava col contatto, che non mettendovi riparo, ne sarebbe infettato tutto il paese, vederlo poi, da questi effetti medesimi cavare argomento certo dell’unzioni venefiche e malefiche; lui che in quel Carlo Colonna, il secondo che morì di peste in Milano, aveva notato il delirio come un accidente della malattia, vederlo poi addurre in prova dell’unzioni e della congiura diabolica, un fatto di questa sorte: che due testimoni deponevano d’aver sentito raccontare da un loro amico infermo, come, una notte, gli eran venute persone in camera, a esibirgli la guarigione e danari, se avesse voluto unger le case del contorno; e come al suo rifiuto quelli se n’erano andati, e in loro vece, era rimasto un lupo sotto il letto, e tre gattoni sopra, «che sino al far del giorno vi dimororno».
Se fosse stato uno solo che connettesse così, si dovrebbe dire che aveva una testa curiosa; o piuttosto non ci sarebbe ragion di parlarne; ma siccome eran molti, anzi quasi tutti, così è storia dello spirito umano, e dà occasion d’osservare quanto una serie ordinata e ragionevole d’idee possa essere scompigliata da un’altra serie d’idee, che ci si getti a traverso. Del resto, quel Tadino era qui uno degli uomini più riputati del suo tempo.
Due illustri e benemeriti scrittori hanno affermato che il cardinal Federigo dubitasse del fatto dell’unzioni. Noi vorremmo poter dare a quell’inclita e amabile memoria una lode ancor più intera, e rappresentare il buon prelato, in questo, come in tant’altre cose, superiore alla più parte de’ suoi contemporanei, ma siamo in vece costretti di notar di nuovo in lui un esempio della forza d’un’opinione comune anche sulle menti più nobili. S’è visto, almeno da quel che ne dice il Ripamonti, come da principio, veramente stesse in dubbio: ritenne poi sempre che in quell’opinione avesse gran parte la credulità, l’ignoranza, la paura, il desiderio di scusarsi d’aver così tardi riconosciuto il contagio, e pensato a mettervi riparo; che molto ci fosse d’esagerato, ma insieme, che qualche cosa ci fosse di vero. Nella biblioteca ambrosiana si conserva un’operetta scritta di sua mano intorno a quella peste; e questo sentimento c’è accennato spesso, anzi una volta enunciato espressamente. «Era opinion comune,» dice a un di presso, «che di questi unguenti se ne componesse in vari luoghi, e che molte fossero l’arti di metterlo in opera: delle quali alcune ci paion vere, altre inventate.»
Ci furon però di quelli che pensarono fino alla fine, e fin che vissero, che tutto fosse immaginazione: e lo sappiamo, non da loro, ché nessuno fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così opposto a quello del pubblico; lo sappiamo dagli scrittori che lo deridono o lo riprendono o lo ribattono, come un pregiudizio d’alcuni, un errore che non s’attentava di venire a disputa palese, ma che pur viveva; lo sappiamo anche da chi ne aveva notizia per tradizione. «Ho trovato gente savia in Milano,» dice il buon Muratori, nel luogo sopraccitato, «che aveva buone relazioni dai loro maggiori, e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi». Si vede ch’era uno sfogo segreto della verità, una confidenza domestica: il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune.
I magistrati, scemati ogni giorno, e sempre più smarriti e confusi, tutta, per dir così, quella poca risoluzione di cui eran capaci, l’impiegarono a cercar di questi untori. Tra le carte del tempo della peste, che si conservano nell’archivio nominato di sopra, c’è una lettera (senza alcun altro documento relativo) in cui il gran cancelliere informa, sul serio e con gran premura, il governatore d’aver ricevuto un avviso che, in una casa di campagna de’ fratelli Girolamo e Giulio Monti, gentiluomini milanesi, si componeva veleno in tanta quantità, che quaranta uomini erano occupati en este exercicio, con l’assistenza di quattro cavalieri bresciani, i quali facevano venir materiali dal veneziano, para la fàbrica del veneno. Soggiunge che lui aveva preso, in gran segreto, i concerti necessari per mandar là il podestà di Milano e l’auditore della Sanità, con trenta soldati di cavalleria; che pur troppo uno de’ fratelli era stato avvertito a tempo per poter trafugare gl’indizi del delitto, e probabilmente dall’auditor medesimo, suo amico; e che questo trovava delle scuse per non partire; ma che non ostante, il podestà co’ soldati era andato a reconocer la casa, y a ver si hallará algunos vestigios, e prendere informazioni, e arrestar tutti quelli che fossero incolpati.
La cosa dové finire in nulla, giacché gli scritti del tempo che parlano de’ sospetti che c’eran su que’ gentiluomini, non citano alcun fatto. Ma pur troppo, in un’altra occasione, si credé d’aver trovato.
I processi che ne vennero in conseguenza, non eran certamente i primi d’un tal genere: e non si può neppur considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza. Ché, per tacere dell’antichità, e accennar solo qualcosa de’ tempi più vicini a quello di cui trattiamo, in Palermo, del 1526; in Ginevra, del 1530, poi del 1545, poi ancora del 1574; in Casal Monferrato, del 1536; in Padova, del 1555; in Torino, del 1599, e di nuovo, in quel medesim’anno 1630, furon processati e condannati a supplizi, per lo più atrocissimi, dove qualcheduno, dove molti infelici, come rei d’aver propagata la peste, con polveri, o con unguenti, o con malìe, o con tutto ciò insieme. Ma l’affare delle così dette unzioni di Milano, come fu il più celebre, così è fors’anche il più osservabile; o, almeno, c’è più campo di farci sopra osservazione, per esserne rimasti documenti più circostanziati e più autentici.

Peste del 1630. Piazza San Babila
La peste è la seconda riflessione storica di Manzoni e si sviluppa per ben due capitoli. Anche qui ricorre ad una vera e propria pausa narrativa e lascia i suoi personaggi per profondersi in un’analisi che, pur inserendosi in una lunga tradizione (che va da Tucidide a Lucrezio e in ultimo a Boccaccio), se ne distacca. All’autore milanese non interessa indagare le cause, gli effetti, il modo in cui si propaga, ma soprattutto come la peste e, attraverso essa la storia, s’inserisce nella vita degli uomini.
Possiamo dividere il lungo passo in quattro parti fondamentali:
- nel primo il modo in cui il morbo si affaccia e si propaga, quindi l’intellighenzia scientifica del periodo, soprattutto il medico Settale, che cerca di vincere l’incredulità della gente. Sembra che la storia per Manzoni, oltre ad essere presieduta dalla volontà divina, sia frutto anche di scelte individuali, e qui, come l’incapacità di molti, abbia aiutato il diffondersi della malattia;
- l’intervento dei francescani e la caccia degli untori. Alla dedizione dei primi nel lazzaretto, a cui, giorno dopo giorno, vengono a mancare i beni di prima necessità, risponde l’irrazionalità dei molti, la ricerca spasmodica di capi espiatori che rendano comprensibile ciò che non può essere capito (o si può capire andando ad analizzare le condizioni storico/economiche: la guerra, l’invasione dei lanzichenecchi, la carestia).
- Il capitolo sottolinea il disinteresse da parte del governatore, preso dalla necessità della guerra, e l’affidamento a dei notabili lasciati senza mezzi. La descrizione che, pur partendo dalla necessità di un affidamento dei credenti a Dio, non potendo contare sugli uomini, di una processione mostra la cecità anche dell’autorità religiosa, perché anch’essa sarà foriera di propagazione del male;
- Torna all’attenzione dell’autore, in quest’ultima parte nella descrizione della peste, la figura dell’uomo, con tutte le sue superstizioni, le violenze per la mancanza del diritto, che colpisce trasversalmente tutte le classi. La ricerca dell’untore diventa centrale, e sui processi farsa ci sarebbe così tanto da raccontare che sarà materia di un vero e proprio scritto manzoniano, pubblicato dopo il romanzo Storia della colonna infame. Il poeta sembra dirci che ad un’epidemia fisiologica sia seguita da un’epidemia intellettuale.
La poesia
CAPITOLO VIII
ADDIO AI MONTI
Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana! Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono, in quel momento, i sogni della ricchezza; egli si maraviglia d’essersi potuto risolvere, e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che, un giorno, tornerà dovizioso. Quanto più si avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco, da quell’ampiezza uniforme; l’aria gli par gravosa e morta; s’inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose; le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro; e davanti agli edifizi ammirati dallo straniero, pensa, con desiderio inquieto, al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso, da gran tempo, e che comprerà, tornando ricco a’ suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo, chi aveva composti in essi tutti i disegni dell’avvenire, e n’è sbalzato lontano, da una forza perversa! Chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini, e disturbato nelle più care speranze, lascia que’ monti, per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha 193 mai desiderato di conoscere, e non può con l’immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno! Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov’era promesso, preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l’amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio! Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai la gioia de’ suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande.
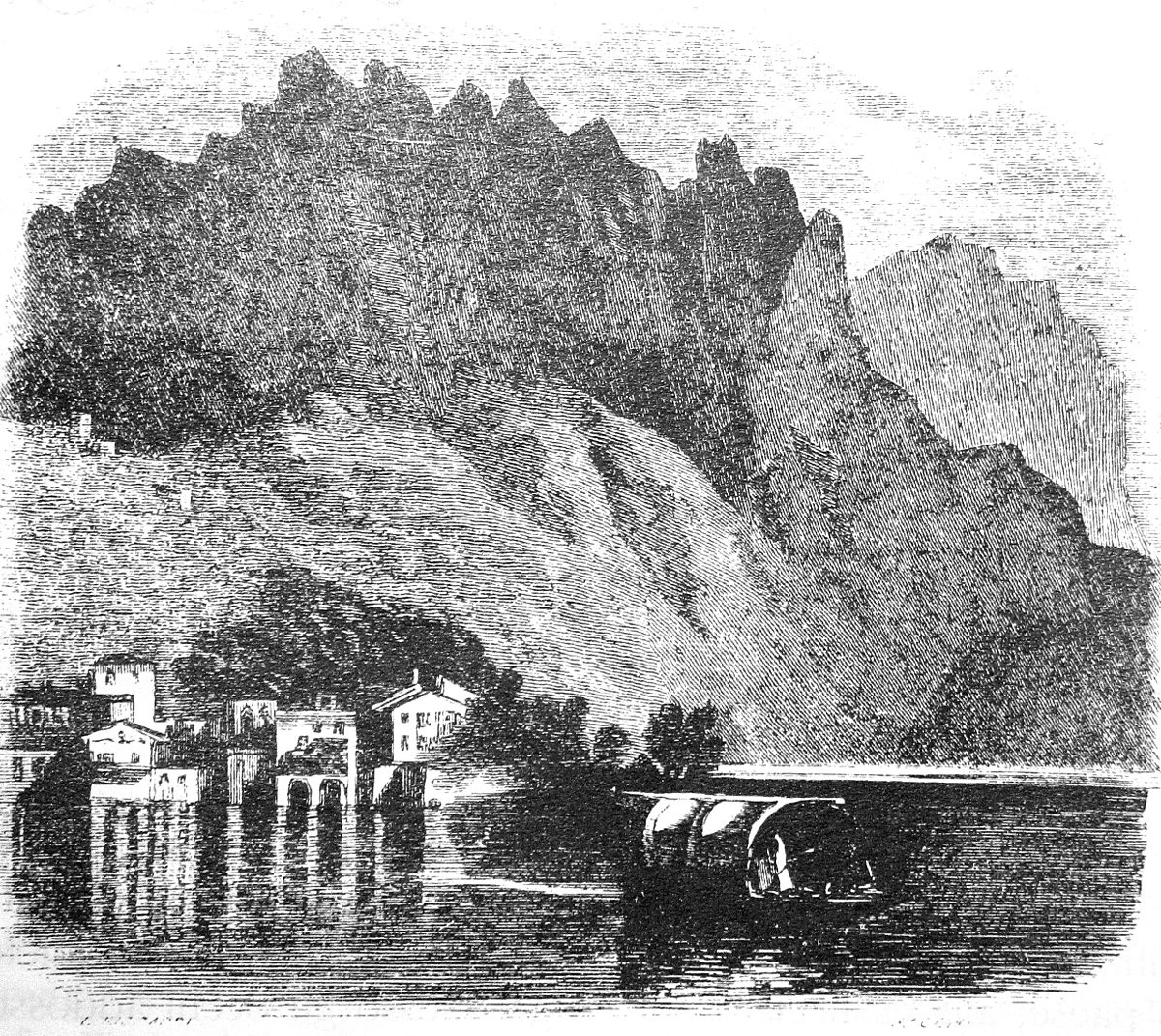 he l’Addio ai monti si configuri come un elemento lirico, basta osservare la prima frase che è strutturata con un endecasillabo. E’ infatti un brano elegiaco: l’abbandono di un luogo in cui, se fosse stata sposa, avrebbe potuto vivere la felicità. Tre sono i sintagmi intorno cui è costruito il passo: “care abitudini”, “care speranze”, “giocondità”: sono queste a costituire un Eden da cui è Lucia è costretta a fuggire. E’ l’Eden fatto di abitudini, di gesti ripetuti, di luoghi conosciuti: sicurezza e felicità, senza bisogno d’allargare l’orizzonte. E se il paese è tranquillità umilmente paradisiaca, l’esterno, la città, non può essere che inferno, con quel groviglio di case, con mancanza di prospettiva (si ricordi l’episodio della carestia). Non è una novità che Manzoni qui si faccia interprete dei pensieri di Lucia; ma appunto perché è l’autore a interpretare i sentimenti che il brano si fa elegia, allo stesso modo in cui Virgilio si fa interprete del pastore a cui è stata strappata la terra.
he l’Addio ai monti si configuri come un elemento lirico, basta osservare la prima frase che è strutturata con un endecasillabo. E’ infatti un brano elegiaco: l’abbandono di un luogo in cui, se fosse stata sposa, avrebbe potuto vivere la felicità. Tre sono i sintagmi intorno cui è costruito il passo: “care abitudini”, “care speranze”, “giocondità”: sono queste a costituire un Eden da cui è Lucia è costretta a fuggire. E’ l’Eden fatto di abitudini, di gesti ripetuti, di luoghi conosciuti: sicurezza e felicità, senza bisogno d’allargare l’orizzonte. E se il paese è tranquillità umilmente paradisiaca, l’esterno, la città, non può essere che inferno, con quel groviglio di case, con mancanza di prospettiva (si ricordi l’episodio della carestia). Non è una novità che Manzoni qui si faccia interprete dei pensieri di Lucia; ma appunto perché è l’autore a interpretare i sentimenti che il brano si fa elegia, allo stesso modo in cui Virgilio si fa interprete del pastore a cui è stata strappata la terra.
CAPITOLO XXXIV
CECILIA

Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne’ cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull’omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre, ché, se anche la somiglianza de’ volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due ch’esprimeva ancora un sentimento.
Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito rispetto, con un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «no!» disse: «non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: «promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sotto terra così. Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un po’ di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: «addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e per gli altri». Poi voltatasi di nuovo al monatto, «voi,» disse, «passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola.» Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, tenendo in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l’unica che le rimaneva, e mettersele accanto per morire insieme? come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato. «O Signore!» esclamò Renzo: «esauditela! tiratela a voi, lei e la sua creaturina: hanno patito abbastanza! hanno patito abbastanza!»
L’episodio di Cecilia sembra stagliarsi con vividezza figurativa contro l’idea di morte che l’intero quadro della peste ci aveva offerto. La capacità manzoniana è quella di darci una figura quasi mariana che è stata tuttavia vinta dal morbo: Cecilia infatti è ancora, nella malattia, bella, di quella bellezza lombarda, dolce ma maestosa (pudica, ma un po’ guerriera, aveva definito Lucia), la cui presenza ingentilisce addirittura i monatti, che con la peggior morte parlano e scherzano. Ma ciò non può avvenire con Cecilia. Prepara il corpicino della figlia per farne offerta a Dio, senza possibilità di alcuna sconcezza; si prepara ad andare verso la luce con lo stessa dignità. Per una volta riuscirà, anche lei figura Christi, a far dei monatti uomini col timor di Dio.
La conclusione
CAPITOLO XXXVIII
IL SUGO DELLA STORIA
Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate, per governarsi meglio in avvenire. «Ho imparato,» diceva, «a non mettermi ne’ tumulti: ho imparato a non predicare in piazza: ho imparato a guardare con chi parlo: ho imparato a non alzar troppo il gomito: ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte, quando c’è lì d’intorno gente che ha la testa calda: ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede, prima d’aver pensato quel che possa nascere». E cent’altre cose. Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n’era soddisfatta; le pareva, così in confuso, che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarci sopra ogni volta, «e io,» disse un giorno al suo moralista, «cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai: son loro che sono venuti a cercar me. Quando non voleste dire,» aggiunse, soavemente sorridendo, «che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di promettermi a voi. Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c’è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia. La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un pochino a chi l’ha raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta.

L’ultima pagina del romanzo ha aperto un dibattito critico assai articolato. Che si può spiegare attraverso due soli atteggiamenti:
- Religioso: la fine “consolatrice”, per cui tutto ciò che è stato di ostacolo, nel corso della storia, non può che ripetere quell’aspetto cattolico manzoniano che vede la sofferenza come unico strumento per l’ottenimento della grazia divina. L’uomo manzoniano è sempre figlio del peccato originale: soltanto attraverso le prove egli, infine può diventare uomo degno di essere chiamato figlio di Dio (si potrebbe anche parlare, per la figura di Renzo, di romanzo di formazione).
- Politico: l’atteggiamento di Renzo, per cui ha imparato a non mettersi nei tumulti, a non predicare in piazza, a non alzar troppo il gomito…., dimostra da una parte l’Italia che Manzoni non vuole (come già detto, l’esperienza giacobina lo spaventa), dall’altra il futuro che egli auspica: un paese di piccoli proprietari terrieri, (potremo dire, una piccola borghesia) con profondi valori cattolici a sorreggerla moralmente. Insomma quel famoso liberalismo democratico di cui Gioberti fu il massimo esponente.






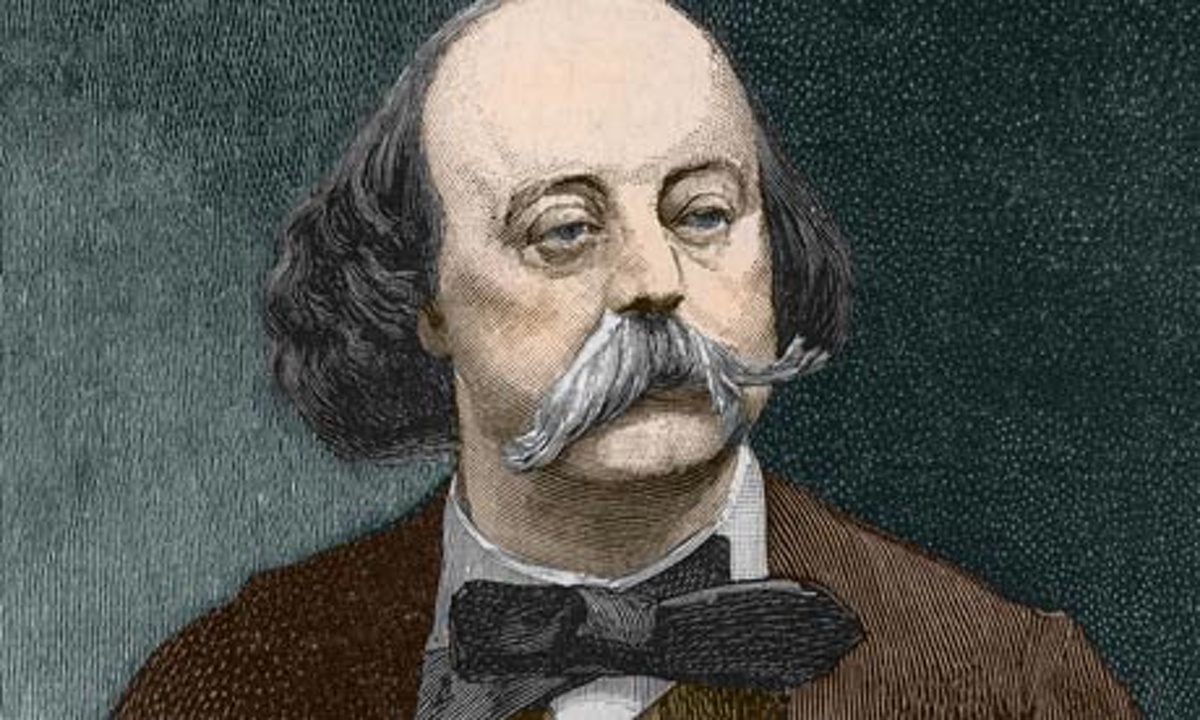
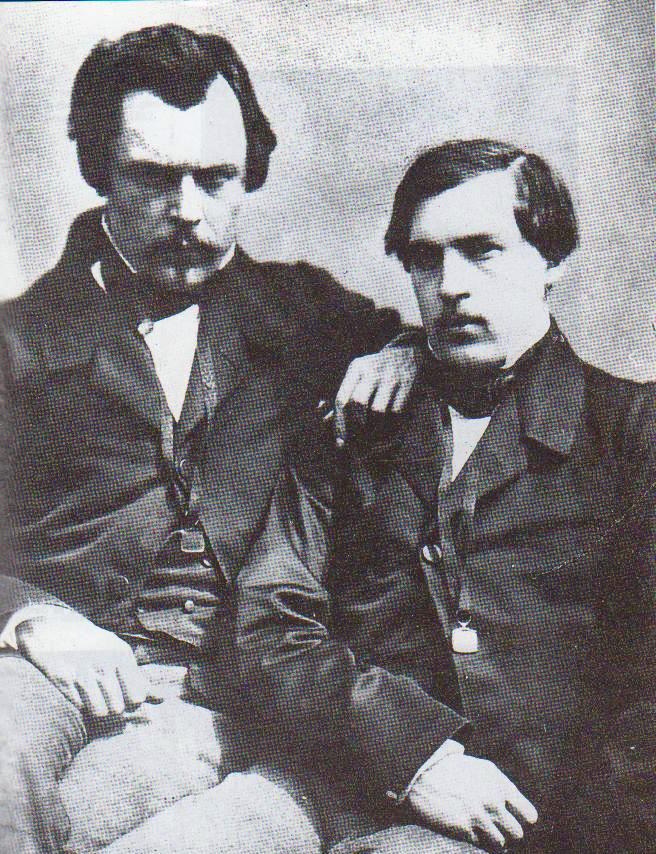
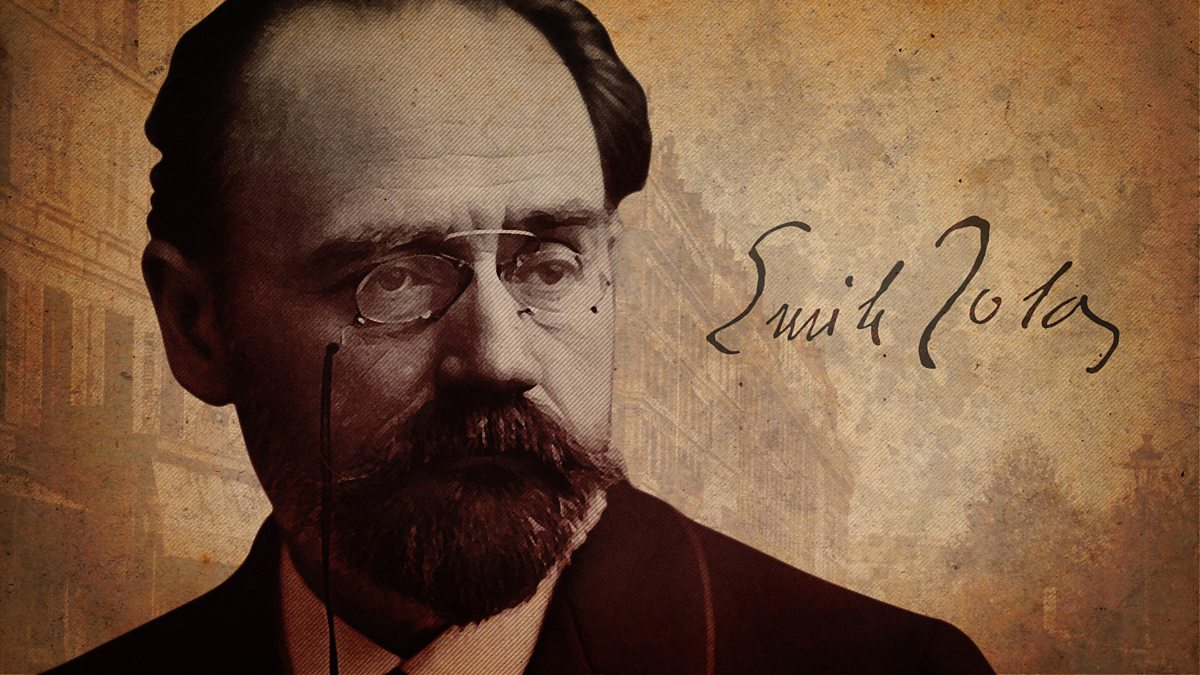
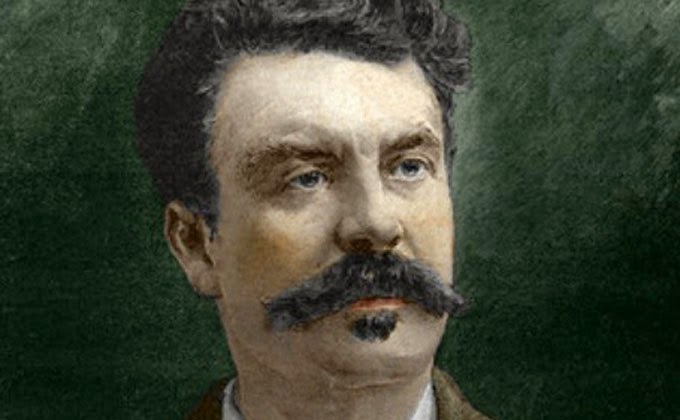

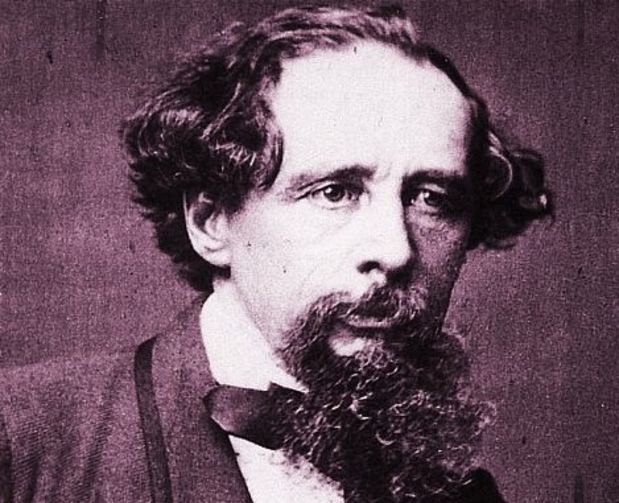








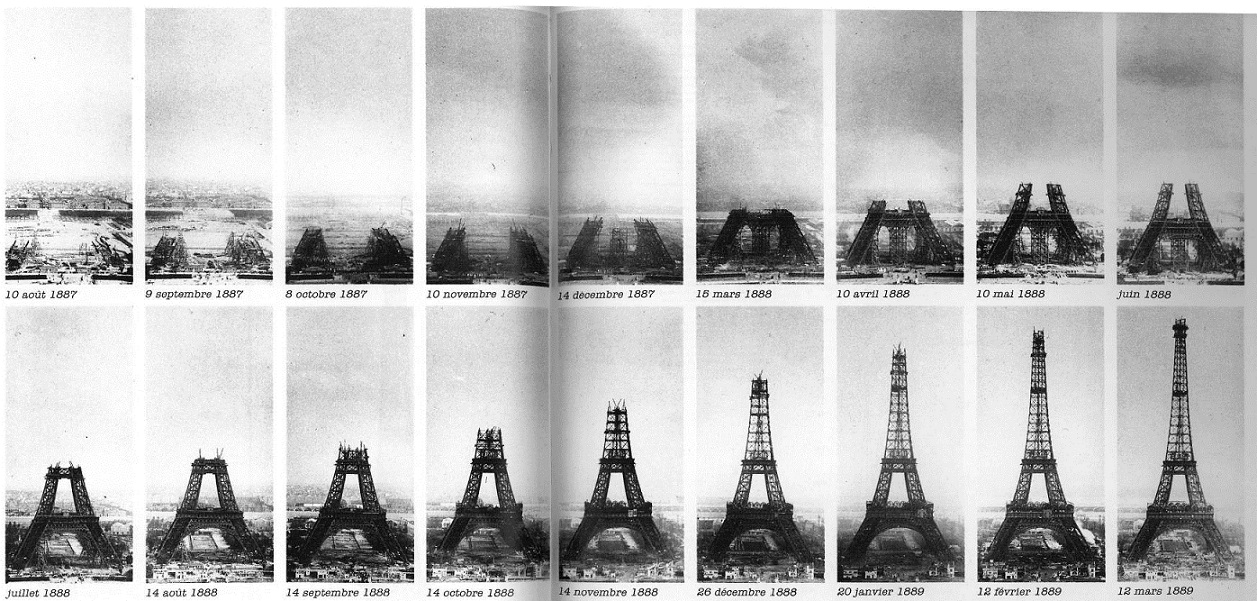

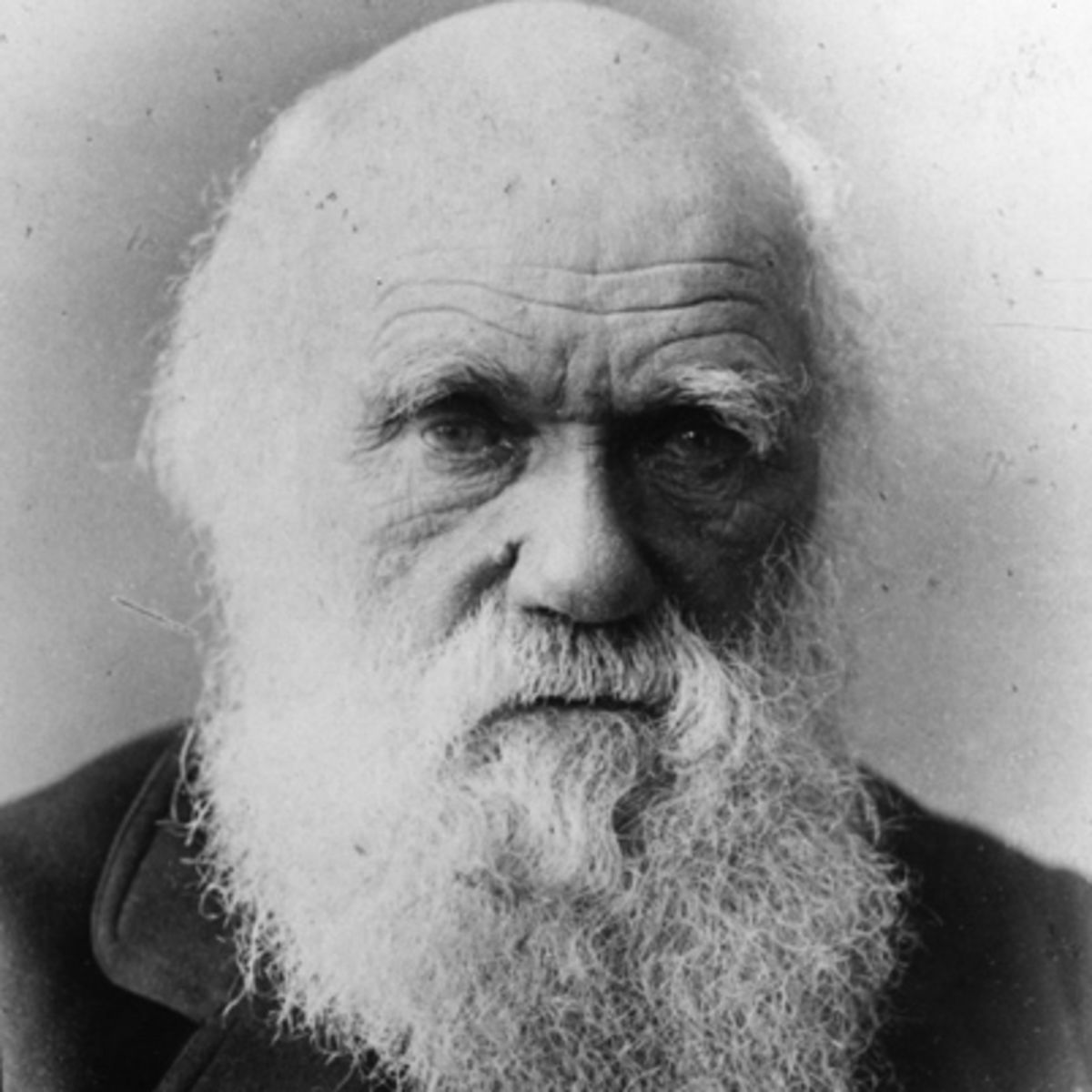

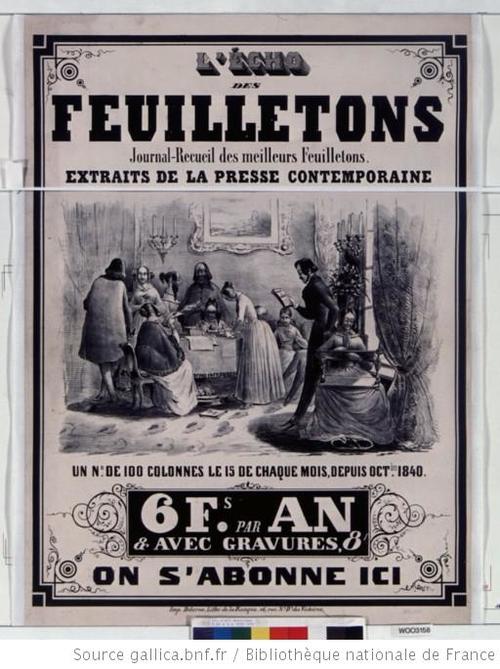



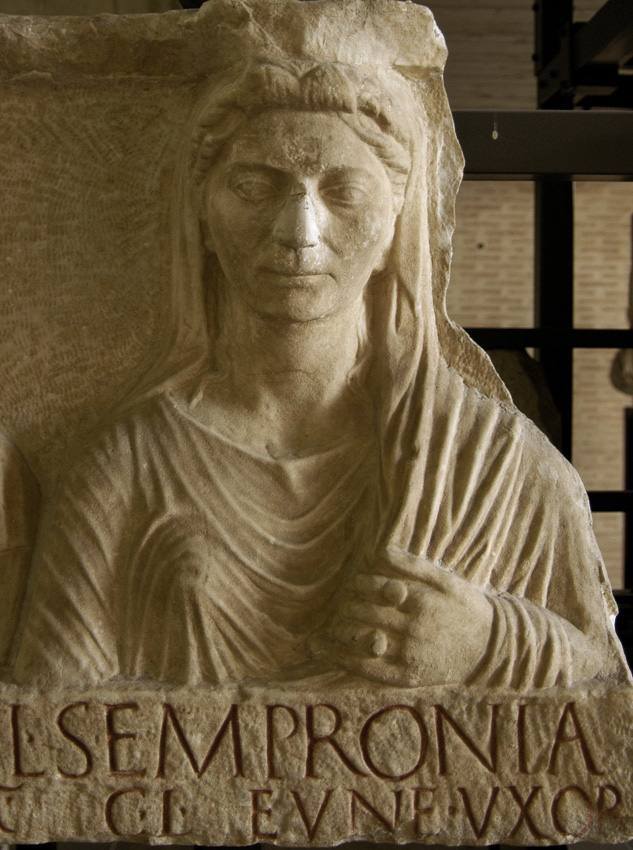


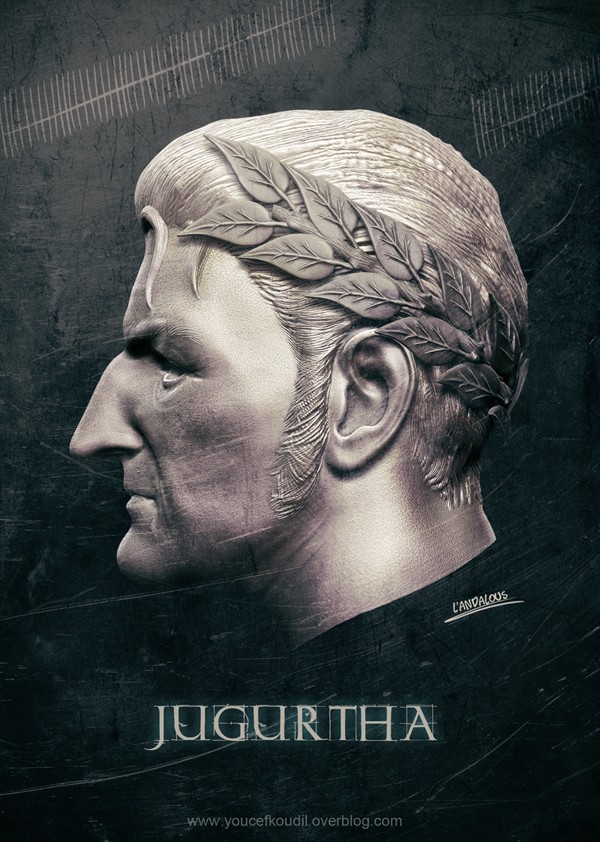




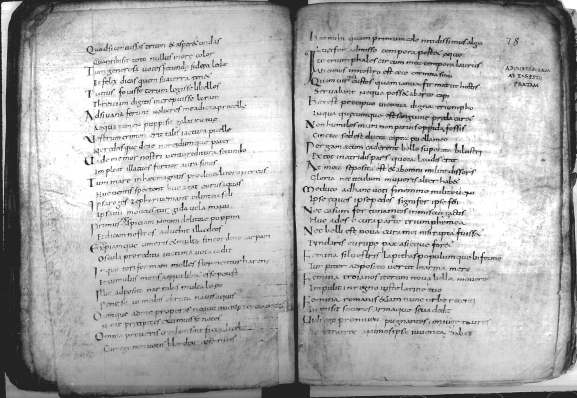





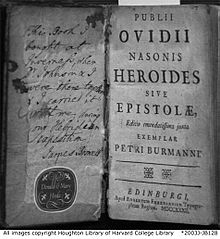

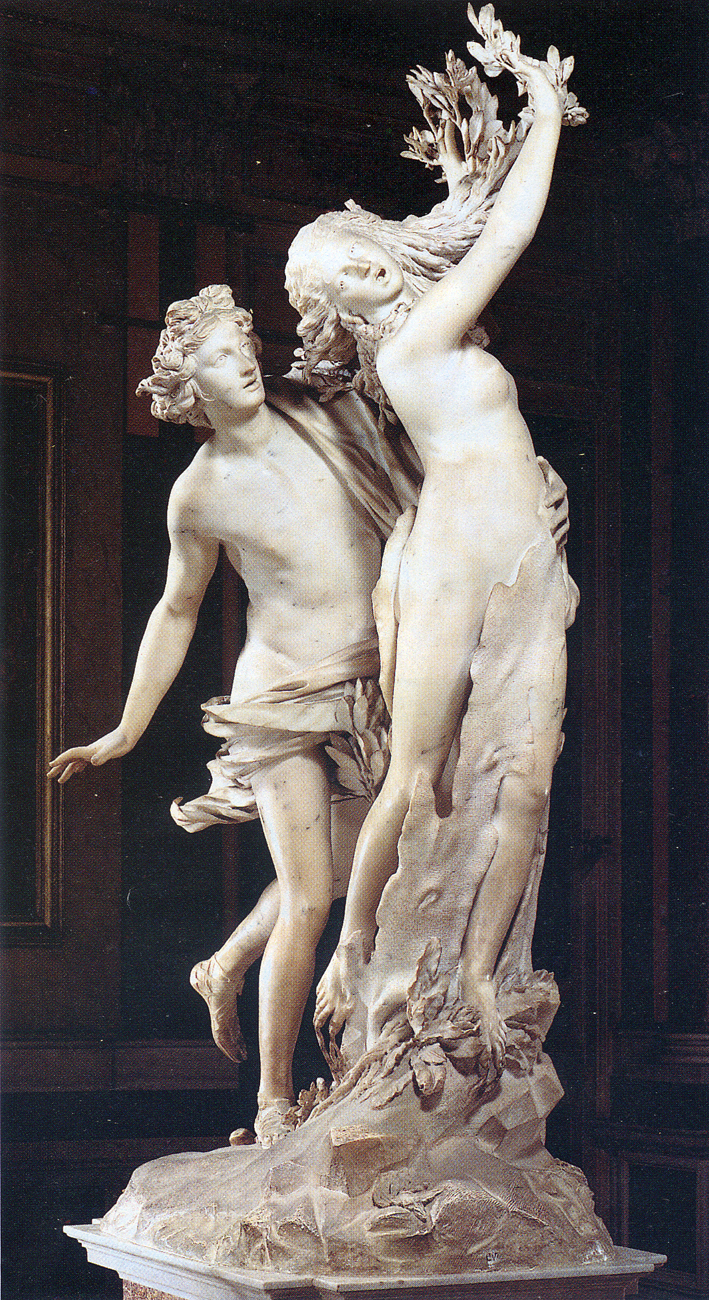



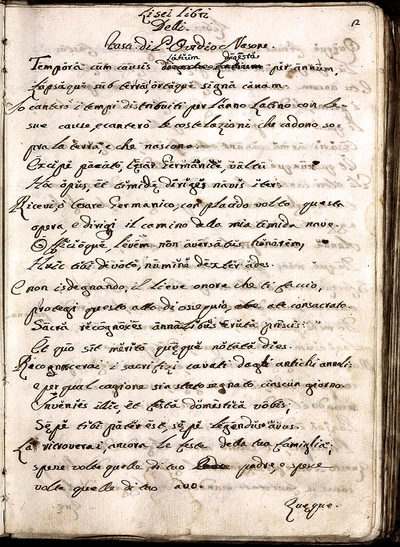


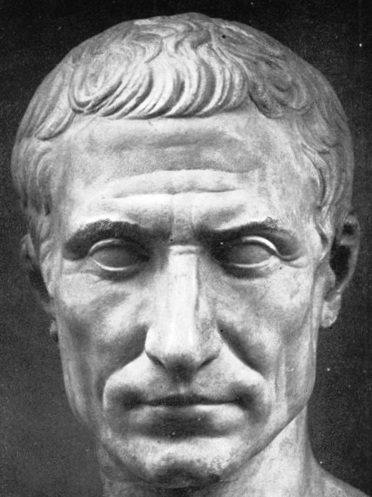
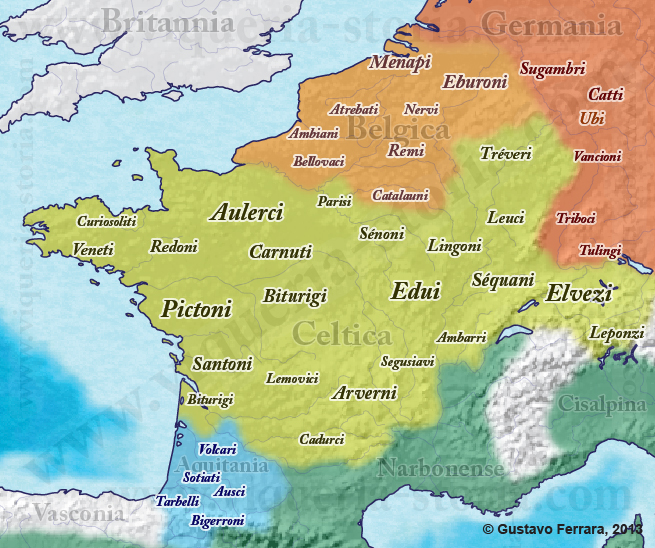









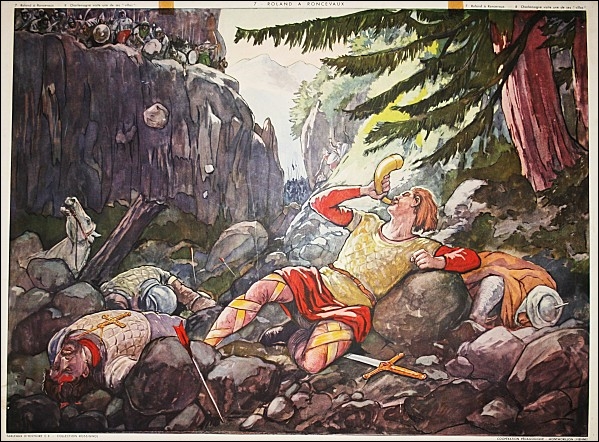












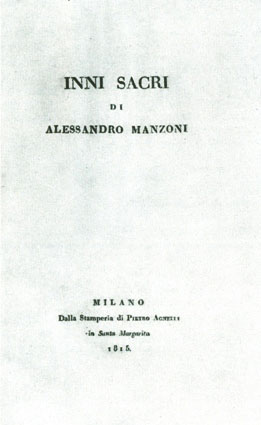
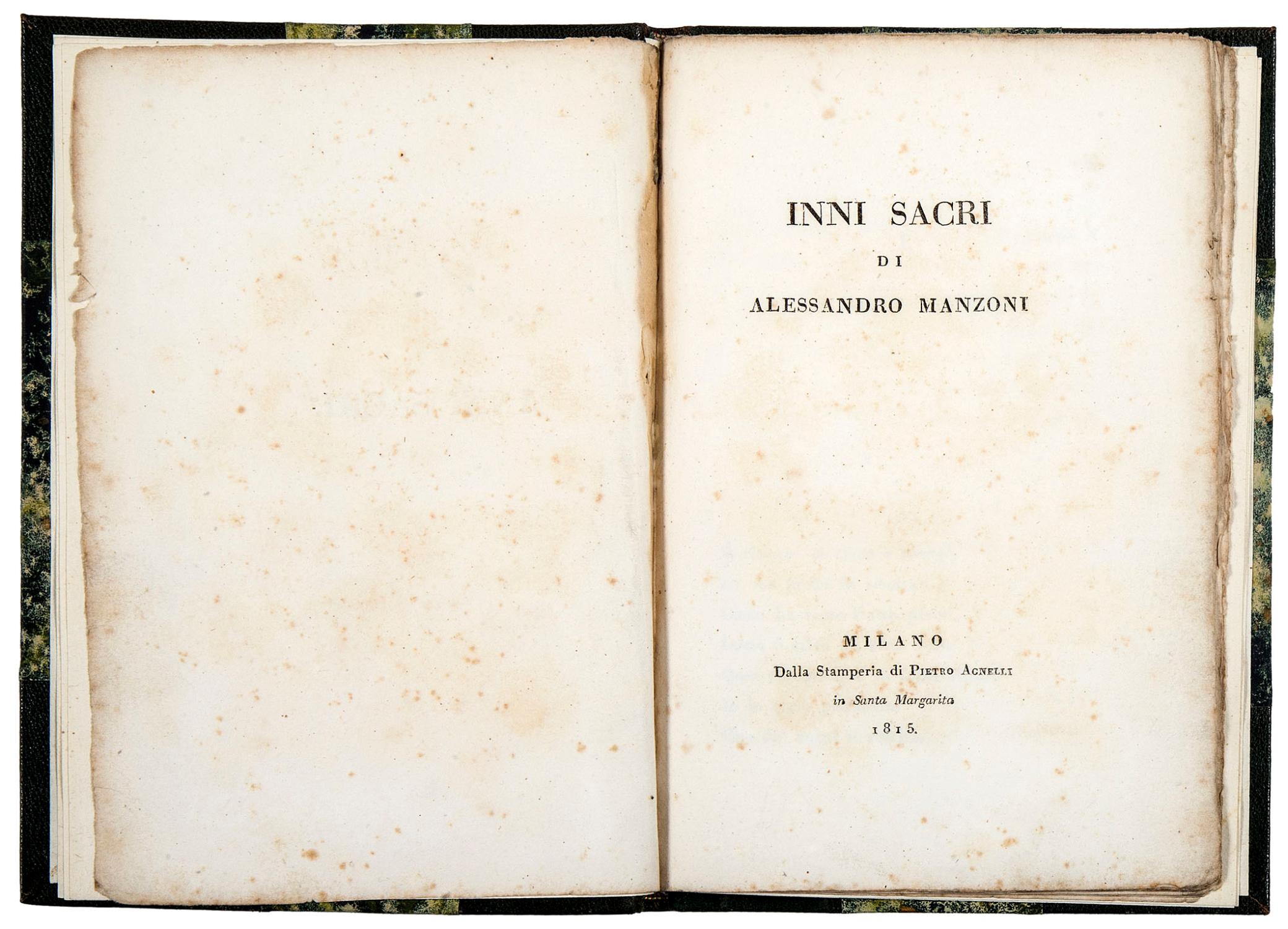
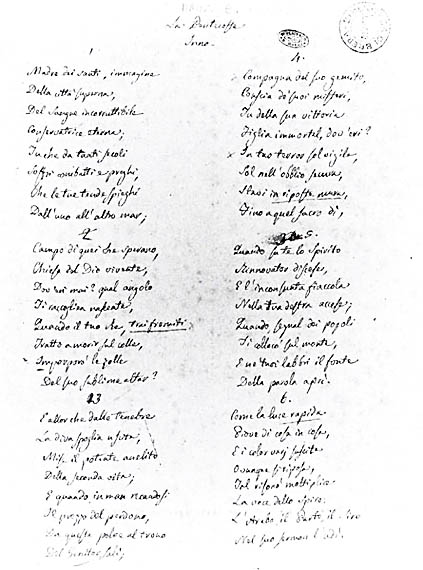
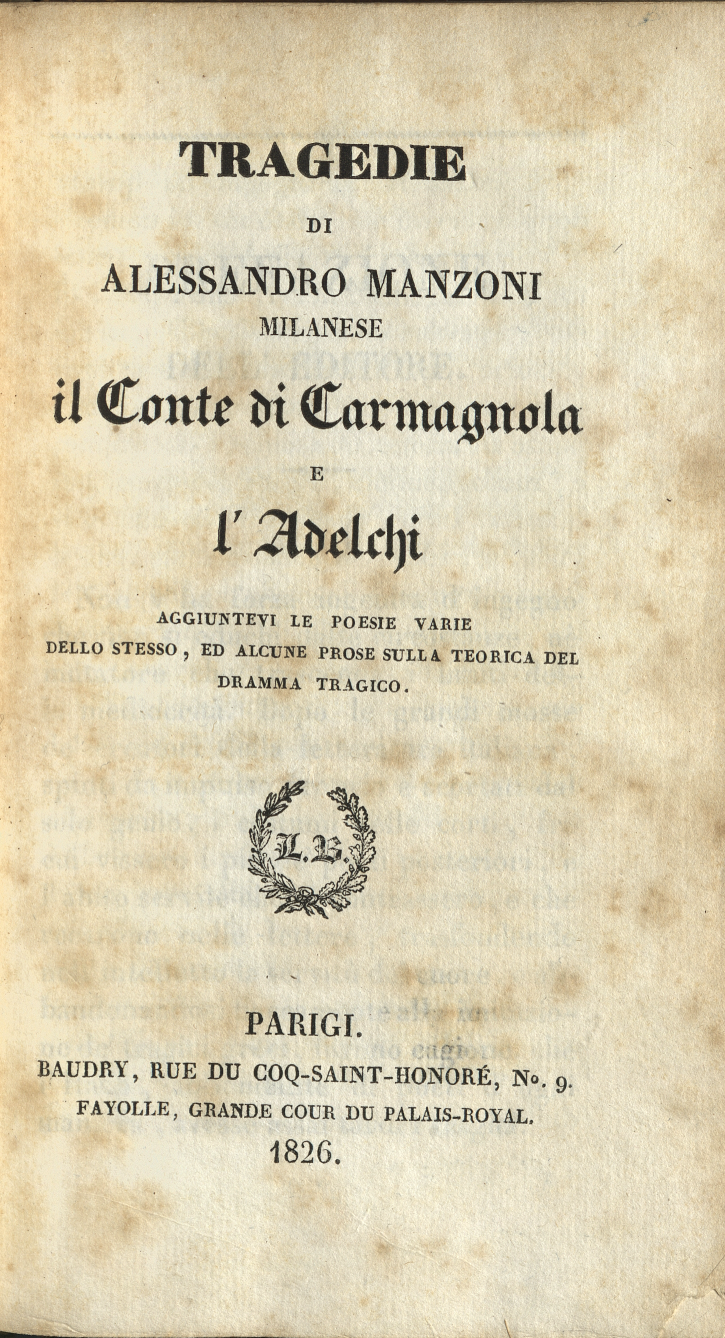







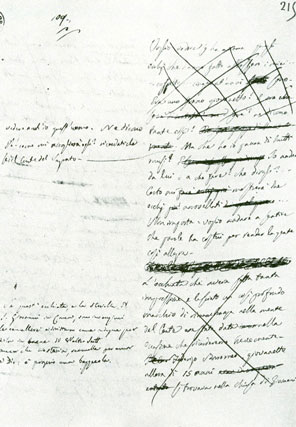
 L’introduzione è di fondamentale importanza per introdurci nel clima ideologico, morale e politico del nostro: egli finge di aver trovato un manoscritto del ‘600 in cui erano narrate storie di picciol affare. Ma chi è l’erudito uomo secentesco che ha riportato la vicenda? Probabilmente uno che l’aveva raccolta dalla stessa bocca di Renzo (come ci dice lo stesso Manzoni) e l’aveva riscritta: Renzo, quindi, narratore ignorante, riporta la sua storia ad un dotto del Seicento, un, potremmo dire, Don Ferrante (personaggio secondario, ma la descrizione della sua biblioteca ci offre la misura della distanza e della durezza con cui Manzoni guardava alla cultura del ‘600). Ma qui la polemica contro la cultura barocca si fa pregnante: se infatti Don Ferrante, con tutta la sua conoscenza scientifica, ha potuto dichiarare che la peste non esiste per poi morirvi, bisogna fare a pezzi quella cultura per fondarne un’altra, bypassandola e tornando all’integrità “morale” dell’umile Renzo. Egli non ha voce, a dargliela ci penserà Manzoni. Sorge il problema della lingua: problema assai dibattuto allora e di difficilissima soluzione per via della mancanza di una lingua letteraria media (l’unica adatta per un romanzo) figlia della disunione politica italiana. La soluzione dello scrittore lombardo sarà ovvia e disegnerà la volontà politica di fondare una lingua media colta per la futura borghesia italiana (non è un caso che il testo diventerà obbligatorio nella scuola): il fiorentino parlato dalle persone colte, l’unico in cui la prosa narrativa, seppur trecentesca col Boccaccio, aveva saputo raccontare.
L’introduzione è di fondamentale importanza per introdurci nel clima ideologico, morale e politico del nostro: egli finge di aver trovato un manoscritto del ‘600 in cui erano narrate storie di picciol affare. Ma chi è l’erudito uomo secentesco che ha riportato la vicenda? Probabilmente uno che l’aveva raccolta dalla stessa bocca di Renzo (come ci dice lo stesso Manzoni) e l’aveva riscritta: Renzo, quindi, narratore ignorante, riporta la sua storia ad un dotto del Seicento, un, potremmo dire, Don Ferrante (personaggio secondario, ma la descrizione della sua biblioteca ci offre la misura della distanza e della durezza con cui Manzoni guardava alla cultura del ‘600). Ma qui la polemica contro la cultura barocca si fa pregnante: se infatti Don Ferrante, con tutta la sua conoscenza scientifica, ha potuto dichiarare che la peste non esiste per poi morirvi, bisogna fare a pezzi quella cultura per fondarne un’altra, bypassandola e tornando all’integrità “morale” dell’umile Renzo. Egli non ha voce, a dargliela ci penserà Manzoni. Sorge il problema della lingua: problema assai dibattuto allora e di difficilissima soluzione per via della mancanza di una lingua letteraria media (l’unica adatta per un romanzo) figlia della disunione politica italiana. La soluzione dello scrittore lombardo sarà ovvia e disegnerà la volontà politica di fondare una lingua media colta per la futura borghesia italiana (non è un caso che il testo diventerà obbligatorio nella scuola): il fiorentino parlato dalle persone colte, l’unico in cui la prosa narrativa, seppur trecentesca col Boccaccio, aveva saputo raccontare.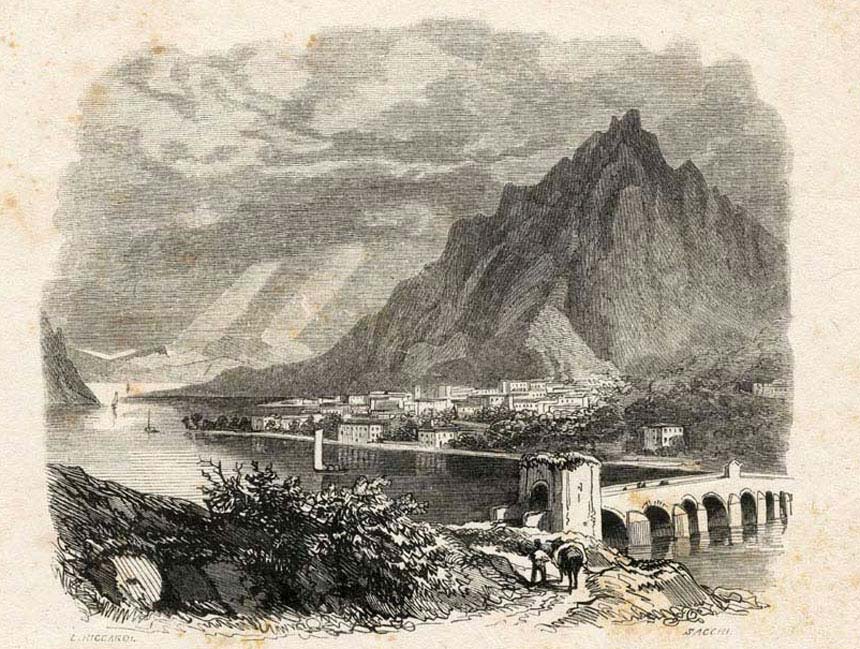

 Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor di leone. Ma, fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l’uomo tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui.
Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor di leone. Ma, fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l’uomo tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui. Renzo ci dà l’opportunità di sottolineare un punto di fondamentale importanza per comprendere l’ideologia di Manzoni: per lo scrittore lombardo gli umili non sono poveri. Troviamo, infatti, la rappresentazione di piccolo proprietario terriero e con un piccolo capitale accumulato negli anni. Ma ciò non toglie allo storico Manzoni la possibilità di rimarcare l’inefficienza del governo spagnolo che, con la sua esosa politica fiscale e l’accaparramento di terre, aveva costretto molti filatori di seta, attività che permetteva un buon guadagno, ad emigrare nel territorio veneto.
Renzo ci dà l’opportunità di sottolineare un punto di fondamentale importanza per comprendere l’ideologia di Manzoni: per lo scrittore lombardo gli umili non sono poveri. Troviamo, infatti, la rappresentazione di piccolo proprietario terriero e con un piccolo capitale accumulato negli anni. Ma ciò non toglie allo storico Manzoni la possibilità di rimarcare l’inefficienza del governo spagnolo che, con la sua esosa politica fiscale e l’accaparramento di terre, aveva costretto molti filatori di seta, attività che permetteva un buon guadagno, ad emigrare nel territorio veneto. Con Lucia Manzoni sembra aver voluto raffigurare quasi un personaggio che riprendesse il cantico evangelico del Magnificat: Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. Infatti quello che emerge in questo ritratto è la pudicizia. Ma sembra, inoltre, che qui Manzoni abbia voluto esprimere il suo concetto di beltà femminile, che vedeva in Enrichetta, sua moglie. Infatti a caratterizzare la figura di Lucia, quello che emerge è certamente ritrosia, non scevra tuttavia da una certa forza (guerriera, viene definita) che appartiene alle contadine, donne lavoratrici.
Con Lucia Manzoni sembra aver voluto raffigurare quasi un personaggio che riprendesse il cantico evangelico del Magnificat: Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. Infatti quello che emerge in questo ritratto è la pudicizia. Ma sembra, inoltre, che qui Manzoni abbia voluto esprimere il suo concetto di beltà femminile, che vedeva in Enrichetta, sua moglie. Infatti a caratterizzare la figura di Lucia, quello che emerge è certamente ritrosia, non scevra tuttavia da una certa forza (guerriera, viene definita) che appartiene alle contadine, donne lavoratrici.

 Interessante è il tratto psicologico: egli è nato combattente, colui che sfida con lo sguardo (cavalli imbizzarriti, definisce Manzoni i suoi occhi), non muta, non è un personaggio in fieri, porta la sua combattività che già andava contro i soprusi, là dove essa è opportuna. Fra Cristoforo diventa pertanto l’emblema di quella chiesa militante che aveva già cantato ne La Pentecoste.
Interessante è il tratto psicologico: egli è nato combattente, colui che sfida con lo sguardo (cavalli imbizzarriti, definisce Manzoni i suoi occhi), non muta, non è un personaggio in fieri, porta la sua combattività che già andava contro i soprusi, là dove essa è opportuna. Fra Cristoforo diventa pertanto l’emblema di quella chiesa militante che aveva già cantato ne La Pentecoste.







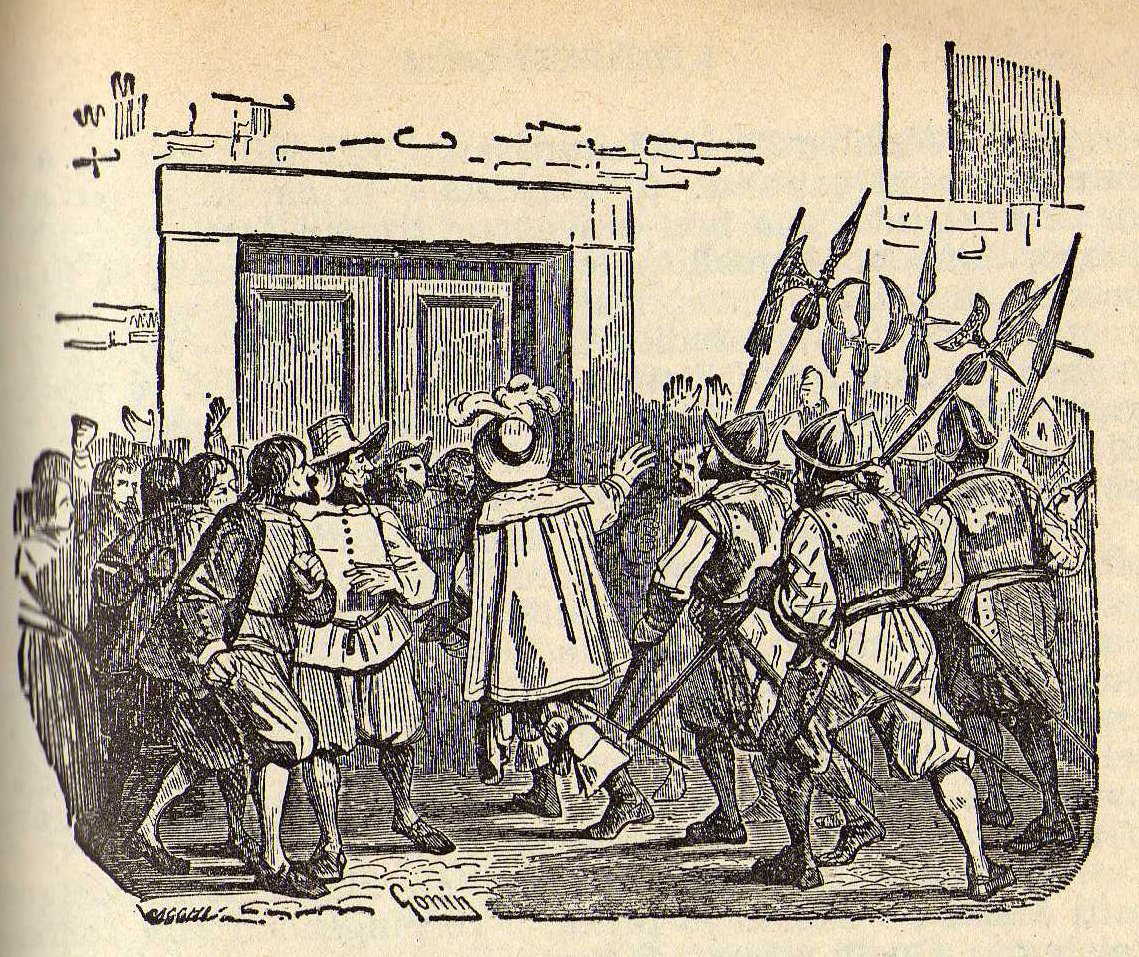
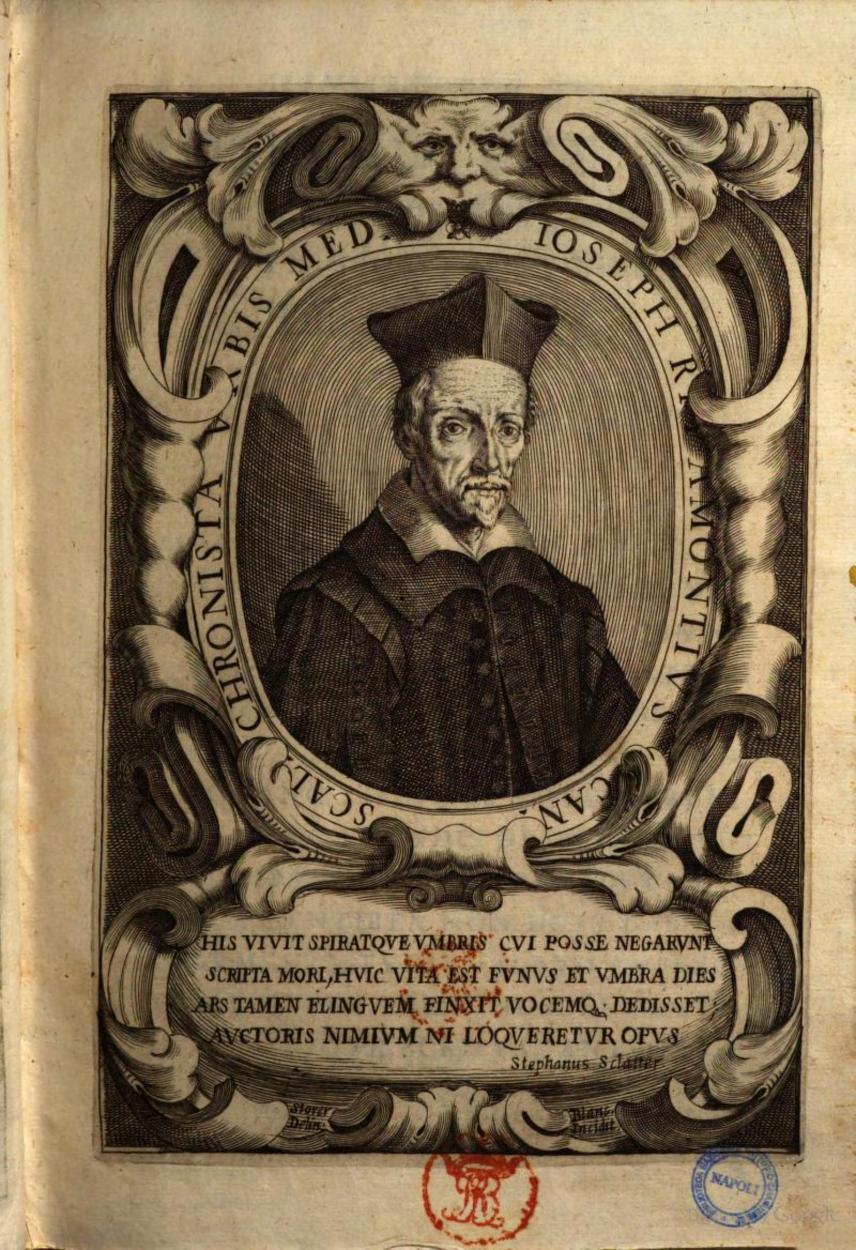


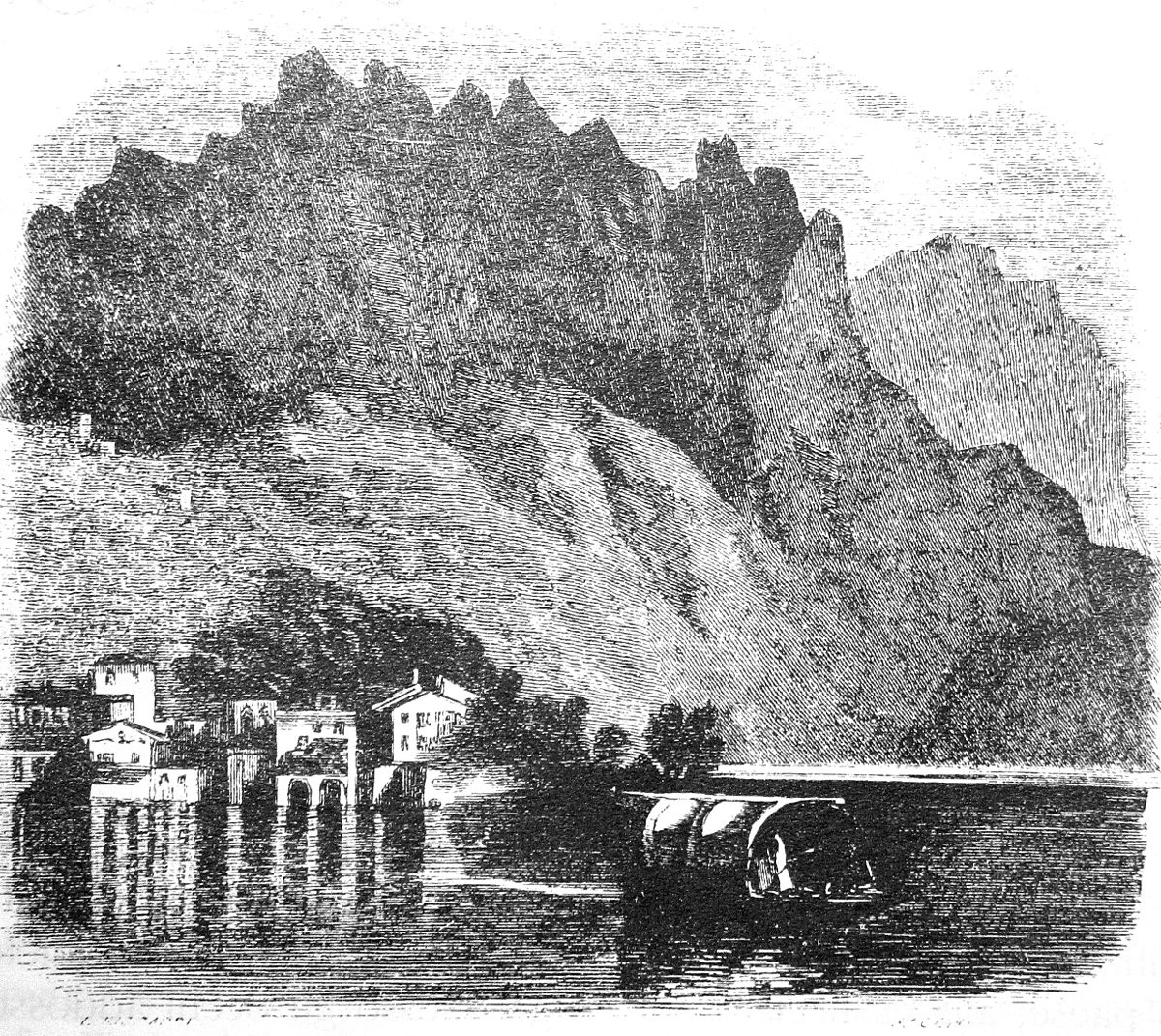 he l’Addio ai monti si configuri come un elemento lirico, basta osservare la prima frase che è strutturata con un endecasillabo. E’ infatti un brano elegiaco: l’abbandono di un luogo in cui, se fosse stata sposa, avrebbe potuto vivere la felicità. Tre sono i sintagmi intorno cui è costruito il passo: “care abitudini”, “care speranze”, “giocondità”: sono queste a costituire un Eden da cui è Lucia è costretta a fuggire. E’ l’Eden fatto di abitudini, di gesti ripetuti, di luoghi conosciuti: sicurezza e felicità, senza bisogno d’allargare l’orizzonte. E se il paese è tranquillità umilmente paradisiaca, l’esterno, la città, non può essere che inferno, con quel groviglio di case, con mancanza di prospettiva (si ricordi l’episodio della carestia). Non è una novità che Manzoni qui si faccia interprete dei pensieri di Lucia; ma appunto perché è l’autore a interpretare i sentimenti che il brano si fa elegia, allo stesso modo in cui Virgilio si fa interprete del pastore a cui è stata strappata la terra.
he l’Addio ai monti si configuri come un elemento lirico, basta osservare la prima frase che è strutturata con un endecasillabo. E’ infatti un brano elegiaco: l’abbandono di un luogo in cui, se fosse stata sposa, avrebbe potuto vivere la felicità. Tre sono i sintagmi intorno cui è costruito il passo: “care abitudini”, “care speranze”, “giocondità”: sono queste a costituire un Eden da cui è Lucia è costretta a fuggire. E’ l’Eden fatto di abitudini, di gesti ripetuti, di luoghi conosciuti: sicurezza e felicità, senza bisogno d’allargare l’orizzonte. E se il paese è tranquillità umilmente paradisiaca, l’esterno, la città, non può essere che inferno, con quel groviglio di case, con mancanza di prospettiva (si ricordi l’episodio della carestia). Non è una novità che Manzoni qui si faccia interprete dei pensieri di Lucia; ma appunto perché è l’autore a interpretare i sentimenti che il brano si fa elegia, allo stesso modo in cui Virgilio si fa interprete del pastore a cui è stata strappata la terra.




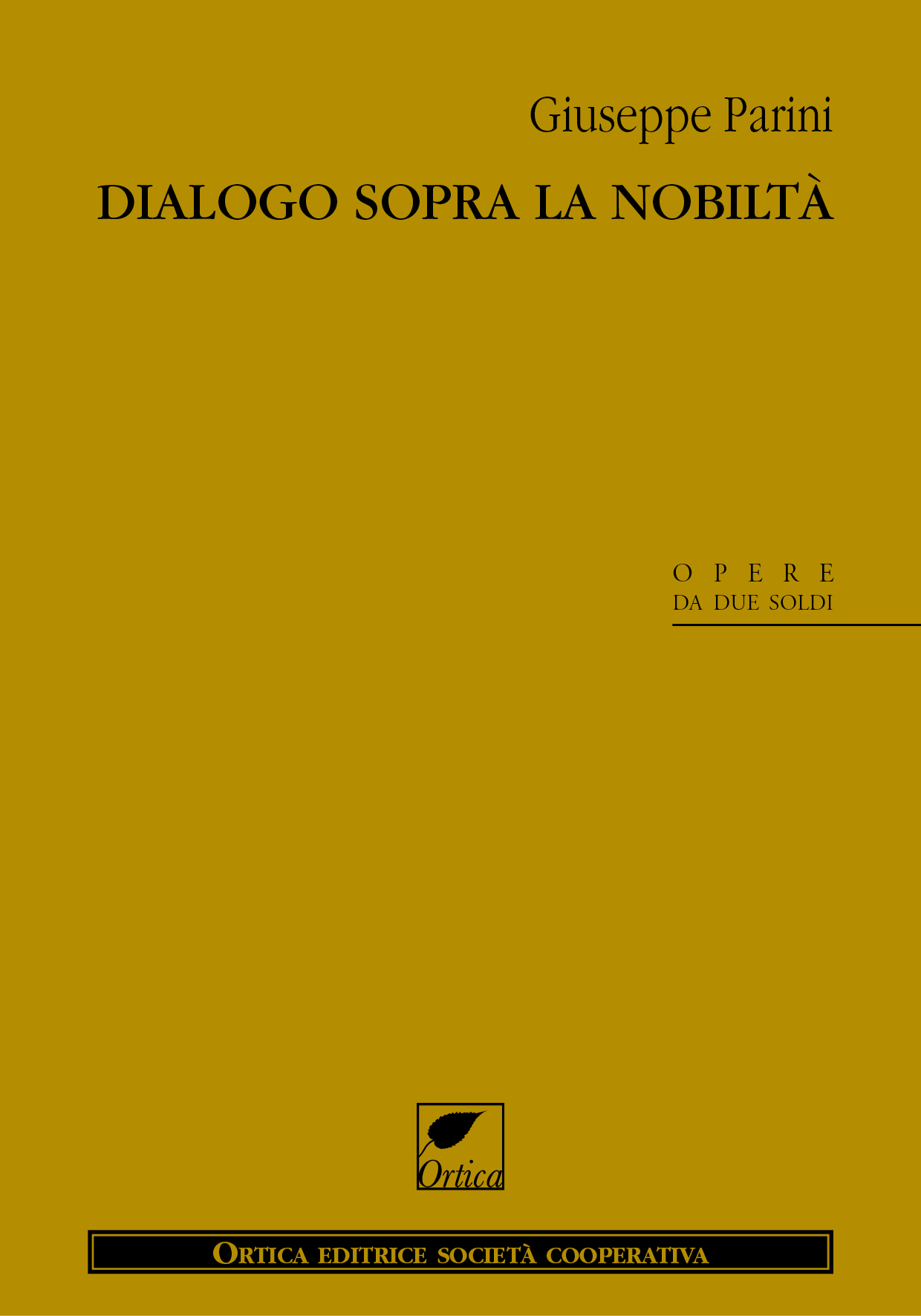
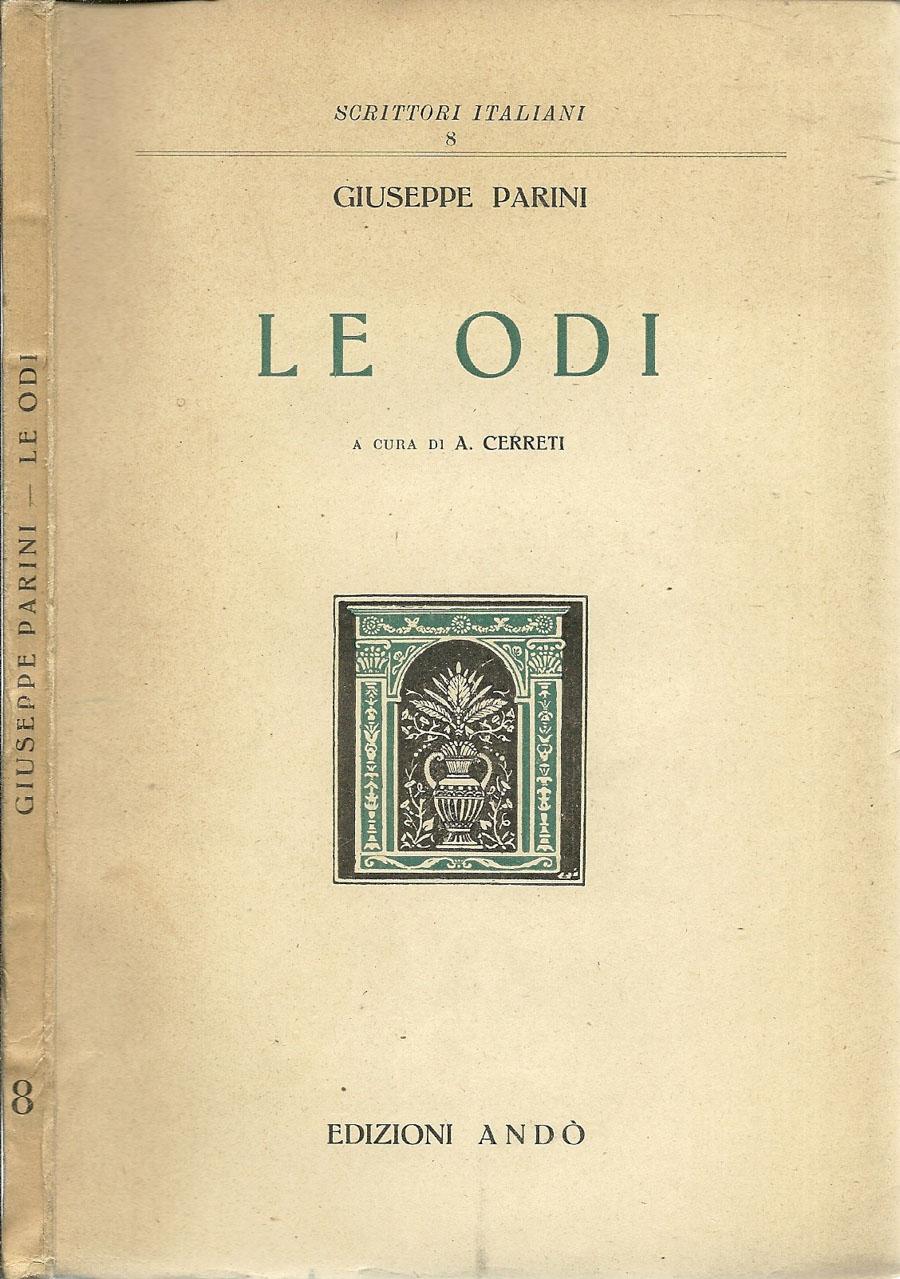






![francesco_petrarca-e12748175979161[1].jpg](https://erprofessor.com/wp-content/uploads/2015/04/francesco_petrarca-e127481759791611.jpg)