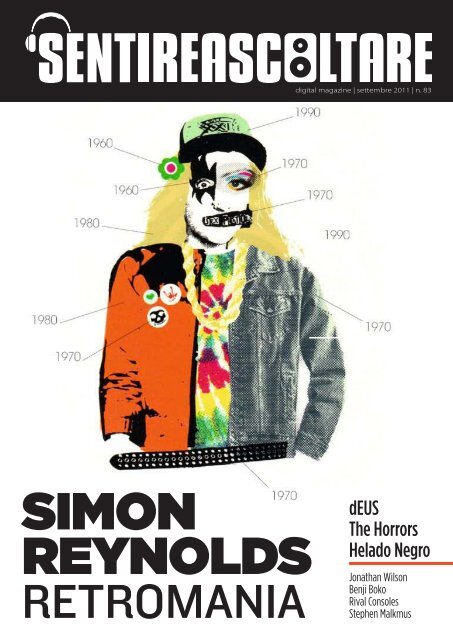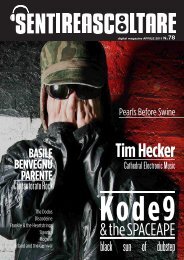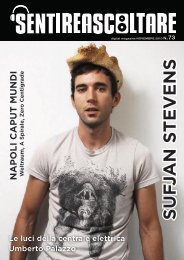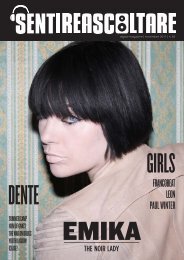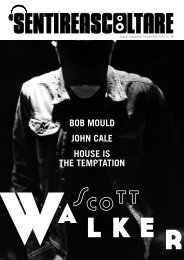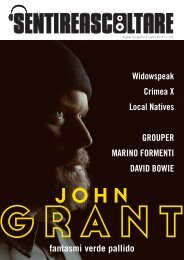RETROMANIA - Sentireascoltare
RETROMANIA - Sentireascoltare
RETROMANIA - Sentireascoltare
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Simon<br />
reynoldS<br />
<strong>RETROMANIA</strong><br />
digital magazine | settembre 2011 | n. 83<br />
dEUS<br />
The Horrors<br />
Helado Negro<br />
Jonathan Wilson<br />
Benji Boko<br />
Rival Consoles<br />
Stephen Malkmus
sentireascoltare.com<br />
p. 4<br />
p. 10<br />
p. 26<br />
Direttore: Edoardo Bridda<br />
Recensioni p. 60<br />
VHS grindhouse » 120<br />
Gimme some inches » 122<br />
Re-Boot » 124<br />
Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />
Ufficio stampa: Teresa Greco, Alberto Lepri<br />
coorDinamento: Gaspare Caliri<br />
progetto grafico e impaginazione: Nicolas Campagnari<br />
reDazione: Alberto Lepri, Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele<br />
Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco,<br />
staff: Stefano Gaz, Stefano Solventi, Stefano Pifferi, Giancarlo Turra, Gaspare Caliri, Marco<br />
Canepari, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Nino Ciglio, Fabrizio Gelmini, Marco Braggion,<br />
Federico Pevere, Andrea Napoli, Mauro Crocenzi, Diego Ballani, Gabriele Marino<br />
copertina: retromania<br />
Turn On<br />
Lucrecia Dalt, Washed Out, Apparat<br />
Tune-In<br />
Jonathan Wilson, Benji Boko, Rival Consoles, Stephen Malkmus<br />
Drop Out<br />
dEUS<br />
The Horrors<br />
Retromania Simon Reynolds<br />
Helado Negro<br />
gUiDa spiritUale: Adriano Trauber (1966-2004)<br />
settembre N.83<br />
ReviewMirror » 126<br />
Campi magnetici » 134<br />
Classic album » 135<br />
SentireAscoltare online music magazine<br />
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05<br />
Editore: Edoardo Bridda<br />
Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />
Provider NGI S.p.A.<br />
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.<br />
Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale,<br />
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,<br />
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Lucrecia Dalt<br />
—Compendio di musica<br />
flessibile—<br />
Colombiana ma di stanza a Barcellona,<br />
con all’attivo collaborazioni importanti<br />
con F.S.Blumm e James Pants: genesi di<br />
Lucrecia Dalt<br />
Turn-On.<br />
Con le sue riletture di brani di Iggy Pop, Simon & Garfunkel,<br />
Burt Bacharach e Osvaldo Farres, Cuatro Covers – in<br />
spazio recensioni – è solo l’ultimo tassello del percorso<br />
musicale multiforme di Lucrecia Dalt. Una biografia,<br />
la sua, che ingloba i classici, si perde in un’adolescenza<br />
trip-hop per poi uscirsene con una formula autarchica e<br />
minimale, sussurrata e imprevedibile, in bilico tra post,<br />
ambient, kraut, elettronica. E’ il cambiamento la struttura<br />
portante del suono: pochi tratti ma fondanti, fuori dai<br />
facili punti di riferimento e dentro un equilibrio coerente<br />
e minimale, mutevole ma al tempo stesso credibile.<br />
Coordinate stilistiche che si mescolano a geografie<br />
già di per sé peculiari, lei colombiana di Medellín trasferitasi<br />
armi e bagagli a Barcellona. Con un’infanzia trascorsa<br />
in una famiglia che con la musica ha sempre trafficato:<br />
«Mio nonno quand’era piccolo suonava la batteria e poi<br />
è diventato anche un’ottimo musicista di maracas; mia<br />
nonna suonava la chitarra; mio zio da ragazzino costruì<br />
un sistema artigianale per il karaoke per cantare le canzoni<br />
di Nino Bravo. In casa si ascoltavano Beatles, Jimi Hendrix,<br />
Doors, Pink Floyd, Bob Dylan, Velvet Undergrond. Tutti artisti<br />
che rinconduco a momenti diversi della mia vita». La<br />
semina è feconda ma il raccolto genera frutti insospettabili.<br />
Se è vero che a metà anni Novanta una cassettina<br />
clandestina dei Portishead rivela alla Dalt – al secolo<br />
María Lucrecia Pérez López - un mondo ai confini con<br />
l’elettronica, il beat sintetico, le macchine, di cui prima<br />
non si aveva nemmeno percezione. Il passaggio successivo<br />
è un praticantato compito tra vinili e giradischi, per<br />
poi approdare al looping via laptop e alla musica suonata<br />
animati da una spinta creativa «introspettiva, solitaria,<br />
ma al tempo stesso eccitante».<br />
Gli esordi discografici differiscono e non poco dalla<br />
Dalt contemporanea. Acerca (Series, 2005) mostra una<br />
musicista più interessata alla programmazione che al ricorso<br />
a una strumentazione tradizionale. Dieci brani che<br />
citano la lezione di certa indietronica tedesca versante<br />
Notwist (con qualche vaga cadenza dubstep/ambient),<br />
presagiscono quel perfezionismo formale che diverrà un<br />
tratto distintivo ma ancora non sorprendono per originalità<br />
e carattere. Preferendo un rassicurante tappeto sintetico<br />
alle geometrie instabili e difficilmente circoscrivibili<br />
che verranno di lì a poco. Anche il passo successivo Like<br />
Being Home (Series, 2007) sa di terreno di prova, un EP<br />
dall’anima folktronica nobilitato da un approccio pop fin<br />
troppo lineare, capace tuttavia di mostrare anche qualche<br />
segno di un cambiamento in atto, di un’ elasticità<br />
potenzialmente avventurosa.<br />
L’album che sancisce la maturità artistica arriva due<br />
anni dopo e si chiama Congost (Pruna Recordings, 2009):<br />
«Ho fatto tutto con un laptop e tre microfoni, mettendo<br />
insieme il suono di chitarra, basso, voci, tamburello, violoncello,<br />
tromba, xilofono, strumenti di legno, giare, bottiglie,<br />
spugne, borse di plastica, percussioni improvvisate, registrazioni<br />
ambientali e samples di batteria. E’ il mio disco<br />
più personale e consapevole. Ho scritto le melodie e ho registrato<br />
e mixato tutto il materiale, ad eccezione di alcuni<br />
interventi strumentali di amici». Voce sospesa in un limbo,<br />
brani spruzzati di psichedelia (Ceniza), ambient (Zig Zag)<br />
e claustofobie assortite kraut-wave (Too Much Light), ma<br />
soprattutto un sentire che preferisce astrarre, lavorare<br />
sul mood, piuttosto che cedere alle strutture organizzate<br />
troppo ripetitive o alla forma canzone tradizionale:<br />
«Quello che passa è quello che mi sembra giusto e coerente<br />
sul momento. Col suono cerco di non rinchiudermi in una<br />
zona troppo “confortevole”. Trascorro molto tempo cercando<br />
nuove combinazioni di effetti per riuscire ad ottenere<br />
elementi inediti dalla stessa sorgente».<br />
Tutto scorre e tutto si modifica. Al punto che lo split<br />
Pasillo uscito l’anno scorso in condivisione con i Radioaisle<br />
sembra ridefinire ancora una volta le direttive stilistiche.<br />
Scegliendo una secchezza minimale, certe chitarre<br />
scarnificate su bassi inquietanti, un’elettronica sempre<br />
più trasparente e complementare. Un fil rouge ripreso<br />
dal Cuatro Covers citato in apertura che mostra una personalità<br />
autonoma e votata alla contemporaneità, nella<br />
consapevolezza di ciò che le accade attorno: «Mi sento<br />
particolarmente vicina a una certa scena di Los Angeles<br />
perchè ho collaborato col Dublab e ammiro musicisti come<br />
Nite Jewel, Julia Holter, Dam-Funk, Daedalus. Apprezzo anche<br />
Luke Sutherland, James Pants, Daisuke Tanabe, Gudrun<br />
Gut, Felix Kubin, Beak>, Momus, Hauschka».<br />
Fabrizio zampighi<br />
4 5
Washed Out<br />
—Melanconia e<br />
ambivalenza—<br />
Abbiamo sentito al telefono Ernest<br />
Greene in occasione dell’uscita del<br />
suo primo album lungo. Fotografia<br />
sul fenomeno Washed Out: dai fasti<br />
dreamwave del 2009 all’adult glo<br />
odierna...<br />
Turn-On.<br />
Ernest Weatherly Greene è sicuramente un ragazzo stereotipico<br />
per la generazione dei nati negli Eighties. Ha un<br />
accento riconducibile a quello del suo Stato, la Georgia.<br />
Possiede quella tipica cortesia americana, gentile e allo<br />
stesso tempo un po’ freddina e, tra i suoi coetanei, ha fatto<br />
le scelte più comuni dell’americano integrato: si è sposato<br />
prima dei trenta, ha cambiato un paio di città e case,<br />
ha passato svariate serate davanti a Prison Break e Lost.<br />
Come musicista, la casistica è ancor più normalizzata:<br />
un passato remoto in una indie-rock band nei Novanta<br />
e la realizzazione, da solo, in cameretta, nei Duemila con<br />
i fidi Reason e Cubase nel desktop. Se proprio vogliamo<br />
chiudere il quadro: a 12 o 13 anni gli troviamo in casa<br />
ascolti grunge e ovviamente i Nirvana, con i quali Ernest<br />
ha iniziato le prime strimpellate alla chitarra.<br />
Anche l’atteggiamento casual che lo contraddistingue,<br />
dalle prime interviste alla nostra chiacchierata telefonica,<br />
è probabilmente rimasto lo stesso, così come lo spirito<br />
un po’ ondivago da provincia americana dal quale Washed<br />
Out trae ispirazione e strategie di fuga, idealmente,<br />
in Europa.<br />
Su Skype gli raccontiamo la storia del glo-fi imparata e<br />
poi scritta svariate volte in altrettanti articoli e recensioni.<br />
L’avrà sentita centinaia di volte ma è doveroso verificare<br />
in prima persona cosa ha da dirci in proposito. Gli<br />
spieghiamo che per la stampa europea - e per l’internet<br />
italico - la cosiddetta scena, anche nota come chillwave,<br />
è stato uno di quei grandi momenti onanistico-giornalistici<br />
dove ci si è potuti sbizzarrire unendo alberi genealogici,<br />
sonorità e una precisa sociologia: il tuffo catartico<br />
dei nati negli 80s verso l’epoca dei propri genitori attraverso<br />
la lente seppia del ricordo estivo.<br />
Il ragazzo risponde pragmatico: la stampa mi ha permesso<br />
di farmi conoscere a livello internazionale, e suonare dal<br />
vivo, quando giusto qualche mese prima ero a casa disoccupato<br />
dai miei genitori attaccato a My Space. Le devo molto<br />
e sono stato onorato di finire negli stessi articoli di Toro<br />
Y Moi, Neon Indian e Memory Tapes. Quello che hanno<br />
scritto sulla scena è vero, ma non dimentichiamoci che gli<br />
Eighties sono stati considerati da noi stessi spazzatura per<br />
lungo tempo, soltanto in un secondo momento, quando<br />
qualcuno ha cambiato idea ed ha finito per influenzare gli<br />
altri, le cose hanno preso una direzione diversa...<br />
Greene non nasce musicalmente da stereotipi pruriti<br />
kitsch, le prime mosse pre-discografiche e precedenti<br />
alle pubblicazioni su Mexican Summer, erano un misto<br />
tra l’ambient e certo Hip-Hop, tra software craccato e<br />
overdubbing di chitarra, piano e la sua voce davanti al<br />
mix. All’epoca, il georgiano ascoltava il catalogo Stones<br />
Throw, tante non precisate produzioni psichedeliche e,<br />
in particolare, Koushik con il quale sentiva un’affinità<br />
diretta. Chiaramente non è tutto qui e c’è tanto altro: in<br />
svariate interviste emerge un po’ di tutto, da Grouper<br />
a (chiaramente) Panda Bear (Animal Collective), e in<br />
pratica, tutto il Pitchfork output.<br />
Con Washed Out, Ernest è stato più volte tentato di<br />
prendere direzioni sperimentali ma alla fine a prevalere<br />
è stato un minimalismo di impronta dance. Il progetto<br />
Washed Out è senz’altro legato alla musica da ballo, o<br />
meglio ne ingloba alcune sonorità come la balearica,<br />
la trance, certi ricordi Rave e l’House. Nell’album lungo<br />
Within And Without troviamo alcune canzoni come<br />
Eyes Be Closed o Echoes che sono chiaramente orientate<br />
in questo senso, mentre nel resto del disco prevale una<br />
vena ambient pop dai rimandi meno direttamente legati<br />
agli 80s. L’ho chiamata adult glo nella recensione e a lui<br />
la definizione piace: la sua, mi racconta, è stata una transizione<br />
fatta di prove ed errori che si è configurata sempre<br />
di più nel formato canzone e di conseguenza nel delineare<br />
una strategia personale - per sottrazione aggiungerei -<br />
incentrata sul canto.<br />
Ernest è ossessionato dal personal style da sempre, aggiunge<br />
che quest’album è semplicemente una collezione<br />
di tracce scritte in diversi momenti ma averle pensate<br />
durante una lunga tournée davanti a così tanti pubblici<br />
differenti lo ha aiutato a sintetizzare maggiormente l’idea<br />
sonica originaria. Differentemente dagli esordi, dove le<br />
produzioni erano, ai suoi occhi, o troppo psych o troppo<br />
dance, l’album risulta decisamente coeso e, trovata la<br />
quadratura, si sono aggiunti i richiami di fino: il pop primi<br />
Novanta, ci racconta, ma soprattutto quegli smalti di<br />
melanconia/ambivalenza che ha sempre visto nei Mazzy<br />
Star e amato, in generale, nell’ascolto musicale.<br />
Del resto, allo stesso modo dei progetti Memory Tapes<br />
o Toro Y Moi dell’amico Chazwick Bundick, anche per<br />
Greene, il 2011, è stato l’anno dell’emancipazione da una<br />
scena chill che nel giro di due anni si è inesorabilmente<br />
disinnescata. Per distinguere maggiormente il proprio<br />
lavoro, il ragazzo ha inoltre scelto, per la prima volta, di<br />
dosarlo tra casa e studio di registrazione avvalendosi<br />
anche dell’aiuto di un produttore come Ben Allen, un<br />
georgiano come lui che nel passato ha lavorato con calibri<br />
grossi come Animal Collective e Deerhunter.<br />
Ben è amico di Ernest da molti anni oramai e il 25%<br />
del lavoro è stata una collaborazione serrata tra me e lui<br />
nel suo studio di Atlanta, ci ammette, precisando che<br />
sono stati 12 giorni per 12 ore filate al giorno. Ben aveva<br />
un’agenda folle di impegni ma con il senno di poi essermi<br />
costretto a lavorare con il tempo che stringeva mi ha reso<br />
più concentrato e ha soltanto fatto bene al lavoro finale. Di<br />
Ben ho apprezzato soprattutto il trattamento sulle percussioni<br />
che hanno conferito all’album molta dinamica e profondità<br />
ma anche la qualità dell’incisione delle parti vocali<br />
(registrate sempre in studio).<br />
Greene è rimasto lo stesso ragazzo dai riferimenti squisitamente<br />
europei: dal mainstream pop di fine Ottanta<br />
britannico all’Ibiza di inizio ‘90, ma il lavoro di sintesi e<br />
l’esperienza lo hanno maturato. Dal vivo, per esempio,<br />
dopo l’abbandono dei laptop set per voce e mac nel<br />
2009, e l’esperienza con la band Small Black l’anno successivo,<br />
Greene è pronto per fare il live che ha sempre<br />
voluto: una indie band di cinque elementi con voce, doppia<br />
tastiera, basso e batteria con la quale suonare il disco<br />
in modo differente. Questa volta, ci afferma, funzionerà<br />
davvero. La formazione precedente era concentrata sul proprio<br />
di progetto. Avevamo provato troppo poco e i risultati<br />
non erano stati eclatanti. Ora le cose sono diverse, il suono<br />
è più compatto e rifinito.<br />
Sul tubo ci sono già alcuni assaggi dove si vede e<br />
s’ascolta un gruppo piuttosto affiatato pur con qualche<br />
dubbio sulle resa canora dello stesso Greene. Del resto,<br />
non è difficile immaginare Washed Out come un progetto<br />
da cameretta (a pensare alle canzoni) e studio (a<br />
registrarle). Abbiamo sempre affermato che il ragazzo<br />
ambient della Georgia ha più l’anima del producer che<br />
non quella del musicista. Lui, di converso, ci racconta<br />
d’essere cresciuto come live musician. Ha più di un anno<br />
e mezzo d’esperienza in formazione dal vivo, ci dice; e tra<br />
poco lo scopriremo dato che lo avermo da noi nelle tre<br />
date del tour italiano, mentre questo inverno, per chi<br />
potrà, sarà all’ATP Nightmare Before Christmas Festival.<br />
Lo hanno chiamato direttamente i Battles, co-curatori<br />
dell’evento assieme a Les Savy Fav e Caribou, artista con<br />
il quale è stato recentemente paragonato (non a torto.<br />
Ascoltate You and I per esempio).<br />
Nel frattempo, a proposito di produzioni, c’è già un remix<br />
project attivato: Grimes ha inciso una sua versione di<br />
Eyes Be Closed, Steve Moore (Loverock) ne ha fatto una<br />
versione più 80s e Miami Vice, Sposhrock una spacey<br />
con l’aggiunta di un vocoder e Star Slinger, un’ultima<br />
dal tiro più hip hop. Niente male per un ordinario ragazzo<br />
della provincia americana.<br />
Edoardo bridda<br />
6 7
Apparat<br />
—Meet The Band—<br />
Apparat si svela e ci racconta<br />
interessanti dettagli sul nuovo album<br />
previsto per settembre, le prossime<br />
collaborazioni, la band e il live set...<br />
Turn-On.<br />
Apparat non è uno che ha bisogno di presentazioni, ma<br />
piuttosto uno che costringe continuamente a fare il punto<br />
della situazione. Dalla ambient-techno warpiana del<br />
periodo in Shitkatapult alla dancey-IDM di Orchestra Of<br />
Bubbles con lady Ellen Allien, dalle mosse indietroniche<br />
di Walls allo slowbeat di Moderat, lo stile di Sascha Ring<br />
è in continua evoluzione, e ormai è difficile da definire<br />
in maniera univoca.<br />
Abbiamo approfittato della sua presenza al Meet In Town<br />
2011 di Roma per meglio comprendere il suo coinvolgimento<br />
nel progetto Apparat Band, che dal 2007 ad oggi<br />
è sempre più consolidato, e per spillargli qualche segreto<br />
circa il prossimo album, partendo dalle anticipazioni che<br />
vi avevamo già dato: si chiamerà The Devil’s Walk, uscirà<br />
il 25 settembre per la Mute e in base ai due singoli già<br />
rilasciati (la minimalista e yorkiana Ash/Black Veil e una<br />
Black Water dai sapori dream e glo-fi), sembrerebbe voler<br />
mostrare il lato più cantautoriale e ‘dreamy’ dell’artista<br />
berlinese.<br />
Gli stimoli delle frequenti collaborazioni artistiche,<br />
il rapporto con l’elettronica e l’evoluzione del proprio<br />
sound: questi alcuni degli interessanti argomenti emersi<br />
durante la chiacchierata, insieme a un paio di indiscrezioni<br />
a voce bassa ed alcune riflessioni su cosa comporti<br />
non essere più un adolescente. Apparat si mette a nudo:<br />
ecco le sue confessioni.<br />
Dopo oltre dieci anni di musica ed evoluzioni, è piuttosto<br />
complicato definire te ed il tuo stile. Come ti<br />
presenti oggi?<br />
Non mi piace star fermo. Ho sempre bisogno di nuove<br />
sfide, è per questo che provo continuamente nuove<br />
cose. Dopo tutti questi anni la mia musica ha un sound<br />
più organico: uso ancora i sintetizzatori, ma li tratto in<br />
un modo differente. Uso molto le registrazioni coi microfoni,<br />
mischiandole col suono. Suppongo abbia voluto<br />
smetterla con le manopole e i display per un po’.<br />
Sembra che ti piaccia particolarmente collaborare<br />
con altri artisti. Facciamo finta che nessuno leggerà<br />
le tue risposte e dicci: qual’è stata la collaborazione<br />
più interessante/eccitante/importante per te?<br />
Sono state tutte esperienze differenti. Lavorare coi<br />
Modeselektor è stato sorprendentemente formativo.<br />
Nessun grosso diverbio, solo lunghe chiacchierate sui<br />
piatti e su piccole cose. Ogni cosa ha preso il tempo necessario.<br />
Quando ho lavorato con Ellen Allien eravamo<br />
molto più veloci, ma abbiamo litigato un sacco. A un<br />
certo punto qualcuno prevaleva sull’altro e facevamo<br />
in quel modo. Non era un sistema democratico come<br />
in Moderat. Più dittatoriale, col dittatore che cambiava<br />
continuamente (ride).<br />
Per il mio ultimo album sono stato aiutato da gente<br />
molto cool: Josh dei Telefon Tel Aviv e Nackt dei Warren<br />
Suicide. E una volta imparato a far tesoro delle idee degli<br />
altri, proprio non ho più voglia di lavorare da solo.<br />
Raccontaci del live set che stai preparando al Meet<br />
In Town, e delle differenze che ci saranno rispetto al<br />
tuo prossimo album in studio. Ti abbiamo visto live<br />
un paio di anni fa con un suono dreamy-tech, vero?<br />
È ancora così? Chi sono i componenti della Apparat<br />
Band, e da dove vengono?<br />
Beh, è la prima volta nella mia vita che suono con una<br />
band fatta interamente da persone e senza l’aiuto di<br />
computer. O almeno, non computer che facciano musica:<br />
ne abbiamo due sul palco, ma sono amplificatori<br />
per le chitarre e loopstation. Tutto viene suonato live, e<br />
suona davvero umano ed organico. Non è molto elettronico.<br />
E nemmeno l’album lo sarà. Potrei dire che in<br />
questo periodo i suoni elettronici sono solo una piccola<br />
parte della mia musica. Un ulteriore strumento.<br />
Che musica ascolti oggi, e quali sono stati i tuoi primi<br />
ascolti quando eri ragazzo?<br />
Ascolto soprattutto musica drone e d’atmosfera. Gli ultimi<br />
dischi che ho comprato sono stati Tim Hecker e Max<br />
Richter. Quand’ero adolescente ho iniziato con techno<br />
piuttosto rude, poi mi sono spostato verso gli Autechre<br />
e roba più astratta. È come se la musica che ascolto diventasse<br />
sempre più dolce e calma ogni anno che passa.<br />
Cos’è arrivato per primo, l’amore per il groove, la melodia<br />
o il ritmo?<br />
L’amore per il groove, decisamente. Quand’ero piccolo<br />
ero un batterista, ma è qualcosa che cambia continuamente<br />
e i ritmi nella mia musica vanno scomparendo<br />
sempre di più. Forse a un certo punto cambierò di nuovo<br />
idea, ma in questo momento proprio non credo che la<br />
bella musica abbia bisogno di un appropriato “ritmo”.<br />
Qual’è la tua concezione della musica dance? È più<br />
una “dance cerebrale” o una dance fisica/ritmica?<br />
Qual’è la componente più importante, e perché?<br />
Per me la dance deve essere grezza, fisica e sorprendente<br />
in ogni momento. È una cosa che non accade spesso - è<br />
per questo che preferisco stare a casa.<br />
Com’è cambiato il tuo rapporto con Berlino in questi<br />
anni?<br />
Prima uscivo spesso, ma era come se avessi un deja-vu<br />
ogni volta che andassi in un club. Come se lo avessi già<br />
fatto. Probabilmente sto solo diventando vecchio. In<br />
questi giorni preferisco godermi la campagna delle periferie<br />
di Berlino, piuttosto che i suoi clubs.<br />
Nuove collaborazione per il futuro?<br />
Penso di voler soffermarmi sulla mia band. Suona davvero<br />
come una grande idea fare un band album. Mi sono<br />
sottoposto al lavoro in studio così tanto in passato, giusto<br />
per provare delle cose, e qualche volta è venuto fuori<br />
qualcosa di buono. Ma era più un prova-e-riprova. Non<br />
credo che possa continuare a lavorare così. Preferisco<br />
scrivere canzoni alla vecchia maniera, e poi lavorarci con<br />
la band invece che buttarmi subito sui computer.<br />
E ovviamente farò un nuovo album Moderat un giorno.<br />
E un altro con Ellen!<br />
Carlo aFFatigato<br />
8 9
Tune-In.<br />
Jonathan Wilson<br />
Testo: Giancarlo Turra<br />
From Us To YoU<br />
Difficile affermare con esattezza da dove parta l’onda<br />
che, in questo inizio di nuovo decennio, sta consegnando<br />
dischi di ambito “cantautorale” di portata non<br />
indifferente. In attesa di ulteriori sviluppi, diremmo<br />
che la corrente è sempre stata lì: viva, pulsante e suo<br />
malgrado carsica, siccome gli anni zero hanno visto i<br />
riflettori puntarsi impazziti da altre parti. Adesso, dopo<br />
le baruffe su quanto di rilevante e imperdibile ci siamo<br />
lasciati alle spalle, è forse giunto il tempo di accantonare<br />
freakerie, silicio e contaminazioni totali per recuperare<br />
una dimensione intima e confessionale. Diversa da<br />
quel gioco un po’ disincantato e un po’ divertito di moderni<br />
songwriters come Will Oldham e Bill Callahan,<br />
alle prese con giochi di identità e paraventi. Adesso,<br />
l’ambizione è mettersi in mostra di nuovo. Di lasciare<br />
le ferite al sole e al sale del pubblico affinché guariscano.<br />
Oppure, che almeno se ne ricavi materia di canzoni<br />
che rimangano. Date un’ascolto in giro e respirate la’ria<br />
fresca però antica di Bon Iver, Josh T. Pearson e Laura<br />
Marling. Ognuno inevitabilmente riconducibile a qualche<br />
altro troubadour precedente che viene tuttavia trasceso,<br />
mescolato con anime affini. E’ musica popolare,<br />
pertanto un problema come l’originalità non ha senso.<br />
Conta aggiungere qualcosa al canone affinché perduri,<br />
come sosteneva il padre del revival folk britannico, Cecil<br />
Sharp, un secolo fa.<br />
—Lo spirito del canyon—<br />
Un nuovo talento è nella Città degli Angeli, a stendere ponti tra passato e futuro.<br />
Volevate un nuovo M Ward? Il suo nome è Jonathan Wilson...<br />
CoUnTrY roads...<br />
In questo quadro policromo ha fatto la comparsa Jonathan<br />
Wilson, classe 1974 dalla Nord Carolina. In trasferta<br />
- come tanti sudisti prima di lui: Gram Parsons, Leon<br />
Russell e Tom Petty tra i tanti - in California; soprattutto<br />
intestatario di un lp, Gentle Spirit, che profuma di classico<br />
istantaneo. Punto di arrivo di una passione d’altri<br />
tempi, tanto è autentico e presente in ogni gesto, ogni<br />
decisione, ogni parola di questo trentasettene. Le ragioni<br />
stanno, probabilmente, nella fatica fatta per arrivare a<br />
questo esordio e in un’origine tipicamente americana:<br />
”Sono nato a Spindale, North Carolina. Mio nonno era un<br />
predicatore battista, per cui ero costantemente dentro<br />
quella “vibrazione” spirituale. Mio padre suonava in un<br />
complesso e ricordo che quando un membro della band<br />
non si presentava, prendevo il suo posto passando da uno<br />
strumento all’altro. Era un gesto naturale”.<br />
E, inoltre, in una gavetta lunga e tortuosa, scandita<br />
nel ’95 dai Muscadine, fondati con l’amico Benji Hughes<br />
e smarritisi dentro un esordio edito tre anni più tardi<br />
dalla Sire. Dopo la fine del sodailzio, Wilson vagava on<br />
the road tra California (nella comunità hippie di Topanga,<br />
poi spazzata via), Georgia e New York per stabilirsi infine<br />
nel Laurel Canyon. Ancora e sempre “golden state”, ma<br />
in un’alveo celebre per aver visto nascere e svilupparsi<br />
tra ’68 e ’74 la celeberrima e florida scena capeggiata da<br />
Joni Mitchell e C.S.N.&Y.; mano a mano più fortuna-<br />
10 11
ta epperò sempre meno brillante artisticamente, fino a<br />
sconfinare nel molle autocompiacimento di James Taylor<br />
e Carly Simon.<br />
...awaY From Home<br />
Con Rick Rubin vicino di casa, Wilson inizia con l’amico<br />
Chris Robinson dei Black Crowes - southern man come<br />
lui: questione di sangue - ad animare le serate con jam<br />
in cui si confrontano musicisti di diverse generazioni.<br />
L’elenco è impressionante: Johnathan Rice, Vetiver,<br />
membri di Wilco e Jayhawks, il tastierista di Tom Petty<br />
& The Heartbreakers Benmont Tench, Elliot Easton dei<br />
Cars, gente che aveva incrociato gli strumenti con Steve<br />
Miller, Van Morrison e Neil Young.<br />
Il soffio vitale, divertimento a parte, è diverso dai “bei<br />
tempi andati”: c’è uno scambio di conoscenze tra giovani<br />
e anziani in cui Rilo Kiley siede a fianco dell’ex Grateful<br />
Dead Phil Lesh e un filo connettivo viene intessuto. Si<br />
traffica con cover e brani improvvisati, invece di suonare<br />
ognuno le proprie cose agli altri. E’ un ritorno al “noi”<br />
dopo il “me” dei seventies, ma col senno di poi. Così che<br />
la storia e il retaggio proseguono e si arricchiscono senza<br />
che il passato venga perduto o schiacci la prospettiva<br />
dentro una cartolina. Semmai, esso funge da solida base.<br />
“Mi sono trasferito nel Laurel Canyon senza aspettarmi di<br />
trovare una qualche cultura rock anni ’60 che avevo idealizzato.<br />
Sapevo quale leggenda lo circondasse ma non ne<br />
afferrai porfondità ed essenza che dopo un po’. Ha senso<br />
che sia stata una sorta di mecca per i muscisti perché quello<br />
spirito perdura: la musica ha un suono diverso, emana un<br />
timbro naturale. E’ un luogo speciale, dunque non mi soprende<br />
che tanti dei miei artisti preferiti abbiano risieduto<br />
qui. Per vent’anni, mio padre teneva delle jam il mercoledì<br />
sera con gli amici; quando arrivai a Los Angeles, cercai lo<br />
stesso tipo di situazione, ma poiché non esisteva, ce la creammo<br />
da soli!” Se vi pare ancora un patetico revival da<br />
figli dei fiori…<br />
slow TUrning<br />
Questa è, comunque, l’incubatrice che tramuta Jonathan<br />
in session man e produttore assai richiesto. Versatile,<br />
anche, considerando come appaia - tanto per citarne<br />
qualcuno - in Vagabonds di Gary Louris e Momofuku di<br />
Elvis Costello, a fianco di J. Tillman ed Erykah Badu.<br />
Nel frattempo, mette mano a un’opera solista in cui fa<br />
tutto da solo intitolata Frankie Ray, la cui (non) publicazione<br />
diverrà un calvario: “Firmai un contratto con la Koch,<br />
il che all’poca pareva la cosa giusta da fare. Poi saltò fuori<br />
che, come tavolta succede, non facevano che positicipare<br />
l’uscita. La cosa peggiore per un’artista è che le sue cose<br />
non vedano la luce al momento giusto; oppure che non<br />
siano più rappresentative nel momento in cui sono pubblicate.<br />
Alla fine, dopo un anno e mezzo, mi rifiutai di immetterlo<br />
sul mercato e adesso Frankie Ray - nonostante copie<br />
‘fisiche’ circolino complete di artwork - si trova su I-Ttunes”.<br />
Wilson affronta lo smacco impegnandosi ancor più a<br />
fondo nella produzione e, quando lo sfrattano dalla casa<br />
di Laurel Canyon per troppo rumore, allestisce uno studio<br />
di registrazione - ovviamente dotato di apparecchiature<br />
analogiche - a Echo Park. Siamo al 2009, e il ragazzo<br />
seguita ad abbeverarsi alla fonte della migliore musica<br />
d’oltreoceano, incamera influenze preparandosi a dire la<br />
sua. Ultimo imprimatur ufficiale lo scorso aprile, quando<br />
si esibisce da David Letterman con Robbie Robertson.<br />
HappY Trails<br />
Il risultato di tanta pazienza e tribolare è un folk traslucido<br />
e opalescente d’acido che ottunde i sensi, aggrovigliandosi<br />
sinuoso e pigro alle pieghe della mente e<br />
attraversando in orizzontale anni Sessanta e Settanta.<br />
Necessita di frequentazione ripetuta, Gentle Spirit, meglio<br />
se tramite un vinile che fantastichi doppio ponte steso<br />
tra Neil Young che incide On The Beach senza fantasmi<br />
attorno e David Crosby che conserva il senno dopo If I<br />
Could Only Remember My Name. Ancora: la sfoglia torpida<br />
dei Pink Floyd sotto il sole di Ibiza attorno ai flash di<br />
Spirit e Quicksilver Messenger Service.<br />
The Way I Feel (esaltante viluppo di elettriche, organo<br />
e archi), Can We Really Party Today? (meditazione in<br />
punta di corde) Waters Down (blues narcolettico e dolce<br />
con stridori all’orizzonte) indicano la cura di chi ha sin<br />
qui intepretato i desideri altrui e adesso corona i propri,<br />
in un presente che maneggia lo scintillare di Gentle<br />
Spirit, Natural Raphsody e Railroad Boy. Emergono la sapienza<br />
degli arrangiamenti e una penna che trae forza<br />
dalle dilatazioni della jam, consegnando composizioni<br />
lunghe e oniriche cosparse di rumori, di sottili straniamenti<br />
che parlano una lingua personale. “Per quanto mi<br />
riguarda, la scrittura di canzoni è simile a dipingere. Non c’è<br />
niente di più gratificante che vedere qualcosa svilupparsi<br />
e prendere forma durante le registrazioni e il missaggio.<br />
Inizio a scrivere con la chitarra acustica o il piano e lascio<br />
di proposito alcune parti non finite, così da poter inserire<br />
un elemento casuale nel processo. Gentle Spirit è il primo<br />
lavoro che vede una band e molti ospiti ad aiutarmi, il che<br />
è stato una gioia”.<br />
Nella piena riuscita della quale ricopre un ruolo indispensabile<br />
la conoscenza dei tanti “ieri” del rock, rivitalizzati<br />
con mano abilissima: “Traggo intuizioni e sonorità da<br />
certe formazioni psichedeliche che mi piacciono come JK &<br />
Co., ma la lista delle mie influenze è lunghissima: J.J. Cale,<br />
John Prine, Gary Higgins, Andy Cabic, Skip Spence, Canned<br />
Heat e – sin da ragazzino - John Lennon e Neil Young. Per<br />
quanto uno voglia scegliere e indicare noni strani o semisconosciuti,<br />
ritengo che ciò che ti influenza davvero e ciò che<br />
tu vorresti ti influenzasse restano due cose diverse“.<br />
E’ frutto d’amore e competenza, la musica di Jonathan<br />
Wilson. E’ un regalo forse troppo bello per anni<br />
incerti, confusi e frettolosi. Fatelo vostro senza esitare.<br />
12 13
Tune-In.<br />
Testo: Carlo Affatigato<br />
Benji Boko<br />
Intervista a Benji Boko, uno dei più interessanti giovani ribelli della scena dance<br />
UK. L’occasione ideale per entrare nel profondo del fermento londinese e carpirne<br />
segreti ed ambizioni<br />
Dopo aver toccato con mano lo spirito delle realtà emergenti<br />
USA nell’intervista a M A N I K, il secondo appuntamento<br />
della nostra rubrica di approfondimenti dance<br />
sbarca finalmente nella famigerata scena londinese, da<br />
anni una fucina di talenti d’eccezione, nuove mode e illuminanti<br />
crossover di stili. Per l’occasione siamo riusciti<br />
a contattare uno dei giovani emergenti più interessanti<br />
del panorama UK odierno, Benji Boko, su cui avevamo<br />
già acceso i riflettori all’uscita del suo debut album Beats,<br />
Treats & All Things Unique: un 24enne letteralmente esploso<br />
durante lo spettacolo di capodanno 2010 alla O2<br />
Arena, dove insieme a Calvin Harris, Justice e Deadmau5<br />
ha mandato in visibilio un pubblico di 17.000 persone<br />
e che, da allora, continua ad alimentare la fama<br />
esplosiva dei suoi live act, in cui puntualmente sfodera<br />
un impareggiabile talento in mixing e mash-ups.<br />
Lo abbiamo chiamato innanzitutto per approfondire<br />
le origini del suo eclettismo e i propositi che lo spingono<br />
a provare combinazioni sempre più coraggiose, ma<br />
soprattutto per poter guardare da vicino lo spirito della<br />
dancing London di oggi, considerata dai più l’ambiente<br />
artisticamente più stimolante del globo. La metropoli<br />
più cool del momento ospita una scena dance selvaggia<br />
e irriverente, ricca di nomi autorevoli largamente conosciuti<br />
come Four Tet e James Holden, a cui recentemente<br />
si aggiungono giovani chiacchierati come Katy B,<br />
—In Da Club #2—<br />
Jamie XX, SBTRKT e Maya Jane Coles (lasciando fuori<br />
realtà meno orientate al club come James Blake e Jamie<br />
Woon).<br />
Benji Boko è solo l’ultimo tassello di un puzzle in<br />
continua espansione, e nell’intervista è venuto fuori<br />
l’identikit del tipico artista UK, con la sua irrefrenabile<br />
voglia di distinguersi e guardare avanti e la sensazione<br />
di appartenere ad una vera elite artistica, cosa che ci ha<br />
spinto ad azzardare un parallelo con la Detroit dei primi<br />
anni ‘80. Abbiamo provato a capire come mai questo<br />
particolare fermento sta avendo vita proprio in Inghilterra,<br />
e nel frattempo abbiamo scoperto i progetti ambiziosi<br />
di Benji, che proseguono ad un ritmo sorprendente.<br />
Un giovane simpatico, estroverso e pieno di energia:<br />
ecco ciò che è emerso in circa venti minuti di conversazione...<br />
Ciao Benji! Che ne dici di iniziare con una presentazione<br />
rivolta a chi non ti conosce? Chi è Benji Boko?<br />
Wow, gran bella domanda! Diciamo che sono un giovane<br />
24enne che ama far musica e che nei concerti diventa<br />
un fottuto matto da legare. Ma in generale quello che<br />
voglio è esprimere me stesso in ogni modo o forma, e<br />
con ogni mezzo.<br />
Questo è proprio lo spirito che si percepisce nel tuo<br />
album di debutto. Una combinazione folle di stili di<br />
diversissima natura: funk, hip-hop, reggae, house...<br />
14 15
Quali aspetti preferisci valorizzare quando fai musica,<br />
tendi più a far ballare o a stimolare la dimensione<br />
d’ascolto?<br />
Penso che le canzoni migliori siano quelle che riescono<br />
in entrambi gli intenti. In generale il mio album è prettamente<br />
orientato all’ascolto, lo puoi metter su a casa o in<br />
macchina, anche se ci sono 3 o 4 brani che potrebbero<br />
andar benissimo nei club. Quando però si tratta di un<br />
concerto o un dj-set, il dancing diventa il cuore della<br />
questione, e il mio compito è quello di far scatenare la<br />
gente nel modo migliore. Sono due lati del mio carattere,<br />
e non sono nemmeno tanto differenti: l’uno ama far<br />
ballare le persone nei live show, l’altro vuol essere più<br />
espressivo, prendersi il suo tempo, toccare una maggiore<br />
profondità, magari essere meno divertente ma in compenso<br />
più riflessivo.<br />
Le tue performance live sono sempre accolte con<br />
grande entusiasmo. C’è un alone di leggenda che circola<br />
nel web riguardo ai tuoi mesh-ups live: strani incroci<br />
improvvisi capaci di tirare in ballo tanto Snoop<br />
Dogg e Missy Elliot quanto i Simpson o Mozart. Da<br />
dove viene questa tua abilità?<br />
Fondamentalmente non ho alcuna inibizione. Non mi lascio<br />
scoraggiare dal fatto che certe cose non dovrebbero<br />
andar su in un club. Se un pezzo di musica sta bene insieme<br />
ad un altro pezzo di musica, e un altro, e un altro più<br />
lento, e un altro più hard, non ho alcuna remora a unirli.<br />
Alla fine è tutta musica, se funziona, funziona! Mi sento<br />
completamente libero di scegliere, se ritengo valida una<br />
certa combinazione, questa sarà nel mio live show.<br />
Nessuna inibizione e nessuna regola: potrebbe essere<br />
il ritratto della scena dance UK di oggi. Mi interesserebbe<br />
il tuo punto di vista in proposito, la<br />
sensazione è che in UK (e a Londra in particolare) gli<br />
artisti siano meno soggetti a regole rispetto al resto<br />
del mondo, più propensi a partorire qualcosa di nuovo.<br />
Cosa ne pensi?<br />
È vero, c’è un sacco di gran musica a Londra oggi, e non<br />
limiterei la cosa alla sola dance. Personalmente è come<br />
se ci fosse qualcosa nell’aria che mi ispira nel far musica,<br />
che mi spinge a guardare al futuro e creare qualcosa che<br />
non è ancora stato fatto. Non so se è una cosa che vale<br />
per tutti, ma sono convinto che l’Inghilterra abbia qualcosa<br />
di decisamente prezioso. Decisamente.<br />
E come mai proprio in UK, e proprio a Londra?<br />
Wow, sinceramente non saprei. L’inghilterra ha anche<br />
la fama di essere piena di hooligans, ma non è così, la<br />
maggior parte di noi è gente che pensa. Forse è anche<br />
qualcosa che deriva dalla storia della nostra nazione,<br />
dalle varie dominazioni, qualcosa che ci spinge sempre<br />
a portarci avanti. In ogni caso non è una virtù che coin-<br />
volge tutti, la musica più cool è prodotta da una stretta<br />
minoranza. Siamo in sostanza dei ribelli che vogliono<br />
creare qualcosa di differente, per quelli che sono stanchi<br />
di sentire sempre le stesse cose in ogni club. Il mondo sta<br />
cambiando, l’Inghilterra sta cambiando, la tecnologia sta<br />
facendo progressi, e noi vogliamo essere tra quelli che si<br />
evolvono meglio degli altri.<br />
Un’elite di ribelli che fanno qualcosa di differente, un<br />
po’ quello che successe a Detroit negli anni della nascita<br />
della techno. Anche per voi far musica “nuova”<br />
è una missione?<br />
Sì, potremmo dire così. La missione è quella di seguire<br />
le evoluzioni del momento, di stare al passo coi tempi<br />
cercando di non suonare noiosi. Forse non siamo ribelli<br />
esattamente come è accaduto in altri contesti storici/<br />
musicali. Forse siamo semplicemente ragazzi intelligenti.<br />
Quali sono le tue ispirazioni? Quali artisti ti hanno<br />
influenzato maggiormente?<br />
Penso che Fatboy Slim sia stata la mia principale ispirazione,<br />
sotto tutti gli aspetti. Ho sempre considerato<br />
la sua musica estremamente creativa. Poi tanti altri:<br />
Coldcut, DJ Yoda, Danger Mouse, Jay Z, Dr. Dre, The<br />
Neptunes, Timbaland...<br />
Un sacco di hip-hop!<br />
Oh sì fratello, adoro l’hip-hop! Quando ho ascoltato Busta<br />
Rhymes l’ho trovato così creativo, differente, quasi<br />
non fosse hip-hop. Sono molto influenzato dal suo carattere,<br />
dal suo modo di pensare la musica. Anche i suoi video,<br />
sono così strani, folli. Penso che l’aspetto visuale sia<br />
ispirativo tanto quanto quello musicale, e Busta Rhymes<br />
è sia visivamente spettacolare che musicalmente creativo.<br />
E lo stesso vale per Fatboy Silm: prendi il video<br />
di Praise You, dove lui salta e balla per strada, fuori da<br />
un cinema americano. Quel video sarà costato meno di<br />
400 sterline. Lo trovo molto significativo: si può essere<br />
creativi anche con pochi soldi.<br />
Come stai cercando di distinguerti dagli altri?<br />
Eheh, altra domanda difficile! In generale prendo spunto<br />
da quei djs o live performer che mi esaltano, come<br />
i Chromeo, che per me sono davvero cool. Però percepisco<br />
un diffuso abbassamento della qualità: ormai<br />
tutti fanno i dj, i producers, bisognerebbe smetterla coi<br />
giochetti! Nei miei live show, ad esempio, quello che<br />
faccio è live remixing: prendo tutti gli strumenti che ho<br />
a disposizione, i laptops e gioco sull’improvvisazione. E<br />
mi sembra che in giro non ci sia nessuno che faccia cose<br />
del genere al momento. Sento di essere ossessionato<br />
dall’idea di essere differente. Non so quanto mi riesce<br />
nella realtà, ma mi sforzo di pensare in modo differente<br />
in ogni istante. In ogni istante.<br />
E direi che il tuo album è riuscito a suonare differen-<br />
te. Ora che sei arrivato al debutto discografico, come<br />
ti senti?<br />
Ovviamente sono spaventato dall’idea che la mia prossima<br />
prova sia meno apprezzata della precedente. Ho già<br />
prodotto un sacco di materiale per il prossimo album,<br />
ma voglio prendermi del tempo per lasciarlo sedimentare,<br />
e vedere se tra un paio di mesi suonerà meglio o<br />
peggio. Nel frattempo mi butterò sui remixes: stanno<br />
già per uscirne due, un remix di Beardyman e un altro<br />
di Kidda su Skint Records. Voglio pubblicare un disco di<br />
miei remix, e poi tornare al mio secondo studio album.<br />
Voglio fare le cose con calma, tornare più e più volte sul<br />
materiale del mio prossimo album. Voglio farlo diventare<br />
qualcosa di molto meglio, più potente, più melodico.<br />
Sono molto eccitato in proposito, verrà fuori qualcosa<br />
di sorprendente.<br />
Ottimo. A quando la pubblicazione?<br />
Probabilmente alla fine dell’anno prossimo, o all’inizio<br />
del 2013. Vedremo.<br />
Ok. In chiusura ti chiedo di convincere chi non ti conosce<br />
ad ascoltare il tuo album. Cosa gli diresti?<br />
Penso che il mio album possa piacere quasi a tutti. Perché<br />
tocca tanti generi, ogni traccia è diversa dall’altra. È<br />
un album che vuol far divertire, vuol trasmettere gioia.<br />
È come se fosse un viaggio. Un viaggio nella mia testa.<br />
Puoi ascoltarlo prima di andare a dormire, o quando ti<br />
svegli, quando sei in viaggio o quando fai sesso, in ogni<br />
situazione! Credo di aver raggiunto una sorta di completezza<br />
in Beats, Treats & All Things Unique, e penso che le<br />
persone genuine lo apprezzeranno.<br />
16 17
Tune-In.<br />
18<br />
Rival Consoles<br />
Testo: Edoardo Bridda<br />
Ryan L. West è cresciuto in una piccola cittadina vicino<br />
Leicester smanettando videogame, ascoltando paccate<br />
di IDM e imbottendosi di visioni sci-fi e sculture robotiche.<br />
I suoi non erano gli anni Novanta della Warp e dei<br />
robot con in mano lo spinello della famosa compilation,<br />
bensì i 2000 bastardi del fidget e del p-funk. Seguendo le<br />
orme di qualche connazionale, le strade che in passato<br />
lo avrebbero condotto nelle varie contee ambient e idm<br />
del Regno Unito (Mo Wax, Planet Mu, Warp, Rising High,<br />
Ninja Tune) lo portano invece in Germania, patria di Robert<br />
Raths e di un’etichetta, la Erased Tapes, piuttosto<br />
distante dall’immaginario del classico idmmer innamorato<br />
dei film di fantascenza.<br />
La label si occupa di cinematica folk-pop post-Kid A<br />
e chamber elettroacustica e, all’interno di questi ambiti,<br />
Rival Consoles e il side project Aparatec, si configurano<br />
apparenemente come anomalie: sono gli unici progetti a<br />
farsi carico di un sentire warp-iano ma sono anche legati<br />
ad aspetti neo-classici che riportano a una macro idea<br />
filmica del label manager perfettamente incarnata dal<br />
musicista più famoso in scuderia, Ólafur Arnalds. Ryan,<br />
del resto, ama un tomo titanico come Drukqs, bibbia drill<br />
di Aphex, e tutto il Venetian Snares estremo fatto di ritmi<br />
impossibili e musiche classiche: l’estetica cameristica<br />
non come fine ma forte mezzo “di contrasto”.<br />
All’inizio, Rival Consoles esprimeva lo scontro tra la<br />
—Melodie complesse—<br />
In un momento di complicazioni ritmiche, dall'Inghilterra arriva un personaggio<br />
cresciuto a pane, Aphex Twin e Daft Punk a dire basta. E' il momento di melodie<br />
ambiziose, videoludiche (e complicate)<br />
britannia ultra modernista dell’IDM e la tradizione classica<br />
dell’Europa continentale: all’epoca dell’eppì The<br />
Decadent (2007) o dell’esordio IO pravalevano seriosità<br />
e frattali, braindance e archi seriosi, residui drum’n’bass<br />
e note veloci à la Squarepusher, ritorni al purismo acid<br />
dell’Aphex della serie Analord e chamber music. Con Kid<br />
Velo il discorso si ribalta: a contrastare una rimica semplificata,<br />
troviamo una complessità tutta melodica e un<br />
funky sintetico che deve moltissimo ai Daft Punk, alla<br />
disco music e qualcosa anche all’house. Dalla cinematica<br />
sci-fi in odor di Moby di un brano come Kitch (apparso<br />
anche nella prima compilation della Erased Tapes sottotitolata<br />
At The End Of All Music Happiness Will Be Erased), si<br />
passa a una videoludica bambinesca e a una pornografia<br />
per robot (Futurama docet). L’elemento magniloquente<br />
e l’amore per la cibernetica non sono spariti (Vos), supportano<br />
e giocano di sponda con giocosità inedite e, a<br />
loro modo, coraggiose.<br />
Ci vuole fegato per suonare complesse trame attraverso<br />
sintetizzatori ultra saturi che portano alle radici<br />
nerd dei parigini di Discovery e tutto questo coraggio, a<br />
sua volta, conduce al paragone con Luke Vibert: entrambi<br />
possiedono radici briannicamente (ambient)techno<br />
ed entrambi trovano la quadratura nelle molteplici modalità<br />
kitch-troniche francesi. Come in un ritorno al nocciolo<br />
- dai 90s alla chip tune music degli eighties - Rayan<br />
19
einterpreta e reinventa con l’estro e la fronte umidiccia<br />
del maghetto del coin-up. E’ ovvio che nell’intervistarlo<br />
la prima domanda ha riguardato proprio questo.<br />
Il tuo nuovo album richiama immediatamente alla<br />
mente gli arcade game degli 80s, e per dirla tutta<br />
sembra andare in profondità nella “demo scene” music,<br />
la musica suonata nei crack intro dei videogiochi<br />
craccati per C64…<br />
Sono creciuto con i computer game come tutti quelli che<br />
sono cresciuti negli anni Ottanta. La cosa che mi piace di<br />
più di quella musica è di quanto volesse essere drammatica,<br />
nonostante le pesanti limitazioni. C’è qualcosa che<br />
muove veramente nei suoni elettronici che cercando di<br />
comunicare qualcosa di epico o tragico<br />
È interessante notare che nel momento in cui gente<br />
come 4mat e goto80 stanno spingendo sui confini<br />
della chiptune music, tu te ne vieni fuori con un album<br />
ispirato ai videogiochi ma suonato con synth e<br />
drum machine del roster Warp<br />
Probabilmente perché i preferisco sonorità profonde e<br />
pesanti. Mi piacciono le batterie che si stagliano in potenza<br />
e amo che i synth siano grossi e increspati.<br />
C’è un sacco di funk ed electro in Kid Velo. E naturalmente<br />
c’è un sacco di gente che parla di Daft Punk e<br />
dell’influenza che hanno avuto nella tua musica<br />
Daft Punk sono una grandissima influenza tanto quanto<br />
un sacco di grossi musicisti elettronici come Röyksopp, i<br />
Chemical Brothers, Justice, ecc. Quel che mi piace di loro<br />
è la confidenza e lo stile con la quale fanno musica. Lo<br />
fanno così bene che sono amati praticamente da tutti. In<br />
musica ci sono due tipi di creatività: la creazione dell’idea<br />
e la sua esecuzione. E hai entrambe sei il massimo, ma se<br />
possiedi solo la prima non significa minimamente che<br />
hai per le mani una grande canzone, ci sono così tanti<br />
fattori che influiscono nel risultato, un buon giudizio è<br />
sempre necessario per mettere tutto assieme e questo<br />
penso che sia quello in cui i musicisti che ti ho citato mi<br />
influenzano di più.<br />
Rispetto a Justice e Digitalism, mi piace in te quell’attitudine<br />
nerd per i dettagli che i Daft hanno sempre<br />
coltivato…<br />
Ah, grazie, I guess...<br />
Il suo sembra un approccio da produttore. Sei parecchio<br />
metodico e dietro a Rival Consoles sembra<br />
ci sia un motto: fare complessità dietro a restrizioni<br />
tecnologiche…<br />
ci sono un sacco di complessità differenti, la mia musica<br />
non è eccessivamente complessa, è complessa all’interno<br />
del genere. Cerco di trovare un bilanciamento tra<br />
semplice e complesso tra melodie e strutture, ma non<br />
come una regola, se qualcosa funziona in un modo<br />
molto semplice sono contento di utilizzarla. E’ semplicemente<br />
difficile trovare forme semplici che sono anche<br />
lontanamente uniche. Penso che dal punto di vista tecnologico,<br />
serva parecchia programmazione e automazione<br />
nel creare sintetizzatori che si evolvano e maturino<br />
nel tempo. Come nella traccia Vos il synth che apre<br />
è un vocoder che ha il suono del traffico come se fosse<br />
un modulatore, questo causa un sacco di profondità e<br />
picchi nel volume e nell’energia del synth che lo rende<br />
veramente ricco.<br />
In IO la complessità riguardava di più il ritmo. Venetian<br />
Snares, Drukqs di Aphex Twin.Questo è più una<br />
faccenda di melodie e armonizzazioni<br />
Penso che sia l’aspetto più forte della musica e perché<br />
c’è una mancanza forte di nuove idee melodiche a mio<br />
avviso. Dappertutto vedi ambient, lo-fi e un sacco roba a<br />
base di glitched rhythmic noise. Volevo che l’album fosse<br />
differente da questi estremisti del ritmo e probabilmente<br />
ho finito per essere estremo dall’altro punto di vista…<br />
Nell’album puoi sentirci alcuni percorso del dopo<br />
Daft Punk. Citavo Digitalism, Justice e aggiungerei<br />
anche gli Autokratz. E’ interessante vedere una nuova<br />
generazione di brit producer rompere le barriere<br />
tra Londra e Parigi<br />
Yeah! Mi piace il french electro e l’house e mi piace molto<br />
della musica francese quel senso dello stile semplice<br />
però difficile da catturare. Sono stato persino scambiato<br />
per un french producer a un concerto!<br />
Musica concreta. In Kid Velo hai campionato qualcosa.<br />
E’ c’è pure una chitarra che mi ha ricordato la hit<br />
degli Stardust dei 90s… Mi piace osservare la tua musica<br />
anche pensando che ci metti dentro dei segreti<br />
come gli special level dei videogiochi<br />
Infatti nessun effetto sonoro da videogame è stato utilizzato.<br />
Ho impiegato principalmente campionamenti di<br />
sci-fi film e french art film. Un sacco di producer utilizzano<br />
suono 8bit ma penso che non renda migliore la loro<br />
musica. Le qualità del synth sono le cose che contano.<br />
Il tuo side project Aparatec è ancora vivo?<br />
La mia etichetta (Erased Tapes ndr.) lo vuole far rivivere<br />
giusto per un’ultima uscita e c’è ancora del materiale che<br />
potremmo utilizzare. Potrei fare qualcosa nel futuro ma<br />
per il momento sono troppo impegnato con Rival Consoles.<br />
Come Luke Vibert, hai forti radici in techno e acid, ma<br />
nella tua musica si trovano anche tagli House e pop…<br />
Sono molto pignolo con House e Acid, e mi piace molto<br />
Luke Vibert. Penso che techno e l’acid hanno una brutta<br />
reputazione perché c’è troppa merda in giro, preferisco<br />
l’House alla techno perché esibisce più stile e melodia.<br />
Mi piace veramente il buon pop perché è così diretto.<br />
Melodia stampate in faccia. Che ti piaccia o no. Penso<br />
che la gente pensa che le cose più subdole e riservate<br />
siano più intelligenti…<br />
Live set o dj set? Entrambi? Cosa dobbiamo aspettarci<br />
da un tuo show? Video?<br />
Ricreo metà del set con il materiale che ho nelle track<br />
missandolo ecc. Mi piace tenere le cose semplici però.<br />
Un sacco di gente che usa ableton pensa di dover fare un<br />
centinaio di cose. Meno opzioni e più pensiero è quello<br />
che fa la differenza.<br />
Quando hai iniziato a fare musica quali erano i tuoi<br />
miti? Sei cambiato ora?<br />
Ho sempre amato Aphex Twin e Daft Punk. Quando<br />
sono andato all’università mi sono focalizzato di più<br />
sulla musica proprio perché vedevo cosa potevo farci.<br />
Ho ascoltato un sacco di roba differente da John Cage<br />
a Stockhausen, Ligeti, Elgar, Merzbow. Ora ascolto roba<br />
ambiziosa, fresca e nuova…<br />
20 21
Tune-In.<br />
22<br />
Stephen Malkmus<br />
—L’indolenza del genio—<br />
Nessuna nostalgia, semmai il compiaciuto orgoglio di chi non ha bisogno di<br />
scendere a patti con un formidabile passato. Due chiacchiere con Stephen Malkmus.<br />
Testo: Stefano Solventi<br />
A volte ritornano. Anzi, in realtà è sempre stato fra noi.<br />
In posizione centrale. Una presenza costante malgrado<br />
l’hype si fosse ormai depositato su altri lidi, altre effervescenze.<br />
Forse perché quel modo di caracollare con noncuranza<br />
arguta e trepidazione dinoccolata è diventata<br />
una vera e propria coniugazione del fare rock. Ben oltre i<br />
Novanta, anni che videro la calligrafia lo-fi dei Pavement<br />
farsi segno caratterizzante di un’epoca in procinto di ricevere<br />
in faccia la risacca dell’illusione progressista, del<br />
Sogno Americano messo alle corde, deturpato e ridicolizzato.<br />
Tanto valeva ghignarci sopra uno spaesamento<br />
ora scontroso, ora beffardo, ora bisognoso di stringersi<br />
in una burbera, intensa malinconia. Scompaginare il canone,<br />
eleggere lo scazzo a fondamenta di un percorso<br />
emotivo autentico, perché autenticamente radicato in<br />
una quotidianità fatta prevalentemente di disillusione.<br />
C’erano già molte se non tutte le premesse di ciò che<br />
stiamo tristemente vivendo oggi. Per questo quando in<br />
una canzone del suo utlimo disco il quarantacinquenne<br />
Stephen Malkmus dileggia le predilezioni esistenziali<br />
di un senatore - desideroso in fin dei conti di soddisfare<br />
le proprie più basse brame ben prima del bene collettivo<br />
- non sembra affatto fuori ruolo. Anzi, appare del<br />
tutto legittimato, una figura autorevole in materia. Sebbene<br />
- si badi bene - non intenda affatto impelagarsi tra<br />
le sempre nutrite fila del rock engagé. No, non è il suo<br />
stile. Lui, l’ex-Pavement, è l’ex-ragazzone dalllo sguardo<br />
inquieto sotto una scorza decisamente matura, diresti<br />
quasi posata, che fa la sua parte nell’ordine sociale (la<br />
famiglia, gli amici), compresa la facoltà di rimarcarne i<br />
tragicomici risvolti. Dall’alto d’uno scranno musicale edificato<br />
in oltre venti anni di carriera, di cui quasi l’ultima<br />
metà passata a costruire un repertorio solista (in condominio<br />
coi fidi The Jicks, a onor del vero) di tutto rispetto.<br />
Addentrandosi album dopo album in una dimensione<br />
psichedelica che lo hanno reso autore e interprete rock<br />
a tutto tondo, capace di sfornare gragnuole soniche micidiali<br />
ferma restando una scrittura improntata alla più<br />
salda e imprendibile obliquità.<br />
Con Mirror Traffic il signor Malkmus sembra chiudere la<br />
parabola recuperando i tempi, i modi e la versatilità della<br />
fase centrale Pavement, coincidente per intendersi col<br />
rimarchevole Wowee Zowee. Se il termine malkmusiano<br />
ha un senso - e lo ha - ebbene questo disco lo incarna<br />
alla perfezione: un carosello iresistibile di genio e indolenza,<br />
di fatalismo stropicciato ma vigile, di flemmatica<br />
arguzia rock che ha smesso da un pezzo la maschera<br />
della trasgressione per covare il senso di una vita normale.<br />
Con tutti gli spigoli e le assurdità del caso. Con le<br />
straordinarie contingenze dell’ordinario volgere degli<br />
affetti e dei conflitti. Un plauso dunque alla produzione<br />
di Beck, capace di infondere la propria visione sonora<br />
senza prevaricare anzi esaltando la calligrafia di Stephen<br />
e dei sodali Jicks. In coincidenza di questo francamen-<br />
23
te inatteso apice artistico, abbiamo più che volentieri<br />
scambiato qualche chiacchiera telefonica col rocker di<br />
Santa Monica.<br />
Il tuo ultimo album con i Jicks ha 15 tracce e un sacco<br />
di ottime idee. Pensi che sia in qualche modo merito<br />
della recente reunion con i Pavement?<br />
Forse un pò, ma non più di tanto. E’ possibile che suonare<br />
nuovamente le vecchie canzoni dei Pavement abbia in<br />
parte influenzato la realizzazione di queste ultime. Ma<br />
molte le stavamo già eseguendo dal vivo prima della<br />
reunion.<br />
Mi pare che le canzoni di Mirror Traffic recuperino<br />
quel senso di disincanto e spontaneità che non avevamo<br />
più notato dai tempi di Wowee Zowee. Sei d’accordo?<br />
Forse sì. Mi pare che il primo album dei Jicks mantenga<br />
quello spirito, dopodichè sono entrato in una fase più<br />
progressive, con suoni più pesanti e in un certo senso<br />
anche più oscuri. Tornando alle vecchie cose ho cercato<br />
di essere accattivante in maniera differente, merito anche<br />
di Beck la cui produzione ha reso tutto più solare e<br />
frizzante.<br />
C’è anche una forte componente psichedelica. E’ un<br />
influenza che hai sempre coltivato o è qualcosa dovuto<br />
alla tua maturazione artistica?<br />
Come ascoltatore e fan, vengo influenzato da quelle<br />
cose che mi sorprendono maggiormente. Cose che suonano<br />
creative, magari realizzate con strumenti differenti<br />
e non strettamente rock’n’roll. Credo poi che la maggior<br />
parte delle melodie che adoro siano un pò selvagge e in<br />
qualche modo psichedeliche perché in fondo la chitarra<br />
è e sarà sempre lo strumento che preferisco.<br />
Mirror Traffic è il tuo quinto album coi Jicks, lo stesso<br />
numero di quelli realizzati con i Pavement. Non credi<br />
che sia il momento di smettere di pensare a Stephen<br />
Malkmus come l’ex leader dei Pavement?<br />
Vorrei che fosse possibile ma credo che sia difficile.<br />
Dovrei avere un grande successo perchè questo possa<br />
accadere. Prendi artisti come Neil Young o Nick Cave:<br />
la gente parlando di loro non cita in continuazione Birthday<br />
Party o Buffalo Springfield solo perché hanno<br />
avuto un grande successo con la loro carriera solista.<br />
Personalmente sono fiero di quello che i Pavement mi<br />
hanno portato e la loro notorietà non mi imbarazza affatto.<br />
Probabilmente la gente continua a parlarne perché<br />
alcuni considerano la musica dei Pavement più importante<br />
di quella dei Birthday Party, o in qualche modo ha<br />
significato di più per loro. Ad ogni modo è una buona<br />
cosa. E’ molto difficile dimenticarsi di cose che sono state<br />
speciali per qualcuno, me compreso. In fin dei conti si<br />
tratta di una parte di me, di tutte le mie canzoni scritte<br />
sin dall’inizio della mia carriera pertanto non ho problemi<br />
a farmene una ragione.<br />
Da quanto tempo conosci Beck e quando è nata l’idea<br />
di una vostra collaborazione?<br />
Ci siamo conosciuti circa vent’anni fa. Difficile credere<br />
che sia passato così tanto tempo. A quel tempo stava<br />
preparando l’album con Loser (Mellow Gold, ndr.) e lo vidi<br />
cantare quella canzone ad un concerto. Era un ragazzo<br />
simpatico, molto amichevole e anche un pò timoroso.<br />
Stava diventando molto popolare un pò dappertutto e<br />
credo che temesse di essere considerato una sorta di<br />
one hit wonder, una specie di loser, proprio come quello<br />
del brano. Per cui era tutto ‘Hey, non sono solo questa<br />
canzone, sono molto di più’. Poi abbiamo fatto parecchi<br />
tour nei 90s e ci incontravamo spesso, soprattutto nel<br />
backstage, anche solo per dirci ‘ciao’. Quando ho iniziato<br />
a pensare al disco lui aveva già iniziato a fare il produttore.<br />
Credo sia stato un bel cambiamento nella sua vita,<br />
voglio dire, smettere con i tour e dedicarsi di più alla<br />
famiglia. Così mi ha chiamato per dirmi quello che stava<br />
facendo. Con tutte le esperienza che abbiamo condiviso<br />
è stato naturale dire ‘hey, facciamo un disco’. Ecco cosa è<br />
successo un paio di anni fa.<br />
Che differenze hai riscontrato rispetto agli altri produttori<br />
con cui hai lavorato? Ha un modo particolare<br />
di lavorare?<br />
E’ difficile da dire. Come ingegnere del suono ha il suo<br />
stile personale ma altre cose sono simili. Alla fine per<br />
me si tratta sempre di preparare gli strumenti e iniziare<br />
a suonare. Sono tutti molto veloci a trovare i suoni giusti,<br />
hanno le loro idee riguardo a come deve suonare<br />
la batteria e il basso, piuttosto che le voci e la chitarra.<br />
Ognuno ha le proprie preferenze nel modo di registrare<br />
ed equalizzare. E’ tutto un pò noioso, più interessante per<br />
una rivista tecnica, credo. Ma ognuno di quelli con cui ho<br />
lavorato sapeva il fatto suo e faceva le cose in maniera<br />
differente. Credo che Beck sia un ottimo ingegnere del<br />
suono: ha registrato parecchie cose, ha realizzato sette<br />
album per conto suo per cui era certamente molto<br />
preparato. Per il resto si entra nei gusti personali. Uno<br />
come Beck credo che si adatti facilmente con chiunque<br />
lavori. Ha ascoltato i pezzi e poi si è tolto di mezzo lasciandoci<br />
fare le nostre cose, senza darci troppi consigli<br />
in fase di registrazione. Penso che avrebbe fatto di più<br />
se, ad esempio, il nostro batterista avesse suonato male.<br />
Ci possono essere vari problemi mentre registri. E’ possibilie<br />
non trovare il groove giusto o cose del genere e<br />
lui avrebbe potuto aiutare in qualche modo o dire ‘proviamo<br />
con un altro pezzo’. Ma fortunatamente non ce<br />
n’è stato bisogno.<br />
Come artisti, trovo che ci sia sempre stata una certa<br />
somiglianza fra voi due, ma non credevo che ci potesse<br />
essere una simile armonia fra i vostri stili...<br />
Siamo entrambi di LA, ragazzi californiani, e siamo appassionati<br />
delle solite cose... Arte, libri... L’idea di trovare<br />
nell’arte una fuga dalle nostre vite; magari è qualcosa<br />
che ognuno fa da teenager... In un certo senso è strano<br />
che due come noi possano essere amici... Non lo conosco<br />
così bene nella vita... Lui è giù a Los Angeles e io sono<br />
qui. Ma musicalmente, è vero, siamo piuttosto simili.<br />
Alcuni degli artisti preferiti all’interno del nostro magazine<br />
si sono fatti una reputazione nel corso dei 90s<br />
(penso ad esempio a Pj Harvey e Flaming Lips), cosa<br />
significa per un eroe dei 90s come te suonare per una<br />
giovane audience nel 2011?<br />
Beh, è molto bello. Mi ricorda di quando negli anni 80<br />
avrei voluto assistere al concerto di gente dei 70s come<br />
Lou Reed o Iggy Pop. Una cosa tipo ‘andiamo a vedere<br />
quel tipo cool e attempato ancora così forte’... Beh, Lou<br />
non era così cool a quel tempo ma era sempre The Reed!<br />
Oppure uno come Mark Smith...<br />
Immagina se fossi nato 15 o 20 anni dopo. Come ti<br />
muoveresti se la tua carriera come musicista iniziasse<br />
adesso?<br />
E’ difficile da immaginare. Credo che alla fine sarei nella<br />
solita situazione ma ci sarei finito con mezzi diversi. A<br />
quei tempi si sentiva parecchia musica nuova. Fra i 16 e<br />
i 25 scavavo parecchio fra le cose nuove per cercare di<br />
capire me stesso. All’epoca mi sarei rivolto a un amico<br />
di qualche radio o di qualche fanzine o avrei utilizzato<br />
il passaparola. Ora il passaparola passa per Internet, ci<br />
sono queste figure in rete, che possono essere website<br />
particolarmente cool o semplicemente persone, magari<br />
amici, che possono trasformarti in qualcosa di nuovo.<br />
Internet ha velocizzato tutto quanto ma mi sembre che<br />
le cose che ho sempre pensato che fossero forti, lo sono<br />
tutt’ora. Mi riferisco a cose di 20-30 anni fa, o anche più.<br />
Cose tipo Velvet Underground, Beatles, Wire, il punk<br />
rock, i Sex Pistols. Magari anche Pavement, Dinosaur<br />
Jr, Pj Harvey, My Bloody Valentine. La gente continua<br />
a pensare che siano grandi artisti.<br />
Dal nostro punto di vista, diciamo ‘europeo’, tu ha<br />
sempre rivestito il ruolo dell’outsider che ci ha sempre<br />
intrigato. Pensi che le tue canzoni, specialmente<br />
le ultime possano essere considerate in qualche<br />
modo politicamente o socialmente impegnate?<br />
Beh, non molto. E’ ancora una piccola stravangante parte<br />
della borghesia che continua ad apprezzare questa<br />
musica. Personalmente non vedo nessuna rivoluzione<br />
all’orizzonte. E’ una specie di accessorio di lusso per gente<br />
che è andata al college, bene educata: una piccola<br />
percentuale del mondo. Vorrei fosse diverso, qualche<br />
volta. Ma non so se vorrei una vera rivoluzione. Mi piacerebbe<br />
che ci fossero cambiamenti in medio oriente,<br />
ma non credo di essere la persona più adatta a parlarne.<br />
Credi che quello con i Jicks sia il tuo progetto definitivo<br />
o hai in mente qualcosa di diverso per il futuro?<br />
Non saprei, per il momento sto facendo questo. La mia<br />
vita è con mia moglie e la mia famiglia. anche mia moglie<br />
lavora, così tutte le mie energie sono impegnate in<br />
questo per il momento.<br />
Verrai in Italia prossimamente con i Jicks?<br />
Sicuramente... Probabilmente saremo a Milano. Magari<br />
anche a Bologna, c’è un’ottima scena da quelle parti.<br />
Magari scenderemo anche più a sud. Bisogna aspettare<br />
e vedere ma spero davvero di si.<br />
24 25
deus<br />
—La bellezza e il movimento—<br />
Drop out<br />
Abbiamo intervistato la band<br />
belga a pochi giorni dall’uscita del<br />
nuovo album, Keep You Close, terzo<br />
capitolo di una istituzione del<br />
rock che ha saputo sopravvivere ai<br />
Novanta, con dignità...<br />
Testo: Federico Pevere<br />
26 27
“Aveva la capacità di accettare la sempre maggiore frequenza di corpi stesi sulle rotaie<br />
e di trasformarla in un concetto filosofico, per così dire: il mondo stava andando in<br />
rovina, precipitava a capofitto in un qualcosa di guasto e cattivo, ben lontano da ciò<br />
che un tempo era saldo e solido e, ovviamente, tenuto insieme con acciaio e legno e<br />
pietrame – precisi diritti di precedenza, orari solo di rado traditi”.<br />
Episodi incendiari assortiti – David Means<br />
episodi inCendiari assorTiTi<br />
Dimenticate i litigi, le pause infinite, gli addii inconsapevoli. Scordatevi gli<br />
anni Novanta. Dimenticate la band di una vita, fermatevi e pensate all’incarnazione<br />
dell’indie rock primordiale, definitivo già nell’essenza, nell’idea,<br />
come doveva essere. Rimodella(tela) sulla vostra pelle, devasta(tela) come<br />
fosse la vostra sola educazione sentimentale ai tempi del senza internet, ma<br />
con l’aggiunta del tutt’altro. Vi riscoprerete adulti, e con voi, tra dicotomie di<br />
passato avvolgente e futuri indistinti, gli eroi dell’antichità rock del vecchio<br />
continente, un po’ malconci ma vivi. Vivi. Escludendo I’armata britannica,<br />
ad emergere ritroverete solo un nome spiccare tra (pochi) altri, profetico<br />
ed esibizionista: dEUS. Il gruppo belga, nonostante le devastazioni di line<br />
up di fine secolo scorso, rappresenta una delle poche istituzioni rock a tutto<br />
tondo (e spigolature) a livello europeo. Una certezza invasata costellata da<br />
(quasi) capolavori indiscussi, seppur antichi; un viaggio per nulla scorrevole<br />
tra la schizofrenia di Worst Case Scenario e la calma apparente di Ideal Crash,<br />
passando per la consapevolezza dell’imprevedibilità di In A Bar, Under The<br />
Sea. I Novanta a risplendere di luce propria.<br />
E poi sei anni di silenzio, inevitabili per rispedirti nel dimenticatoio o<br />
nell’elevarti a culto, necessari se del tuo gruppo ne hai fatto ragione di<br />
vita. Pocket Revolution, del 2005, li rilancia nella mischia, un po’ appannati<br />
e confusionari (ricordate Bad Timing: l’inizio della seconda esplosione),<br />
conveniente trampolino di lancio per Vantage Point, del 2008, così ruffiano<br />
e inevitabilmente ammiccante da risultare amorevole anche a chi fan non<br />
era. Un trittico chiuso (in sei anni, un’inezia in casa dEUS, sei album in più<br />
di vent’anni) ora da Keep You Close (in uscita il 19 settembre), a costituire il<br />
tassello mancante, la saldatura definitiva figlia di una line up consolidata<br />
e da un leader mai così leader, collante tra collante, il pavoneggiante Tom<br />
Barman, uomo della provvidenza dieci anni fa a ricostruire il tutto, come<br />
prima, tra i cocci del successo.<br />
Dell’ultimo album e di tutt’altro, ne abbiamo parlato con il chitarrista<br />
Mauro Pawlowski, Deus ex machina sonoro del rock belga (come dimenticare<br />
le intuizioni malate dei The Love Substitutes e l’intimità noise dei<br />
Club Moral?), che rappresenta il lato drammatico (musicalmente) e sornione<br />
(umanamente) dei nuovi dEUS; il sole incalzante di Grugliasco (città-centro<br />
industriale alle porte di Torino) ce lo presenta di nero vestito, devastato da<br />
lunghi balbettii e innocui silenzi (è reduce da sedici ore di tour bus), così<br />
attento nel misurare le parole, anche quelle dimenticate. Con lui si gioca<br />
d’intuito, come con l’amalgama sonoro stratificato dei dEUS, si indovina.<br />
Partiamo da lontano e dall’odiato: le definizioni e le etichette improvvisate.<br />
Tra l’eleganza del movimenTo<br />
Keep You Close potrebbe costituire in casa dEUS, l’album della maturità; sicuramente<br />
non quello della consacrazione, ride Pawlowski che poi improvvisamente<br />
serioso annuncia, sì, siamo diventati una band matura. Lo siamo<br />
sempre stati, analizza scivolando nell’arroganza piacevole. Quando si tratta<br />
di recensire un loro album risuona l’eco delle antiche parole di Barman, la<br />
definizione della loro musica, come due facce della stessa medaglia. Una spontaneità<br />
e naturalezza che li porta a concepire in un continuum sonoro unico,<br />
digressioni sonore velate di melanconia, vedi i due estremi dell’ultimo disco<br />
a costituirne l’ossatura cesellata: dalla melodia trafitta dal dolore dell’iniziale<br />
Keep You Close alla nera e devastata d’organi, Easy, passando per veri e propri<br />
anthem: ammiccanti prima, il singolo Constant Now, decisamente rock’n<br />
roll, se non baldanzoso (ci passino il termine mainstream), e quindi l’ovvietà<br />
decisa di Dark Sets In.<br />
Chiedo una definizione. In una parola? Bellezza, risponde pronto. Si fa improvvisamente<br />
pensieroso. Con l’ultimo album ci siamo soffermati su uno<br />
stato d’animo più definito, più intimo e personale. Introspettivo. Anche se l’unica<br />
parola decisiva nel rappresentare questa nostra fase è la ricerca ostinata<br />
della bellezza. Abbiamo scritto molta musica nell’ultimo anno, un paio di ep<br />
usciranno entro la fine del 2011 - confida Pawlowski - tutta accomunata da<br />
uno spirito diverso rispetto ai precedenti lavori, disomogenei e in qualche modo<br />
schizofrenici.<br />
La scrittura delle canzoni risente di un approccio più caldo e melanconico,<br />
per nulla rassegnato, ma in qualche modo consapevole del proprio stato<br />
umano, sofferente o ottimistico non ha importanza, verrà da sé. In una parola,<br />
liquido, volubile, a cos’è dovuto? Pawlowski parte da lontano: Quando<br />
spendi molto – o forse troppo - tempo assieme, si condividono gli stessi umori,<br />
le stesse emozioni. Si crea un vortice in cui diventi parte di un processo creativo<br />
28 29
continuo e incontrastabile, c’è chi pensa ai violini, chi ai cori, chi perfeziona gli<br />
arrangiamenti, chi si concentra sulla melodia. Tutti vivono e si occupano di qualcosa<br />
di diverso nelle proprie vite, poi nei Deus tutto torna allo stato brado, tutto<br />
è diversificato prima, eppure accomunato poi. Non pensiamo alla riuscita finale<br />
delle canzoni, a come devono suonare. Tutto va oltre l’umore del momento. Le<br />
canzoni nascono assieme se c’è questo sintomo: le stesse sensazioni, la stessa<br />
predisposizione, poi la musica rifletterà esclusivamente la nostra condivisione,<br />
null’altro, niente di personale.<br />
Anarchia e famiglia, condivisione e movimento definiscono il processo; il<br />
come dei dEUS rappresenta l’essenza della creatività, tutto, il fine ultimo<br />
della loro ricerca. Pawlowski nel corso dell’intervista usa continuamente le<br />
parole exciting e brilliant, non bisognose di traduzione. Il cerchio si chiude<br />
e così l’obiettivo diventa la ricerca della bellezza, senza dimenticare l’eccitazione<br />
e il movimento, dopo tutto siamo una rock band - l’agitazione è nella<br />
nostra natura – diventata famiglia, vista la regolarità con cui sono usciti gli<br />
ultimi album. La band diventa ossimoro, viene alla mente la canzone Slow<br />
come manifesto del nuovo corso, un elegia dell’agitazione: piace pensarla<br />
come il movimento della lentezza.<br />
la perFezione o la provvisorieTà<br />
Il pomeriggio è assolato, a risuonare c’è solo asfalto; l’epica live dei dEUS<br />
non ne risentirà nonostante il pubblico di granito. Keep You Close è un album<br />
ampiamente metabolizzato dai componenti della band, a sostenerlo<br />
il fine lavoro di rifinitura, a definirlo nell’ultimo anno, una sottile manualità<br />
da cesellatore, una sorta di (ri)definizione post live. Un’influenza importante<br />
sulla resa definitiva dei pezzi l’ha avuto la dimensione live, non in termini di<br />
cambiamento effettivo, e cioè una sorta di ripensamento sulle dinamiche che<br />
costituiscono i pezzi, tutto ciò in base alla reazione del pubblico, ma dal punto<br />
di vista dell’approccio nella registrazione del disco, il feeling tra noi e il pubblico<br />
è stato fondamentale, ha trasmesso freschezza ed eccitazione alle registrazioni.<br />
Una sorta di prova generale, quindi. Sì, le volevamo suonare live prima di<br />
finirle. Un test in bilico tra la sensazione di perfezione che ti trasmette il disco<br />
e la provvidenziale provvisorietà del live, un gioco di rimandi che si rifletteva<br />
esclusivamente sul nostro mood, una sorta di condivisione ben diversa dal rinchiudersi<br />
per un anno nel nostro studio di registrazione, una sorta di bunker<br />
gradevole, tra fiori di plastica e famiglie al seguito.<br />
Mettersi in gioco e ritirarsi a meditare. Il nuovo disco è pronto, definitivo,<br />
non ci possono essere ripensamenti e così la scaletta del concerto di Gugliasco<br />
è incentrata soprattutto sui pezzi più antichi, calcando una sorta di best<br />
of, inframmezzata da piccoli inserti dal nuovo repertorio. E così, all’ombra del<br />
gigantesco centro commerciale, Slow riempie di groove e impulsi la scena,<br />
Tom Barman indiavolato con la chitarra saccheggia la folla. Sun Ra e Instant<br />
Street sono terreno di Pawlowski, a rilanciare ricami chitarristici per i cori dei<br />
mille di Gugliasco. La già citata Constant Now risuona già come un classico,<br />
pop e danzereccia al punto giusto, all’apparenza un outtake di Vantage Point<br />
in sostanza il nuovo singolo della band di Anversa; tutt’altro discorso per<br />
Ghosts (è solo la seconda volta che la suoniamo, quasi si giustifica Barman),<br />
fiacca e ridondante, ancora bisognosa di attenzioni in chiave live. Tra i bis,<br />
la tribalità diventata assordante di Dark Sets In, uno dei pezzi di punta di<br />
Keep You Close, futuri cori casalinghi a casa Pukkelpop, il tutto a lanciare<br />
l’apoteosi serpentina di Bad Timing e l’inno a sudare, l’immancabile Suds<br />
and Soda. Un’esibizione frastornante, kitsch, a rasentare l’esibizionismo più<br />
sofferente. L’ennesima dicotomia.<br />
A ben vedere, dalle premesse pomeridiane dell’affabile Pawlowski, una<br />
dimensione che ci ha contagiato, consentendoci un approccio più caldo nella<br />
scrittura dei testi e della musica di Keep You Close. Il risultato? La conferma<br />
della nostra indole, della nostra doppia anima. L’album può essere paragonato<br />
The Ideal Crash, con cui condivide lo stesso produttore, David Bottrill,<br />
e lo stesso taglio emozionale, come testimoniano la similarità delle due<br />
copertine del disco. Piccoli esempi, particolari che diventano associazioni.<br />
Pensavamo che una vecchia foto inglese – a ritrarre due scienziati intenti ad<br />
analizzare un fossile (il loro passato, ndr) - fosse semplificativa del nostro nuovo<br />
corso, smettiamola con queste inutili fotografie rock’n roll! Sono alla ricerca del<br />
passato, loro come noi, e quindi dell’armonia antica.<br />
non è Un paese per giovani<br />
Molte sono le suggestioni – se non le divagazioni – che dipingono e costituiscono<br />
il mondo dEUS. Il cinema (Any Way The Wind Blows) di Tom Barman.<br />
L’amore per la letteratura (amo alla follia il genio di David Foster Wallace) di<br />
Pawlowski, vedi i suoi viaggi in Italia con la meglio gioventù letteraria del Belpaese<br />
(Sandro Veronesi, Francesco Pacifico, Caterina Bonvicini, Paolo Giordano).<br />
A livello prettamente musicale, a testimoniare tutta quest’effervescenza<br />
belga, ci pensano i continui rimandi e le immancabili collaborazioni. Spicca,<br />
nell’ultimo album, la rivolta sentimentale di Twice, dove le voci di Barman e<br />
Greg Dulli diventano letteralmente tutt’uno. La differenza è indefinibile, il<br />
tutto raccolto da un epica senza possibilità. Tom e Greg Dulli si sono cercati e<br />
annusati a lungo. Poi per caso, l’incontro durante una pausa del tour con i Gutter<br />
Twins, inevitabile la proposta di collaborare nel nuovo disco, ai cori in Twice e in<br />
Dark Sets In. Il tutto è stato molto naturale, la sua grande voce ha fatto il resto.<br />
Il tutto si è risolto in paio d’ore di lavoro, molto intense e brillanti.<br />
Il discorso scivola inevitabilmente su Mark Lanegan, qualcosa sembra accomunare<br />
alcune delle sue atmosfere devastate con la direzione amara e<br />
predestinata (verso il buio) di Keep You Close. Pawlowski sorride, hai colto<br />
nel segno, lo ammiriamo molto, sarebbe molto interessante una collaborazione<br />
con lui. Riferimenti musicali inevitabili, e tra le possibili collaborazioni<br />
immaginarie e non? Tra i morti, senz’altro, James Brown e Fela Kuti. Tra<br />
i vivi, amo moltissimo il primo Franco Battiato, periodo Fetus, con lui sì, mi<br />
piacerebbe collaborare. Penso immediatamente all’immagine di un Battiato<br />
timorato che canta Energia durante la trasmissione RAI. Tutto è Pop. Il pop<br />
diventa maschera come il pubblico di Battiato, perso poi tra le divagazioni<br />
di Meccanica. Il pop ci mangia, e poi, ci digerisce? Siamo etichettati continuamente,<br />
ne siamo costretti e assuefatti da questa cultura. Siamo parte di un<br />
sistema senza giovani, sì, siamo costretti ad essere pop. C’è chi etichetta tutto,<br />
ma c’è chi non ne vuole fare parte.<br />
La bellezza è etichettabile? Sicuramente no, ma Il futuro dei dEUS è stato<br />
scritto, l’aspetto kitsch degli anni zero è stato ridimensionato, incastrato solo<br />
nel perimetro live, alla bellezza il resto.<br />
30 31
—Sons And Fascination—<br />
Drop out<br />
the horrors<br />
Dai recessi catacombali di Strange<br />
House ai voli pindarici di Skying:<br />
facciamo il punto di un'ascesa musicale,<br />
emotiva e artistica.<br />
Testo: Diego Ballani<br />
32 33
Nei primi mesi del 2007 la metro di Londra è tapezzata di manifesti di<br />
questi ossuti ventenni carichi di occhiaie. Gli Horrors sono il gruppo del<br />
momento, quello che tutti vogliono vedere dal vivo e che nella capitale<br />
britannica riempie le pagine delle free press.<br />
L’entusiasmo dei molti va di pari passo allo scetticismo dei più. Non bisogna<br />
essere troppo smaliziati per capire che band così pesantemente connotate<br />
a livello di suono e immagine, si bruciano velocemente, facili prede di hype<br />
vampirici, di quelli che ti succhiano prospettive e forze e ti lasciano senza<br />
coscienza sul pavimento di una scena musicale cinica e iperscrutabile.<br />
Solo qualche mese prima un amico me ne parla in termini entusiastici<br />
in occasione della prima calata italiana: “Devi vederli, sembrano i Morlocks<br />
intenti ad eseguire il repertorio dei Jesus And Mary Chain”. Aggiunge che le<br />
ragazze che facevano la fila di fronte al camerino della band non erano esattamente<br />
(per quantità e qualità) quelle che alle nostre latitudini accolgono<br />
i negletti gruppi revivalisti.<br />
In effetti la pesante ombra del glamour li pedinava dalla loro formazione,<br />
avvenuta non molto tempo prima. Spider Webb (al secolo Rhys Webb)<br />
gestisce lo Junk Club di Southend e nonostante la giovane età, è un’autentica<br />
eminenza in campo 60s garage e freakbeat; oltre ad essere un fanatico<br />
collezionista di rarissimi 7’’, organizza serate a tema che diventano in breve<br />
uno degli appuntamenti più cool in città. E’ qui che inizia a fare comunella<br />
con quattro abituali frequentatori. “Joshua (Hayward, chitarrista) ed io lavoravamo<br />
da un macellaio - ricorda il cantante Faris Badwan - Joe (Spurgeon,<br />
batterista) e Tom (Cowan, bassista) lavoravano invece in un mattatoio.” Ecco<br />
in parte spiegata la natura efferata del progetto.<br />
Ad appena due settimane dalla nascita gli Horrors tengono il loro primo<br />
concerto. “Abbiamo eseguito cinque pezzi. Sapevamo a malapena suonare gli<br />
strumenti”. Due di quei cinque pezzi sono The Witch dei Sonics e Jack The<br />
Ripper di Lord Screaming Sutch, ma a colpire nel segno non è tanto la<br />
musica, quanto la compattezza di immagine per cui optano, qualcosa che li<br />
distingua immediatamente all’interno della congestionata scena britannica,<br />
una specie di versione gotica e vittoriana dei Music Machine. Le premesse<br />
per l’hype ci sono tutte. Ed è a questo punto che arriva anche la musica.<br />
Gli Horrors iniziano ad infilare una sequenza mozzafiato di singoli dal suono<br />
rovinoso: il fuzz arrugginito, le stilettate di Vox e i feedback a profusione<br />
generano un magma sonoro su cui Badwan urla come un orco delle fiabe<br />
sull’orlo di una crisi isterica. Per il primo Sheena Is A Parasite (centocinquanta<br />
secondi di chitarra che stride come le unghie di Freddy Krueger sul ferro)<br />
viene anche girato un video, affidato al regista Chris Cunningham, in cui il<br />
premio Oscar Samantha Morton è posseduta da fremiti soprannaturali che<br />
la scuotono al ritmo osceno del brano. Roba da brividi.<br />
Nei primi mesi del 2007 tutto sembra pronto per accogliere l’esordio della<br />
band più chiaccherata dal tempo degli Oasis. Possono le fantasie sinistre<br />
di un gruppo di giovani perpetuarsi per la durata di un intero LP? Strange<br />
House vince la scommessa anche se di misura. Come a voler chiarire da<br />
subito i propri intenti, i cinque aprono l’album proprio con Jack The Ripper<br />
e lo infarciscono di un garage rock da cavernicoli, gravido di atmosfere cimiteriali<br />
trascinatesi a noi dai recessi più oscuri dei 60s. Una carcassa sonora<br />
intrisa di incrostazioni wave, capaci di sedurre con le atmosfere decadenti<br />
dei Bauhaus e quelle dolenti dei Birthday Party.<br />
Lo scarto da tanti act revivalisti è affidato ad una produzione moderna,<br />
frutto del lavoro di ben cinque produttori (fra cui spiccano i nomi di Alan<br />
Moulder, Jim Sclavonous e Rick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs) e di un uso<br />
dello studio che fa tesoro della passione della band per la musica dance<br />
(“Nella nostra collezione troverai parecchia roba acid house e drum and bass”<br />
affermava in quei giorni Cowan). Non manca neanche l’eco del recente New<br />
Rave, grazie ad un organo Acetone usato come una vera e propria arma<br />
contundente.<br />
A rafreddare gli entusiasmi è una certa uniformità di fondo e la sensazione<br />
che quello degli Horrors sia un progetto studiato a tavolino. Sono loro<br />
stessi ad accorgersene con un filo di amarezza: “Pensiamo che la gente non<br />
riesca a credere che una band vestita così possa interessare qualcosa della musica”.<br />
Ecco allora che la trasformazione ha inizio.<br />
A marzo del 2009 sul sito degli Horrors fa la comparsa un video di austera<br />
bellezza diretto dall’ex Jesus And Mary Chain Douglas Heart. Sea Within A<br />
Sea mostra la band trasfigurata in un contesto da happening psichdedelico:<br />
è il nuovo inizio e al tempo stesso il superamento del discorso fin qui intrapreso<br />
dal quintetto britannico. Divisa rigidamente in tre sezioni (intro<br />
metronomico alla NEU!, parte centrale wave-gaze e coda electro pop), la<br />
canzone è un manifesto programmatico della durata di quasi dieci minuti<br />
che non ha ancora trovato eguali all’interno della discografia horrorifica.<br />
Dentro c’è tutta la smania art pop dei nuovi Horrors.<br />
Primary Colours, irrompe qualche mese più tardi con le sue folate chitarristiche<br />
che si innalzano come dense spirali di fumo, le tastiere boreali che<br />
saturano i colori e sfocano ritmiche e melodie. Si tratta del più entusiasmante<br />
mix fra post punk, psichedlia e kraut rock sia ascoltato da tempo, un suono<br />
emozionante e cerebrale che pretende di essere ascoltato e assimilato. Ci<br />
sono ancora sporadici assalti dal grottesco piglio horror (in particolare su<br />
New Ice Age) ma sembrano solo echi del recente passato. Il centro nell’album<br />
34 35
sta nei graffi e nelle carezze di Who Can I Say, con le sui refoli sintetici alla<br />
Joy Division e le dolorose abrasioni del fuzz; nel technicolour dream a 8mm<br />
di Mirror’s Image, con i suoi loop electro stranianti, che perdono consistenza<br />
fino a sciogliersi in una densa mescola shoegaze.<br />
Per la prima volta si percepisce che la creatura Horrors è un mostro bicefalo.<br />
Da una parte c’è il saldo appiglio al lato gotico del progetto garantito<br />
da Badwan e dal suo oscuro songwriting, dall’altra c’è lo spirito più eclettico<br />
di Cowan e Webb (che nel 2009 pubblicano l’ep Something Clockwork<br />
This Way Comes con il moniker Spider And The Flies, segnato dal<br />
comune amore per il compositore Joe Meek, per i Can e la new wave) decisivo<br />
nell’imprimere la svolta artsy al gruppo. In particolare, benchè ancora<br />
ancorata al canovaccio verse-chorus-verse, la formula degli Horrors sembra<br />
sempre più lagata alla ricerca di sonorità suggestive, dell’effetto straniante<br />
e dell’atmosfera disturbante. “Non siamo il tipo di band che si siede sul tour<br />
bus con la chitarra acustica e cerca di tirare fuori un pezzo. Abbiamo bisogno<br />
di stare in uno studio e sfruttarne tutte le potenzialità”.<br />
A produrre l’album questa volta è Geoff Barrow, di cui probabilmente non<br />
sapremo mai l’entità del contributo artistico, ma al quale è facile attribuire<br />
la paternità di un’effettistica cinematica presente anche negli ultimi Portishead.<br />
A chi chiede loro se sono preoccupati della reazione dei fan della<br />
prima ora, i cinque rispondono seccamente: “non siamo interessati ad avere<br />
fan spaventati di un simile cambiamento”.<br />
La svolta, peraltro, è evidente anche dal vivo, non solo per il look che<br />
rinuncia agli eccessi goth degli esordi, prediligendo un nero sobrio da Manchester<br />
primi 80: il set si basa sulle nuove canzoni (i brani di Strange House<br />
vengono stipati quasi interamente nei bis), ma fallisce il tentativo di riprodurre<br />
dal vivo il maestoso impianto sonoro di Primary Colours, quasi che<br />
gli Horrors debbano ancora portare a compimento la loro dimensione live.<br />
In particolare si percepisce la difficoltà della band nel reinventare il proprio<br />
show, rispetto agli infuocati esordi in cui i cinque davano libero sfogo al<br />
proprio estro teatrale ed eseguivano ogni brano al doppio della velocità,<br />
in pieno spirito garage punk. Badwan, dal canto suo, fa quello che può, ma<br />
non è ancora lo sciamano psichedelico che ci si aspetterebbe ascoltandolo<br />
sulle tracce dell’album.<br />
Nonostante questo, riguardano proprio lui le notizie che rompono il silenzio<br />
attorno alla band. L’esibizione in Vaticano dei Cat’s Eyes, il progetto<br />
parallelo di Faris e della soprano e polistrumentista canadese Rachel Zeffira,<br />
genera un’onda mediatica che si propaga fino a fare del duo un’entità<br />
autonoma di primissimo piano. Badwan si dimostra autore raffinato e interprete<br />
duttile: cita Morricone e Nino Rota e spinge di un passo in avanti la<br />
propria vocazione cinematica.<br />
Nell’omonimo esordio, pubblicato la scorsa primavera, i Cat’s Eyes rinverdiscono<br />
i fasti di storici duetti dei sixties come quello Hazelwood/Sinatra e<br />
Gainsbourg/Bardot grazie ad una serie di brani prepotentemente evocativi,<br />
capaci di spaziare dal pop soul all’exotica, mantenedo connotazioni maestose<br />
e tenebrose. Con gli Horrors ancora in studio a preparare il seguito di Primary<br />
Colours ci si interroga l’impatto che il nuovo progetto del singer possa avere<br />
sulla band originaria. “Posso solo dire che sono migliorato come musicista – confida<br />
Faris – e spero che questo si rifletta anche nella musica degli Horrors”.<br />
Still Life, il primo singolo estratto dal nuovo lavoro, spiazza ancora una<br />
volta, sebbene possa considerarsi come l’ovvia prosecuzione del lato sin-<br />
tetico di Primary Colours. Più che un upgrade si tratta di un aggiustamento di<br />
tiro rispetto al lavoro precedente. “Quello che abbiamo fatto è stato semplicemente<br />
rallentare i tempi, aggiungere ritmo, dare più respiro alla voce - afferma<br />
Cowan - Ci sono poi tutta una serie di idee astratte, non necessariamente collegate<br />
ad un suono, che tuttavia volevamo sperimentare. La cosa più importante<br />
è stato portare avanti quel feeling iniziato con Primary Colours, quel senso di<br />
esaltazione e positività”. Intanto sono due le parole che si inseguono come<br />
un tam tam attraverso tutte le recensioni: Simple Minds.<br />
In effetti il passo lento, la vocalità solenne di Badwan e lo sfarfallio di<br />
tastiere ricorda proprio quello della band di New Gold Dream. Sottotraccia<br />
però c’è di più, ed è l’uscita di Skying a confermarlo. E’ storia di questi giorni,<br />
ma vale la pena ricordarla: il lavoro che la band compie su timbri, sonorità è<br />
complesso e strutturato. I brani sono omaggi floreali all’art pop di tradizione<br />
europea. Nella densa stratificazione sonora dell’album si sovrappongono i<br />
bagliori della Sheffield dei primi 80s, l’austerità della Berlino dei tardi 70s e<br />
la leggerezza della Manchester dei primi 90s. I tappeti sintetici la fanno da<br />
padrone e creano eleganti strutture psichedeliche talvolta scardinate da un<br />
uso imprevedibile della chitarra. E’ un suono al tempo stesso, trascendente<br />
e straordinariamente immanente, che si prende i suoi spazi ma si muove<br />
sempre all’interno degli steccati del pop.<br />
Sarà interessante valutarne l’impatto live ora che la band ha deciso dare<br />
maggiore omogeneità ai propri set eseguendo esclusivamente i brani degli<br />
ultimi due album. Tuttavia Skying lascia la piacevole sensazione di rappresentare<br />
l’inizio di qualcosa, più che la sua compiuta realizzazione: la perpetua<br />
transizione di una band che nel tentativo, ancora mortificato, di trovare se<br />
stessa, lascia per strada perle destinate a segnare in maniera indelebile il<br />
pop di questo primo scorcio di millennio.<br />
36 37
etroMANIA<br />
Simon ReynoldS<br />
Drop out<br />
Lungo ragionamento a distanza<br />
con Simon Reynolds su un tema<br />
cruciale come la ‘fine della musica’,<br />
tra hauntology, r’n’b, dubstep,<br />
Terzo Mondo, mixed media &<br />
web, free impro, boom bap, emulrock...<br />
Testo: Gabriele Marino<br />
38 39
Per chi legge SA, Reynolds non ha certo bisogno di presentazioni. Ma un<br />
ripasso dei fondamentali ogni tanto sicuramente non guasta.<br />
Simon Reynolds (Londra, 1963) è nell’immaginario di chi consuma critica<br />
musicale «quello che ha inventato il termine post-rock». È considerato uno<br />
dei massimi critici contemporanei, influente anche in ambito accademico<br />
(popular music studies e dintorni), indicato dagli addetti ai lavori come perfetto<br />
esempio di integrazione tra puntiglio metodologico e capacità narrative.<br />
Tra i suoi lavori, in cui è spesso evidente uno sfondo teorico mutuato<br />
dalla teoria critica e dai cultural studies, vanno citati almeno i basici Energy<br />
Flash: A Journey Through Rave Music and Dance Culture (1998; ed. it. Generazione<br />
ballo/sballo, Arcana, 2000; rist. 2010 Energy Flash), in cui si è occupato<br />
delle sottoculture elettroniche emergenti in Inghilterra, dalla house al rave<br />
e oltre (è l’harcore continuum ragazzi), e Rip It Up and Start Again: Post Punk<br />
1978-1984 (2005; ed. it. Post-Punk, Isbn, 2006), monumentale ricostruzione<br />
storico-critica della new wave (qui invece la nostra recensione dell’antologico<br />
e auto-celebrativo follow up di Post Punk, Bring the Noise, in italiano Hip-Hop-<br />
Rock, che traccia i percorsi del meticciato musicale bianco+nero dagli anni<br />
Ottanta ai Duemila).<br />
Reynolds ha cominciato a scrivere di musica sulla fanzine autoprodotta<br />
Monitor (1984) ed è poi passato alla stampa regolare, prima su «Melody<br />
Maker» e, poi come freelance di lusso, su «Mojo», «Uncut», «The Wire», «Village<br />
Voice», «New York Times». Il suo ultimo libro è Retromania, un saggio<br />
sulla vera e propria “ossessione del passato che sembra permeare la cultura<br />
pop contemporanea”, uscito a giugno per Faber&Faber e di cui attendiamo<br />
l’edizione italiana per metà settembre. Il suo blog personale è http://blissout.<br />
blogspot.com/. Questo invece il blog italiano dedicato a Retromania, curato<br />
da Isbn: http://retromania-isbn.blogspot.com/.<br />
Fine della musica?– Abbiamo avuto il piacere di intervistare via Skype<br />
Michele Piumini. Ci ha parlato del suo lavoro di traduzione per i tuoi libri<br />
e ci ha dato molte gustose anticipazioni di Retromania, la cui versione<br />
italiana uscirà il 15 settembre come sempre per Isbn. Fin dal titolo e dai<br />
lanci sul web il libro ci ha subito interessato; molto semplicemente, perché<br />
il suo tema è la ‘fine della musica’ (e delle arti in generale). Nel senso<br />
pienamente post-moderno di fine della Storia, del progresso come freccia<br />
orientata verso il futuro, fine del nuovo. Michele ci ha fatto capire come<br />
il libro sia, da questo punto di vista, piuttosto pessimista. Ci rivolgiamo<br />
sempre più al passato della nostra memoria per trovare ispirazione e - soprattutto<br />
- prendere interi blocchi di materia musicale: abbiamo avuto il<br />
revival degli Ottanta, dei Novanta, abbiamo rivalutato il Kitsch, i b-movie<br />
e così via. In musica adesso c’è l’Hauntology, con il glo-fi, la chill-wave,<br />
l’hypnagogic pop, tutte forme di sublimazione della nostalgia di un certo<br />
passato musicale. Ecco, da un punto di vista strettamente pratico, la big<br />
question è: cosa succederà quando i nostri figli o i loro figli si troveranno<br />
di fronte come uno possibile revival un “revival del revival”?<br />
Come parte delle mie ricerche per Retromania ho letto The End of History<br />
di Francis Fukuyama; non il libro del 1992, proprio il saggio originale,<br />
scritto poco prima della caduta del Comunismo e che in un certo senso la<br />
anticipava. Quello che mi ha più sorpreso è stato scoprire quanto il saggio<br />
fosse ambivalente: non è assolutamente una trionfalistica celebrazione della<br />
vittoria del capitalismo liberale contro il socialismo. Il paragrafo conclusivo<br />
immagina secoli e secoli di noia gettare la loro ombra sul nostro futuro:<br />
un’era post-ideologica di compiaciuto consumismo. Fukuyama pensa che<br />
finiremo con il re-inventarci scismi ideologici giusto per rendere la nostra vita<br />
più interessante, usandoli come un defibrillatore per fare ripartire il cuore<br />
della Storia.<br />
L’equivalente musicale di questa idea di una infinita fine della storia è una<br />
delle cose su ho più meditato in Retromania, come quando scrivo che la pop<br />
music finirà “non con uno schianto [è una citazione da The Hollow Men di Eliot,<br />
ripresa da molti e ad esempio da Richard Kelly nel suo film-corto circuito<br />
pop Southland Tales; ndr] ma con un box set i cui quattro dischi che non<br />
avrai mai il tempo di infilare nel lettore”. Uno stato di entropia assolutamente<br />
piacevole, in cui possiamo usufruire di tutti i capolavori di cinque decadi di<br />
storia del rock, come pure di tantissimi tesori perduti e di estemporanee<br />
scoperte marginali provenienti dal passato, in cui possono nascere continuamente<br />
nuove band per offrire infinite sottili ricombinazioni che rimescolino<br />
le carte del catalogo di stili offerto dal passato. L’Ipod e Internet, con la loro<br />
sovrabbondanza di scelte, hanno aperto la strada ad una condizione postideologica<br />
del fandom musicale, in cui siamo tutti eclettici e galleggiamo<br />
tra i generi, avanti e indietro tra i decenni, senza mai prendere davvero una<br />
posizione, senza mai concentrarci davvero su un particolare genere, scena,<br />
epoca. La mia curiosità intorno alla musica mi conduce verso l’eclettismo,<br />
ma il mio carattere mi fa tendere verso l’ossessione. Puoi vedere in azione<br />
questa mia vera e propria lotta interiore lungo tutto Retromania: da una parte,<br />
mi sento profondamente attratto da quella che la giornalista di punk del<br />
NME Julie Burchill ha sprezzantemente descritto come “rock’s rich tapestry”<br />
(la ricca tappezzeria del rock); dall’altra, credo, come del resto la Burchill,<br />
che l’essenza del fandom musicale sia il fanatismo (è quello che significa<br />
40 41<br />
james ferraro
fan, fanatico). La musica insomma dovrebbe essere questo, dovrebbe essere<br />
una monomania, una devozione e un credo dedicati ed esclusivi. Per me,<br />
l’Ipod shuffle rappresenta una specie di incessante e promiscuo galleggiare,<br />
un andare alla deriva, senza scopo né passione.<br />
C’è qualcuno (di nuovo) lì fuori?– Riesci a trovare oggi qualche forma<br />
musicale davvero nuova? La dimensione del cambiamento musicale<br />
sembra avere cambiato scala, diventando sempre più piccola. Oggi, per<br />
esempio, siamo costretti ad esaltarci (se proprio vogliamo esaltarci per<br />
qualcosa) per un minuscolo mutamento stilistico all’interno della carriera<br />
di un produttore dubstep, sempre all’interno della sua estetica dubstep…<br />
È così difficile cambiare oggi? Sempre che cambiare faccia rima con rinnovarsi<br />
e rinnovare…<br />
Mi capita di incontrare cose che mi colpiscono e mi sembrano “nuove”,<br />
“relativamente nuove”, “abbastanza nuove” (di solito c’è sempre un qualche<br />
modificatore prima di nuovo). Ma tendono ad essere sporadiche e isolate,<br />
piuttosto che collegate a generi e a una occorrenza più generale. Negli anni<br />
Novanta c’erano interi generi o movimenti che avanzavano come massicce<br />
ondate di innovazione, e queste maree di novità si sono sostenute tra loro<br />
per anni, in alcuni casi per una intera decade. Il rave potrebbe essere un esempio,<br />
specialmente la linea che dall’hardcore arriva alla jungle, allo UK garage<br />
e al 2step, tutte fasi interne ad una stessa macro-scena/macro-genere.<br />
O l’r’n’b, che si è dimostrato sorprendente anno dopo anno, se segui la linea<br />
che da Teddy Riley passando per Timbaland arriva ai Neptunes. E si può<br />
dire che anche l’hip hop e la dance hall abbiano rappresentato una costante<br />
fonte di innovazione da metà degli Ottanta fino a tutti i primi Duemila. Con<br />
buona probabilità si può dire lo stesso del metal, anche se io non l’ho mai<br />
seguito da vicino, ma sicuramente anche agli occhi di un outsider è sembrato<br />
mutare sensibilmente per tutti gli Ottanta e Novanta.<br />
Nel decennio scorso, al contrario, è sembrato che i generi principali siano<br />
rimasti piuttosto statici, e che solo qualche volta, in mezzo a una grande<br />
quantità di lavori poco avventurosi, fosse possibile trovare dei lampi isolati<br />
di novità. Come ho detto, trovo che l’r’n’b dei Duemila non sia stato anche<br />
solo lontanamente innovativo come quello con cui Timbaland rivoluzionò<br />
l’intera scena. Eppure, in anni recenti, sono rimasto di stucco davanti a cose<br />
come Umbrella di Rihanna e Single Ladies di Beyonce, due pezzi che mi<br />
hanno davvero impressionato.<br />
Sul dubstep… Preso nell’insieme, mi sembra un’estensione degli anni<br />
Novanta, una sorta di coda della discendenza che dalla jungle ha portato<br />
verso lo UK garage. È un genere che produce ancora e con regolarità materiale<br />
eccitante, che si propone con un suo feel di novità: certi pezzi di Zomby,<br />
Cooly G, James Blake, Ramadanman e pochi altri. Penso che attualmente<br />
la frangia wobble della scena [wobble è l’etichetta onomatopeica che indica<br />
i bassi super-treble di certo dubstep; ndr], che gli ‘intenditori’ disprezzano<br />
perché conservatrice, rozza e machista, sia in realtà l’area che sa più di nuovo<br />
all’interno del dubstep. Il beat dell’halfstep e quelle bassline meccaniche e<br />
stridenti degli oscillatori sono genuinamente nuove. Semplicemente, sono<br />
davvero sgradevoli! Potrebbe anche piacerti un blast repentino di “filthstep”,<br />
prendendolo come una piacevole dose di abietto e ringhiante rumore, ma<br />
42<br />
per nessuna ragione al mondo mi andrebbe di passare un’intera serata ascoltando<br />
Borgore e Stenchman. In altri ambiti della musica elettronica,<br />
penso che produttori come Ricardo Villalobos e Actress stiano facendo<br />
cose davvero interessanti, per quanto, ancora, il loro lavoro suoni come<br />
un’estensione della minimal house e del glitch e di altre cose dei tardi anni<br />
Novanta.<br />
Una cosa che mi sembra invece piuttosto epoch-defining, identificativa<br />
e modellativa di questo momento musicale, sono le sperimentazioni con la<br />
voce, la vocal science: varie forme di testurizzazione digitale delle voce come<br />
l’Autotune, l’accelerazione o il rallentamento dei vocals, il micro-editing dei<br />
sample vocali e la creazione di nuovi pattern. Questo avviene in tutto il<br />
panorama musicale, dal livello ultra-underground del footwork di Chicago,<br />
fino all’elettronica hip spinta da Pitchfork e FactMagazine (Burial, James<br />
Blake), alla witch house dei Salem e al cuore del pop mainstream con Black<br />
Eyed Peas e Ke$ha. Le origini di questo fenomeno si possono fare risalire<br />
agli anni Novanta, a produttori garage come l’americano Todd Edwards e<br />
produttori jungle come l’Omni Trio, indietro fino a Nitro Deluxe, questo act<br />
electro/house newyorkese che faceva cose pazzesche con i sample vocali<br />
usati come note di una tastiera, anno 1987. Ma la vocal weirdness sembra<br />
essere ancora oggi un’area con grosse potenzialità.<br />
rihanna
Saturazione del linguaggio?– Questo impasse musicale generalizzato<br />
potrebbe essere anche un impasse propriamente linguistico? Se la musica<br />
è arrivata in qualche modo alla fine, non potrebbe essere perché<br />
non siamo più in grado di creare nuovi idiomi o anche solo sotto-idiomi<br />
musicali (per non parlare di veri e propri nuovi strumenti o modi di fare<br />
musica)? E come possiamo giudicare la storia ormai cinquantennale di<br />
tutto quel del filone chiamato free improvisation o improvvisazione non<br />
idiomatica (da Derek Bailey in avanti) che ha cercato proprio di uscire<br />
dalle gabbie dei generi e degli stili - un fallimento? Personalmente penso<br />
che sia stato un approccio produttivo fino a un certo periodo e che poi si<br />
sia in qualche modo standardizzato, automatizzato, allo stesso modo di<br />
come si automatizza la peggiore pop music su scala industriale. È il dark<br />
side di molta della cosiddetta avant-garde music…<br />
Non mi sono mai appassionato alla musica improvvisata. Trovo la sua<br />
filosofia abbastanza sospetta, per quanto mossa da buone intenzioni, perché<br />
non credo che tutta questa libertà assoluta e questa mancanza di limiti<br />
facciano davvero la felicità di qualcuno o possano portare a fare della buona<br />
musica, della buona arte. Disciplina e concentrazione sono la chiave della<br />
soddisfazione emozionale e psicologica, restrizioni e regole sono vitali per la<br />
creazione artistica. Basta fare un paragone tra i primi fantastici pezzi hip hop<br />
e rave, realizzati con un equipaggiamento veramente basico come l’MPC<br />
Akai o programmi come Cubase, e la musica elettronica dei Duemila, molto<br />
più complessamente strutturata e lavorata, per vedere come, quando hai<br />
meno possibilità, meno agevolazioni a tua disposizione, meno memoria nel<br />
campionatore, puoi raggiungere risultati molto più potenti. Tornando all’improvvisazione,<br />
in teoria è un approccio che dovrebbe aprire questo infinito<br />
mondo di possibilità sonore; ma nella pratica i performer tendono spesso a<br />
cadere in un vocabolario di pernacchie, cigolii, crepitii, sirene, ecc. alla fine<br />
piuttosto omogeneo e prevedibile. Sono d’accordo con Brian Eno quando<br />
brian eno<br />
dice che l’intera storia del free jazz e dell’improvvisazione non idiomatica<br />
fuori dal jazz si è dimostrata fuorviante. Personalmente, preferisco ascoltare<br />
la jazz fusion degli anni Settanta, anche le cose più pompose e massimaliste<br />
che sono venute fuori dall’approccio di Miles Davis.<br />
Lo stesso tipo di omogeneità affligge altri movimenti musicali che hanno<br />
cercato di andare al di là di ogni regola, verso uno spazio astratto. È successo<br />
alla musica concreta e all’elettronica del secondo dopoguerra. Io amo molto<br />
alcune di queste musiche, così tanto da riuscire ad apprezzarne anche tutti<br />
gli esponenti di terza categoria, ma è davvero sorprendente constatare<br />
quanto velocemente questa cosiddetta “musica infinita” abbia prodotto i<br />
suoi cliché e i suoi suoni standardizzati.<br />
Il Terzo Mondo come risorsa? – È possibile che le musiche provenienti<br />
da “altri posti” - ovviamente in un’ottica occidentale e occidentalizzata,<br />
e quindi India, Cina, Africa - possano costituire un’importante risorsa residua<br />
per fare “nuova musica”? I paesi cosiddetti emergenti offrono un<br />
ventaglio di musiche - specialmente “estreme”, metal, noise, elettronica<br />
- molto interessante, che sembra in qualche modo riflettere le condizioni<br />
di vita di quei luoghi (penso al rap superslang e heavy bassy giamaicano,<br />
al thrash metal indiano, ecc.). Abbiamo già avuto esperienza di questo<br />
fenomeno con artisti giapponesi, per esempio Merzbow o i Ruins di<br />
Tatsuya Yoshida…<br />
È certamente possibile che una prossima ondata di rinnovamento per la<br />
popular music venga dai paesi non occidentali nel loro complesso e cioè dai<br />
paesi in via di sviluppo o da potenze demografiche come Cina, India e Brazile.<br />
I loro sistemi economici super-dopati genereranno ogni sorta di tensioni<br />
sociali e spaccature culturali e questo potrebbe generare una forma musicale<br />
genuinamente del 21° secolo, che conquisti il mondo così come accaduto in<br />
passato con il jazz e il rock’n’roll. L’esplosione del pop/rock avvenne quando<br />
le forme folk incontrarono l’amplificazione elettrica e i mass media. Potrebbe<br />
accadere che il folk non occidentale si scontri con le tecnologie digitali e<br />
con Internet generando qualche nuovo inimmaginabile sound. Potrebbe<br />
essere qualcosa di fortemente integrato con la dimensione visuale, in un<br />
modo che non si è ancora visto nei video pop, nonostante la loro esistenza<br />
da diversi decenni. Una forma in cui il suono non venga “accompagnato”<br />
dalle immagini, ma sia completamente immerso, fuso con le immagini del<br />
visual e in cui le due cose vengano generate simultaneamente.<br />
Mixed media e il web?– Pensi che sia possibile uscire dalla stasi creativa<br />
attraverso una sperimentazione insistita sui mixed media? Se le arti (cinema,<br />
letteratura, grafica, musica) sembrano essere arrivate in qualche<br />
modo alla frutta, è possibile mettendole assieme creare qualcosa di<br />
più potente, magari di nuovo, sviluppando le intuizioni dei pionieri della<br />
electronic literature e dell’electronic video? Il futuro dell’arte è insomma<br />
nello sviluppo delle tecnologie elettroniche e di quelle web based?<br />
Vedi alla risposta precedente. A ben vedere, finora la gran parte delle<br />
tecnologie digitali e di Internet è stata orientata alla facilitazione, non hanno<br />
44 45
cioè creato interamente nuove attività possibili o nuove forme artistiche, ma<br />
hanno semplicemente reso grandemente più facili le cose che facevamo già<br />
nell’era analogica. Per esempio, l’iPod è uno strumento molto più capace e<br />
flessibile del walkman; il filesharing è la drammatica espansione del circuito<br />
di tape-trading che esisteva già negli anni Ottanta; i blog sono fanzine che<br />
puoi pubblicare molto più frequentemente di quanto era possibile fare ai<br />
tempi della carta e dell’inchiostro e che puoi distribuire in tutto il mondo e<br />
a costo zero. Anche Youtube è paragonabile al mercato che i fan di un particolare<br />
artista mettevano in piedi per scambiarsi le copie dei video con le<br />
sue apparizioni televisive in giro per il mondo. Per quanto riguarda il musicmaking<br />
e il dj-ing, le tecnologie digitali per lo più eliminano tutta la parte<br />
legata alla fatica e all’abilità tecnica, che erano necessariamente richieste nei<br />
contesti analogici: tagliare e montare nastri è stato sostituito dai software di<br />
editing e molte delle operazioni di deejaying più complesse e difficili adesso<br />
possono essere fatte in automatico dai programmi.<br />
Quello che vale davvero la pena di osservare sono le cose che prima<br />
erano inconcepibili e che adesso il digitale rende possibili. Il fatto di rendere<br />
tutto mostruosamente più semplice ed economico non è necessariamente<br />
un bene per la musica, perché porta ad un flusso di sovrapproduzione. Il<br />
fatto che oggi siano richieste molte meno capacità per creare musica apre i<br />
giochi a un sacco di persone che un tempo sarebbero state scoraggiate dalle<br />
difficoltà tecniche di base o dalle abilità richieste che non possedevano o<br />
dal tempo e dai soldi necessari da investire. E scoraggiare molte persone dal<br />
fare un disco sarebbe effettivamente una cosa utile.<br />
Boom bap vs. Hardcore continuum? – Nel 2009, 2tall (Jim Coles) e Kper<br />
(Laurent Fintoni) hanno pubblicato un mega-mixtape chiamato A Boom<br />
Bap Continuum (http://www.aboombapcontinuum.com), con il quale<br />
intendevano sintetizzare 10 anni, 1999-2009, di estetiche hip hop, una<br />
“evoluzione in continuità”, da Lootpack, Company Flow, Sound Providers,<br />
Busta Rhymes, passando per la rivoluzione di J Dilla (e Dabrye, Prefuse73,<br />
Madlib), fino a produttori come Paul White, Dam-Funk, Hudson Mohawke,<br />
Nosaj Thing, Harmonic 313 e pezzi come Wind It Up di Pritchard e Om’Mas<br />
Keith dei Sa-Ra, includendo anche artisti chiave del dubstep/grime come<br />
Kevin Martin (The Bug, King Midas Sound), Joker e Loeafah. L’idea è<br />
che l’hip hop si sia evoluto da una forma dominata dalla figura dell’MC<br />
e incentrata quindi sul rapping a una forma strumentale con al centro la<br />
figura del producer, ma mantenendo sempre e comunque il focus sulle<br />
sue radici funk, al di là di tutte le etichette di genere che sono state coniate<br />
nel tempo come glitch, wonky, abstract ecc. Fin dal titolo, la compilation<br />
sembra polemizzare con il tuo hardcore continuum, suggerendo che<br />
tu non abbia sottolineato a dovere l’influenza dell’hip hop nell’elettronica<br />
popular inglese e affermando che l’hip hop, oltre le manifestazioni più<br />
appariscenti, oltre il mainstream dei rapper milionari che dominano le<br />
charts, sia ancora una forma vitale e produttiva. Che ne pensi?<br />
È una prospettiva interessante oltre che un buon mix. Ci sono tantissime<br />
altre narrazioni musicali all’interno della musica beat-based che possono<br />
co-esistere con l’hardcore continuum. Non sono in competizione tra loro.<br />
C’è il continuum della trance, quello del gabber/Euro-hardcore, quello della<br />
house e così via. E si intersecano in alcuni punti particolari: per esempio,<br />
l’hardcore belga dei primi anni Novanta si interseca con entrambi i continuum<br />
hardcore/jungle e gabber. Ma è possibile riconoscere e seguire una<br />
linea unica lungo tutta questa intricata proliferazione di suoni.<br />
Non penso che il trip hop sia parte dell’hardcore continuum, ci sono<br />
punti dove si intersecano, in figure come Roni Size, forse. Ma molto trip<br />
hop è stato comunque grandioso - particolarmente Tricky e i Massive Attack<br />
- e la sua collocazione più giusta è proprio nel boom bap continuum.<br />
Le forme strumentali di trip hop, come quelle di Dj Vadim o della Ninjatune,<br />
appartengono a questa linea evolutiva. Il boom bap è un tipo particolare<br />
di hip hop che punta più sul movimento della testa che sul ballo vero e<br />
proprio, e questo calza a pennello al trip hop, che è sempre stato un genere<br />
incentrato su un groove lento e che richiedeva una predisposizione stoned,<br />
immersiva e contemplativa alla musica.<br />
L’idea che io non abbia mai sottolineato l’influenza dell’hip hop<br />
nell’elettronica inglese è però sbagliata. Sono stato anzi il primo giornalista<br />
a mettere in evidenza la sterzata breakbeat nella rave music, dicendo che<br />
si trattava della cosa più avventurosa e fruttuosa che stava accadendo alla<br />
dance inglese e che avrebbe portato a esiti molto più validi della progressive<br />
house e della trance che all’epoca stavano ricevevano anche troppa attenzione<br />
e consenso critico. L’hardcore breakbeat e la jungle sono stati proprio<br />
una conseguenza dello scontro tra hip hop, house music e reggae. Ma, guardando<br />
all’essenziale, l’hardcore è stato soprattutto una questione di fast rap.<br />
I Public Enemy sono stati un’enorme influenza per tutti i b-boy inglesi che<br />
si stavano sintonizzando sulla acid house diventando dei raver. Agli Shut<br />
Up and Dance, pionieri dell’hardcore, piaceva definirisi “fast rap group”. E i<br />
Public Enemy non hanno mai fatto boom bap, erano più che altro una raffica<br />
46 47<br />
tricky
di rumore high-energy e questa atmosfera apocalittica e rivoltosa. Un approccio<br />
al suono molto punk, un ruggito a medie-frequenze. L’hardcore rave<br />
accolse proprio questo aspetto del rap di fine anni Ottanta: vedi le cose più<br />
uptempo, riff-oriented e sonicamente stridule come It Takes Two di Rob Base<br />
e Dj EZ Rock, le produzioni di Marley Marl, le prime cose della Def Jam. Penso<br />
che quando l’hip hop si è ammorbidito ed è diventato conscious, dal 1989 in<br />
avanti, e ha preso questa direzione del sample ricercato (del crate-digging)<br />
e del boom bap strumentale, molti b-boy inglesi non abbiano apprezzato<br />
questo cambiamento. Era gente che aveva ascoltato l’acid house, che era<br />
una roba maledettamente futuristica, e il cui metabolismo era su di giri a<br />
causa l’ecstasy; così presero i beat che apprezzavano di più dell’hip hop - i<br />
break beat, i sub-bassi, i sample stridenti, lo scratching, il rapping che agitava<br />
le folle di MC lanciatissimi come Flava Flav - e cominciarono a combinarli<br />
con la house. In America la “hip house” - i Jungle Brothers che rappano sopra<br />
pezzi di Todd Terry - fu una moda passeggera, mentre in Inghilterra presero<br />
la cosa molto sul serio. Terry, la cui versione newyorkese della house era<br />
inzuppata di attitudine hip hop, molto più sampledelica della house classica<br />
di Chicago, era considerato un dio all’interno della scena rave UK.<br />
La mia idea generale sulla questione è che non esista soltanto il boom bap<br />
nella storia dell’hip hop. Ci sono molti altri percorsi all’interno dell’hip hop<br />
e dello stesso rap. La linea che unisce l’electro anni Ottanta e gli stili Dirty<br />
South come il bounce e il crunk, per esempio. In ogni caso, le mie due fasi<br />
preferite del rap sono quella della seconda metà degli anni Ottanta (Def Jam,<br />
Marley Marl, Salt N’Pepa, Erik B & Rakim, Public Enemy, ecc.) e gli ultimi anni<br />
Novanta/primissimi Duemila (quello che chiamo street rap: Cash Money,<br />
Ludacris, Ruff Ryders and DMX, Lil Jon, ecc.). Mi piacciono anche alcune cose<br />
del filone conscious, groove-oriented e boom bap (J Dilla è uno dei miei<br />
favourites), ma in definitiva, il mio rap preferito è quello chiassoso, aggressivo,<br />
aspro, spesso futuristico, non propriamente groovy. [22 giugno 2011]<br />
public enemy<br />
la Tavolozza onnisCienTe<br />
QUesTioni CenTrali, marginali e aCCessorie<br />
aspeTTando ‘reTromania’<br />
di Stefano Solventi<br />
Da queste parti attendiamo ogni nuovo libro di Simon Reynolds come<br />
un piccolo grande turning-point. Il giornalista e scrittore londinese è uno<br />
dei pochi in grado di storicizzare il passato prossimo connotandone in alta<br />
definizione le isobare stilistiche e le forze vettoriali, dettagliandole con gustosa<br />
maniacalità. Con la fragranza schietta e forbita d’una visione che è assieme<br />
dall’alto e dal basso, lo sguardo espanso del satellite e quello orizzontale di<br />
chi annusa il vento e la qualità delle nuvole. Stavolta, per quanto mi riguarda,<br />
l’attesa è anche maggiore. Stando infatti alle anticipazioni, ampiamente confermate<br />
dalla nostra intervista, Retromania tratterà argomenti che su questa<br />
webzine abbiamo spesso avuto modo di affrontare. E abbiamo fondati motivi<br />
per ritenere che lo farà con una lucidità che a noi - ahinoi - è mancata (ci consoliamo<br />
con la soddisfazione di averci provato). All’inizio fu con un articolo<br />
- correva l’anno 2004 - su quello che ci piacque definire emul-rock, ispirato<br />
allo sciame di band di smaccata ispirazione new wave (nei suoi vari aspetti,<br />
compresi prodromi e succedanei) che ebbe il merito di riaccendere gli entusiasmi<br />
delle allibite generazioni post-undicisettembre. Quell’effervescenza<br />
stradaiola, scafata, sia pure sbruffoncella (come spesso il rock ama essere), ci<br />
sembrava significare anche qualcos’altro: ci sembrava indicare una modalità<br />
espressiva inedita, una nuova mappa di riferimenti stilistici, emotivi, culturali.<br />
Un’atomizzazione estetica che oltrepassava d’amblé le tradizionali specificità<br />
culturali, geografiche e generazionali. Perché i nuovi soggetti rock quelle barriere,<br />
semplicemente, sembravano ignorarle. Cosa era accaduto?<br />
Azzardiamo una risposta: si stava affacciando alla ribalta la generazione<br />
delle band di “nativi digitali”, per i quali tutta la storia del rock - anche quella<br />
meno accessibile, più “esoterica” - era una enorme tavolozza disponibile e<br />
simultanea. Esperienza e conoscenza, frutto di annosa dedizione e ricerca,<br />
smettevano di essere patrimonio esclusivo e denotativo di appassionati<br />
all’ultimo stadio per divenire un gesto di pura e semplice condivisione (via<br />
web, naturalmente). L’ultimo degli sbarbatelli poteva permettersi di godersi<br />
i gioielli scabri della scena proto-punk californiana e discettarne pure, alla<br />
stessa stregua del ribaldo cinquantenne incanutito. E magari poteva persino<br />
saperne di più, averne un quadro prospetticamente più strutturato. Tutto<br />
ciò valeva - ormai da qualche anno - per i semplici appassionati. Ma chi più<br />
appassionato di un (sia pure aspirante) musicista rock? Naturale perciò che<br />
questo nuovo stato delle cose riverberasse nelle nuove proposte musicali.<br />
Pensateci: il ventaglio di possibilità stilistiche dal quale pescare la propria<br />
calligrafia musicale - sul quale strutturare il proprio background - si presentava<br />
d’un tratto pressoché sterminato. E sommamente slegato da qualsivoglia<br />
istanza - diciamo così - momentanea e territoriale. Una sorta di onniscienza<br />
iper-globalizzata. Detto altrimenti, in ogni luogo ed in qualsiasi condizione<br />
socio-politica poteva verificarsi una qualsiasi fenomenologia musicale frutto<br />
di qualsivoglia incrocio di modelli e reminiscenze. Rendendo di fatto possibile<br />
lo sbocciare di innumerevoli revival contigui, consecutivi, sovrapposti,<br />
contemporanei. Uno stato di revival permanente.<br />
Presto fu chiaro che la riarticolazione dei tanti, tantissimi “passati” del rock<br />
diventava un intercalare sempre più diffuso, e non certo tra i soli debuttanti.<br />
48 49
sufjan stevens<br />
Anzi: anche nei musicisti di più lungo corso covava un fanciullino-emulatore<br />
che presto iniziò ad affiorare in superficie. Naturale, a pensarci bene:<br />
chiunque perseguisse un rinnovamento della propria cifra espressiva non<br />
poteva che abbeverarsi alla grande fonte del sapere condiviso. Poi, o forse<br />
innanzitutto, c’era da tenere in grande considerazione un aspetto legato alla<br />
percezione della cosa. Come già sottolineato, per i semplici appassionati era<br />
mutato drasticamente il contesto, i presupposti, lo scenario insomma nel<br />
quale si consumava l’adorato gesto dell’ascolto. In ragione di ciò persino<br />
l’artista più “analogico”, quello che si ostinava a farsi largo nella mata escura<br />
del passato a colpi di vinili, poteva egualmente venire percepito come il<br />
prodotto di una riarticolazione di codici appartenenti al grande calderone<br />
del web. Insomma, non c’era scampo: volenti o nolenti eravamo precipitati<br />
in un’era di inevitabile post-modernità sonora. Tanto valeva farsene una<br />
ragione. E godere dei buoni, anche buonissimi frutti - chessò, un Sufjan<br />
Stevens, gli Oneida, i cari Arcade Fire... - che non mancavano di sbocciare.<br />
Come è sempre stato e come sempre sarà.<br />
oneida<br />
C’era però un corollario che iniziava a farsi luce: non aveva più senso<br />
andare in cerca di “scene” musicali. O almeno, non come accadeva fino a<br />
pochi anni prima (a ben vedere, i Novanta sono stati il decennio delle grandi<br />
scene, nonché l’ultimo). In ogni cameretta del globo tecnologicizzato può<br />
decidersi il prossimo fenomeno musicale, la prossima combinazione intrigante,<br />
l’intruglio sonoro che monopolizzerà i social network per il prossimo<br />
warholiano quarto d’ora di celebrità. Ogni musicista è un soggetto autonomo.<br />
Ogni cervello - ogni sensibilità - è uno dei tantissimi punti nodali della<br />
rete in grado di incrociare, organizzare, plasmare i dati, essendo in possesso<br />
cioè dei mezzi per smentire ogni premessa stilistica corrente e determinare<br />
una combinazione interessante. Quindi - ed è un quindi grosso come un<br />
transatlantico - più nessuna scena è possibile. Proprio perché tutte lo sono. In<br />
attesa di una nuova dimensione sonora che a dire il vero appare del tutto improbabile<br />
- un’invenzione che prescinda le modalità del passato definendo<br />
un percorso inedito, che ci obblighi a scozzare i riferimenti assodati in oltre<br />
mezzo secolo di pop-rock - possiamo ipotizzare che una scena connotata<br />
come la Seattle del grunge o la Bristol del Trip-hop non sarà più possibile.<br />
Casomai si verificasse, avverrà alla stregua di una coincidenza estemporanea,<br />
la cui fenomenologia sarà pesantemente determinata da una distorsione/<br />
forzatura giornalistica (che era comunque tipica anche delle scene tradizionali:<br />
è la stampa, bellezza).<br />
Queste solo alcune delle questioni che ci piace apparecchiare sul tavolo<br />
in attesa di leggere Retromania, volume che potrebbe fornirci se non le<br />
risposte del caso quanto meno nuove e insospettabili chiavi di lettura. Già<br />
che ci siamo, tanto per condire ulteriormente l’attesa, ne approfittiamo per<br />
spendere una obiezione preventiva. Prendiamola larga: dal momento che<br />
hai l’opportunità reale di accedere ad una quantità formidabile di musica<br />
- tendente, in ordine alle umane possibilità, all’infinito - di qualsivoglia origine,<br />
stile e collocazione temporale, scegliere cosa ascoltare diviene un atto<br />
sommamente significativo. Scegliere consapevolmente di dedicare i prossimi<br />
trenta minuti all’ascolto di una playlist, una scaletta, un programma, al<br />
limite pure un disco, è prima di ogni altra cosa un gesto di auto-limitazione.<br />
E perciò di individuazione. Come dice il vecchio adagio: sei ciò che ascolti.<br />
Ok, forse non diceva così, ma non è mai stato tanto vero come adesso.<br />
Certo, bisogna porre attenzione però alla parola da un milione di dollari:<br />
“consapevolmente”. Ebbene, chi o cosa governa questa consapevolezza? E<br />
quanta ce n’è in ciò che Reynolds chiama col consueto acume, connotandolo<br />
negativamente, “fandom”? Tale pratica non potrebbe rappresentare una<br />
nuova modalità di individuazione, un processo blandamente determinato,<br />
un peregrinare per approssimazione e impulsi, ok, ma non per questo meno<br />
nutritivo e niente affatto privo di discernimento, convinzioni, ragione? In ultima<br />
analisi, a fronte di una situazione drasticamente mutata, non potrebbe<br />
trattarsi di una modalità nuova frutto dell’ennesimo, inevitabile, naturale<br />
adattamento evolutivo? Insomma, non ci starà mica diventando un apocalittico,<br />
il buon Reynolds?<br />
Ok, mi sembra più che abbastanza. Ne riparleremo fra poche settimane.<br />
In epoca post-Retromania.<br />
50 51
helAdo<br />
Negro<br />
—Canta, o gufo del post-glo—<br />
Drop out<br />
Roberto Lange rivisita il glo con<br />
elementi sudamericani. Fra mille<br />
progetti e collaborazioni lo abbiamo<br />
intervistato ripercorrendo<br />
la sua carriera gustando un gelato<br />
nero..<br />
Testo: Marco Braggion<br />
52 53
Canta Lechuza è il nuovo disco di Roberto Carlos Lange, un ragazzo che<br />
tra gli svariati alias si fa chiamare Helado Negro e suona come se avesse<br />
passato la giornata a mangiare calippi di glo-fi e granatine di bossa nova in<br />
una spiaggia affollata del Sud America.<br />
Il missato suona fresco, lontano dalle candeggine pop del 2009 che oggi<br />
sarebbero improponibili. Dietro ci senti lo stile e l’esperienza di chi ha lavorato<br />
sodo per portare a casa un risultato personale, lontano dall’hypsteria e<br />
dalle mode. E’ il motivo principale per cui lo abbiamo contattato telefonicamente<br />
nella sua casa di Brooklyn in un pomeriggio caldissimo, con in<br />
testa le note di un cangiante mondo sonico capace di spaziare tra hip-hop,<br />
avanguardie varie, installazioni, ambient e art-pop.<br />
rooTs<br />
Roberto è subito accomodante e chiacchierone al telefono, quasi come se<br />
fosse lì con te a sorseggiare una limonata con zucchero e Martini bianco. Ci<br />
racconta di essere nato da genitori equadoregni che amavano la musica ma<br />
di essere cresciuto in Florida, a Miami. La musica che lo ha accompagnato<br />
lungo tutta l’infanzia è quella del suo Paese d’origine. Ce l’ho nel sangue, fa<br />
parte delle mie radici, afferma subito, aggiungendo che il padre faceva molto<br />
spesso delle feste a casa e invitava diversi musicisti a suonare cover o canzoni<br />
folk. I suoi genitori non erano musicisti, ma la musica equadoregna era parte<br />
della famiglia. Quando diventa adolescente, inizia però a rifiutare le radici.<br />
I Lange stanno a Miami, mica in Sud America, e nella città gira un sacco di<br />
musica elettronica, si iniziavano a sentire pezzi con le drum machines, sintetizzatori<br />
e campionatori. Quella roba, ci racconta, la passavano pure alla radio.<br />
E’ stata una grossa influenza.<br />
I primi passi Lange li muove in un misto di folk, anni Ottanta e macchine<br />
cheap, influenze che vengono riprese e traslate nei primi dischi a nome<br />
Boom & Birds (l’EP Confetti del 2004 e il full Camino de manos chuecas del<br />
2005): suoni hip-hop tagliati con l’elettronica intimista quasi viennese di<br />
Kruder & Dorfmeister (che avevano iniziato a sfondare con l’idea del downtempo<br />
di qualità bossato quasi un decennio prima). Il tutto abbastanza derivativo,<br />
ma comunque godibile. Un sound che nell’EP si collega anche alle<br />
atmosfere dei Tortoise (Sometimes Too Lucky) e nel full trova coerenza e<br />
compatta le idee di una stagione abbozzata, spunti e lampi di inizio millennio<br />
che scaldano le mani del ragazzo, derivati in gran parte dalle giustapposizioni<br />
di un altro mago dell’homemade electro: Luke Vibert.<br />
Bbreaking e tagli elettrici sono il pane quotidiano di una carriera<br />
all’insegna dei continui traslochi: Crescere in Florida ha influenzato le mie<br />
produzioni, ammette, ma è ad Atlanta dove ho imparato i fondamenti del soul<br />
e dell’r’n’b. Lì c’è un background black immenso e la comunità musicale nera<br />
è molto solida. Ho iniziato a collezionare dischi,campionarli, approfondito le<br />
mie conoscenze musicali sulla musica americana in genere dal blues al jazz.<br />
Roberto è orgoglioso di aver frequentato il Sud degli States e aggiunge<br />
una riflessione: molte volte a New York o Chicago si dice ci siano queste scene,<br />
ma i musicisti che le fanno provengono principalmente del Sud. Sun Ra era<br />
dell’Alabama, John Coltrane del North Carolina.<br />
epsTein<br />
A cavallo del nuovo millennio il ragazzo aveva già iniziato a pubblicare demo<br />
e tracce a nome Epstein. Il disco che raccoglie le prime registrazioni della sua<br />
54 55
mutazione (composte quando viveva a Savannah in Georgia) esce nel 2004<br />
per Botanica Del Jibaro e poi viene ristampato su Asthmatic Kitty (etichetta<br />
che pubblicherà da lì in poi tutti i suoi lavori): Puñal. Qui riprende le lezioni<br />
dei turntablisti à la DJ Vadim o DJ Shadow (Playa, Mar, Cerdo, Juego sembra<br />
venir fuori direttamente da ...Endtroducing), ma non si impunta su un tecnicismo<br />
da nerd, anzi, viaggia su coordinate che collegano mondi street, world,<br />
electro, funk e jazz in un sentimento che richiama l’estetica Ninja Tune più<br />
aperta che mai a visioni alternative all’ortodossia dei b-boys, comprendendo<br />
nelle sue corde l’intimismo del post-rock vanpeltiano (Te Conozco Sin Pelo) e<br />
il blues stralunato di Beck. La materia sonora di Epstein è comunque figlia di<br />
una cultura sampledelica che in quegli anni vivacchia su allori ormai rinsecchiti<br />
e inizia velocemente ad eclissarsi, a causa delle spinte innovative che<br />
arrivano dal mondo underground UK, quali grime e dubstep. Anche da qui<br />
si capisce come il ragazzo sia caparbio e vada dritto per la sua strada, senza<br />
affidarsi a troppi talent scout o scenesters.<br />
Il percorso temporale delle uscite di Epstein è singolare, dato che il successivo<br />
disco (Gente Sin Pueblo del 2004) riflette in un flashback ulteriore le<br />
registrazioni di quando il ragazzo abitava a Miami (2003) e ad Atlanta (2004).<br />
Nel sito ufficiale Roberto afferma che questa musica è per muoversi e per<br />
non vedere confini. Un percorso che con il passare del tempo si avvicina alle<br />
origini e che anche oggi con il moniker di Helado Negro tenta di guardare<br />
sempre al passato.<br />
Gente Sin Pueblo è una raccolta di idee che trova nel bbreaking e nella<br />
sampledelia le sue coordinate principali: DJ Food (El Cuco) e Funki Porcini<br />
(Sin Pueblo) numi tutelari della mente creativa di Roberto. La parabola del<br />
progetto Epstein non è ancora conclusa. In seguito ai due album citati, usciranno<br />
successivamente un progetto a nome Epstein Y El Conjunto (Canto<br />
De Hermanos, su Arepaz, 2007), Otros nel 2008 (registrato tra Atlanta e New<br />
York, sempre su Arepaz), When Man Is Full He Falls Asleep e Sealess Sea (entrambi<br />
su Asthmatic Kitty nel 2009 e 2011), quest’ultimo purtroppo passato<br />
in sordina qui da noi, ma notevole nella capacità di coniugare le produzioni<br />
di Panda Bear/Animal Collective con un suono organico di bbreaks dal<br />
sapore old-school misto ambient-noughties.<br />
Tanto per non annoiarsi, il ragazzo inizia contemporaneamente una collaborazione<br />
con il chitarrista/bassista Matt Crum a nome ROM. Nel 2000<br />
partono come un gruppo di improvvisazione free influenzata dal post-rock<br />
che ben presto diventa un modo per scambiare idee soniche tagliate con<br />
l’accetta dello studio. In nove anni escono un 7” (Crawl Upside Down), un 12”<br />
(Into the Clouds) e due album (Self-titled e Foot Signal).<br />
gelaTo nero<br />
Ma torniamo al gelato. In Georgia Roberto conosce Guillermo Scott Herren<br />
aka Prefuse 73. Lavorare con lui è facile, dato che sono buoni amici; ci conosciamo<br />
dal 1999. Con Guillermo approfondisce le nozioni di studio engineering<br />
che da lì a breve gli permetteranno di lavorare per Savath & Savalas, All<br />
Tiny Creatures (un remix), My Brightest Diamond (l’album Shark Remixes<br />
Vol. 3), Bear In Heaven (il missaggio del fortunato disco omonimo) e di collaborare<br />
tra gli altri anche con Schools of Seven Bells. Collaborazioni che<br />
gli fanno vedere le cose da un’altra prospettiva (vedi ad esempio il remix per<br />
Epstein dello stesso Prefuse e di Jaytram, batterista degli Yeasayer).<br />
Con questi biglietti da visita, parte da Atlanta e va a finire guardacaso a<br />
Brooklyn, New York. Il posto più adatto per emergere nel panorama indie<br />
di inizio millennio. Qui inizia a smanettare anche con i video (la gran parte<br />
dei quali è visibile sul suo sito in costante aggiornamento) e a pensare a<br />
un nuovo progetto: Helado Negro, appunto. Un moniker che può essere<br />
incluso nel ‘flashback-continuum’ reynoldsiano degli anni ‘80 ‘90. Non avevo<br />
altra scelta, ci dice, parlando ancora delle sue origini musicali: quegli anni<br />
sono stati importanti per la mia formazione, ascoltavo tutto quello che usciva<br />
quando ero bambino, ed ero come una spugna gigante; è inevitabile quando<br />
cresci riferirti alle cose che sentivi da piccolo.<br />
HN sembra essere più song oriented dei lavori licenziati a nome Roberto<br />
Carlos Lange (vedi ad esempio il mini pseudo-ambient Short-lived Music del<br />
2001). La ragione per cui separo i due nomi - ci spiega Roberto, un po’ sorpreso<br />
dalla domanda - è che quando canto in spagnolo mi chiamo Helado Negro e<br />
quando canto in inglese ridivento Roberto. Quando faccio cose col mio nome<br />
è per progetti specifici, che probabilmente non dureranno molto.<br />
56 57
Il primo disco di HL risale al 2009 (Awe Owe su Asthmatic Kitty). Il sound<br />
è un folk speziato con testi in spagnolo, strumenti della tradizione sudamericana,<br />
tropicalismi à la Tom Zé (Dos Suenos, Dahum) e percussioni che<br />
ricordano ancora una volta l’approccio di Beck ai suoni che provengono<br />
da sotto l’equatore. Il disco risulta piacevole all’ascolto, ci riporta al sogno<br />
post-balearico (Espuma Negra) che in quel periodo sta montando una nuova<br />
onda glo che esploderà nelle prove successive di Ariel Pink, Toro Y Moi,<br />
Washed Out (anche lui vivie in Georgia) e molti altri. Di Neon Indian ci dice<br />
ad esempio di aver sentito i suoi primi lavori e di esserne stato colpito positivamente.<br />
Mi ricordano le produzioni hip-hop degli anni ‘90 e penso di pescare<br />
anch’io dallo stesso serbatoio, anche se le influenze maggiori vengono dai miei<br />
amici, dalle persone con cui collaboro. L’acustico che si scontra con l’elettrico<br />
nell’uso dei loop e dei samples (Time Aparts): un mix che arricchisce - come<br />
nelle vecchie produzioni On-U Sound di Adrian Sherwood - la canonica base<br />
sul quattro costruendo una delle tante ipotesi possibili di latin psych-funk<br />
ammiccante all’hip-hop.<br />
L’anno successivo esce il mini Pasajero. Qui HN si mette alla voce e alla<br />
chitarra, lasciando a una squadra di collaboratori le altre strumentazioni.<br />
In più assolda la cantante Julianna Barwick, che aggiunge backing vocals<br />
e magie atmosferico-ambient (Jurame) a una visione sonica sempre più<br />
slavata, infarcita di echi (La la, Adios Maldito Mundo) e melodie pop cantabilissime<br />
(Rosita). La collaborazione con Julianna inizia tre anni fa, quando<br />
Roberto le chiede di aprire un concerto di HN; è poi approdata ad un tour<br />
e probabilmente proseguirà con un progetto che dovrebbe ultimarsi alla<br />
fine di quest’estate.<br />
Non c’è due senza tre: quest’anno HN aggiunge al CV Canta Lechuza, un<br />
controcanto south al botto di Destroyer (Kaputt), che prescinde dai ricordi<br />
‘techno’ delle star già menzionate e si arma delle features proprie del cantautorato:<br />
attenzione alla voce e alla melodia (2° Dia), pochi e semplici overdub,<br />
qualche effetto ricordo elettronico (Cenar En La Mañana) e il gioco è fatto,<br />
tanto che in certi punti fa pensare a qualche canzone del nume Caetano<br />
Veloso (Mi piacerebbe cantare come lui. Mi piacciono la bossa e il suono della<br />
sua musica).<br />
Ma che ha di diverso rispetto ai glo-fiers più blasonati? La chiave di lettura<br />
della sua musica deve puntare alle radici. Non a caso il ragazzo ha indagato<br />
sulle sue origini, producendo due mixtapes (Oscuro como boca de lobo, su<br />
Now-Again/Stones Throw) di standard folk sudamericani, che comprendono<br />
tracce di Gato Barbieri, Victor Jara e altri artisti poco noti della cosiddetta<br />
diaspora latinoamericana. Quei suoni lo hanno sicuramente influenzato,<br />
anche se con quei due tapes non ho tentato di studiare, mi piace di più essere<br />
influenzato passivamente. Mi piace sentirli e non analizzarli più di tanto.<br />
Lo slackerism e l’understatement di ogni bravo artista contemporaneo<br />
insomma. L’eredità folk mescolata con pochi ingredienti di sintesi porta a una<br />
consapevolezza nuova, che guarda sì al passato delle consolles e dei suonini<br />
a 8 bit, ma che sa anche spingersi più in là, acquistando un sapore che alla<br />
lunga dura di più, forse perché corroborato da fondamenta più solide, o<br />
perché l’elemento ritmico non prevale e non scavalca troppo la vocalità, conferendo<br />
un’aura pop al tutto. La necessità delle ritmiche è confermata anche<br />
dallo stesso Roberto, che ci spiega come ai suoi occhi Canta Lechuza sia un<br />
disco dancey. Dipende dal modo in cui balli. A me sembra che sia un disco per<br />
far muovere la gente. Tutte le cose che ho fatto sono sempre state fatte con molti<br />
sintetizzatori e con campionatori. Awe Owe ad esempio è stato scritto in gran<br />
parte con campioni sui quali i musicisti suonavano. Penso che sia sempre difficile<br />
interpretare quello che si fa. Se c’è una chitarra non è detto che sia folk music. Mi<br />
interessa di più l’evoluzione del suono della parte tecnica. Il titolo dell’album<br />
letteralmente sta per ‘canta gufo’ e viene fuori da un verso tradizionale della<br />
religione Santeria che ha delle radici Yoruba. All’inizio volevo chiamare l’album<br />
‘Al gufo cosa importa?’, ma poi l’ho cambiato così. Non è un’ordine che viene<br />
dato al gufo. Non so bene cosa voglia dire, dipende da come lo interpreti. Io ci<br />
vedo più di un significato in quelle parole, ma non è letterale.<br />
non solo mUsiCa<br />
Roberto come abbiamo detto, è attivo anche sul lato video. Le sue produzioni<br />
riflettono un’attitudine quasi interamente lo-fi, che si ricollega al<br />
lavoro di molti creativi over trenta di cui abbiamo già parlato sulle pagine<br />
di SA (vedi il rinnovato interesse per la cheap-tune music o il glo-fi stesso).<br />
Infanzia e adolescenza attaccati alla TV (mia nonna ne aveva una in bianco e<br />
nero), magari proprio con colori lo-fi (i miei amici avevano queste strane TV a<br />
proiezione, con tre cerchi per proiettare le immagini... ricordo queste immagini<br />
così saturate e poco chiare, sono le cose che mi sono sempre piaciute vedere) e<br />
alle mitiche iconografie Nintendo: ho smesso di giocare quando la grafica era<br />
troppo realistica, non era più fantasiosa, assomigliava troppo al reale... è per<br />
questi motivi che mi piace l’analogico, perché è un’interpretazione della realtà,<br />
non tenta di rappresentarla al meglio, è solo un’idea.<br />
Questa multimedialità (Roberto ha collaborato anche a varie sculture sonore<br />
per installazioni) non sembra stressarlo: ogni cosa che faccio è collegata e fa<br />
parte della mia vita. Se sono ispirato non mi pesa lavorare su più fronti, anche<br />
se mi piacerebbe essere un po’ più bravo per quanto riguarda i video, ci dice<br />
ridendo. Un artista a tutto tondo che sta già lavorando ad un nuovo disco<br />
(probabilmente in uscita il prossimo anno) e che se troverà agganci in Europa<br />
suonerà ad Ottobre anche nel vecchio continente. Date un’occhiata al<br />
suo sito, e se potete mettetelo in playlist nel prossimo Festival.<br />
58 59
— cd&lp<br />
Recensioni<br />
settembre<br />
aa. VV. - utmarKEn 2011 (utmarKEn, luglio<br />
2011)<br />
Genere: noise<br />
A soli due anni dalla pubblicazione dell’omonimo 10<br />
pollici (che non mancammo di salutare con gioia nella<br />
relativa recensione) chiude, immaginiamo per questioni<br />
di permessi, l’Utmarken di Goteborg, centro polivalente<br />
sede di tutta la scena noise/out locale. Se nel 2009 era<br />
stato il suddetto vinile a celebrare il momento di maggior<br />
attività e creatività dei ragazzi svedesi, pare giusto<br />
che oggi sia un box di tre cassette a sancire la fine<br />
dell’esperienza. E qualcosa è pure cambiato nel corso<br />
di questi pochi anni, anche se più a livello anagrafico<br />
che altro.<br />
Ritroviamo infatti i beniamini (si fa per dire) Ättestupa in<br />
apertura con una Orostid - Greppet Hårdnar non così ispirata<br />
come lo fu a suo tempo Änglamakerskan ma sempre<br />
in grado di scandire l’immancabile liturgia funebre.<br />
Matthias Andersson non è più con Källarbarnen ma si è<br />
messo in proprio sotto il moniker Arv & Miljö, così come<br />
Viktor Ottosson non compare come Street Drinkers ma<br />
con l’assai più rumoroso, e rovinoso, Blodvite.<br />
New entry anche per David Eng degli Ättestupa, che<br />
col nuovo solo-project Skuggor ci martoria le orecchie<br />
degli otto minuti di Luften Blev Döv, e una nuova e più<br />
disastrata versione di Black Death che i Lust For Youth<br />
recuperano dall’album Solar Flare. Chiude Sewer Election<br />
e il suo harsh già da tempo sinonimo di garanzia<br />
letale.<br />
Un ricettario di malessere nordico, insomma, che ancora<br />
un volta fa il punto su una delle scene più attive e prolifiche<br />
- al limite dell’ipertrofia - d’Europa. Chissà cosa si<br />
inventeranno i giovani vandali scandinavi ora che la loro<br />
alcova non c’è più.<br />
(6.7/10)<br />
andrEa napoli<br />
aaron dilloWay - lip SynCing to VErmE<br />
(hundEbiSS rECordS, luglio 2011)<br />
Genere: noise<br />
Il reprobo in fuga dai Wolf Eyes, il padrone della efferata<br />
Hanson, il noiser più freakettone di tutti (do you remember<br />
Nepal?) riprende a pieno regime la sua produzione<br />
unendo le forze di nuovo con la premiata ditta Hundebiss,<br />
pronta ad incartarne come suo solito il nuovo albo<br />
in vinile. Lip Syncing To Verme vede Dilloway tornare a<br />
pubblicare sull’italico suolo dopo la sortita in cassetta<br />
proprio per la Hundebiss col titolo omonimo. Non di ristampa<br />
si tratta però, quanto di rielaborazione extended<br />
del mood che pervadeva quella tape in rigorosa edizione<br />
limitata. Droni montanti di sfattume noise e immondizia<br />
a bassa fedeltà che si scioglie in una stasi ambientale<br />
putrida fatta di materici rimasugli (A1), spastiche parentesi<br />
ritmiche dal procedere nonsense (A2), loop di nastri<br />
manipolati, tagliati, cuciti, imbastarditi innervati però da<br />
una predilezione cinematica (A3).<br />
La label, sempre attenta a edizioni curate nel minimo<br />
dettaglio (questa è in formato origami gigante e apribile),<br />
ne parla come di uno “slow motion Stan Brakhage on<br />
K”, per evidenziare il portato fluido e cinematografico del<br />
flusso sonoro. A noi viene più in mente una passeggiata<br />
bucolica in una landa di fangose aberrazioni, dalle quali<br />
si tenta di uscire in tutti i modi ma vi si resta imprigionati<br />
senza possibilità di fuga. Provate a calarvi nell’ascolto<br />
delle due lunghe tracce untitled del lato B e converrete<br />
che sembrano la colonna sonora di una discesa senza<br />
ritorno, drammatizzata fino allo spasimo, nelle sabbie<br />
mobili. Mai morte fu tanto piacevole.<br />
(7/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
amEliE tritESSE - Cazzo nE SapEtE Voi dEl<br />
roCK and roll (intErno4rECordS, luglio<br />
2011)<br />
Genere: reaDinG rock<br />
C’è un senso di feroce familiarità che ti aggredisce appena<br />
partono le note degli Amelie Tritesse. Quelle che<br />
Manuel Graziani, apprezzato giornalista musicale, ha<br />
preparato per il suo progetto, sono le storie di un’umanità<br />
periferica che da queste parti dovremmo conoscere<br />
fin troppo bene.<br />
Tutta quella parte della provincia italiana, che non è<br />
quella falsamente ecumenica di Ligabue, per cui la formazione<br />
fatta sui dischi (magari dei Gun Club, sognando<br />
le palme di Miami) è importante quasi quanto gli insegnamenti<br />
di nonni coriacei (come quelli cantati nella<br />
highlight<br />
a WingEd ViCtory For thE SullEn - a WingEd ViCtory For thE SullEn (KranKy,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: post ambient<br />
Cosa può mai accadere se un visionario del dream pop come Dustin O’Halloran - la metà mascolina dei<br />
Devics, da tempo autore di un apprezzato percorso parallelo solista - e un artefice del miglior postambient<br />
come Adam Wiltze - del duo texano Stars Of The Lid - decidono di unire gli ineffabili intenti?<br />
Qualcosa di non clamoroso, certo, ma denso e intenso a dispetto della dogmatica levità. Sette tracce<br />
orchestrali per il debutto omonimo di questo progetto denominato A Winged Victory For The Sullen,<br />
sette passi tra le nuvole coltivando angelici turbamenti, palpitazioni tenui<br />
e trascendenze paniche.<br />
Archi come il respiro misterioso della natura o il brusio segreto di tutte le<br />
albe già state e future, il piano che sgocciola accorata pensosità come un<br />
Brian Eno liofilizzato (Requiem for the Static King Part Two), impressionismo<br />
e romanticismo sfumati d’astratto (il Debussy bradicardico di Minuet for a<br />
Cheap Piano, lo Chopin misterico della splendida A Symphony Pathetique), lo<br />
struggimento artico e pastorale degli ultimi Sigur Ròs (Steep Hills of Vicodin<br />
Tears), certa delicata narcosi Terry Riley (All Farewells Are Sudden), il tutto sullo<br />
sfondo d’un minimalismo imperturbabile e accorato (l’apprensione Eric Satie<br />
dell’iniziale We Played Some Open Chords and Rejoiced, For the Earth Had Circled the Sun Yet Another Year).<br />
Questo disco è il tedio sublime che stavamo cercando e non avevamo osato chiedere. Un’ipotesi di retroavanguardia<br />
appartata, accattivante in virtù di una raffinatezza mai forbita, fieramente obsoleta. La<br />
dedica al mai troppo rimpianto Mark Linkous è il tipico valore aggiunto della faccenda.<br />
(7.3/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
tenera Oplà). Nei suoi testi c’è un senso dell’ironia arguto<br />
e pungente, capace di fermarsi ad un passo dal cinismo;<br />
come quando in uno dei brani più divertenti e amari<br />
della raccolta (Liverpool Pub) fa i conti con lo stato d’animo<br />
di un precario alle prese con il rampantello di turno.<br />
Ad accompagnare la prosa c’è un gruppo affiatato e concreto,<br />
che rifugge dalle tentazioni artsy per ricorrere a<br />
strutture squisitamente rock. “Un energico read’n’rock di<br />
provincia”: sono loro stessi a suggerire la definizione più<br />
corretta sulla copertina del libro che accompagna il cd.<br />
Un mix inestricabile di musica e letteratura e vita che<br />
alterna sferzate elettriche, meditazioni digitali e crescendo<br />
elettroacustici che finiscono per prorompere in un<br />
canto liberatorio (La Sudarella). Un caso più unico che<br />
raro in un panorama musicale pronto come non mai ad<br />
affibbiare etichette fallaci.<br />
(7/10)<br />
diEgo ballani<br />
antitEQ - m.ag.ma Ep (magmatiQ rECordS,<br />
aprilE 2011)<br />
Genere: techno, iDm<br />
Non è ancora troppo tardi per recuperare l’ultimo EP di AntiteQ,<br />
dj e producer milanese con un paio di uscite in breve<br />
formato al suo attivo e un interessante sound esterofilo<br />
fatto di techno, idm e dubstep che val bene una chance.<br />
Questo Music Against Masses intende realizzare ancora una<br />
volta la rivincita della dance intelligente sulla pista techno,<br />
e lo fa accumulando complessità d’ascolto come da catalogo<br />
Warp ‘90 (B, N), con tanto di nerdismi 8bit che fanno<br />
tanto Aphex Twin (C, A). ‘Fuck dance, we are artists’? Non del<br />
tutto, perché la prepotente cassa in quattro sullo sfondo<br />
regala durezze di stampo teutonico e accende comunque<br />
le sinapsi sensibili all’aria del club europeo. In realtà dunque<br />
è più sfoggio dei propri mezzi che sviluppo di un concept.<br />
Tutto in una misura che non guasta e con un carattere ben<br />
definito. C’è speranza per un full-lenght qui in Italia o anche<br />
qui è inevitabile la fuga a Berlino?<br />
(6.6/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
60 61
antonEllo brunEtti - opEn to ChangE<br />
(autoprodotto, maggio 2011)<br />
Genere: sonGwritinG rock<br />
Chitarra acustica da folk singer vissuto, qualche nota di<br />
piano ad aggiungere un velo di condensata autorevolezza<br />
e per finire un’eterea sognatrice voce sufficiente a<br />
toccare le corde più intime dell’animo. Potrei fermarmi<br />
qui per raccontare questo debutto solista più che valido<br />
del calabrese classe ’85 Antonello Brunetti. Ma siccome<br />
il disco consta anche di un’altra metà, chiamiamolo<br />
lato B, più elettrico, caotico e meno studiato, tocca fare<br />
un distinguo. Buona parte di Open To Change si può<br />
facilmente ricondurre ai soliti noti del songwriting (Jeff<br />
Buckley, Nick Drake, Joni Mitchell), e in definitiva risulta<br />
essere questa la prospettiva più compiuta, felice e<br />
meglio resa del disco; brani come Underwater o My Will<br />
Becomes Weird ci restituiscono un cantautore in grado di<br />
disegnare originali e fascinose melodie e a pennellarci<br />
sopra testi taglienti, sognanti e provocatori.<br />
C’è poi l’altra metà, più italiota, che ha riferimenti vaghi<br />
(Carmen Consoli, Paola Turci) e che pecca di quell’accuratezza<br />
nella resa sonora e negli arrangiamenti che<br />
invece è motivo di vanto della prima parte. Nello stato liquido,<br />
Ordine, Crowded Train, appaiono come frammenti<br />
capitati per caso o per sbaglio in una raccolta di belle<br />
canzoni scolpite con gusto e passione per un genere<br />
che Brunetti non si limita ad imitare, ma che riesce ad<br />
interpretare e a riscrivere con originalità e coraggio. Il<br />
genere è dei più difficili, va detto. La concorrenza è spietata.<br />
Open To Change potrebbe rappresentare un buon<br />
viatico per smuovere le acque, per catturare l’attenzione<br />
di qualche discografico, per segnalare la propria presenza<br />
in un mare affollatissimo. Ma certi esperimenti, per il<br />
momento, meglio abbandonarli.<br />
(6.4/10)<br />
gianluCa lambiaSE<br />
apparat - thE dEVil’S WalK (mutE,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: post-rock<br />
Dell’ultima svolta acustica di Apparat vi avevamo già<br />
dato doverose anticipazioni con le news e con un’intervista<br />
incentrata sul sound della formazione band. E a<br />
chi voleva toccare con mano, bastava assistere a uno<br />
degli ultimi live per far balzare subito agli occhi il nuovo<br />
assetto: Sascha Ring al centro della scena, chitarra in<br />
mano e microfono alla bocca, e i membri restanti dedicati<br />
all’accompagnamento strumentale, che tradotto in<br />
termini sonori significa componente elettronica ridotta<br />
all’osso e un profilo post-rock in bilico tra Sigur Rós e<br />
Coldplay, che faceva sentire la mancanza del carattere<br />
più sperimentale dell’artista berlinese.<br />
Arriva The Devil’s Walk, realizzato in collaborazione con<br />
Patrick Christensen dei Warren Suicide e Joshua Eustis<br />
dei Telefon Tel Aviv, e le tiepide impressioni precedenti<br />
non vengono di fatto ribaltate: impostazione cantautoriale<br />
preponderante (Song Of Los), impronta netta del<br />
Thom Yorke solista (Escape, Ash/Black Veil) e zuccherosità<br />
dreamy che fan quasi chillwave (Black Water). Il<br />
formato lungo permette di inquadrare meglio il disegno<br />
complessivo e svela una certa attenzione per il mood e<br />
le suggestioni del suono minimale (c’è dell’anima dietro<br />
brani come Goodbye e Candid De La Calle), ma compone<br />
un quadro scarno e algido, senza finezze compositive<br />
degne di nota e sicuramente derivativo.<br />
Censurare la sincera volontà di adottare un nuovo volto<br />
sarebbe cattivo (e sospettare che si stia volutamente<br />
mirando al popolo dei postrockers è pura perfidia), ma<br />
se ti nascondi dietro le orme tracciate da altri è lecito<br />
sollevare obiezioni. Avevamo già assistito lo scorso anno<br />
ad un analogo abbandono delle certezze electro con<br />
Trentemøller e il suo Into the Great Wide Yonder
.<br />
Da quelle parti però c’erano ricchezza di contenuti e<br />
precise intenzioni espressive, qui povertà espressiva e<br />
qualche piacioneria di troppo. E il carattere mostrato<br />
negli ultimi quindici anni dov’è finito?<br />
(5.9/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
aQuadrop - Soul Ep (l2S rECordingS,<br />
agoSto 2011)<br />
Genere: italian post-Dubstep<br />
Di quell’immensa distesa di realtà sommerse che è la<br />
scena dubstep/wonky italiana, il milanese Aron Aquadrop<br />
Airaghi è tra quelli col sound più esterofilo ed originale.<br />
E infatti è anche tra quelli più apprezzati oltre il<br />
confine, avendo acquisito una certa autorevolezza coi<br />
primi eppì e soprattutto con l’album Aurora Borealis<br />
del 2010, col quale ha approcciato la materia dubstep<br />
spaccandola tra conservatorismo downtempo e intraprendenza<br />
wobble. Dopo aver catturato l’attenzione di<br />
producers come Untold, EL-B e Starkey, quest’anno<br />
il ragazzo sta dicendo la propria sulle nuove pieghe<br />
post-dubstep/future-garage in corso, e questo Soul EP<br />
arriva dopo un percorso di avvicinamento partito con<br />
il singolo iLICK YOU (che al caro SBTRKT piacerebbe un<br />
sacco) e proseguito con una Drops che sembra uscita<br />
dal recente catalogo Hotflush.<br />
Le spinte controverse del nuovo corso step mostrano sia<br />
la voglia di andare oltre che l’orgoglio di appartenenza<br />
ad una storia che ha radici lontane, per cui l’intelligente<br />
rispolvero 2-step garage di Soul è il giusto omaggio al<br />
passato da parte del nuovo che avanza. Le spinte più<br />
coraggiose invece le danno Evolution, mescolando un<br />
feeling soul vagamente Jamie Woon alla frizzante vivacità<br />
Mount Kimbie, e King Of The Jungle, con un tappeto<br />
tribal-funky a sostegno di coraggiose tesi wonky-beat<br />
a metà strada tra Jamie XX e Flying Lotus. Che in Italia<br />
bolla qualcosa in pentola lo sapevamo già e ve l’avevamo<br />
detto più volte, ma constatare una qualità che nulla<br />
ha da invidiare alle ultime derive londinesi fa comunque<br />
un certo effetto. Aspettando l’esplosione definitiva...<br />
(7.1/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
aStrid WilliamSon - pulSE (onE littlE<br />
indian, agoSto 2011)<br />
Genere: ambient pop<br />
Quinto disco e un cambio di rotta sostanziale per Astrid<br />
Williamson, signora del pianoforte e della canzone proveniente<br />
dalla terra d’Albione. Se l’ultimo disco, Here<br />
Come The Vikigns del 2009, era apparso un appannato<br />
tentativo di mettere i propri talenti al servizio di un pop/<br />
rock senz’anima, con Pulse decide di sfruttare la propria<br />
formazione di pianista e musicista classica per una<br />
ricerca sonora più originale e meno usa e getta. Le dieci<br />
composizioni giungono come il risultato di una stretta<br />
collaborazione con il produttore Leo Abrahams, noto<br />
per il suo lavoro con Brian Eno.<br />
Se il singolo Pour è una rivisitazione ambient dell’elettronica<br />
umana tardi Ninties venata di Europop, il resto<br />
del disco è in costante equilbrio tra pianismi minimali<br />
(Underwater), qualche ritorno alla chitarra pop-folk degli<br />
esordi (Connected), rock-pop radiofonico speziato di atmosfere<br />
aeree (la titletrack), esperimenti etno-camerisitici<br />
(Cherry), e ambient dolce venato della delicata voce<br />
della Williamson (Paperbacks, Husk). Una tavolozza di<br />
colori più ampia che cerca una quadratura tra Lisa Germano,<br />
l’ondata islandese tra Novanta e Duemila, il Brian<br />
Eno della musica per ambienti, e l’elettronica più easy.<br />
Nemmeno questo è un capolavoro, ma preferiamo il recupero<br />
di un pensiero musicale all’inconsistenza della<br />
rincorsa a un mercato radiofonico che sulla Williamson<br />
- forse a torto - ha già detto la propria.<br />
(6.6/10)<br />
marCo boSColo<br />
azari & iii - azari & iii (looSE lipS, agoSto<br />
2011)<br />
Genere: retro-house<br />
I canadesi Azari & III, ovvero Christian Farley / Dinamo<br />
Azari e Alphonse Lanza / Alixander III, hanno debuttato<br />
nel 2009 con Hungry For The Power, un cuore soul cir-<br />
condato dal classico tintinnare di vecchi house claps,<br />
una spremuta funky e sintetiche Inner City / italo disco.<br />
Il crooning extra black ci ricordava i dischi di Jimmy<br />
Edgar e qualcosa di Seth Troxler, i ritornelli si portavano<br />
dentro lo struggle della house diva. Fritz Helder e<br />
Starving Yet Full, i primi due di una lunga serie, erano<br />
i vocalist e il pezzo, uscito sulla francese I’m A Cliché,<br />
faceva il giro del mondo finendo nelle playlist di gente<br />
insospettabile come Grizzly Bear e Broken Social Scene.<br />
Lo stesso anno, “Azari and Third” ripete il botto con Reckless<br />
With Your Love, altra mossa felpata e dark, altro<br />
tuffo edonista negli eccessi della New York del Paradise<br />
Garage condito con la più basica tecnologia di Chicago<br />
e Detroit (bello anche il remix con la base hi-NRG / Snap<br />
di Tensnake), tutto tra metà e fine Ottanta con bpm morigerati,<br />
vedi alla voce Nicolas Jaar, specchi bagnati<br />
sulle pareti, r’n’b lascivo, visioni afrofuturiste (Indigo) e<br />
soltanto una piccola concessione agli eighties paraculi<br />
con il singolo, del 2010, Into The Night (di cui trovate<br />
anche un bel remix strumentale dello stesso Jaar).<br />
Ora che finalmente abbiamo l’album lungo per le mani<br />
scopriamo che la coppia era seria quando affermava a<br />
XLR8R di star lavorando alla propria new, futuristic shit.<br />
Si sono circondati di synth e hanno imbastito una vera<br />
e propria “orchestra analogica” in studio. Nel frattempo,<br />
sono diventati un quartetto che non rappresenta più<br />
(o non solo) una risposta a Hercules And Love Affair,<br />
Jessica 6 (Lost In Time e il nuovo singolo Manic) e compagnia<br />
boogie disco (Manhooker). L’album esplora varie<br />
Tunnel Vision, spazialità acid (Infiniti, Change Of Heart) e<br />
anche del vintage funk (Prince citato in Undecided) ma,<br />
a perderci, è un poco dell’originaria disinvoltura...<br />
(6.8/10)<br />
Edoardo bridda<br />
balam aCab - WandEr / WondEr (tri anglE,<br />
agoSto 2011)<br />
Genere: ambient-step<br />
Sembrava che andasse a parare nei lidi della witch<br />
house il giovane americano Alec Koone con il suo EP<br />
d’esordio (See Birds), ma visto che la bolla in poco più<br />
di un anno è bella che scoppiata, con questo full la sua<br />
direzione si affianca più che al noise drone delle streghe<br />
alle sonorità soul di James Blake e compagnia soulstep,<br />
aggiungendo atmosfere ambient che utilizzano i setting<br />
derivati dall’IDM e le vocals Novanta à la Lamb per<br />
costruire un quadretto di ambientronica meditativo e<br />
infinitamente retrò.<br />
Oh Why, che ha già fatto rizzare le antenne a più di un<br />
talent scout, riporta sul piatto un’atmosfera new age<br />
a bassa velocità con vocine in elio ed effettini ad 8 bit<br />
62 63
che non sai bene se sia più classica o rave post-Zomby.<br />
Await e Apart riesumano le voci liquide già utilizzate da<br />
Burial e soci soul-step in un giochino arcade innocuo,<br />
ma che con gli echi effettati ha un che di hauntologico<br />
e spiritato, quasi psichedelico, Motion è una dedica implicita<br />
alle voci innocenti di Björk, Welcome filtra voci<br />
liriche à la Antony, inabissandole in maelstrom cupi e<br />
senz’uscita, Now Time brilla di popness e di canzoncine<br />
per infanti, Fragile Hope si scontra con le atmosfere di<br />
Four Tet, perdendo molto per quanto riguarda originalità<br />
della proposta.<br />
Non si capisce bene dove voglia andare a parare il ventenne<br />
di Ithaca. Un disco di glich r’n’b che vive le contraddizioni<br />
post-00 del soulstep e del glo, situandosi in<br />
una microscuola che in Sun Glitters, Holy Other, How<br />
To Dress Well e nell’ultimo The Field trova buona compagnia,<br />
a cavallo tra elettronica, revival shoegaze e foto<br />
sfocate con colori pastello. Molta carne al fuoco che non<br />
prende una direzione decisa e facilmente riconoscibile,<br />
ma che preferisce fermentare in un limbo che ancora<br />
una volta propone (ma per quanto?) un revival new age<br />
per chi negli anni Ottanta era alle prese con le compilation<br />
Bimbomix. L’ennesima testimonianza dalla generazione<br />
post-noughties di dazed and confused people’.<br />
(6.6/10)<br />
marCo braggion<br />
banda blaCK rio - SupEr noVa Samba FunK<br />
(Far out, agoSto 2011)<br />
Genere: neo-brazilian<br />
Strano l’effetto che fanno i lifting. Nel senso che l’ensemble<br />
brasiliano guidato oggi da William Magalhães - che<br />
ha raccolto il testimone dal padre, il sassofonista e fondatore<br />
dell’ensemble Oberdan - prova a rinverdire una<br />
formula che, lungo i ’70, mescolava morbidezze black<br />
alla Kool And The Gang ed Earth, Wind & Fire guardando<br />
al jazz di Coleman Hawkins e ai maestri della<br />
bossanova, gettando nel calderone una presina di hiphop<br />
e qualche ospite prestigioso. Mossa che nondimeno<br />
sfocia in una serie di lusinghe ultraraffinate buone<br />
per la programmazione di Radio Montecarlo, come se<br />
un Donald Fagen autocompiaciuto timbrasse svogliato<br />
il cartellino per stendersi in spiaggia al più presto.<br />
Siccome i momenti più “modernisti” maneggiano soltanto<br />
luoghi comuni e quel poco di rap non disturba,<br />
pertiene alle due deviazioni dal percorso poste in chiusura<br />
consegnare le uniche cose memorabili. La falsa<br />
tranquillità di una Irerê con Gilberto Gil e una trasognata<br />
Aos Pés Do Redentor presa per mano da Caetano<br />
Veloso non bastano a conferire la sufficienza a un<br />
progetto dove Seu Jorge e membri dei Mobb Deep si<br />
aggirano spaesati. E che mostra sin troppe rughe.<br />
(5.5/10)<br />
gianCarlo turra<br />
barn oWl - loSt in thE glarE (thrill<br />
JoCKEy, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: Doom<br />
Il Signore verrà alla fine dei tempi a dividere i giusti dagli<br />
empi. I giusti ascenderanno nella Sua gloria. Per gli empi<br />
sarà pianto, stridore di denti, e il suono dei Barn Owl<br />
nella terra desolata.<br />
È una ferita lacerante Lost In The Glare, il lamento disperato<br />
dell’uomo senza una fede. Caminiti e Porras<br />
sono due anime smarrite che vagano nel deserto in<br />
cerca di un segno, in attesa di un bagliore accecante in<br />
cui lasciarsi andare. È una spiritualità che agogna uno<br />
spirito e si lascia sopraffare dalla paura (il folk desertico<br />
di Turiya) e dall’oscurità (la scurissima e opprimente The<br />
Darkest Night Since 1683 o il lamento per chitarre Light<br />
Echoes). Ma laggiù, da qualche parte, sembra spuntare<br />
sempre una flebile luce - i Popol Vuh inquieti negli<br />
apreggi vaganti di Devotion I, la trascendenza nel nulla<br />
del fingerpicking di Temple Of The Wind, o la maestosa<br />
speranza del tripudio finale al ralenti Devotion II.<br />
Umanamente parlando c’è da augurarsi che Caminiti e<br />
Porras trovino presto il bagliore accecante in cui perdersi,<br />
musicalmente c’è da sperare che non perdano un<br />
minimo della loro sceneggiatura visionaria.<br />
(7.3/10)<br />
FranCESCo aSti<br />
bioSphErE - n-plantS (touCh muSiC uK,<br />
giugno 2011)<br />
Genere: ambient techno<br />
Substrata, l’album più noto di Geir Jenssen, contiene<br />
uno dei brani (Hyperborea) inclusi nella colonna sonora<br />
dell’ultimo film di Terrence Malick The Tree of Life. A<br />
Seattle, lo scorso luglio, si è svolto un festival omonimo,<br />
Substrata 1.1, dove il musicista norvegese era presente<br />
sia nelle vesti di headliner sia come curatore di un workshop<br />
che ha portato un gruppo di fortunate persone<br />
alle Cascade Mountain Range per una session di phonoregistrazioni.<br />
Geir è un pilastro dell’ambient techno da oltre vent’anni.<br />
Dal suo primo lavoro ambientale a nome Bleep<br />
(The North Pole by Submarine, 1990) alla seguente<br />
carriera come Biosphere, il norvegese della prolifica<br />
Tromsø (Bjørn Torske, Röyksopp, Mental Overdrive)<br />
ha istituzionalizzato la propria figura come padre<br />
fondatore della arctic ambient (variante nordica della<br />
prima IDM britannica) e aperto la strada alle numerose<br />
highlight<br />
albErto arCangEli - pop doWn thE rabbit holE (autoprodotto, luglio 2011)<br />
Genere: pop psych<br />
Cose strane accadono ai tempi di internet. Tipo che una famosa azienda di pneumatici sceglie come<br />
soundtrack per una campagna pubblicitaria europea la canzone di un perfetto sconosciuto, pubblicata<br />
in un EP autoprodotto e liberamente scaricabile. E’ accaduto al circa quarantenne Alberto Arcangeli<br />
di Tavullia, cittadina marchigiana altrimenti celebre per aver dato i natali a Valentino Rossi. Proprio così,<br />
bisogna stare attenti perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo, come ad esempio questo Pop<br />
Down The Rabbit Hole.<br />
Arcangeli si dichiara canonicamente devoto al verbo Beatles e Rolling Stones, ma se vi prendete il disturbo<br />
di dare un ascolto al famoso EP di cui sopra - Dreamsongs, licenziato un paio di anni fa - potrete<br />
imbattervi in ruspanti cover di Moby Grape, Buffalo Springfield e The Zombies, nonché una delle<br />
migliori riletture della kinksiana Sunny Afternoon che io ricordi. Sono tutte originali invece le dieci tracce<br />
di questo nuovo album che può essere considerato il suo primo vero e proprio,<br />
sintonizzato su un registro pop ammaliante e acidulo, marcatamente<br />
sixties tanto nel piglio sognante e giocoso quanto nel retrogusto obliquo.<br />
Non lo definirei un caso di retro-nostalgia quanto piuttosto la voglia di<br />
scegliersi una precisa collocazione emotiva, capace poi di riverberare nella<br />
contemporaneità sulla scorta di una scrittura fresca e intensa, oserei dire -<br />
addirittura - entusiasta.<br />
Vedi quando sboccia impetuosa e sghemba un po’ come potrebbe il nipotino<br />
gentile di Robyn Hitchcock (la title track), lennoniana come gli Eels<br />
più accomodanti (Hard Games e quella Wheels And Love il cui clip - realizzato dall’animatore Massimo<br />
Ottoni - si è aggiudicato il premio della crtica all’International Animation Festival Of Brazil), brumosa e<br />
struggente come dei Clientele in estasi Left Banke (Against The Day), tenera e indolenzita come capitava<br />
spesso ad Elliott Smith (Nothing Compares To Your Eyes). Parliamo di canzoni che non cambieranno la<br />
storia del pop-rock, ma ti possono cambiare il colore di un pomeriggio, se avete capito ciò che intendo.<br />
Il tutto in free download dal sito dell’artista, il che non guasta.<br />
(7.4/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
derive chillout dei Novanta. Negli anni, il musicista ha<br />
affinato le proprie tecniche come field recorder e scalatore<br />
professionista colmando così il gap tra la natura<br />
e musica. Il taglio ambientalista, del resto, si è presto<br />
tradotto in una misurata ricerca ricombinatoria degli<br />
elementi precedentemente messi in campo e non ha<br />
prodotto album che andassero oltre il compiacimento<br />
dei fan. Lo scorso lavoro (Dropsonde) poneva l’accento<br />
su un (post)jazz davisiano abbondantemente esplorato,<br />
mentre in quest’ultimo si ritorna ai quadretti narrativi<br />
della Tromsø pre-Röyksopp, a un IDM più brit che mai<br />
(echi Orbital in Genkai-1 e Fujiko) e alle solite soundtrack<br />
fine 70 (Jōyō), con la differenza che questo<br />
lavoro si pone come un concept a dir poco preveggente.<br />
N-Plants è basato sul sogno post-bellico giapponese e, in<br />
particolare, sul futuristico programma nucleare del Paese<br />
iniziato nel dopoguerra. Lo scorso febbraio il norvegese,<br />
ignaro oracolo di quel che sarebbe successo, affascinato<br />
dalle fotografie delle centrali e preoccupato dalla loro<br />
vicinanza al mare ha inciso le tracce dell’album dosando<br />
il rassicurante nitore giapponese (il sogno post-war) al<br />
compatto movimento verso il futuro (Shika-1) attraversando<br />
il mix con sinistri sibili (Sendai-1, Ikata-1) e scuri/<br />
imperturbabili loop ritmici, aggiungendo infine sporadici<br />
monologhi in giapponese (Fujiko, Monju-1).<br />
E’ il lavoro più ispirato da un po’ di tempo a questa parte,<br />
ma quel che avrebbe potuto essere una grande opera, è<br />
in ultima analisi solo’ un lavoro dignitoso.<br />
(6.7/10)<br />
Edoardo bridda<br />
64 65
londiE - paniC oF girlS (FiVE SEVEn muSiC,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: new wave, pop<br />
Di questi tempi, quando ti trovi davanti gli originali fa<br />
sempre un po’ strano. Senti un pezzo qualsiasi di Move<br />
Like This e lì per lì ti sembrano gli Strokes, e invece sono<br />
proprio i Cars. E allo stesso modo senti l’incipit tutto synth<br />
appiccicosi e schitarrate power pop del singolo What I<br />
Heard, pensi si tratti di chissà quale gruppettino fresco<br />
fresco e invece sono proprio loro, i Blondie (o meglio, ciò<br />
che ne resta: Debbie Harry, Chris Stein, Clem Burke più i<br />
gregari del caso). Già, fa strano trovarsi davanti gli originali,<br />
e non è tanto una questione di rughe e voci arrochite<br />
dallo scorrere delle stagioni. Nemmeno una questione di<br />
nostalgia, o di implacabili paragoni con l’irraggiungibile<br />
- per tanti, e sempre variabili motivi - produzione che<br />
fu. Come per il ritorno dei citati Cars, dipende sostanzialmente<br />
da come lo fai, in barba al tempo che passa. E a<br />
primo impatto con la tripletta che apre il nono album (in<br />
trentacinque anni!) dei newyorkesi, diresti proprio che<br />
non lo fanno poi così male: D-Day, What I Heard e Mother<br />
hanno il tiro melodico delle tipiche hit alla Blondie; no,<br />
non siamo a livelli contagiosi dei tormentoni classici (anche<br />
della relativamente recente Maria, l’insperato rilancio<br />
del ’99 se ben ricordate), ma l’impianto regge, insomma.<br />
Il problema che emerge via via non è poi tanto lo stile<br />
o la forma, ovviamente (la ripetizione fisiologica della<br />
storica formula vincente, vedi il reggaettino facile facile<br />
di The End The End), ma la ciccia. E qui ce n’è poca,<br />
troppo poca anche solo per accontentarsi ed essere<br />
semplicemente felici che siano ancora tra di noi, i Blondie.<br />
Di fronte alla fiacchezza e (duole dirlo) la schietta<br />
bruttezza di cose come Girlie Girlie, Wipe Off My Sweat e<br />
Le Bleu, viene quasi in mente l’ultimo Bowie di Reality (e<br />
non è un paragone lusinghiero, se come speriamo conoscete<br />
bene il duca Bianco); e a poco vale la presenza<br />
nientemeno di Zach Condon dei Beirut, la cui Sunday<br />
Smile viene ripresa in modo dopotutto onorevole e la<br />
cui tromba è possibile sentire qua e là, così come un<br />
paio di ballate che appaiono quantomeno ispirate (China<br />
Shoes e Words In My Mouth, che avremmo visto bene<br />
in bocca a Marianne Faithfull). Non tutti i ritorni riescono<br />
col buco, ahinoi (le copertine invece sì: questa qui, del<br />
pittore olandese Chris Berens, è invero notevole).<br />
(5/10)<br />
antonio puglia<br />
blood orangE - CoaStal grooVES (domino,<br />
agoSto 2011)<br />
Genere: 60s pop, 80s<br />
Avevamo rintracciato il moniker Blood Orange, nuova<br />
pelle di Lightspeed Champion, prima con S’Cooled (ottobre<br />
2009) e Forget It (settembre 2010), poi quest’anno<br />
con una manciata di tracce: il singolo Dinner (uscito per<br />
la Terrible di Chris Taylor ovvero Grizzly Bear, CANT), Bad<br />
Girls, ed infine Sutphin Boulevard.Dev Hynes, del resto, ci<br />
parlava del nuovo album già parecchi mesi fa in un’intervista<br />
all’altezza del sophomore Life is Sweet! Nice to<br />
Meet You alludendo a una tracklist incentrata sul lo-fi, il<br />
black-funk e il dub. Scordandosi di menzionare l’aspetto<br />
dominante, gli amati 80s, il prolifico texano aveva posto<br />
l’accento sulla peculiare natura aperta del progetto, rimasta<br />
tale a risultato finito tra episodi caratterizzati dal<br />
pop estivo della decade edonista e divagazioni ritmiche<br />
e/o atmosferiche desert lounge e post-punk.<br />
Sul lato propriamente melodico, improntato su una sintesi<br />
di funk e soul, il meglio dell’album lo ritroviamo in<br />
Forget It (surf e rockabilly e una crema solare di strofe e<br />
ritornello à la Prince / Elvis Costello, synth e pennate di<br />
chitarra Chris Isaak e tanto di assoli trash rock), Champagne<br />
Coast (succo mainstream 80s di gran classe), e<br />
nella versione dell’album di S’Cooled (base disco-dub<br />
Adrian Sherwood / PiL, il gioco di chitarrine caraibiche<br />
e percussioni a cascata circa 84), tascurabili invece gli<br />
episodi su basi desertiche come I’m Sorry We Lied (un<br />
giochino di basi wave e chitarre Morricone-Calexico) e<br />
Complete Future (una scusa per aggiungere il proprio<br />
punto di vista alle sonorità del Rome di Daniele Luppi<br />
e Danger Mouse) con la sola Can We Go Inside Now a<br />
ricavarne un rotondo artigianato pop.<br />
Merito assoluto di Dev: aver riportato alle orecchie certi<br />
assoli trash blues à la Chris Rea (Are You Sure You’re Really<br />
Busy?), richiami Soho Culture Club e ricordi Bowie altezza<br />
Little China Girl, come dire: se l’intuito e il talento sono fuori<br />
discussione, fosse veramente concentrato il ragazzo classe<br />
85 potrebbe sfornare degli autentici capolavori pop.<br />
(7/10)<br />
Edoardo bridda<br />
butChEr boy - hElping handS (damagEd<br />
goodS, agoSto 2011)<br />
Genere: inDie pop<br />
Una ricerca su Google potrebbe trarvi in inganno, perché<br />
la sigla sociale di questo combo britannico è precedente<br />
all’omonimo film di Neil Jordan (del 1997, tradotto<br />
in italiano come “Il garzone del macellaio”). John<br />
Blain Hunt ha cominciato al sua attività poetico-artistica<br />
agli inizi di quella decade, inviando versi a testate varie<br />
e realizzando qualche piccola performance, ma sicuramente<br />
senza saper suonare una nota con la chitarra. Ma<br />
se da questo terzo disco della band vi aspettate spoken<br />
word, reading e simili, siete stati tratti in inganno anco-<br />
highlight<br />
anthony JoSEph & thE SpaSm band - rubbEr orChEStra (naiVE, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: spoken/funk<br />
C’è un mondo dietro alle parole di Anthony Joseph caldo d’Africa, colorato di Caraibi, annaffiato di impegno<br />
civile e politico, corroborato dallo studio, dalla performance, dal girovagare alla ricerca di una<br />
ricostruzione del grande mito black, quello del più imponente esodo che l’umanità abbia mai conosciuto<br />
nella storia. Una migrazione costante, quella del popolo d’Africa che ha portato il proprio carico di<br />
tradizioni, musiche, profumi, colori e in ogni riva che ha toccato ha saputo<br />
lasciare un segno e prendere in prestito qualcosa. Meticciato dell’anima e<br />
dell’animo prima ancora che culturale ed etnico. C’è tutto questo dentro ai<br />
settanta e passa minuti che compongono Rubber Orchestra, il nuovo disco<br />
del poeta, romanziere, ricercatore universitario (Birkbeck College, University<br />
of London) e musicista Anthony Joseph e della sua “voodoo punk” Spasm<br />
Band.<br />
Un riferimento obbligato è sicuramente lo scomparso Gill Scott-Heron, probabilmente<br />
il più famoso artista dello spoken word. Il suo fantasma, però,<br />
si aggira solo nella lunga e conclusiva Generations, in cui il canto della diaspora si tinge di soft soul dai<br />
ritmi dilatati. Per il resto, i riferimenti, a cominciare dalla copertina con quei giubbotti di pelle e quei<br />
dreadlock, sono per il funk anni Settanta, per George Clinton, per i Parliament. Il tutto contaminato<br />
con il jazz di Bennie Maupin e Ornette Coleman, Miles Davis e Herbie Hancock, e con il calypso, la soca<br />
e i ritmi in levare dei Caraibi.<br />
Se Joseph ci mette il soul, non tanto nella vocalità, ma nel prendere a cuore le sue storie di “political<br />
funk”, i suoi sette compagni di viaggio, di cui val la pena di ricordare almeno la chitarra nerissima di<br />
Christian Arcucci e i duttili fiati di Oscar Martinez, aprono il ventaglio al free/noise (Cobra chiudendo il<br />
cerchio con altro funk politico, quello targato Pop Group), al soul pop venato di funk (Started Off As A<br />
Dancer), a territori caraibici in senso più stretto (Money Satan, Damballah), ma anche venando lo spoken<br />
di Joseph di rock (Bullet In The Rocks che fa il verso anche alla quasi omonima canzone dei Rage Against<br />
The Machine).<br />
Rubber Orchestra è anche una raccolta di poesie dello stesso Joseph, pubblica in contemporanea con il<br />
disco. Il che non fa altro che sottolineare come la sua arte e quella dei suoi sodali abbia bisogno di spazi<br />
ampi per essere apprezzata: non ci sono ritornelli da facile presa, né strizzatina alle classifiche. C’è “solo”<br />
la storia della diaspora d’Africa.<br />
(7.5/10)<br />
marCo boSColo<br />
ra una volta.Anni da autodidatta autarchico di sinistra<br />
hanno dato a John Blain Hunt le basi per suonare che,<br />
unite agli incontri giusti, hanno portato alla formazione<br />
di una vera e propria band, esordio sul palco del Royal<br />
Air Forces Association Club di Glasgow nel 2005. Da lì<br />
all’esordio discografico il passo è breve (Profit In Your<br />
Poetry, 2007) e le buone recensioni portano a un sophomore<br />
a stretto giro di tamburo (React Or Die, lavorato<br />
nel 2008, ma pubblicato l’anno seguente).Ma se non c’è<br />
spoken word, cosa si troverà dentro alle dodici tracce di<br />
Helping Hands? Belle And Sebastian up tempo (Imperial,<br />
Bluebells, Russian Dolls), bozzetti cinematografici à<br />
la Tindersticks (J Is For Jamie, T Is For Tommy), qualche<br />
sprazzo messicaneggiante come di Calexico solo appena<br />
più elettrici (The Day Our Voices Broke, I Am The<br />
Butcher). Quel che rimane è un pugno di buone canzoni<br />
indie pop, screziate di intelligenza e bagnate da una<br />
splendida viola che - talvolta - evoca John Cale.<br />
(6.5/10)<br />
marCo boSColo<br />
66 67
Cant - drEamS ComE truE (Warp rECordS,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: Dream pop<br />
Nei Grizzly Bear, Chris Taylor è il personaggio più Gus<br />
Van Santiano. Senza di lui non esisterebbero né i magici<br />
cori né le basi di basso ma soprattutto i ragazzi dovrebbero<br />
trovarsi un nuovo produttore e missatore.<br />
Label owner da un paio d’anni, apprendiamo ora che il<br />
fosco biondo ha sempre avuto nel cassetto il sogno di<br />
fare il songwriter e che però scrivere canzoni non è mai<br />
stato la sua specialità. Di sicuro, nei Bear, con Ed Droste e<br />
Daniel Rossen (Department of Eagles), non lo avrebbe<br />
realizzato facilmente e dunque ecco CANT, la sfida alla<br />
cronica incapacità nel completare i brani, un progetto<br />
nato dopo un tour con i Radiohead e i complimenti<br />
di Johnny Greenwood per i quali s’esaltò, interviste alla<br />
mano, soprattutto lui.<br />
Pubblicato in Europa da Warp e in USA per la sua Terrible<br />
Records (con la quale esordì con un primo 7 pollici sotto<br />
CANT, nel 2009, con Ghosts), il producer pubblica ora un<br />
dieci tracce pesantemente influenzate dallo streaming<br />
sonico di Thom Yorke & Co., in piccola misura dal Peter<br />
Gabriel solista agli esordi, e senz’altro dagli eighties di<br />
Forget firmato da George Lewis Jr. (Twin Shadow) di<br />
cui Taylor è stato, a sua volta, il produttore.<br />
La presenza di Lewis influenza parecchio gli smalti dayglo<br />
di Believe o l’ancora più 80s The Edge quando il cuore<br />
dell’album diluisce l’eredità dei Bear (le folk song in riva<br />
al mare BANG, She’s Found A Way Out, una lo-fi al piano<br />
Breicht) in una serie di contraltari per drum machine,<br />
bassi profondi e altri trick che abbiamo più volte incontrato<br />
nel catalogo contaminato ed eterogeneo della<br />
Warp dei 00s (vedi anche Answer).<br />
A mancare, in queste strutture aperte, sussurranti e potenzialmente<br />
infinite, è proprio il featuring di una personalità<br />
forte come Thom Yorke che sappia intersecarsi nei<br />
piani elettronici. L’album gioca consapevolmente con i<br />
propri limiti e conserva un suo fascino a patto che non<br />
rischi nelle citazioni (il piano di Rises Silent in evitabilissimo<br />
stile Pyramid Song). Dignitoso side project ma<br />
niente di più. Per ora.<br />
(6.8/10)<br />
Edoardo bridda<br />
CaShiEr no.9 - to thE dEath oF Fun (bElla<br />
union, agoSto 2011)<br />
Genere: inDie pop<br />
Una nota stampa che cita gli Stone Roses impone per<br />
lo meno di drizzare le orecchie al passaggio di questo<br />
gruppo di Belfast.<br />
In realtà, i rivoli di crema psycho folk che i Cashier<br />
No.9 riversano sull’ascoltatore incontra i temi floreali<br />
dei mancuniani solo nei suoi momenti più spediti, vuoi<br />
per una certa somiglianza del singer con le tonalità più<br />
alte della voce di Ian Brown, vuoi perché l’andamento<br />
soave e trasognato (al netto del groove danzereccio)<br />
dell’opener Goldstar ricorda il tema di Waterfall.<br />
Per il resto la grandeur un pò sognante, l’opulenza dei<br />
suoni (che porta ad esempio ad un utilizzo generoso di<br />
rulli di tamburi, xilofoni e synth a profusione) è quella di<br />
chi ha fatto propria la concezione barocca di Brian Wilson,<br />
Scott Walker e Phil Spector, seppur applicandola a<br />
melodie dal sapore West Coast e dall’appeal immediato<br />
(Lost At Sea, Goodbye Friend).<br />
I Cashier, peraltro, il loro Phil Spector lo hanno trovato<br />
nella figura del produttore David Holmes. E’ lui ad allestire<br />
una moderna versione del wall of sound, ricoprendo<br />
le melodie zuccherine di una patina opalescente che ne<br />
esalta la luminosità. Un gioco di riverberi che campisce<br />
ogni spazio donando ai brani quello stupore psichedelico<br />
che fa spiccare loro il volo.<br />
(6.9/10)<br />
diEgo ballani<br />
CauSa Sui - pEWt’r SESSion 2 (El paraiSo<br />
rECordS, luglio 2011)<br />
Genere: psicheDelia<br />
Avranno di che essere soddisfatti i patiti delle jam psichedeliche<br />
dilatate allo stremo con il volume 2 delle<br />
Pewt’r Session dei danesi Causa Sui. Lunghe improvvisazioni<br />
che passano in rassegna tutto il campionario<br />
pischedelico, dalle espansioni a la Grateful Dead fino<br />
allo space rock matrice Hawkwind, condito da abbondante<br />
salsa krauta. Quello che ricordano di più i Causa<br />
Sui sono gli Amon Dull II privi della carica misteriosa ed<br />
esoterica da sabba dei boschi mitteleuropei.<br />
L’apertura di Garden Of Forking Paths si apre con un<br />
andamento jazzato per poi sfociare in un profluvio di<br />
effetti wah e saliscendi chitarristici. Gelassenheit ricalca<br />
l’incedere di Hallogallo dei Neu! sbrodolandolo in una<br />
furia impro che perde le coordinate. La finale Brassica<br />
Blues mette i Led Zeppelin sotto codeina sfilacciando<br />
un hard blues per undici minuti. Pewt’r Session 2 è un<br />
disco più che dignitoso ma in cui alla fine a prevalere<br />
sono la caccia alla citazione e un’improvvisazione che<br />
sfocia sempre in suoni già noti.<br />
(6.3/10)<br />
FranCESCo aSti<br />
Chllngr - haVEn (grEEn oWl, luglio 2011)<br />
Genere: Dub-soul<br />
C’è chi con un sol disco battezza il suono del momento<br />
anticipandone i risvolti che verranno, e chi si limita a<br />
inserirsi in un continuum consolidato cavalcando l’onda<br />
del tempo. C’è un anno, questo 2011, che verrà ricordato<br />
per la tonificante irradiazione soul che ha ridisegnato<br />
gli equilibri evolutivi, illuminando con un raggio trasversale<br />
le mosse migliori in campo dub, r’n’b e dance.<br />
E infine c’è un producer danese, CHLLNGR, che arriva<br />
esattamente a metà dei dodici mesi e debutta con un<br />
album, Haven, che funge da perfetto riassunto di quanto<br />
recentemente detto nei vari avvicendamenti step da<br />
James Blake in avanti.<br />
Sarebbe stato il momento più favorevole per aggiungere<br />
altri elementi di novità, ma Haven non vuole partecipare<br />
alla competizione: sceglie invece di ripartire da<br />
tesi classicamente Burial (Ask For, Haven) per mettere di<br />
nuovo al centro la questione soul, secondo schemi già<br />
collaudati da Jamie Woon (i risvolti rhythm-and-dub di<br />
Sundown e Dark Darkness) e SBTRKT (le beat-illusioni<br />
di Dusty e May 3). Un occhio dunque che guarda deciso<br />
agli ambienti caldi di Londra, ma uno stile che mantiene<br />
comunque una propria freddezza climatica. Il disco piuttosto<br />
si adagia sulla tipica desolazione dub, che risorge<br />
dalle ceneri e si riscopre intimista e gelosa dei propri<br />
contenuti.<br />
CHLLNGR va in controtendenza: mentre tutt’intorno<br />
le voci si sovrappongono cercando di affermarsi sulle<br />
altre, lui si muove con passo felpato e carattere timido,<br />
non punta ad imporsi ma propende ad una partecipazione<br />
passiva. Fosse arrivato con nove mesi di anticipo<br />
avrebbe fatto il botto, oggi invece si attesta come disco<br />
di rappresentanza del sound dell’anno, a cui però manca<br />
il guizzo per distinguersi. Ma si sa, l’esordio in sordina è<br />
il miglior presupposto per stuipire al ritorno...<br />
(6.8/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
ClamS CaSino - rainForESt Ep (tri anglE,<br />
giugno 2011)<br />
Genere: hip hop / Downtempo<br />
Di Clams Casino, negli ultimi mesi, abbiamo parlato parecchio,<br />
ed ecco finalmente il suo nuovo attesissimo EP:<br />
Rainforest, seguito di quell’Instrumental Mixtape che l’ha<br />
fatto conoscere al mondo come uno dei beatmaker più<br />
interessanti in circolazione (anche grazie alla prolifica<br />
collaborazione con Lil B, il freak numero uno del rap<br />
statunitense oggi).<br />
Cinque tracce che confermano quanto di buono avevamo<br />
scritto sul suo conto. Il giovanissimo producer<br />
del New Jersey, infatti, è un grandioso talento dell’era<br />
Internet, fautore di paesaggi sonori dal notevole impatto<br />
emotivo, racchiusi in strumentali hip hop dal gusto<br />
classico ma contemporaneamente ipermoderno. Natural<br />
è un trip emozionale con pitch rallentato; Treetop<br />
si staglia su un sample chitarristico e field recordings;<br />
Waterfalls riprende le intuizioni dei brani precedenti e<br />
le estremizza; Drowning è come un mantra per nativi<br />
digitali; Gorilla chiude il pacchetto con un gran gioco<br />
di piatti e riverberi.<br />
Un altro strike, quindi, nell’attesa del nuovo album ufficiale<br />
di Lil B, intitolato I’m Gay, in cui si spera che la<br />
combo che ha dato vita ad un capolavoro come I’m God<br />
si ripeta su quei livelli. Aspettiamo fiduciosi.<br />
(7.4/10)<br />
Filippo papEtti<br />
Clap rulES - goldEn handS (bEar FunK,<br />
luglio 2011)<br />
Genere: Disco-electro-pop<br />
Quando, nel 2009, erano saliti alla ribalta con i 12’’ Old<br />
Sequencer e Buio Omega, i Clap Rules erano andati giù<br />
di nu-disco grintosi e svergognati, mirando con decisione<br />
a far ballare senza perdersi in divagazioni nobili.<br />
Quest’anno l’italianissimo trio composto da Fabrizio<br />
Mammarella, Andrea Gabriele e Massimiliano Leggieri<br />
approda sulla lunga distanza e sposta l’accento su un<br />
piano parallelo: tono ritmico alleggerito, ispessimento<br />
della densità electro e aderenza al formato pop, vale a<br />
dire più cura verso l’orecchio e un certo distacco dalla<br />
pista.<br />
In Golden Hands prevalgono dunque sound di maniera e<br />
formule collaudate, vedi la leggiadria Junior Boys di Oh<br />
Uiba e Silver Mountains o l’incedere dritto house-electro<br />
di Pericoloso e Approccio. Tra i momenti più riusciti il vocoder-pop<br />
di Get Excited, a metà tra i primi Daft Punk e<br />
l’ultimo Squarepusher, le movenze 4/4 ambient di Azzardo<br />
e una breve parentesi (Golden Hands) di quella<br />
space disco che trova oggi piena espressione con Massimiliano<br />
Pagliara. Nel complesso non ci sono grossi<br />
appunti da muovere, ma rimane la sensazione che i tre<br />
nostrani abbiano potenzialità maggiori di quelle effettivamente<br />
espresse sul disco. Fine lavoro di produzione e<br />
sound piacente che accontenta tutti, ma il groove killer<br />
dov’è finito?<br />
(6.1/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
Colin l. orChEStra - inFinitE EaSE / good<br />
god (northErn Spy rECordS, luglio 2011)<br />
Genere: neo-country<br />
Ne parlavamo in occasione della fine-corsa targata Usa<br />
Is A Monster, di cui Colin Langenus era la metà esatta.<br />
Ora le prime release della propria personale orchestra<br />
68 69
sono qui, ma prima di addentrarvici, sono necessarie un<br />
paio di premesse: 1) dimenticate le sfuriate neo-progmetal<br />
della casa madre e tutta la ludica follia che le caratterizzava;<br />
2) tralasciate di concentrarvi sul suffisso<br />
“Orchestra” perché, pur supportato da un numero indefinito<br />
di collaboratori (fino a trenta!), questo è il progetto<br />
in solo di Langenus; da lui parte e con lui si conclude.<br />
Detto questo, infilarsi in questi due distinti album - non<br />
un doppio, ma due entità distinte seppur pubblicate<br />
all’unisono e per la stessa label - è come infilare la testa<br />
nella terra della tradizione che più americana non si<br />
può. Country, in primo luogo. Psichedelia, in secondo.<br />
Diciamo un 60/30 per esprimersi in percentuali, col restante<br />
10% sparso abilmente tra southern-rock, qualche<br />
spruzzata jazzy, del sano r’n’r virato deserto e anche<br />
qualche punto di weirdismi vari. Al centro del tutto c’è<br />
sempre e solo lui, però. L’insano chitarrista dread-locked<br />
e dal barbone rosso fuoco mostra come agire fuori dagli<br />
steccati sia una necessità più che un mero vezzo, muovendosi<br />
agilmente tra forme sonore che mai ci saremmo<br />
aspettati di sentire da uno come lui. Mai sopra le righe,<br />
mai rumorosa in senso stretto, eppure rivoluzionaria nel<br />
suo essere ancorata ad una tradizione “altra” rispetto al<br />
sentire musicale di Langenus. Uno che per inciso ha<br />
trafficato con l’underground diy americano più torbido<br />
con la Massive Distribution e che ora stravolge se<br />
stesso tra nenie country assolate e dilatate (You Need<br />
Sleep), desert-rock made in Meat Puppets (Paradise) o<br />
stomp-rock tutto fiati e sudismo (Nothing To Say).<br />
Se Good God sembra quello più regolare nelle sue forme<br />
classiche, qualche svisata avant e qualche sperimentalismo<br />
weird in più li rintracciamo in Infinite Ease: il rumorismo<br />
di fondo che apre la cavalcata di Beer Can, la<br />
psych solipsistica di Descaped, le lunghe dilatazioni di<br />
Hold Tite e Best Thing dicono di una eccentricità da intendersi<br />
etimologicamente come allontanamento da<br />
un centro indefinito e, insieme, fuga verso nuovi mondi<br />
da esplorare.<br />
(7.2/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
Comma - ViSionario (mK rECordS, giugno<br />
2011)<br />
Genere: cantautorato wave<br />
Coniugare un certo gusto anglofono con la tradizione<br />
cantautorale italiana non è mai stata cosa semplice. Il rischio<br />
di cadere nel retorico, nel già fatto, nello scimmiottamento<br />
o peggio ancora nel plagio, incombe sovrano.<br />
Trovare una soluzione originale e innovativa, in questo<br />
genere, è sempre obiettivo particolarmente difficile da<br />
raggiungere. In questo senso Comma, all’anagrafe Pier-<br />
paolo Mazzulla, insieme al suo alterego di penna Andrea<br />
Orlando, ci riesce molto bene, inventandosi in Visionario<br />
una terza via che se da un lato ha sì tanti riferimenti arcinoti<br />
(Ivan Graziani, Mario Venuti, Moltheni), dall’altro<br />
ha la maturità artistica di riprenderli e scriverci sopra<br />
qualcosa che si posiziona sia su una linea di continuità<br />
che di rottura, prendendo in prestito lo stretto necessario<br />
per metterlo in mostra alla giusta occasione.<br />
Lo fa in un susseguirsi di viaggi interiori e intimisti, ma<br />
anche raccontandoci semplicemente la vita di tutti i<br />
giorni: quella semplicità disarmante che solo la quotidianità<br />
sa dare. La titletrack è la ricetta ideale per chi si<br />
avvicina a questo disco. Una sorta di guida all’ascolto, di<br />
premessa intenzionale: “solo un visionario può cambiare<br />
la realtà/solo un visionario può far crollare un muro”. Romantica<br />
ballata di quelle che non si ascoltavano da tempo,<br />
Tramonto è un ottimo esempio di come il cantautore<br />
calabrese sappia giocare molto bene con melodie ariose<br />
e immaginifiche, mai mero accompagnamento ma volto<br />
a formare con le liriche un connubio inscindibile. Granello<br />
di Cielo, lievemente dipinta da un solitario pianoforte<br />
da bistrot francese, è l’emblema della piacevole leggerezza<br />
di un disco che fa incontrare scanzonati momenti<br />
pop rock (Anime, Due Corpi) e fotogrammi di riscatto<br />
sociale (L’escluso).<br />
Canzoni nell’accezione più italiota del termine: da canticchiare<br />
e strimpellare, senza astruse pretese storiche<br />
ma con l’ambizione, tutt’altro che scontata, di emozionare<br />
ed emozionarsi, far riflettere riflettendo. E di questi<br />
tempi non è poca cosa.<br />
(6.9/10)<br />
gianluCa lambiaSE<br />
CSS - la libEraCiòn (CoopEratiVE muSiC,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: pop<br />
Come gli Wombats un anno dopo, ma nel rispettivo<br />
ambito elettro-contaminato, i brasiliani CSS erano, nel<br />
2006, una perfetta cartina al tornasole di ciò che era<br />
andato nei primi Duemila. Mescolavano punk e pop,<br />
sintetico e rock e se avevano senz’altro avuto il merito<br />
d’allungare la vita all’electro-clash (Chicks On Speed)<br />
rappresentavano la classica bolla speculativa per chiunque<br />
- dall’ascoltatore indie-generico (Off The Hook) al sofisticato<br />
divoratore p-funk (Music Is My Hot Hot Sex, Let’s<br />
Make Love and Listen to Death From Above) e di videoclip<br />
(Alala), dal discografico (Sub pop, Warner) al produttore<br />
videogame (Fifa, Midnight Club: Los Angeles...) - volesse<br />
vederci/respirarci/viversi una fetta di fugace inizio millennio<br />
abulimicamente citazionista.<br />
Con il successivo Donkey, e gli 80s che iniziano a spin-<br />
highlight<br />
bEirut - thE rip tidE (pompEii rECordS, agoSto 2011)<br />
Genere: fanfara pop<br />
Un percorso in salita con una pausa prima della meta, così si configura oggi il cammino di Zachary Francis<br />
Condon all’indomani dell’uscita di The Rip Tide, album definitivo di un ragazzo che da caso indie si è<br />
trasformato in un icona pop al pari di Arcade Fire, The National e Sufjan Stevens.<br />
La sua è una di quelle classiche storie a lieto fine: prima c’è stata la Gulag<br />
Orkestar, l’inserimento in una effervescente scena di nuove espressioni balcaniche<br />
non ordinariamente etniche quali A Hawk And a Hacksaw e Matt<br />
Elliott, poi il consolidamento della formula trans-balcanica con il sophomore<br />
The Flying Club Cup, e quindi il momento di riflessione e la conseguente<br />
mosse di lato: un doppio eppì diviso tra divagazioni messicane con la Jimenez<br />
Band di Oaxaca e una manciata di vecchie tracce elettroniche composte<br />
in gioventù sotto il nome di RealPeople.<br />
Ora a quattro anni di distanza, abbiamo le canzoni di quest’album, scritte<br />
nell’inverno scorso a New York e lungamente testate dal vivo (East Harlem compare già in Beirut: Live<br />
at the Music Hall of Williamsburg del 2009). Zac partorisce la sua versione della serenata pop-folk per il<br />
Sud del Mondo, qualsiasi esso sia, un cuore imbevuto di struggente malinconia e fanfare sul perimetro,<br />
mansuete, bofonchianti, a far da sfondo o da snodo. La melodia è padrona.Strofe e ritornelli dunque al<br />
comando e, in cima, il crooning, severo e imperturbabile, perfetto, quasi monocromatico ma compensato<br />
egregiamente dal songwriting (specie nei brani basati sull’accompagnamento al piano - Vagabond).<br />
Sterilizzando gli ottoni (A Candle’s Fire, Payne’s Bay, Port Of Call, The Peaock), e surfando sull’effetto cartolina<br />
impolverata del West, Zac ne esce con un trittico di classici istantanei come la citata Santa Fe, unica<br />
traccia ad avere un arrangimaneto elettronico (omaggio alla città dove Zac è nato anche artisticamente),<br />
l’accorata East Harlem (per chitarrina e fiati in background) o l’ancor più solitaria Goshen 1 (piano, voce<br />
e crescendo ai fiati).The Rip Tide è l’album definitivo per Beirut. Trentatrè minuti di titoli di coda. Il poi<br />
si vedrà.<br />
(7.35/10)<br />
Edoardo bridda<br />
gere (Move), i ragazzi si reinventano senza lo stesso<br />
successo (Left Behind), abbandonano l’indie-electro più<br />
ruspante, compattano e puntano svogliatamente alle<br />
radio fm e a quell’America che li ha sempre visti con<br />
freddezza e, a tempo perso, iniziano a giocare d’anticipo<br />
sui Novanta (Rat Is Dead (Rage)). Risultato: consolidamento<br />
di una nicchia mainstream “di riserva” negli UK,<br />
due passi indietro nelle charts dei singoli (tranne in Finlandia!?)<br />
e sbuffo del mondo internettaro che reclama<br />
ricordi 80s da immaginario collettivo e non l’ennesimo<br />
revival dell’intorno 78-84 (il p-funk di Jager Yoga o la<br />
mutant disco Reggae All Night).Con La Liberación, i CSS<br />
ritornano alle origini ma ritentano la scalata americana<br />
con le proteiche I Love You e City Girl che strizzano l’occhio<br />
all’infantilismo di Katy Perry e alla fake riotness di<br />
Ke$ha (vocoder compreso), e provano a condirli con<br />
i triti trucchetti punky degli esordi (lisergiche MGMT<br />
o sintetiche nu rave). Sono episodi piuttosto isolati e<br />
fortunatamente con il tropicalismo scazzato e divertito<br />
le cose vanno nella dirazione giusta salvo scadere in ritornelli<br />
da corso all’acquagym (Echo Of Love) o banalizzazioni<br />
Chicks On Speed (You Could Have It All).<br />
E’ un vero peccato che metà dell’album se ne vada in<br />
questa direzione quando era stata una bella Hits Me Like<br />
A Rock con tanto di cameo di Bobbie Gillespie (Primal<br />
Scream) ad anticipare l’intero album tra morbidezze 80s<br />
e vintage funk. Il rischio più grave, del resto, è quello di<br />
mandare all’aria una seconda parte che matura i citati<br />
tagli 90s di Donkey con risultati soprendentemente<br />
adulti. Lovefoxxx migliora la cadenza di qualche strofa<br />
in slacker punk (Rhythm To The Rebels) e il bassista e produttore<br />
del disco Adriano Cintra ci mette l’ideale mix di<br />
strati produttivi (Fuck Everything).<br />
Non sono male i brasiliani quando macinano la verve<br />
urban che va dai Sonic Youth alle Throwing Muses<br />
passando persino per i Pulp e una coda al pianoforte<br />
70 71
dell’ospite Mike Garson, session man per il bowiano Alladin<br />
Sane (Partners In Crime). E’ questo il nuovo volto<br />
radical chic del combo brasiliano (bella anche Red Alert),<br />
ancora pop-punk ma animato - e bentornati aggiungiamo<br />
- di sincera urgenza e fors’anche una rinnovata<br />
consapevolezza. Peccato per le schifezzuole nella parte<br />
iniziale.<br />
(6.5/10)<br />
Edoardo bridda<br />
daVE Cloud & thE goSpEl oF poWEr -<br />
praCtiCE in thE milKy Way (FirE rECordS,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: american white trash<br />
Bisognerebbe sempre andarci piuttosto cauti con i cosiddetti<br />
“miti underground”: basta un alone di stranezza<br />
ed ecco che ti spacciano per genio un semplice mestierante.<br />
Diteci infatti cosa c’entra mai lo sciamanesimo tirato<br />
in ballo dall’etichetta con il sig. Cloud, che da un<br />
quarto di secolo pare delizi con incendiare esibizioni dal<br />
vivo il sottobosco di Nashville. Sarà probabilmente un<br />
mago sulle assi di un palco, costui, nondimeno l’ascolto<br />
del suo nuovo disco restituisce cinquantacinque minuti<br />
di noia a tratti sconfinante nel puro fastidio.<br />
Una confusione dilettantesca che fa apparire Deviants e<br />
Butthole Surfers dei freschi diplomati di conservatorio<br />
- con però molta più creatività e gusto - e che ha spinto<br />
in passato l’altrimenti serio The Wire a definire Cloud un<br />
incrocio tra Roky Erickson e Charles Bukowski. Fosse<br />
vero soltanto la metà, questo poetastro dall’insopportabile<br />
birignao declamatorio caverebbe di tasca ben altro<br />
che tediosi siparietti esotici, ballate legnose e tremolanti<br />
atmosfere in bilico tra calligrafismi funk, space-rock<br />
e surf, che spesso alterna con una manovalanza hard<br />
da motociclisti del tutto priva di mordente e attributi.<br />
Accozzaglia tale da indurci a pensare dove stia, nel<br />
rutilante mondo della stampa musicale, il confine tra<br />
sprovveduto e furbacchione.<br />
(4.5/10)<br />
gianCarlo turra<br />
daVid thomaS broughton - outbrEEding<br />
(brainloVE rECordS, giugno 2011)<br />
Genere: folkpop<br />
Un talento purissimo. Dice qualcuno che il talento è la<br />
dote di sapersi fidare dell’istinto. Il capolavoro The Complete<br />
Guide to Insufficiency - già da allora si capiva<br />
ma a un lustro di distanza non mancano le conferme - è<br />
fatto di questo. Intuiva genialmente che si potesse fare<br />
musica minimalista prendendo i mattoni dagli stilemi<br />
del folk anglosassone. E, istintivamente, David Thomas<br />
Broughton canta senza pensarci, facendo che quegli<br />
stilemi vengano a lui, senza fatica - motivo per cui non<br />
manca di detrattori, che poco riguardo gli riservano, una<br />
volta nominate le derivazioni vocali e pathos da Anthony<br />
o Devendra Banhart.<br />
Le canzoni di Outbreeding sono articolazioni di un<br />
“buon senso” cantautoriale, tutto suo e del tutto coerente<br />
con gli anni in corso. Lo shift, rispetto a The Complete<br />
Guide e al precedente It’s in There Somewhere (fatti<br />
salvi alcuni casi, come Potential Of Our Progeny), è la dimensione<br />
band-oriented, l’uso di una batteria, di una<br />
chitarra, a volte di un pianoforte, di strumenti arrangiati.<br />
La voce raggiunge l’intensità a cui siamo abituati, tocca<br />
vette di svenevolezza, è sempre al centro dell’attenzione.<br />
David sospende però la tecnica tutta personale di<br />
coltivazione del frammento, prende a strutturare ciò che<br />
ha sempre lasciato all’ascoltatore, cioè la ricostruzione<br />
emozionale, aldilà della fruizione, dei brani. Ci si chiede<br />
cosa possa servire a Broughton una dimensione tanto<br />
tradizionale, se e in che modo riesca ancora a cadere<br />
in piedi. La risposta è contenuta in Staying True, una su<br />
tutte. Riscatto di scrittura e di arrangiamento, manifesto<br />
per la nuova personale onda. La canzone “chiusa” che<br />
chiude il capitolo canovaccio, forse.<br />
Non mancano certo, almeno nei titoli, le ripetizioni dal<br />
precedente It’s in There Somewhere (Ain’t Got No Sole,<br />
Nature). Eppure le due coppie di versioni sono aliene le<br />
une alle altre. Outbreeding è un altro mondo dove le<br />
cose che si chiamano alla stessa maniera sono diverse.<br />
Istintivamente continueremo a cercare sue notizie, a seguire<br />
le vicende di David, avendone colto l’intensità rara<br />
e la capacità di sorprendere con l’instabilità.<br />
(7.2/10)<br />
gaSparE Caliri<br />
dEEpChord - haSh-bar loopS (Soma<br />
rECordS, luglio 2011)<br />
Genere: tech-house<br />
Anche solo nelle nelle zone di contatto con deep e ambient-noise,<br />
la superiorità della formula techno-dub di<br />
Deepchord è fuori discussione: The Coldest Season<br />
è probabilmente una delle pagine più belle degli anni<br />
Duemila in quest’ambito e Liumin, dello scorso anno,<br />
un degno seguito che ha avuto il merito di divulgarne<br />
il verbo oltre i classici confini dell’elettronica. Con<br />
Hash-Bar Loops, registrato dal solo Rod Modell ad Amsterdam<br />
e pubblicato da Soma Records, il leggero calo<br />
di qualità dal 2007 a oggi va rilevato ma, di sicuro, non<br />
stigmatizzato.<br />
Senza Hitchell, Rod concentra maggiormente l’attenzione<br />
sull’ambient (il taglio Pan American di Spirits) e i<br />
minimal groove (Stars, City Center), tra beat chicagoani<br />
(Sofitel), latitudini marittime (i micro-tagli folk di Merlot)<br />
e altrettanto note basi propriamente techno (l’ordinaria<br />
Tangier e la più magmatica Electromagnetic); ritornano<br />
perciò fondamentali l’esperienza da solista (ricordiamo<br />
come sempre il capolavoro personale Incense & Black<br />
Light) e soprattutto l’uso del field recording, qui particolarmente<br />
rivolto allo studio della percezione del<br />
suono da club.<br />
Claps ridotti a phonoregistrazioni di sfregamenti di<br />
foglie (Oude Kerk) o sgocciolamenti dai tubi (Crimson),<br />
sporadiche voci lontane, riverberi del cemento e una costante<br />
cassa davvero subacquea (come se stessimo fuori<br />
del club dietro alla porta tagliafuoco di sicurezza - Balm -<br />
oppure nel bar in fondo a un lungo corridoio - Crimson)<br />
fanno di Hash-Bar un concept per esistenzialisti in pausa<br />
sigaretta che guardano il cielo fuori dal main stage con<br />
Biosphere in cuffia e i bpm ancora in corpo; un piede<br />
appoggiato al muro di una Amsterdam in ricordo Rave<br />
(Black Cavendish) e occhi fissi a guardar ebeti qualche<br />
particolare industriale nel capannone occupato (Neon<br />
And Rain).Diventa chiaro che il sound designer ci racconta<br />
le stesse cose di sempre scegliendo, di volta in<br />
volta, un’angolazione e setting di base differenti: Tokio<br />
era più omogenea e tech, la capitale olandese più magmatica<br />
e house. La maniera di una formula definitiva si<br />
rinnova grazie a un vecchio prefisso della critica musicale:<br />
art-dub-techno.<br />
(7/10)<br />
Edoardo bridda<br />
dESErt motEl - yarn (SoFa rECS, agoSto<br />
2011)<br />
Genere: inDie rock<br />
Li ricordo quattro anni fa all’esordio con un Out For The<br />
Week End ep che, come si dice, basta il titolo. Figuriamoci<br />
se un inveterato younghiano come il sottoscritto<br />
poteva non apprezzare. Poi dei Desert Motel non ho<br />
saputo più nulla fino ad oggi, allorché mi viene recapitato<br />
Yarn, l’esordio su lunga distanza per Sofa Recs. Che<br />
mi ha riservato qualche motivo di stupore. Pare proprio<br />
infatti che il quartetto di Aprilia capitanato dal chitarrista<br />
e cantante Cristiano Pizzuti, abbia allargato il raggio<br />
d’azione risciacquando i panni alt-country in un acidulo<br />
intruglio british. Ferma restando - bontà loro - la nota<br />
destrezza compositiva. Ed ecco quindi che gran parte<br />
delle dodici tracce in scaletta strizzano l’occhio ai palpiti<br />
indie-rock d’Albione, vedi quella Misery Road come potrebbero<br />
certi I Am Kloot, una Something che riverbera<br />
languori Oasis e le particelle Beatles di Valentine’s Gone.<br />
Discorso simile per una Flowers che addirittura scomoda<br />
impeto post-wave, mentre Let It Shine persegue carezzevoli<br />
mestizie acustiche che avrebbero spopolato in<br />
epoca NAM.<br />
Poi, siccome l’imprinting è una cosa seria, riaffiora eccome<br />
l’antica fregola Wilco - versante elettrico - nelle<br />
baldanzose trepidazioni di Paperstars e Kurtz. E’ un<br />
pendolare estetico tutto sommato intrigante, ancor più<br />
quando una Brugge, Belgium si aggira tra le coordinate<br />
con fare deliziosamente ibrido, cosa che fa - ancor più<br />
significativamente - pure quella Paths che ricordiamo<br />
nel suddetto ep in versione roots. Preso atto della nuova<br />
situazione, va detto che l’ascolto è gradevole anche<br />
se rispetto agli impegnativi modelli di riferimento paga<br />
dazio in termini di soluzioni sonore (puntuali ma abbastanza<br />
prevedibili) ed interpretazione (il canto si canta<br />
un po’ addosso con fare legnoso). Devono farne insomma<br />
di strada, i Desert Motel. Se scattano gli interruttori<br />
giusti, potrebbero farla davvero.<br />
(6.7/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
dEuS - KEEp you CloSE (piaS, SEttEmbrE<br />
2011)<br />
Genere: rock<br />
Tre anni dopo aver consolidato il ritorno a pieno regime<br />
col più che discreto Vantage Point, i Deus ribadiscono<br />
il concetto col tipico album da rock-band matura. Detta<br />
altrimenti, la scaletta di Keep You Close mette in fila<br />
nove pezzi piuttosto ispirati e ben confezionati, forse<br />
la miglior collezione dai tempi di The Ideal Crash. Non<br />
fa né meno né più di questo. E lo fa piuttosto bene: le<br />
turbe Nick Cave via Afghan Whigs di Darks Sets In (non<br />
a caso troviamo il caro Greg Dulli ai cori, come anche in<br />
Twice), il rigurgito eighties di Constant Now (particelle<br />
INXS e Police in fregola Wall Of Voodoo), le inquietudini<br />
gotiche di The Final Blast e una title track che spennella<br />
romanticismo noir innervato d’archi e xilofono, valgono<br />
abbondantemente il prezzo del biglietto. Sarebbe<br />
perciò intellettualmente disonesto non considerarlo un<br />
buon disco.<br />
D’altro canto, non possiamo esimerci di tornare con la<br />
mente a quei Deus che rappresentarono una possibilità<br />
di rock “diversamente indie” nei Novanta: lo spiffero nel<br />
vaso di Pandora da cui sprizzavano spiritelli zappiani,<br />
inquietudini mitteleuropee, foghe noise, allucinazioni<br />
cabarettistiche e improcrastinabili struggimenti. Ecco,<br />
di quel brio versicolore e indocile, non è rimasto praticamente<br />
nulla, barattato alla pari con la padronanza<br />
dei mezzi e la lucidità calligrafica. Poco male, si sa<br />
come vanno queste cose. Gli anni passano, cambiano<br />
gli obiettivi, si smerigliano le fregole eccetera eccetera.<br />
72 73
highlight salmente tocca proprio ad un brano intitolato La Noia<br />
Cut handS - aFro noiSE (SuSan laWly, luglio 2011)<br />
Genere: afro-harsh-noise<br />
E così, mentre un Bennett - Tony - compie operazioni di necrofilia scorretta riesumando la salma/voce<br />
di Amy Whinehouse a nemmeno un mese dal trapasso, un altro Bennet, molto più efferato e privo di<br />
umana compassione (così come di meri istinti economici), compie una operazione di necrofilia corretta.<br />
Assonanze Bennett-Whinehouse / Bennett-Whitehouse a parte, la distanza tra i due mondi è a dir poco<br />
siderale. Mr William Bennett aka Whitehouse, smette i panni del violentatore<br />
sonico col quale si mostra da decenni sul panorama harsh-industrial<br />
e power-electronics mondiale per indossare quelli a nome Cut Hands. Efferato<br />
lo stesso, a ben vedere, ma lievemente più intelligibile e piuttosto<br />
sorprendente se non si conosce la vita recente del solitario noiser inglese.<br />
Afro Noise mette infatti le asperità Whitehouse al servizio dell’afro-sound<br />
percussivo di cui ultimamente, vedi alla voce Congotronics, il mondo occidentale<br />
ha conosciuto il valore primordiale, la profondità ancestrale e<br />
l’assoluto fascino a fronte di una povertà di mezzi (produttivi, oltre che di<br />
materie prime) incredibile. Bennett sposta l’attenzione non solo sul Congo ma anche sul Ghana e sui suoi<br />
funeral drumming per innescare una bomba ritmica a metà tra l’analogico e il digitale. Vera e propria<br />
tempesta di percussività primordiale che assume le forme della ossessiva reiterazione ritmica (l’opener<br />
Welcome To The Feast Of Trumpets), della techno terzomondista (Stabbers Concpiracy), della poliritmia<br />
(Shut Up And Bleed) non disdegnando efferatezze harsh (le lancinanti scudisciate di Munkisi Munkondi o<br />
i sibili stracciaorecchie di Nzambi Ia Lufua) e squarci di stasi synthetica (++++ Four Crosses).<br />
Non una novità questi contatti con mondi “altri”. Bennett ne ha recentemente dato prova in composizioni o titoli<br />
come Munkisi Munkondi (da Bird Seed del 2003), Nzambi Ia Lufua (in Cruise del 2001) e Bia Muntati (da Racket)<br />
tutte presenti in Afro Noise così come in quella opera di rielaborazione del Bennett-pensiero che fu Whitehouse<br />
Electronics ad opera del collettivo Zeitkratzer. Così come è una sorpresa scoprire che ci sia proprio lui dietro la<br />
compilation Estreme Music From Africa del 1997, una delle prime testimonianze della musica off africana.<br />
Whitehouse goes to Africa? Noi apprezziamo, pur rimanendo sempre più perduti nelle pieghe del suono<br />
di un progetto tra i più avanguardistici di sempre.<br />
(7.3/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
Però, che vi devo dire: a me questo programmino dal<br />
tiro ragguardevole, prodotto con la sagacia del caso, fa<br />
un po’ l’effetto di un panino dopo un’anatra all’arancia.<br />
Va bene giusto per completare il ciclo dell’appetito.<br />
(6.6/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
diliS - nulla da CapirE (SEahorSE<br />
rECordingS, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: cantautorato rock<br />
E’ di una leggerezza quasi irritante il nuovo disco dello<br />
stabiese Dilis, moniker dietro al quale si nasconde<br />
Pietro Di Lietro, già cantante e chitarrista dei La Condizione<br />
Danzante. Dal titolo vagamente de gregoriano,<br />
Nulla da capire è un lavoro omogeneo, ben curato,<br />
piacevole fin troppo. Chitarre acustiche ed elettriche<br />
sono più che sufficienti all’artista campano per disegnare<br />
carezzevoli e struggenti melodie in un folk altisonante,<br />
ricco di fascino e gusto. Nick Drake, Jeff<br />
Buckley, Damien Rice rappresentano quasi dichiaratamente<br />
i punti di riferimento: rincorsi, riletti, cercati,<br />
celebrati.<br />
E in parte il gioco riesce pure. Il vero limite - da prendere<br />
ad ogni modo con i guanti trattandosi di un lavoro che<br />
nel complesso supera ampiamente la sufficienza - sta<br />
nei testi poco convincenti, distonicamente lontani, a<br />
loro modo ripetitivi nel descrivere una condizione di<br />
precarietà interiore o relazionale ben inquadrata in Fatti<br />
distanti. Ci si muove poco e male, sicuramente non all’altezza<br />
delle più che buone soluzioni armoniche. Parados-<br />
il compito di dare una ventata di risveglio ad un lavoro<br />
che rischia di far fatica a catturare l’attenzione dell’ascoltatore<br />
per la sua intera durata. Un album che rimane<br />
comunque suonato molto bene e che strumentalmente<br />
ha delle perle da non trascurare (la titletrack, Ti Mostrerò,<br />
la fiammeggiante Kaos Kafè): idee interessanti che con<br />
testi più variegati e un cantato meno ammiccantemente<br />
sussurrato, potrebbero raggiungere risultati notevoli.<br />
Le qualità non mancano di certo. La rabbiosa, conclusiva<br />
e sferzante Diventiamo Cattivi ne è la riprova, andandosi<br />
a posizionare esattamente all’interno di questo solco:<br />
meno sdolcinato e più romantico, meno sussurrato e più<br />
onirico, meno ermetico (sic!) e più vissuto. Ti vogliamo<br />
più cattivo, Pietro. Speriamo di averti fatto arrabbiare<br />
abbastanza.<br />
(6.6/10)<br />
gianluCa lambiaSE<br />
diStanCE (uK) - dubStEp allStarS - Vol. 8<br />
(tEmpa, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: Dubstep<br />
Greg Sanders aka Distance, ovvero, dell’oscurità e<br />
dell’atmosfera, il lato più riffettoso e pro-club della<br />
scuola dubstep, la scienza del basso tremolante roboassistito,<br />
il boomerang che raggiunge Scorn e torna in<br />
mano.<br />
Il prime mover della scena dubstep, tempo fa DJ per l’ex<br />
radio pirata Rinse FM (oggi convertita in passaparola<br />
pseudo-commerciale del genere), firma l’ottavo capitolo<br />
della saga più famosa e rappresentativa delle collane<br />
del dubstep con una combriccola del blasco formata<br />
da, tra gli altri, Benga, Cyrus, Tunnidge e naturalmente<br />
Pinch, personaggio di culto con il quale l’uomo divide il<br />
progetto Deleted Scenes (resuscitato per l’occasione).<br />
18 su 25 sono tracce esclusive, dubplate che il dj e<br />
producer custodiva gelosamente. Ben otto sono sue.<br />
E’ l’impronta, forte e coesa, di una tracklist che pivota<br />
sci-fi (la sua Knowing) e una generosa manciata di coriacei<br />
giri di wobble-dub cartilaginosi (Troubles, ancora<br />
di Distance) dove non c’è scampo se non accendendo<br />
la vista al calore.<br />
Circondato da bestie aliene, rettili (Out Of Reach di<br />
V.I.V.E.K) e cyborg di carne e circuiti (una bomba a mano<br />
come Ultimate Moment di Deleted Scenes), Sanders è<br />
entrato nel cono d’ombra. Gli electro headz modaioli<br />
gli preferiranno il pop (James Blake, Magnetic Man,<br />
Katy B.), l’intellighenzia europea il mash live di Roska<br />
o Kode9 ma appunto per questo l’ortodossia è importante.<br />
Chiamiamolo Predator-step, quando l’half step<br />
di gente come Kryptic Minds (la citata Transcendent)<br />
ne è l’aspetto più audiofilo. In entrambi i casi, si scava<br />
in profondità. Fin che ce n’è.<br />
(7/10)<br />
Edoardo bridda<br />
dJ ShadoW - i’m ExCitEd Ep (iSland, luglio<br />
2011)<br />
Genere: rockinG beats<br />
Shadow aggiunge al già buono I Gotta Rokk EP una<br />
seconda preview dell’album che uscirà il prossimo settembre.<br />
Quattro brani che spaziano dal rocking-ghetto<br />
‘molto’ M.I.A. di I’m Excited (con il featuring di Afrikan<br />
Boy), alla sperimentazione doom-elettronica della stupenda<br />
Banished And Forsaken, che ricorda le atmosfere<br />
più intimiste e ambient dell’esordio, tagliando con vocals<br />
ereditati direttamente da film horror che rimandano<br />
alle visioni più cupe della Londra underground e aggiungendo<br />
pure qualche rasoiata industrial e qualche<br />
colpo percussivo kraut.<br />
Nel ‘lato B’ c’è poi la visione rock psichedelica e profondamente<br />
californiana di Come On Riding, con classici<br />
riff e backing vocals à la Eagles che distende gli<br />
animi e prepara per la conclusiva Let’s Get It, miscuglio<br />
di assoli trash metal, hip-hop, folk e bbreaking<br />
elettronico dove ovviamente Shadow si accasa più<br />
facilmente.<br />
Le tracce di questo EP - a sentire il blog della crew<br />
Solesides - dovrebbero tutte comparire nell’album,<br />
ma per non sbagliare è meglio accattarselo. L’uomo<br />
si assesta su una buona media e ha qualche picco di<br />
eccellenza, che speriamo venga bissato su più episodi<br />
nel full. Una buona prova di resistenza sul campo per<br />
Josh.<br />
(6.8/10)<br />
marCo braggion<br />
domEniCo lanCEllotti - CinE priVê<br />
(malintEnti diSChi, agoSto 2011)<br />
Genere: new brazilian sounD<br />
Dopo aver trascorso gli anni zero ad azzardare rock<br />
sperimentale nei Mulheres que dizem sim e scozzare<br />
samba, psych e funk nei Domenico +2 (assieme ad<br />
Alexandre Kassin - già collaboratore di Arto Lindsay - e<br />
Moreno Veloso, figlio di Caetano), e dopo essersi fatto<br />
conoscere dalle nostre parti per aver partecipato alla<br />
rilettura della celentanissima Svalutation operata dai<br />
siciliani Akkura, il carioca Domenico Lancellotti - suo<br />
padre è il compositore di origine calabrese Ivor Lancellotti<br />
- giunge oggi all’esordio solista con questo Cine<br />
privê, da lui stesso prodotto mentre al missaggio ha<br />
pensato un pezzo da novanta come Mario Caldato Jr.<br />
74 75
highlight go ancestrale timeless e boundless innervato da una<br />
dEEp88 - CollECting duSt (12 rECordS, ottobrE 2011)<br />
Genere: italo-Deep<br />
Se vogliamo quantomeno arginare la fuga di cervelli musicali verso le label straniere (Eskimo Recordings,<br />
Gomma e BPitch ne sanno qualcosa), sarebbe il caso di tenerci stretti talenti nostrani come Alessandro Pasini.<br />
A maggior ragione se la formula è di quei prodotti italici che all’estero farebbero faville: il primo fulllenght<br />
a nome Deep88 offre una frizzante deep-house analogica pulita e<br />
rifinita con cura, con un imprinting classico ed un’eleganza più europea che<br />
liviense (la cassa dritta su tappeti synth di Summer Just Can’t Wave Goodbye<br />
e Coast To Coast tiene vicine tanto la moderna Germania di Mathias Kaden<br />
e Paul Kalkbrenner quanto la ambient-house britannica dei 90s). Un album<br />
dal carattere preciso, denso di quell’immancabile melodicità italo-disco che<br />
avvicina il tutto al sound sul quale Guglielmo Bottin sta costruendo la sua<br />
fama (Don’t Play Minimal, Play Minigolf, italians do house-disco better).<br />
Il ragazzo sa alimentare anche il lato più pop-oriented di Italo82 (sì, le radio<br />
potrebbero sforzarsi di più) o Funkanova (coi contributi vocali di The Huge a completare il mix ideale),<br />
e mostra disinvoltura di manovra lounge (G# Point, Stories) o jazz (House Is Coming, con citazioni di lusso<br />
verso i mostri sacri Larry Heard e Chuck Roberts a chiudere il cerchio della classicità). C’è tanta storia<br />
house in Collecting Dust, e vale soprattutto come riscoperta delle buone abitudini, una genuinità che<br />
premia in termini di spontaneità. Nel mondo perfetto le etichette locali avrebbero fatto a pugni per<br />
accaparrarselo e pomparlo a dovere, la dura realtà invece è che lui è finito in Germania e noi rischiam<br />
di restare con un pugno di mosche...<br />
(7.2/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
Dieci tracce che trasfigurano l’innesco bossa tra morbide<br />
nostalgie exotica e vaticini sintetici ipotizzando<br />
tropicalismo fragrante e contemporaneo. O, per usare<br />
le targhette del caso, Musica Popular Brasileira contagiata<br />
dal germe Brazilian Electronica, ferme restando<br />
però le radici della questione, siano esse la sensibilità<br />
acustica (Os Pinguinhos, Fortaleza) o il dinamismo percussivo<br />
(l’acidità dinoccolata di Pedra e Areia). Languida<br />
e futuribile, l’idea musicale di Lancellotti mira quindi ad<br />
un intrattenimento corroborato di implicazioni auditive<br />
complesse, vedi quella Receita che cincischia affabile e<br />
meditabonda per poi pennellare il ritornello d’estro spacey<br />
Terry Riley, oppure la formidabile Zona portuària<br />
che non spiacerebbe al David Byrne eniano, o ancora<br />
la title track pervasa di solleciti miraggi Steely Dan via<br />
dEUS. Impossibile poi tacere riguardo allo zuccherino<br />
di Su di te, adorabile italo-soul a base di sentimenti formattati<br />
sul miglior garbo malinconico sixties.<br />
(7.2/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
drEam WEapon ritual - anothEr ViEW<br />
(magiCK With tEarS, luglio 2011)<br />
Genere: etno-psych<br />
C’è irrimediabilmente l’umore della Sardegna mitica,<br />
ancestrale e meno à la page nelle note di Another View.<br />
Quello che i due ex T.A.C. Simon Balestrazzi e Monica<br />
Serra affidano alla nuova sigla Dream Weapon Ritual è,<br />
come da titolo, uno sguardo “altro”, scevro di qualsiasi<br />
implicazione etnica o folklorica ad uso mass-mediatico<br />
e ideale per inscenare una mini sinfonia in due soli atti<br />
(Unending Green Waves e Big Hungry Birds) in cui umori<br />
psichedelici e folkerie varie, evanescenze ambient e afflato<br />
sperimentale, eteree ambientazioni e spiritualità<br />
(semi)pagana convivono naturalmente in un unicum<br />
coeso e affascinante.<br />
Calarsi nell’ascolto dei flussi di coscienza improvvisati<br />
dei due autori su basi insieme acustiche e elettroniche<br />
(chitarre classiche ed elettriche, tanpura elettronico, salterio<br />
preparato, kaos pad e altro ancora), diviene così<br />
una sorta di stargate, un portale attraversando il quale<br />
si viene calati nell’immaginaria atlantide nostrana, luo-<br />
sensibilità che si direbbe più naturalista che esoterica.<br />
Perdersi è, come capirete, facile in questo mare, così<br />
come il rimanere appagati da tale stordimento seppur<br />
la durata esigua precluda abbandoni totali.<br />
(7/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
Edo - pEr VEdErE loSt (autoprodotto,<br />
FEbbraio 2011)<br />
Genere: italiana, pop<br />
Edoardo Cremonesi, classe 1986, qualche anno fa si è<br />
paracadutato sul palco di TRL per farsi autografare la<br />
chitarra dal cantante dei Muse. Tale chitarra fu poi utilizzata<br />
dal nostro per suonare nel suo gruppo grunge<br />
dell’epoca, gli Isterica. Per avventurarsi nel suo esordio<br />
cantautorale, queste due informazioni sono un buon<br />
punto iniziale. Edo, pur mantenendo in modo sorprendente<br />
un’invidiabile omogeneità di fondo, salta con disinvoltura<br />
da un onesto cantautorato indie-folk italiano<br />
a vaghi accenni sintetici (invero un po’ sbiaditi) che abbozzano<br />
un improbabile My Awesome Mixtape in fissa<br />
per Fatboy Slim e strane assonanze con Nicolò Fabi, il<br />
tutto senza farsi mancare l’armamentario completo di<br />
campanellini, chitarrine e tastierine senza il quale, attualmente,<br />
sembra si finisca per risultare poco credibili.<br />
La direzione musicale non propriamente a fuoco finisce,<br />
tuttavia, in secondo piano, colonna sonora di un<br />
monologo ininterrotto di un personaggio che potrebbe<br />
essere il tuo compagno di università che non aveva<br />
nessun problema a paragonare Cobain e Inzaghi e che,<br />
un giorno illuminato dall’ispirazione, finisce per cantarti<br />
i fatti quotidiani delle feste erasmus.<br />
Niente più di un pop ai minimi termini tradito nei propri<br />
intenti low profile sin da un titolo così radicato nell’oggi<br />
più profondo. Servirebbero più pause e poesia.<br />
(5.9/10)<br />
giulia CaValiErE<br />
ElEanor FriEdbErgEr - laSt SummEr<br />
(mErgE, luglio 2011)<br />
Genere: alt. pop<br />
Le vie del pop alternativo sono notoriamente infinite e<br />
ultimamente anche parecchio trafficate. Bene o male.<br />
Vedi il caso di Eleanor Friedberger, metà fraterna dei<br />
Fiery Furnaces, col qui presente Last Summer al debutto<br />
come solista. All’insegna appunto d’un pop accomodante<br />
ancorché scafato, denso di rimandi a certe<br />
effervescenze errebì e soul dei Seventies, guarda caso<br />
il decennio che vide nascere la cantautrice dell’Illinois.<br />
A tratti sembra d’essere dalle parti dell’ultima Joan<br />
As Police Woman, però senza quella devozione (vedi<br />
soprattutto Glitter Gold Year), quasi fidando invece nel<br />
retrogusto della superficialità, nelle incalcolabili implicazioni<br />
del semplice - che semplice mai è - intrattenere.<br />
C’è qualcosa di ingegnoso nella capacità di pezzi accomodanti<br />
come My Mistakes (twist giocattolo col cuore<br />
asprigno), I Won’t Fall Apart On You Tonight (le Go-Go’s<br />
sbarazzine) o Heaven (sogno sintetico glam caramellato<br />
motown) di riuscire a sembrare anche qualcos’altro.<br />
Deve avere a che fare con lo stesso fenomeno che rende<br />
oltremodo gradevole quella voce in bilico tra Lorella<br />
Cuccarini e una Kate Bush senza falsetti. Una qualche<br />
forma di talento che trova compimento nelle belle Owl’s<br />
Head Park (morbidezze arty Brian Eno e vaga aura etno<br />
Peter Gabriel) e quella Roosevelt Island che sembra<br />
un’appendice funky dell’ultimo Destroyer. Uno di quei<br />
non-capolavori che lasciano il segno.<br />
(7/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
F.S. blumm/luCrECia dalt - Cuatro CoVErS<br />
(la bèl nEtlabEl, maggio 2011)<br />
Genere: elettronica-ambient<br />
Tutto nasce da una collaborazione a distanza finalizzata<br />
a trovare un terreno musicale comune. Quattro cover di<br />
estrazione diversissima che nelle mani di Lucrecia Dalt<br />
e F.S. Blumm diventano un ipotesi di indietronica figlia<br />
della tradizione Morr mixata a un ambient destrutturato<br />
e distrattamente post-rock.<br />
Quizaz Quizas Quizas di Osvaldo Farres, Close To You di<br />
Burt Bacharach e Hal David, I’m Sick Of You di Iggy Pop<br />
e Old Friends di Simon & Garfunkel, trasfigurate in un<br />
fluire minimale di chitarra, basso, glokenspiel, piano (di<br />
Nils Frahm), beat sintetico. «L’idea era quella di fare qualche<br />
esperimento, come incrociare la musica di alcuni dei brani<br />
con le parole di altri o mescolare i linguaggi. Ad esempio il<br />
testo del brano di Bacharach è stato modificato con le parole<br />
di Close To Me dei Cure.» A illustrarci il modus operandi<br />
dietro a Cuatro Covers è proprio la Dalt, la stessa che riduce<br />
il brano di Farres a una Quizas Perhaps Quizas decadente<br />
e senza vie di fuga, i toni trionfali di Bacharach in una<br />
Close To Vos impalpabile e sfilacciata, la lascivia dell’Iggy<br />
più violento in una S.O.Y. elettro e monocromatica, la<br />
poetica crepuscolare di Simon & Garfunkel nel sussurro<br />
solitario di Old Amigos. Blumm dal canto suo fa quello<br />
che gli riesce meglio, ovvero aggiungere livelli, rumore,<br />
nuove chitarre, pur nell’ottica di un suono che rimane<br />
elementare, irregolare, difficilmente circoscrivibile.<br />
Filtrare il proprio background giovanile con un approccio<br />
contemporaneo: questa la principale linea guida del<br />
progetto. E l’esperimento - in download gratuito sul sito<br />
76 77
dell’etichetta - ci pare decisamente riuscito.<br />
(7/10)<br />
Fabrizio zampighi<br />
FEnnESz - SEVEn StarS (touCh muSiC uK,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: Drone<br />
A tre anni da Black Sea, Fennesz torna con un 10’’ sempre<br />
per Touch di cui verrà pubblicata a settembre una<br />
versione cd con l’aggiunta di un paio di remix (Shift, Reshift)<br />
già disponibili in download se si acquista il vinile<br />
presso il Touchshop.<br />
Il mini contiene quattro brani all’insegna di un suono<br />
crudo e diretto - spogliato del noise e senz’altro più povero<br />
rispetto alla tracklist del mare nero - dove la chitarra<br />
elettrica (ma anche acustica) del viennese troneggia<br />
su un missato di synth, giusto qualche linea di basso e<br />
altrettanto castigati inserti digitali. L’album è stato inciso<br />
lo scorso gennaio e le prime due tracce, Liminal e July,<br />
risalgono a esistenti versioni occasionalmente suonate<br />
dal vivo (Liminal è stata incisa in una camera d’albergo<br />
a Bali nel 2010), la prima vede l’austriaco dipingere a<br />
scure tinte una landa goth-industrial salvo poi risolverla<br />
in caldi arpeggi alla elettrica, la seconda, riporta alla<br />
cara trasfigurazione folk-pop attraverso un suono più<br />
pacifico e orchestrale.<br />
La vera novità del disco è comunque la batteria di Steven<br />
Hess (Fennesz stesso parla di voler includere le pelli<br />
nei lavori futuri), microfonata da Christoph Amann,<br />
presente nella traccia che dà il nome all’album, nonché<br />
l’aggancio più immediato all’indimenticato Endless<br />
Summer. Seven Stars riporta alla magia estiva dei suoi<br />
primi 2000 ma la sostanzia in una seconda trasfigurazione<br />
per synth, chitarra “in chiaro” e, infine, le timide spazzole<br />
del batterista (che non spostano il risultato finale di<br />
alcunché). Il finale Shift completa il mini con un drone<br />
ascensionale, elegiaco e crepuscolare che rimanda agli<br />
esperimenti goth dream primi 90 quali Lycia, Black<br />
Tape For A Blue Girl e co..<br />
Rispetto alla magistralità di Black Sea, Fennesz sembra<br />
voler tornare ai basic della propria musica (4AD, shoegaze,<br />
drone music, i Beach Boys trasfigurati di Plays) per<br />
trovare nuove strade.<br />
(6.7/10)<br />
Edoardo bridda<br />
Fionn rEgan - 100 aCrES oF SyCamorE<br />
(hEaVEnly, agoSto 2011)<br />
Genere: folk/cantautorato<br />
C’ha messo cinque anni, ma alla fine la stoffa autoriale<br />
e personale comincia a farsi sentire. Dopo un esordio<br />
(The End Of History) nominato - da perfetto sconosciuto<br />
al Mercury Prize - e un sophomore in direzione<br />
più elettrica (The Shadow Of An Empire), il cantautore<br />
dublinese classe 1981 comincia a staccarsi dai riferimenti<br />
del genere a cui ha dimostrato amore sconfinato.<br />
Così si lasciano i territori totalmente dylaniani e l’intimismo<br />
più drakiano per cercare di scavare una propria<br />
linea accanto all’altro ingombrante dublinese di questi<br />
anni, Conor O’Brien, meglio noto come The Villagers.<br />
Il fingerpicking di janschiana memoria rimane un tratto<br />
saliente della composizione di Fionn Regan, ma si<br />
fonde con un arrangiamenti orchestrali che mettono<br />
insieme il folk britannico classico, con il pop orchestrale<br />
e qualche influenza esotica che fa capolino qua e là.<br />
Non mancano le ballate d’amore struggente con tanto<br />
di campanelle (Lake District), i calembeur linguistici (List<br />
Of Distractions), i riferimenti bucolici (For A Nightingale).<br />
Ma è con commistioni più personali, come il tentativo<br />
di unire le Cliffs of Moher con Tin Pan Alley di Horses Are<br />
Asleep o nella titletrack che si nota di più la stoffa della<br />
sua penna.<br />
Come si conviene a un folksinger, Regan sa certo scrivere<br />
poetiche storie di vita in musica (Sow Mare Bitch Vixen,<br />
1st of May), ma questo ce lo si aspetta. Quello che non ci<br />
si aspetta è che senza stravolgere una formula classica si<br />
riesca ancora a trovare poesia. Regan ci riesce.<br />
HVN228 Fionn Regan - For A Nightingale by heavenlyrecordings<br />
(7/10)<br />
marCo boSColo<br />
ganglianS - Still liVing (SoutErrain<br />
tranSmiSSionS, agoSto 2011)<br />
Genere: psych-pop in lo-fi<br />
Il comeback della formazione di Sacramento sembra<br />
mettere a fuoco le già ottime intuizioni proposte con<br />
Monster Head Room, l’esordio targato Souterrain Transmission<br />
che ci colpì favorevolmente un paio di anni<br />
fa. Ora il concentrato psych-rock in lo-fi del quartetto<br />
sembra avere un più ampio range col quale mostrarsi,<br />
sgrezzando le monodimensionali strutture portanti<br />
dell’esordio: dalle agrodolci e quiete introspezioni tipiche<br />
da ventenne rocker in action alle esplosive eruzioni<br />
di solare felicità si sfruttano numeri out-rock limitrofi a<br />
certa wave (Things To Know), slanci strumentali indie-<br />
80s ed estasi folkish californiana. Il tutto, sempre reso in<br />
maniera solare e spiaggia-friendly, come d’ordinanza. Se<br />
Ryan Grubbs, chitarrista e voce principale del quartetto,<br />
esordisce cantando al mondo “This is a sad, sad song /<br />
For all you sad, sad people” (l’opener Drop The Act) insomma,<br />
non c’è da prenderlo troppo sul serio.<br />
Still Living, nomen omen, ce li mostra vivi e vegeti, allegri<br />
e spensierati, sia che trattino la materia con vocalità<br />
sinfonic-pop retaggio di Beach Boys et similia (That’s<br />
What I Want), che emulino il ripescaggio rock 60s-oriented<br />
dei Thee Oh Sees (il mood oscuro e i coretti irresistibili<br />
di Jungle, le melodie twangy di Good Times) o<br />
che inanellino gemme di puro sixties sound wilsoniano<br />
(California) o di psichedelia soffusa e suadente (Bradley<br />
o Sleep), i quattro centrano sempre il bersaglio grosso.<br />
Dopotutto, è lo stesso portavoce della band ad ammetterlo:<br />
This is outsider music, but with a pop sensibility that<br />
brings everyone in. Come dargli torto?<br />
(7/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
gianCarlo FrigiEri - i Sonnambuli<br />
(autoprodotto, agoSto 2011)<br />
Genere: cantautorato<br />
Autoprodotto, autodistribuito e soprattutto - buon per<br />
lui, buon per noi - sempre più fertile, Giancarlo Frigieri<br />
torna a poco più di un anno dal buon Chi ha rubato le<br />
strade ai bambini? con questo I sonnambuli che di<br />
fatto ne raccoglie il testimone, insistendo nel solco di<br />
quella stessa sensibilità disallineata che a tratti sconfina<br />
in una calda, meditata misantropia. Tu chiamalo se vuoi<br />
cantautorato, senza prefissi né suffissi, questa critica intensa<br />
e impietosa sotto forma di canzoni ai (falsi) rituali<br />
del vivere civile e al loro inevitabile riverbero nell’intimità.<br />
Intendo proprio QUEL cantautorato, dei Guccini<br />
dei Bennato dei Bertoli e dei Gaber, per intendersi, le<br />
cui calligrafie aleggiano un po’ in tutta la scaletta. Quello<br />
che non si ha più il coraggio di fare e sentire, perché<br />
linguaggio trito e pretenzioso, compiacente e autogratificante,<br />
col tranello della retorica sempre pronto a<br />
spalancarsi ad ogni passo.<br />
Frigieri, invece, non fa una piega. Tiene la barra ferma<br />
e fiera, spreme lo sdegno con cura piantando gli occhi<br />
negli occhi del sonnambulismo esistenziale - senza fare<br />
sconti, neanche a se stesso - e perciò confeziona dieci<br />
ballate ben salde sulle proprie gambe. Perché a farlo con<br />
le giuste dosi di intensità, cura e asciuttezza, il giochino<br />
funziona eccome, ed è perfino capace di suonare ben<br />
immerso nella contemporaneità. Quando poi l’ex-Joe<br />
Leaman cala sul piatto gli ingredienti “alieni” del suo<br />
retroterra, è il classico grasso che cola: vedi ad esempio<br />
la flemma Fred Neil de Il turista, i tremori Tim Hardin<br />
nella splendidamente gaberiana Fino a rovinar del tutto,<br />
le palpitazioni semiacustiche Eels di Comodo o il fragore<br />
Neil Young/Steve Wynn di Controesodo.<br />
Per restare alle canzoni, doveroso mettere in rilievo<br />
come La madonna del cavalcavia vanti uno dei migliori<br />
testi - accorato e spiazzante - mai partoriti dal Nostro,<br />
mentre l’arguta La gente sciorina un bell’arrangiamento<br />
in bilico tra oriente e tex-mex. Forse la più bella del<br />
mazzo sarebbe l’indolenzita Non lo so dire, ma andrebbero<br />
prima digerite quelle somiglianze dell’arpeggio col<br />
tema di Rose rosse per te, e francamente la vedo dura.<br />
Disco sostanzialmente riuscito, robusto sia esteticamente<br />
che poeticamente al netto della tutt’altro che<br />
sgradevole fragranza low-cost. Ancora uno chapeau per<br />
Giancarlo Frigieri.<br />
(7/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
giorgio barbarotta - Snodo (gb,<br />
atraCouStiC, WondErmarK, giugno 2011)<br />
Genere: folk rock, pop<br />
E’ incline alla poesia intimista quanto alla denuncia sociale<br />
il nuovo album di Giorgio Barbarotta Snodo. Un’accoppiata<br />
forse non originalissima ma resa attraente e<br />
piacevole da un folk rock imbevuto di blues e melodia<br />
all’italiana diretto con passione e gusto dal cantautore<br />
trevigiano. E’ dedicata al premio Nobel per la pace<br />
Barack Obama il brano che apre il disco, Buone nuove,<br />
un’intensa e amara riflessione a cui fa seguito il singolo<br />
Noi, elegiaca rivendicazione ambientalista. Guai a<br />
prendersi troppo sul serio però e L’Alchimista, divertita<br />
metafora del mestiere del cantautore, e Galleggiando<br />
in provincia, ironica folk song sulla condizione degli artisti<br />
che vivono ai margini delle rotte che contano, sono<br />
pronte a ricordarcelo.<br />
La delicata dedica alla nascita di un figlio, Il Motore è<br />
l’amore, fa invece il paio con l’introspettiva ballad dal<br />
misurato sapore romantico Riesci ad imbrogliare il tempo,<br />
in un percorso più intimo e sussurrato. La denuncia<br />
delle condizioni di vita dei lavoratori nei campi di raccolta<br />
di pomodori al sud (Podere 41) e la rabbiosa Mediacrazia,<br />
nero e psichedelico atto d’accusa sull’imperare<br />
dei mezzi d’informazione, riporta l’album su frequenze<br />
decisamente più agguerrite e militanti. Ma nell’evocativo<br />
Snodo c’è ancora tempo per uno svincolo onirico e<br />
misticheggiante disegnato attraverso il connubio tra<br />
leggende di mare, storie di porto e credenze religiose<br />
(Dalla marea), una festosa celebrazione di vita e natura<br />
dai toni bandistico-edonistici (Sinfonia di maggio) e il<br />
personalissimo confronto-dialogo con il divino (Che ne<br />
diresti). Inutile girarci intorno: Barbarotta è uno che con<br />
le parole ci sa fare. Forse non sempre riesce a risolvere<br />
musicalmente come vorrebbe e in alcuni casi l’ascoltatore<br />
attento potrebbe avvertire un leggero senso di<br />
insoddisfazione condivisa con l’autore. Ma di contro<br />
ci sono le rime invidiabili di un poeta che dopo tanta<br />
78 79
gavetta ha confezionato un album godibile nella sua<br />
interezza e meritorio di vetrine importanti.<br />
(6.5/10)<br />
gianluCa lambiaSE<br />
giorgio Canali E roSSoFuoCo - roJo (la<br />
tEmpESta diSChi, agoSto 2011)<br />
Genere: rock (combat?)<br />
Se Nostra signora della dinamite (2009) aveva spostato<br />
l’asse dalle parti di un cantautorato rock vero e proprio,<br />
mai tanto denso e pensoso per non dire intimista, con<br />
Rojo la premiata ditta Giorgio Canali e Rossofuoco<br />
torna a mettere l’accento sull’urgenza stradaiola, sull’indignazione<br />
scatarrata triturante retorica. Presentando il<br />
disco - il sesto del repertorio “solista” - lo stesso ex-CC-<br />
CP racconta di aver dovuto superare una crisi creativa,<br />
qualcosa a metà tra la sindrome da pagina bianca e lo<br />
stress da prestazione. Oppure, più probabilmente, una<br />
overdose da incazzatura per lo stato delle cose che lo<br />
inducevano perlopiù a masticare bestemmie.<br />
Poi s’è aperta una crepa di speranza, merito forse - chissà<br />
- del venticello primaverile che spirava dalle parti di<br />
Puerta del Sol, e puntuale è arrivata la reazione: ecco<br />
riaccendersi la spia del disincanto, ecco sgorgare queste<br />
undici canzoni come altrettante invettive calate a<br />
mitraglia, bestemmie - ebbene sì - ma acide e amare<br />
per demolire il facile conformismo delle illusioni, il tutto<br />
ricondotto alla irragionevole ragione del rock (in questo<br />
senso la opening track Regola #1 è una sorta di manifesto<br />
poetico).<br />
Lo spasmo è più diretto e sbrigativo che mai, insegue le<br />
proprietà liberatorie dell’immediatezza sacrificando un<br />
po’ di quel rovello scuro che nei precedenti lavori ispessiva<br />
la trama di ombre Noir Desir. Ciò non rappresenta<br />
affatto un problema quando l’estro è imbelvito: vedi la<br />
stoniana Risoluzione strategica #6, una non meno che<br />
travolgente Carmagnola #3 (dal formidabile finale) e<br />
quella specie di Bob Dylan trafelato - mai tanta armonica,<br />
in un lavoro di Canali - di Ci sarà (che se la sfornasse<br />
un Ligabue - ipotesi ab absurdum, s’intende - potrebbe<br />
galoppare nelle playlist d’ogni ordine e grado). A pagare<br />
dazio ahimè sono invece le ballate, a parte la discreta<br />
Controvento e una accorata ma un po’ fiacca Orfani<br />
dei cieli: si snoda piuttosto prevedibile difatti Treno di<br />
mezzanotte ed è piuttosto bruttina - un po’ come certi<br />
bolsi Modena City Ramblers, poniamo- quella La solita<br />
tempesta cantata assieme ad Angela Baraldi.<br />
Detto questo, ci sia consentito ribadire che quando lo<br />
zio Giorgio tiene lo sguardo truce ad alzo zero si va lisci<br />
e sferzanti as usual, vedi il sacrosanto pane al pane di<br />
Sai dove e le sincopi post-wave di Un crepuscolo qua-<br />
lunque. Insomma, con tutte le inevitabili e accidentali<br />
differenze del caso, è il solito Giorgio Canali. E questa è<br />
la buona notizia.<br />
(6.8/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
girlS namES - dEad to mE (tough loVE<br />
rECordS, giugno 2011)<br />
Genere: GaraGe pop lo-fi<br />
C’è un romanticismo combattuto ed esistenzialista alla<br />
base di questo disco e che distingue i Girls Names dalle<br />
dozzine di lo-fi pop act emersi in questi ultimi anni. Una<br />
sensibilità che permette loro di costruire dolcissime e<br />
pervicaci melodie dal taglio britannico, di quelle che<br />
si indossano per più di una stagione, a differenza delle<br />
decine di emuli dei Pains Of Being Pure At Heart che<br />
scorrazzano per l’underground.<br />
Probabilmente, non avessimo ancora nelle orecchie l’ultimo<br />
bellissimo album dei Crystal Stilts, apprezzeremmo<br />
Dead To Me con maggior vigore. Perché la materia<br />
trattata dal combo di Belfast, al netto della performance<br />
catatonica dei newyorkesi, è la stessa: garage 60s e languore<br />
noisy, influenze che in più di un’occasione arrivano<br />
a sovrapporsi.<br />
La sfasatura si avverte proprio sul piano delle melodie<br />
(doorsiani e diafani i primi, smithsiani e twee i secondi),<br />
ma anche su quello del carattere (fortemente tratteggiato,<br />
ai confini col grottesco quello degli Stilts, ancora<br />
in fieri quello degli Irlandesi).<br />
Ciò non toglie che i brani di questo grazioso dischetto,<br />
con il loro garage pop rumorso ed infettivo, ideale punto<br />
d’incontro fra l’allure shoegaze post J&MC e l’irrequietezza<br />
del C86 più mercuriale, forniscano un puntello di<br />
lusso a quel sentimentalismo dolciastro e appiccicoso<br />
che si vorrebbe adolescenziale, ma che fatalmente, è<br />
materia di struggimento per thirty something nostalgici.<br />
(6.8/10)<br />
diEgo ballani<br />
grEat SaunitES (thE) - dElay JESuS ’68 (il<br />
VErSo dEl CinghialE, maggio 2011)<br />
Genere: heavy psych rock<br />
Il duo nell’accezione post-White Stripes può voler dire<br />
garage-rock bluesy e pestone con basso&batteria che<br />
si slanciano a rotta di collo tra urgenza luciferina e incedere<br />
rock. Oppure psichedelia ascensionale infinita alla<br />
maniera degli Om. O ancora, noise brutale in modalità<br />
carrarmato come nel caso dei Lightning Bolt.<br />
Poi però, ed è il caso dei qui presenti The Great Saunites,<br />
ci sono esperienze che pur non innovando riescono<br />
nella affascinante fusione dei suddetti referenti. L. Kan-<br />
highlight<br />
dJ QuiK - thE booK oF daVid (mad SCiEnCE, aprilE 2011)<br />
Genere: hip hop<br />
C’era una volta Dj Quik e la Golden Age dell’hip hop statunitense. C’erano l’attitudine HC newyorkese<br />
e lo spirito rilassato e smooth di L.A., le scintille col morto tra East e West Coast e le guerre fraticide tra<br />
Crips e Bloods. C’era per l’appunto la carriera ventennale di un produttore/<br />
rapper/beatmaker nato e cresciuto a Compton tra più rispettati della costa<br />
ovest: una specie di Dr. Dre in miniatura.<br />
La novità è che Dj Quik, all’anagrafe David Marvin Blake, è ancora qui e ha<br />
pure un sacco di cose da dire. A dimostrarlo c’è The Book Of David, album<br />
licenziato dalla sua Mad Science in questo 2011 segnato dal’omologazione<br />
del crunk lilwayniano, dal noioso hipster-hop di Tyler The Creator o dalla<br />
compravendita dell’anima di giganti come Snoop Dogg (di cui Blake mixò<br />
nel 2007 l’album Ego Trippin) da parte dell’euroconvertitore David Guetta. A<br />
dispetto di tutto ciò, Quik ci regala una boccata d’aria e una colonna sonora<br />
perfetta per quest’estate insolitamente fresca e conciliante.<br />
E’ chiaro fin da subito con Fire & Brimstone in cui si rispolvera la tipica inventiva ritmica dell’hip hop con<br />
la h maiuscola; poi in ordine sparso Luv Of My Life, Ghetto Rendezvous, Flow For Sale o la troutmaniana So<br />
Compton, tutte figlie del bay area sound, impregnate di devozione funkadelica a cavallo tra hip house,<br />
G-funk ed un sacco di losangelini (Gift, Kurupt BlaKKaz). Le liriche sono quelle di uno che ha vissuto<br />
tutto sulla propria pelle senza nessun compiacimento del passato gangsta. In questo senso Killer Dope<br />
possiede il ritornello/manifesto con il refrain “the street never changes, only faces do”, come a dire che il<br />
ghetto-meccanismo è sempre lo stesso: cambiano solo le facce delle persone che scompaiono sotto i<br />
colpi di Glock.<br />
Non mancano poi i numeri r’n’b (Do Today, Real Women, Hydromatic, Time Stands Still), sempre pregevoli<br />
e sempre ben interpretati dai feat. di Jon B. o Dwele: miele e classe. Qua e là ricompare pure l’ultrabeat<br />
lirico (rubato dall’anticoniano Dose One) di Bizzy Bone direttamente dai defunti Bone Thugs-n-Harmony.<br />
A proposito di grandi ritorni, in Boogie Till You Conk Out, è proprio lo scambio di battute sul microfono<br />
tra una pietra miliare come Ice Cube e lo stesso Quik a restituirci il commovente momento verità di<br />
questo disco: “Quik you are a Genius!” “No... you are a genius!” “Ok I’m a genius! hahahhaha..”. Modestia e<br />
consapevolezza in un solo colpo.<br />
Per concludere, non pensiate che questo sia un disco per nostalgici. TBOD è piuttosto un lavoro che fa<br />
venire la nostalgia di un tempo in cui fare hip hop era anche un modo per tramandare la musica del<br />
passato direttamente nel futuro (dov’è finita la cultura del diggin’?) e non semplicemente un modo per<br />
espandere l’ego ed il portafoglio di qualche rapper con sindromi depressive. Bel colpo vecchio!<br />
(7.7/10)<br />
dario moroldo<br />
dur Layola (batteria) e Atros (basso) - nome de plume<br />
dietro cui si nascondo i due protagonisti - mettono in<br />
scena tre lunghi brani in cui dispiegano l’ampia apertura<br />
alare tra psych dilatata, stoner corposo e rock mefitico<br />
prediligendo ovviamente la profondità del groove<br />
coinvolgente.<br />
Se qua e là emergono reminder Sleep (Golden Mountain)<br />
o Black Sabbath (l’attacco della title track), l’afflato krautrock<br />
alla Can (si noti il gioco di rimandi del titolo dell’al-<br />
bum) e le ambientazioni oscure ed ipnotiche sono rese<br />
in maniera molto personale tra scarti improvvisi di velocità,<br />
ritmiche mai statiche e vertigini umorali. Luca Ciffo<br />
(Fuzz Orchestra) alla registrazione e Giuseppe Ielasi al<br />
mixing sono poi più di una garanzia per questo giovane<br />
progetto lodigiano e l’ennesima bella sorpresa per la<br />
label di Alberto Pirti Messaggi.<br />
(6.8/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
80 81
houSEmEiStEr - muSiC iS aWESomE (boyS<br />
noizE, maggio 2011)<br />
Genere: electro-house<br />
Una delle ipotesi probabili è che quel matto di Housemeister<br />
abbia finalmente capito l’importanza di una<br />
struttura portante solida. Una questione che finora il<br />
ribelle producer berlinese non sembrava essersi posto:<br />
prima in Enlarge Your Dose (2006, voto: 6.4/10) e poi nel<br />
successivo Who Is That Noize (2008, voto: 6.1/10) a tenere<br />
banco erano state le sue ossessioni anarchiche, volte<br />
a mettere ogni cosa in discussione, sovrapporre stratificazioni<br />
ed esagerare la complessità. Un gusto nerd che<br />
pagava il prezzo dell’artefazione, trasformando un mix<br />
potenzialmente giocoso e naif in eccentriche operazioni<br />
a rischio autoreferenzialità.<br />
Music Is Awesome non stravolge il metodo, sia chiaro: le<br />
sferragliate electro sputano ancora sopra al ritmo mirando<br />
alla dissonanza noise (vedi The Little Robotman<br />
o nBaxx, insieme al compagno di follie Boys Noize) e i<br />
trattamenti 8bit rimangono la soluzione privilegiata per<br />
agevolare il groove (nella giusta misura, come in Feed<br />
The Robots o Clarisse). Eppure questa volta Martin Böhm<br />
lascia intendere di voler rinunciare in parte all’immagine<br />
spiritata per angolare efficacemente la fruibilità d’ascolto.<br />
Ne derivano piccoli ma importanti spiragli di novità,<br />
come un più equilibrato rigore electro-house che non<br />
forza il lato rave (una Rapide risulta affine a certe proposte<br />
di Mathew Jonson), una certa cura per le irrinunciabili<br />
simmetrie dance (Schnee Von Gestern) e un rallentamento<br />
dei ritmi mentre si studia l’approccio al nu-rave (Music Is<br />
Awesome sta bene dietro ai Digitalism).<br />
Non sarà esattamente una rivoluzione, ma una buona<br />
sorpresa sicuramente sì.<br />
(6.6/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
houSSE dE raCKEt - aléSia (KitSuné muSiC,<br />
agoSto 2011)<br />
Genere: pop rock<br />
I francesi Housse De Racket arrivano al secondo album,<br />
e la faccenda si sposta di poco rispetto al precedente<br />
Forty Love del 2008. Confermato quel giocoso indie-rock<br />
da autoradio facilmente godibile per chi già apprezza<br />
nomi come Kooks e Phoenix, con la hit Roman che non<br />
sfigura di fronte alla precedente Oh Yeah. Gli inserti elettronici<br />
sono previsti dalla ricetta anche perché fan tanto<br />
pop (Human Nature, Château) e qualche traccia di neopsichedelia<br />
light (Ariane) non ostacola le ambizioni del<br />
gruppo: Mtv li ha già adocchiati, ora tocca al marketing...<br />
(6/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
hudSon mohaWKE - Satin panthErS Ep<br />
(Warp rECordS, agoSto 2011)<br />
Genere: wonky<br />
Ross Birchard torna a pubblicare e lo fa con un EP veloce,<br />
colorato, hi-energy: in una parola, estivo. Enfant<br />
prodige della scena wonky, HudMo si mantiene fedele<br />
ai propri elementi di riconoscibilità (l’enfasi sul ritmo,<br />
la tavolozza di colori smaltati, il clash di elementi) declinando<br />
adesso l’amore per i breakbeat e per i sample<br />
vocali spezzati e pitchati in salsa più marcatamente footwork.<br />
Cinque pezzi per un quarto d’ora di durata totale,<br />
in free streaming sul canale Youtube dell’artista fino al<br />
giorno dell’uscita fisica del disco (qui invece la snippet<br />
preview, ancora disponibile).<br />
Octan è la intro, sfarfallio spacey alla Xevious ad libitum;<br />
Thunder Bay il singolo di cui avevamo già dato notizia,<br />
un frullato irresistibile di Timbaland, Flying Lotus, Supermario,<br />
nu-rave e footwork appunto; Cbat è un interludio<br />
ragga strumentale che fa pensare a A Milli di Lil<br />
Wayne, rullante secco e campanellino in levare; All Your<br />
Love punta agli anni Ottanta, opportunamente dopati<br />
alla sua maniera con una tastieraccia house stonata e<br />
tom tom tribali in primo piano; Thank you, ancora su<br />
breakbeat footwork, con dentro un tripudio di rullante<br />
che manco una marching band e inciso aperto con intrico<br />
di tastiere.<br />
(6.9/10)<br />
gabriElE marino<br />
idaho - you WErE a diCK (talitrES rECordS,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: slow-core<br />
Malgrado una carriera quasi ventennale, Jeff Martin ancora<br />
non ha il riconoscimento di cui dovrebbe godere.<br />
Perché è vero che si tratta dell’ennesimo songwriter - un<br />
californiano di studi classici nascosto dietro uno tra i più<br />
quieti stati dell’unione - a elogiare la lentezza, pure resta<br />
degno di interesse uno stile personale anche a fronte<br />
di evidenti somiglianze con Mark Eitzel (però meno<br />
sofferto e drammatico) e ai meno esangui Red House<br />
Painters (in ogni caso degli Idaho pressoché coevi).<br />
Come che sia, Jeff pare contento del riconoscimento<br />
puramente underground garantito da una decina di<br />
apprezzabili dischi giocati tra passi rallentati e chitarre<br />
meste (eccezione il più muscolare Three Sheets To The<br />
Wind del ’98), echi di Neil Young e ballate pianistiche<br />
raccolte senza disperazione.<br />
Malinconia di fine estate che scalda cuore e mente tramite<br />
canzoni da camera e cameretta che occasionalmente<br />
escono a dare un’occhiata al mondo e che all’appello<br />
mancavano da The Lone Gunman, primo frutto del<br />
contratto con la Talitres risalente a sei anni fa. Nulla di<br />
cambiato frattanto, se non che maturità e classicismo<br />
raffinano viepiù uno slow core romantico e avvolgente<br />
da artigiano colmo di classe e gusto. Ti scopri a farlo<br />
girare più volte, a lodarne la compattezza d’insieme e<br />
centellinare l’acidula title-track, gli acquerelli The Happiest<br />
Girl, Reminder e Flames, la raffinatezza dolente di<br />
Weigh It Down e quella invece briosa in Waited For You<br />
o Up The Hill, l’intimismo che sorregge The Setting Sun.<br />
Da tenere a portata di mano.<br />
(7/10)<br />
gianCarlo turra<br />
impoSSibili - SEnza ritorno<br />
(autoprodotto, giugno 2011)<br />
Genere: punk<br />
Per chi avesse voglia di gustarsi un punk di quelli senza<br />
pretese, suonato con distorsioni a manetta e i più<br />
semplici giri armonici, il nuovo disco dei veterani del<br />
punk milanese Impossibili fa più che al caso loro. Senza<br />
ritorno è un lavoro che venti anni fa avrebbe raccolto<br />
sicuramente consensi maggiori. Oggi dire qualcosa di<br />
nuovo sul punk non è facile né gli Impossibili sembrano<br />
volerci provare, confezionando, piuttosto, un album<br />
che dal vivo potrebbe regalare una divertente serata<br />
agli aficionados ma nulla più. La furia rabbiosa di brani<br />
come Utopia, Paura di reagire, Multinazionali, hanno il<br />
sapore della nostalgia più che dell’invettiva. Nostalgia<br />
per un mondo, una generazione, che sapeva veicolare<br />
attraverso un genere il rifiuto di regole, limiti, stereotipi<br />
e quant’altro. Ma il mondo e le generazioni sono<br />
cambiate.<br />
Ci si arrabbia con molto meno e forse non ci si arrabbia<br />
neanche più. Un punto senza ritorno, per l’appunto, ma<br />
tant’è. Molto affascinante invece il trittico dedicato alla<br />
figura della donna composto da Alice, Laura e Ilaria. Araya<br />
(voce, chitarra), Ale (basso, cori) e Davide (batteria)<br />
hanno indubbiamente personalità e esperienza da vendere.<br />
Trasuda tutto da questo disco, autoprodotto come<br />
ormai accade da diversi anni per uno dei più longevi<br />
gruppi del punk italiano. Ma il tentativo di rispolverare<br />
vecchi mood proto punk non basta allo storico gruppo<br />
meneghino per andare oltre una stentata sufficienza,<br />
meritata comunque per la costanza e la precisione mostrata<br />
anche in questo lavoro. Tutto però suona di già<br />
sentito, quando va bene, di vecchio, se va male. Poco<br />
convincente anche la cover di Voglio vederti danzare.<br />
Battiato è già di suo estremamente punk, perché provare<br />
a emularlo?<br />
(6/10)<br />
gianluCa lambiaSE<br />
Jim o’rourKE - old nEWS # 5 (EditionS mEgo,<br />
giugno 2011)<br />
Genere: elettroacustica<br />
Vive di opposti, Jim O’Rourke? In qualche modo, se una<br />
persona fa di tutto, tocca anche gli estremi, che rimangono<br />
sempre più impressi nelle menti più che gli altri<br />
punti del continuum. Jim ci ha abituato a un ritmo di<br />
lavoro e a una frequenza di pubblicazione molto alta,<br />
prima, a lunghe pause, nel mentre, e oggi a un ritorno<br />
sui giradischi degli appassionati del noise, dell’elettroacustica,<br />
della musica sperimentale in uscita dai Novanta.<br />
Old News # 5 è il primo capitolo, sebbene sembri il<br />
quinto, di una serie di uscite per l’austriaca Mégo, posizionato<br />
sull’altra faccia della luna rispetto a The Visitor,<br />
piuttosto volto a seguire un andirivieni nel passato e<br />
nel presente degli esperimenti sui nastri di O’Rourke.<br />
Quattro brani che viaggiano dalle recentissime produzioni<br />
fatte dalla nuova base di Tokyo del compositore<br />
fino a risalire ai primi anni Novanta. E la regola sembra<br />
essere l’attrazione e la valorizzazione reciproca dei contrasti.<br />
Zero compromessi in Detain the Man to Whom,<br />
del 1992, noise elettroacustico massimalista e diretto.<br />
Ma, prima ancora, Jim ci rapisce con un tocco di nastri<br />
che accenna vie di fuga tonali quasi da primi minimalisti<br />
(Pedal & Pedal), maturità da manuale e piacere puro per<br />
chi ama il genere.<br />
Mother and Who, la fibrillante traccia che chiude il disco,<br />
e copre l’intero lato D, inizia invece con un delirio alla Alvin<br />
Curran, con sottofondo di timbri acutissimi che perforano<br />
le orecchie di coloro che sono ancora in grado<br />
di udirli. Eppure ciò che ci aspetta è una suite di switch<br />
on / switch off tra una nota e il tema che si origina da<br />
essa. Perfetto correlativo oggettivo, in definitiva, della<br />
musica di O’Rourke, maestro di tecnica elettroacustica<br />
e padrone degli sbalzi. Cogliamo l’esca e attendiamo<br />
con buone aspettative le prossime puntate della serie.<br />
(7.2/10)<br />
gaSparE Caliri<br />
JoliE holland - pint oF blood (anti-,<br />
giugno 2011)<br />
Genere: folk, americana<br />
L’avevamo lasciata ben cinque anni fa Jolie Holland con<br />
un disco che prometteva bene. Oggi torna nello studio<br />
casalingo accompagnata dai Grand Chandeliers: gli amici<br />
di sempre Shazad Ismaily al basso e Grey Gersten alla<br />
chitarra e in più il cameo straordinario di Mark Ribot<br />
nel downtempo blues di The Devil’s Sake.<br />
Se ai primi ascolti il disco può sembrare un po’ troppo<br />
derivativo e formalmente statico, col passare dei minuti<br />
(e probabilmente dei loop), si scopre come la texana<br />
82 83
highlight<br />
ES - tutti Contro tutti portiErE VolantE (FoSbury, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: rock<br />
Correva il 2003 quando gli Es si guadagnavano gli entusiasmi del mondo indie per The mistercervello<br />
LP, album che li vedeva esordire ufficialmente dopo l’autoproduzione altrettanto intrigante di MUSICA<br />
TEDesCA tric e troc (1999). Poi, chissà perché, non ne abbiamo più avuto<br />
notizie. Un po’ di tumulti in formazione, la “distrazione” di altri progetti (coi<br />
sodali Valentina Dorme soprattutto), forse una certa allergia per l’aria da<br />
catastrofe imminente degli anni zero. Insomma: spariti. Evaporati. Altro che<br />
iato, signori miei. Otto anni è un coma vero e proprio. Quando già stavamo<br />
per decretarne la morte clinica - al netto di qualche spasmo vitale in<br />
un paio di compilation perlatro ormai datate - la band trevigiana si rende<br />
oggi protagonista di un risveglio clamoroso col qui presente Tutti contro<br />
tutti portiere volante. Nel frattempo sono diventati un quintetto e le idee<br />
sembrano un po’ più solide, fermo restando il piglio balzano. Ovvero, stavolta abbiamo a che fare con<br />
canzoni vere e proprie, con la voglia di compiersi in quanto tali.<br />
Ascoltandole vieni colto da una strana sensazione: come se le ideuzze più imprendibili dei Novanta ti<br />
osservassero beffarde, sfarfallando vivaci tra stomaco e pensieri, scoppiettando nonsense allusivi come<br />
adrenaliniche apoteosi contro-emo. Quasi volessero dirci (quelle ideuzze): ci avete liquidate troppo in<br />
fretta, signori miei. Il programma si compie quindi nel segno d’un lo-fi sparso e dinoccolato (la svenevolezza<br />
ghignante di Ho ormai i tuoi nei, la noncuranza malkmusiana di Metà di metà), concedendosi<br />
sdilinquimento post-psych (Sto benissimo), divagazioni Flaming Lips via Polvo (Pardesòra, Air guitar) e<br />
sacrosanto estro noise-pop (Kerry Von Erich), mentre un simile processo euforizzante sembra riguardare<br />
tanto le vampe oblique degli Scisma (L’articolo the davanti a nome di band) che la gravità letteraria dei<br />
Marlene Kuntz (La lingua sotto i denti, Ex bambini buoni).<br />
E’ tutto un gioco, certo, graziosamente indocile ed evasivo, però tutt’altro che disimpegnato semmai<br />
impegnato - disperatamente impegnato - a tenere accesa la fiamma pilota dell’intelligenza. Vale a dire,<br />
cazzonismo analitico - per non dire anarchico - come antidoto per questi tempi grami. Che altro dire:<br />
felice di riaverli tra noi.<br />
(7.2/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
abbia trovato uno stato di grazia cavalcando la tradizione<br />
(vedi la cover di Townes Van Zandt Rex’s Blues)<br />
e rivangando i suoi blues (Littlest Birds l’avevamo infatti<br />
già sentita nel debutto Catalpa del 2003). In più ci sono<br />
l’omaggio al blues elettrico di Neil Young (l’opener All<br />
Those Girls), le puntatine rock slo-mo southern (Gold And<br />
Yellow), le visioni con violini oniric-country (June) e pure<br />
le strizzatine d’occhio al pop acustico (Wreckage).<br />
Un quinto album che conferma la Holland come una<br />
delle più interessanti voci americane fuori dalle scenes’,<br />
dentro un cammino che col passare del tempo si rivela<br />
pieno di personalità e di continua voglia di mettersi in<br />
gioco. Ben fatto, Jolie.(7.2/10)<br />
marCo braggion<br />
Jonathan WilSon - gEntlE Spirit (bElla<br />
union, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: aciD folk<br />
Più che un disco, quello di Jonathan Wilson, trentasettenne<br />
da Forest City, North Carolina, è un atto d’amore.<br />
Per una musica, il folk speziato d’acido che ha attraversato<br />
in lungo e in largo una stagione musicale<br />
che si è stesa a cavallo dei Sixties e dei Seventies, e una<br />
scena, quella del Lauren Canyon, rivitalizzata coinvolgendo<br />
Chris Robinson e attirando una pletora senza<br />
quasi fine di musicisti del giro Americana/alt-country/<br />
folk psichedelico americano. Il risultato di questo atto<br />
d’amore, fatto di lunghe jam session immerse in quel<br />
mondo verticale che è un canyon e di tempi dilatati per<br />
la composizione e registrazione degli episodi, è un di-<br />
sco di folk capace di incamerare elementi pop, parente<br />
stretto di David Crosby, del Neil Young On The Beach e<br />
dei Quicksilver Message Service, di quella stessa musica<br />
di cui sono innamorati i Pink Floyd pre-dark side of<br />
the moon.<br />
The Way I Feel è un tributo alle chitarre dei Crazy Horses,<br />
supportate da un organo e agli archi che sono il tappeto<br />
su cui poggiano molte delle composizioni migliori. Il<br />
fingerpicking di Can We Really Party Today? è già materia<br />
da hobo su una strada polverosa, verso il sogno americano,<br />
mentre Waters Down si tinge di blues leggero per<br />
una delicata elegia bucolica che si chiude in scatoligici<br />
presagi di tempesta. I brani, spesso lunghi (ben oltre i<br />
sei minuti), di Gentle Spirit trasudano di presenze ectoplasmatiche,<br />
di echi e riverberi del canyon, di schegge<br />
e manipolazioni sonore che mostrano l’abilità di Wilson<br />
come produttore e ingegnere del suono (già con Erykah<br />
Badu, Elvis Costello e James Browne), oltre che la<br />
sua competenza polistrumentistica. Code e introduzioni,<br />
rumori e voci stranianti che appaiano senza essere<br />
annunciate in molti brani contribuiscono a dare quel<br />
tocco di acidità che basta a farlo stare fuori dalla strada<br />
maestra del folk e introdurlo in quel cono d’ombra dove<br />
psichedelia e folk si incontrano.<br />
Per un disco completamente registrato in analogico,<br />
e il cui principale output è l’antico vinile, Gentle Spirit<br />
appare comunque un disco di oggi, immerso com’è in<br />
quella nostalgia che sta caratterizzando molto del folk<br />
contemporaneo, poso desideroso di staccare lo sguardo<br />
da alcune decadi particolarmente foriere di talenti e<br />
grande musica. Lo fa guardando al passato con l’occhi<br />
dell’innamorato, ma anche con il giusto distacco di chi<br />
quel passato sa manipolarlo e renderlo nuovamente<br />
attuale.<br />
(7/10)<br />
marCo boSColo<br />
KanyE WESt/Jay-z - WatCh thE thronE (roCa-FElla,<br />
agoSto 2011)<br />
Genere: hip hop pop<br />
Pensato inizialmente come EP che raccogliesse il meglio<br />
dei brani messi in free download con l’operazione GOOD<br />
Fridays, diventato poi progetto autonomo e album vero<br />
e proprio, registrato in giro per il mondo, Watch the<br />
Throne è praticamente un jam album, infarcito com’è<br />
di ospiti (il solito Kid Cudi, una ottima Beyonce, un Bon<br />
Iver riconoscibile ma comunque troppo trasparente),<br />
pezzi co-cantati e co-prodotti (stradominano Kanye e<br />
Mike Dean ma ci sono anche RZA, Neptunes e Q-Tip).<br />
Jam album eppure lavoro più concreto, meno dispersivo<br />
di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, e non poteva essere<br />
diversamente, dato che quello era un disco-manifesto,<br />
un progetto affetto da un gigantismo programmatico,<br />
da una megalomania baraccona e fuori misura, anche<br />
per Kanye.<br />
La formula di mesh hiphop + superpop viene ampiamente<br />
confermata, ma qui l’uomo trova, in coppia con Jay-Z<br />
(spaccone pure lui, ma coi piedi sempre ben piantati<br />
per terra), l’equilibrio giusto delle parti. No a caricature<br />
involontarie allora o a particolari tamarrate, via a giri<br />
incisivi, campioni molto indovinati e loop funzionali<br />
(Otis Redding, ovviamente James Brown, Quincy Jones,<br />
i Cassius, persino un trattamento killer su un mini-riff di<br />
Phil Manzanera), dosando bene dimensione rap (occhio,<br />
se Jay-Z quando vuole spacca tutto, Kanye è raramente<br />
interessante come rapper, semplicemente perché per<br />
lui il rappato e i testi non sono tanto un fattore estetico,<br />
quanto un espediente comunicativo, politico), appetibilità<br />
pop, trucchi elettronici (l’autotune ballad New Day,<br />
l’ostinato scampanellio di Welcome to the Jungle, una<br />
Who Gon’ Stop Me con lontani echi footwork, una Niggas<br />
in Paris dalle parti dei Die Antwoord) e suggestioni UK<br />
(leggi ragga). Il tutto sempre tra strada e poltrona di<br />
pelle, tra pathos sincero e sincera ostentazione di sé:<br />
“Now all my niggas designing and we all swaggin’ / Ignore<br />
the critics just to say we did it / This ain’t no fashion show,<br />
motherfucker, we live it”.<br />
Dicevamo dell’autocaricatura bypassata: beh, ci sarebbe<br />
proprio Made in America, inno di orgolio nazionale<br />
e di orgoglio nero (sfilano i santini Martin Luther King,<br />
Malcolm X, le prime grandi cantanti blues) come solo<br />
gli americani riescono a concepire, con una ‘bitch’ che<br />
sta manco ad una virgola di distanza da ‘jesus’ (e del resto<br />
Kanye aveva già avuto modo di precisare che “pussy<br />
and religion is all I need”), ingenuo da morire, ma - forse<br />
anche per questo - a tratti sinceramente commovente.<br />
Un ottimo album di HH commerciale, incisivo, luccicante,<br />
ma anche sanguigno, bello ruvido, con un’ottima media<br />
generale e qualche numero davvero potente.<br />
(7.3/10)<br />
gabriElE marino<br />
Karl marx WaS a broKEr - alpha to omEga<br />
(ESCapE From today, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: math stoner<br />
Un ossimoro come propulsore poetico di questo ordigno<br />
basso-batteria capace di snocciolare noise-wave<br />
intruppato math, carburato hardcore e dalle incandescenti<br />
derive stoner. Del resto questi tempi di templi<br />
(certezze economiche, fortezze finanziarie...) che crollano,<br />
autorizzano eccome una scudisciata nonsense come<br />
Karl Marx Was A Broker, questa la ragione sociale dei<br />
84 85
due pistoiesi al debutto con Alpha To Omega. Un power-duo<br />
che non proferisce parola, sissignori: lasciano<br />
che a parlare sia la strutturata veemenza del suono, la<br />
capacità di scomodare con quel minimo di armamentario<br />
- si aggiunga una loop station - massimi sistemi<br />
quali Kyuss, Fugazi, i Wire più tracotanti, i primi efferati<br />
Red Hot Chili Peppers (nelle convulsioni funky di<br />
Destruction Derby) e persino quei buontemponi dei Foo<br />
Fighters (nella beffarda Teletubbie).<br />
Ma poi i testi in realtà ci sono, stanno nel libretto come<br />
un invito a cantarli (?) in autonomia, magari meditando<br />
su quella carrellata di volti catalogati con spirito lombrosiano,<br />
trovandoci non la segreta radice del male ma il<br />
segno stesso della patologia classista, poi conclamata in<br />
un’altra straordinaria immagine dove la borghesia “illuminata”<br />
si concede una seduta spiritica per indagare ciò<br />
che non gli è dato sapere. Avrete capito che la sostanza<br />
sonora - apprezzabile ma in fondo poco originale e brillante<br />
solo a tratti - rappresenta l’ingrediente principale<br />
ma non il migliore d’una proposta che sembra invece<br />
compiersi nel suo insieme concettuale, al modo d’un<br />
sacrosanto scapaccione che vaporizzi il torpore.<br />
Che la data di uscita - l’undici settembre - sia tutto fuorché<br />
casuale, è un sospetto da ritenersi fondato.<br />
(6.8/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
KaSabian - VEloCiraptor (Sony, SEttEmbrE<br />
2011)<br />
Genere: pop<br />
Ripartire dopo un album come West Ryder Pauper Lunatic<br />
Asylum non deve essere stato facile. La formula<br />
che si è rivelata vincente (quel peculiare melange di<br />
pop, dance, psychedelia e kasabianismi vari) non era<br />
replicabile senza tirare la coperta da una parte o dall’altra.<br />
Alla fine si è optato per la strada apparentemente<br />
meno avventurosa, quella di suono più pop e sofisticato.<br />
Hanno un bel dire Pizzorno e compagni quando affermano<br />
di aver voluto realizzare un album di rock classico;<br />
canzoni come la ben nota Days Are Forgotten, contengono<br />
alcuni dei chorus più immediati fin qui scritti dal<br />
gruppo del Leicestershire. Attenti però a parlare di gioco<br />
al ribasso, perchè i Kasabian questa volta guadagnano<br />
in ecletticità quello che hanno ceduto in originalità.<br />
Grazie ad un utilizzo più consapevole dello studio di<br />
registrazione (oltre ai notevoli mezzi messi a loro disposizione<br />
dall’etichetta) azzardano da un lato temi cinematici<br />
con tanto di orchestra (Let’s Roll Like We Used<br />
To) e pimpanti soul pop bacharachiani (Goodbye Kiss),<br />
dall’altro puntate più decise nella musica da club (I Hear<br />
Voices) e caldi riff da Stones dei tardi 70s (Re-Wired).<br />
Si divertono, e questo è evidente, soprattutto quando<br />
recuperano quella lunaticità del disco precedente: La<br />
Fée Verte e Neon Noon sono i due estremi della loro concezione<br />
di ballad psichedelica (sbilenca e merseybeat<br />
la prima, lunare e vagamente kraut la seconda) a dimostrazione<br />
che c’è ancora possibilità di redimere il loro<br />
lato più smaccatamente tamarro.<br />
Certo, è con brani Switchblade Smiles e Velociraptor che<br />
i quattro dimostrano di trovarsi più a loro agio: meccanismi<br />
dance rock ben rodati che loro descrivono come<br />
la musica del futuro, ma che alle nostre orecchie suonano<br />
come l’ennesima riproposizione dei loro groove più<br />
muscolari, quelli che ne hanno fatto degli entertainer di<br />
lusso anche per gli ascoltatori più sgamati. Oggi più che<br />
mai dipende quanto si ha voglia di stare al loro gioco.<br />
(6.6/10)<br />
Edoardo bridda<br />
KErEn ann - 101 (Emi, giugno 2011)<br />
Genere: pop<br />
Sembra che a Keren Ann i quattro anni di distacco tra<br />
questo nuovo 101 e il precedente omonimo abbiano<br />
fatto gran bene. Abbandonate le radici folk e le immaturità<br />
stilistiche, la fanciulla israeliana trapiantata nella<br />
capitale francese e poi a New York ha costruito un disco<br />
perfettamente pop, un album tondo, di giri, giochi melodici<br />
ben riusciti e ottimamente prodotti.<br />
Una nuova direzione, tutta concentrata nella via di mezzo<br />
che c’è tra una ballata dai tratti beatlesiani com’è Run<br />
With You e un singolone radiofonico e tirato come My<br />
Name Is Trouble. Quel che emerge è che Keren Ann conosce<br />
la materia, sa esattamente cosa significa mettere<br />
in piedi un discorso orientato alla melodia, alle armonie<br />
proprie della più pura musica pop. 101 è anzitutto un<br />
disco calibrato e raffinato, che dimostra le conoscenze<br />
musicali della sua autrice e la capacità di farle proprie.<br />
Un’interessante svolta per un talento vocale indiscutibile<br />
che tra uno sguardo agli 80s insieme a Belle and<br />
Sebastian e Madonna (Sugar Mama) non rinuncia ai<br />
60s con Blood On My Hands (il brano più convincente<br />
dell’intero album).<br />
Non siamo di fronte a qualcosa di strutturalmente importante,<br />
o a un disco che possa andare molto oltre i<br />
gusti dei fan, tuttavia 101 rappresenta una buona affermazione<br />
artistica da parte di un’autrice che fa dell’eterogeneità,<br />
delle più disparate scelte melodiche, il suo<br />
fiore all’occhiello.<br />
(6.8/10)<br />
giulia CaValiErE<br />
KindESt linES - CoVErEd in duSt (WiErd,<br />
giugno 2011)<br />
Genere: Dream-synth-pop<br />
I Cure del primo periodo virati al femminile. Certo, è sicuramente<br />
una lettura troppo semplicistica ma Covered<br />
In Dust, l’esordio lungo dei Kindest Lines, profuma di<br />
Disintegration lontano un miglio.<br />
La band di New Orleans si muove su territori non troppo<br />
lontani da quelli della casa madre Wierd, ovvero synthwave<br />
scura e malinconica, ma evidenzia uno scarto sensibile<br />
rispetto a certe oscure presenze del catalogo della<br />
label newyorchese grazie agli accenti accessibilmente<br />
pop e un romanticismo di fondo più marcati. In questo<br />
senso, il riferimento ai Cure è più un complimento che<br />
una accusa, visto che i tre riescono a far rivivere le atmosfere<br />
plumbee e opprimenti ma piene di romanticismo<br />
della prima fase - guarda caso anch’essa a tre - della<br />
band di Robert Smith.<br />
Jack Champagne (chitarre), Justin Blaire Vial (tastiere,<br />
drum programming) e Brittany Terry (voce, tastiere)<br />
inscenano una pop-wave spesso sintetica, dal taglio<br />
esistenzialista e dalle atmosfere dreaming che smussa<br />
gli angoli e le ossessività cold-wave di riferimento grazie<br />
soprattutto alla voce heavenly di Brittany: calda ed<br />
evocativa, la fa immaginare come una eroina goth rinchiusa<br />
in qualche torre medievale, ma da sola non riesce<br />
a tenere in piedi l’impalcatura sonora del trio.<br />
Gli spunti più interessanti però giungono quando il trio<br />
si smarca dall’ingombrante riferimento per muoversi<br />
in una sorta di electro-disco 80s in bassissima battuta<br />
come nell’ebm virata sensualità synth-pop di Running<br />
Into Next Year, nella disco-dark di Strange Birds o nel funk<br />
robotico e struggente della conclusiva Colors Treasured.<br />
Cosa questa che ci fa però ben sperare per le future evoluzioni<br />
personali.<br />
(6.6/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
la muga lEna - Strani pupazzi umanoidi<br />
SEnza FaCCia (autoprodotto, luglio 2011)<br />
Genere: post rock<br />
Post rock prima. Poi psichedelia progressive, e qualche<br />
entrata jazz e funk: ecco servita la seconda prova dei La<br />
Muga Lena, ovvero Strani pupazzi umanoidi senza<br />
faccia.<br />
La formazione messinese riconferma la buona impressione<br />
che già aveva suscitato Ciarlatani di brasiliana memoria,<br />
aggiornando le fascinazioni Tortoise alla musica<br />
componibile dei Mariposa. Sembrano canzoni assemblate<br />
queste 8 tracce: pelli e chitarre pestano le solite<br />
poliritmie di casa Chicago (Soo-har & Zazz-o-Reus), arri-<br />
vano i synth e attaccano variazioni psych/prog più ‘70<br />
che Motorpsycho (La morte di Abu Mazen, Anonimia),<br />
poi Gaet ci mette la voce e pare un grunger navigato<br />
tipo Eddie Vedder (Ester Coraro).<br />
Unico neo: manca un pò di quello spirito surreale e<br />
weird che era nelle corde gruppo (vedi citazioni a fantomatici<br />
movimenti per i diritti psichedelici e copertina<br />
che pare uscita dal pennello di Magritte); c’è fantasia<br />
negli arrangiamenti ma rigorosità nell’interpretazione<br />
dei generi, e viene meno quel pizzico di personalità che<br />
avrebbe garantito il salto della palude indie. Ma non c’è<br />
fretta, comunque è un bel sentire.<br />
(6.8/10)<br />
StEFano gaz<br />
ladybug tranSiStor (thE) - ClutChing<br />
StEmS (mErgE, luglio 2011)<br />
Genere: pop rock<br />
Quattro anni esatti dopo Can’t Wait Another Day, metabolizzata<br />
- per quanto e come sia possibile in questi casi<br />
- la tragica morte del batterista San Fadyl, tornano i Ladybug<br />
Transistor di Gary Olson a propinarci la loro affabile,<br />
affidabile, appassionata disinvoltura. Nulla è cambiato<br />
in questo Clutching Stems - settimo opus lungo<br />
per la band di Brooklyn - se non un ulteriore grado di<br />
pacatezza, dietro la quale avverti vibrare il consueto mix<br />
di trepidazione e abbandono, la propensione per il pop<br />
accomodante ma nient’affatto scontato, messo a punto<br />
sintetizzando l’ineffabile guittezza di Scott Walker,<br />
l’arcobaleno pop Bacharach, i palpiti tenui Left Banke,<br />
un pizzico d’estro Morrissey, dosi omeopatiche Kinks<br />
e via discorrendo.<br />
Un intruglio (indie-)pop capace di filare liscio mentre<br />
ti suggerisce tutta la complessità del patrimonio genetico,<br />
in virtù della disarmante facilità di scrittura riconducibile<br />
alle calligrafie dei Jens Lekman, dei Calexico,<br />
dei Belle And Sebastian e dei Clientele. Dieci tracce<br />
senza clamorosi sussulti né cadute, tra le quali meritano<br />
particolare menzione Oh Christina (dalle gradevolissime<br />
fragranze cameristiche sixties), una Light On The Narrow<br />
Gauge mossa da morbida urgenza Prefab Sprout via<br />
Sea And Cake, l’indolentemente bossa Caught Don’t<br />
Walk e una title track che incede vagamente wave come<br />
un contagio dei più soffici Wire.<br />
Come al solito non sembra nelle loro corde licenziare<br />
un disco capace di fare il botto. Ma è sempre un piacere<br />
averci di nuovo a che fare.<br />
(6.8/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
86 87
ladytron - graVity thE SEduCEr (nEttWErK<br />
muSiC group, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: electro pop<br />
Il problema con il nuovo Ladytron è che i quattro ci<br />
avevano abituato male. Apparsi come precursori, in un<br />
periodo in cui l’electropop non se lo filava nessuno, arrivavano<br />
sul pezzo col giusto anticipo per rimodulare i<br />
suoni sulla lunghezza dell’electroclash.<br />
Fiutando appena in tempo il cambiamento, seppero<br />
fare di Witching Hour e Velocifero gli ideali marchingegni<br />
wave pop psichedelici, inseriti perfettamente in<br />
un panorama indipendente che stava riscoprendo shoegaze<br />
e post punk.<br />
A questo punto, con un decennio sulle spalle, un nome<br />
rispettato un pò ovunque e una schiera di electro poppers<br />
che incalza, il quartetto si trova a ragionare sul da<br />
farsi, tentato da un ritorno a casa con gli onori dei prime<br />
movers e la ricerca di nuovi pertugi in cui far infiltrare il<br />
loro dar dark pop.<br />
La risposta, diciamolo subito, non sempre convince. Non<br />
lo fa con le percussioni latine di Melting Ice e tantomeno<br />
con i tormenti onirici di Ambulances, in cui le sofferte<br />
voci aeree infrangono definitivamente il tabù della glacialità<br />
ladytroniana.<br />
In una situazione del genere tanto vale affidarsi al mestiere:<br />
quando si tratta di costruire strutture sintetiche<br />
boreali, come quelle di White Elephant e Moon Palace,<br />
con quelle linee electro fluttuanti, gli inglesi dimostrano<br />
ancora di sapere il fatto loro; stessa cosa può dirsi degli<br />
assalti wave dello strumentale Ritual.<br />
Si rileva pure qualche positivo elemento di novità (con<br />
Trasparent Days, una sorta di Atmosphere pacificata, carica<br />
di mistero e positività, ideale colonna sonora per<br />
film sulla scoperta di nuovi mondi), tanto che alla fine riescono<br />
a far pendere la bilancia a loro favore; mai come<br />
in questo caso, però, si era percepita l’assenza di progettualità,<br />
cosa non da poco quando si è metà umani e<br />
matà macchine come i Ladytron.<br />
(6.8/10)<br />
diEgo ballani<br />
lantErnS on thE laKE - graCiouS tidE, taKE<br />
mE homE (bElla union, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: folk<br />
La voce celestiale di Hazel Wilde si spande come uno<br />
spirito sull’opener Lungs Quicken. E subito vengono in<br />
mente i Sigur Rós: atmosfere dilatate e angeliche per<br />
un dream pop dalle tinte bucoliche sorretto da spasmi<br />
elettronici. Come sottolinea la stessa etichetta, la<br />
stampa probabilmente (e i blogger soprattutto) farà<br />
largo uso dell’immaginario 4AD per raccontarci questo<br />
esordio sulla lunga durata del sestetto di Newcastle. E’<br />
tutto vero, ma ci pensa l’alternarsi delle voci femminile<br />
e maschile, quella di Paul Gregory, a garantire un po’<br />
di variabilità. Oltre a un immaginario che non si ferma<br />
sulla porta del gruppo islandese, ma attinge ad atmosfere<br />
cinematografiche (Keep On Trying), al folk-rock (A<br />
Kingdom, davvero adrenalinica ed evocativa), alle ballad<br />
narcotiche (Blankets Of Leaves, I Love You Sleepyhead).<br />
Ma fanno capolino anche circolarità post (If I’ve Been<br />
Unkind) e arrangiamenti cameristici.<br />
Si sono scomodati i Low e i Mazzy Star, band di cui si<br />
possono ritrovare in filigrana le lezioni. Ma la verità è<br />
che ci troviamo di fronte a un altro frutto dell’incontro<br />
tra il dream-pop e il folk più trasognato di questi ultimi<br />
tempi, quel settore che più che raccontare - come da<br />
tradizione - le storie di un luogo ne evoca la luce, i colori,<br />
l’allure, il ricordo. Suonato bene, arrangiato meglio,<br />
Gracious Tide, Take Me Home mieterà cuori e consensi,<br />
stimolerà incontri erotici e qualche viaggio della fantasia,<br />
ma come gli amori estivi, sarà dimenticato al primo<br />
temporale autunnale.<br />
(6.6/10)<br />
marCo boSColo<br />
lEgEndary Kid Combo (thE) - CaraVanSaray<br />
(u-pop, giugno 2011)<br />
Genere: folk-rock<br />
Rockabilly (Hangman) e balcani (Mustapha) miscelati<br />
a un recupero da isola ecologica che affianca i Beastie<br />
Boys di Fight For Your Rights, i Guns & Roses di Pasadise<br />
City, lo Snoop Dogg di My Medicine. In un punk-folk scapicollante<br />
a metà strada tra Sons & Daughters, Tito &<br />
Tarantula e Gogol Bordello che in fatto di (ipotetiche)<br />
truzzerie non scherza affatto.<br />
Ma li si perdona, i The Legendary Kid Combo, ché di<br />
immaginario si nutrono e quello propagandato dal loro<br />
terzo disco è come al solito polveroso e rustico, battagliero<br />
e di confine. Quanto basta per riconfermare le<br />
buone cose già ascoltate in passato e aggiungere un<br />
nuovo mattoncino alla produzione di una band che rimane<br />
soprattutto concerti, sudore, energia sprigionata.<br />
Chi cerca innovazione si rivolga altrove perchè qui le<br />
virtù sono altre: solidità, buona tecnica, entusiasmo da<br />
vendere. E un approccio fisico capace di conquistare anche<br />
quella U-Pop chiamata a curare la stampa del disco<br />
per il mercato giapponese.<br />
(6.4/10)<br />
Fabrizio zampighi<br />
highlight<br />
laura marling - a CrEaturE i don’t KnoW (Virgin, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: folk-rock<br />
Con gli artisti “giovani” c’è il rischio latente di eccedere con la severità. Il cinismo si mette in mezzo e,<br />
come nel caso della cantautrice britannica Laura Marling, si oscilla tra il desiderio di conferme e quello<br />
di una crescita che si riveli il più possibile armonica, degna di un indubbio<br />
talento. E’ stata infatti fulminea la carriera della ventunenne, assurta dal<br />
quieto Hampshire alle cronache con due dischi di folk-rock mai scontato<br />
che l’hanno condotta fuori dalla (presunta) “scena” di West London che ne<br />
battezzò i primi passi. Perché se è facile lasciarsi indietro i mediocri Noah<br />
And The Whale, un po’ meno lo è imporsi su Mumford & Sons e soprattutto<br />
su Johnny Flynn.<br />
In Alas, I Cannot Swim e in I Speak Because I Can respiravi però passione e<br />
padronanza di mezzi che A Creature I Don’t Know conferma appieno, tratteggiando<br />
altre belle canzoni di taglio classico all’insegna di una minuziosa cura per l’essenza e il dettaglio<br />
e della confessionalità ombrosa che fu di Joni Mitchell e Sandy Denny. Le cui anime Laura sovrappone<br />
(Sophia, The Beast) oppure fonde (la scarna, sublimemente inquieta Rest In The Bed Of My Bones; una<br />
briosa All My Range; la struttura umorale e i robusti echi dylaniani di Salinas). Altrove prediligendo vivide<br />
ipotesi di Leonard Cohen al femminile (Night After Night) o di una Suzanne Vega sospesa tra prateria<br />
e brughiera (The Muse). Si arriva alla fine senza accorgersene: si ricomincia, riscaldati di malinconia e<br />
appagamento. Felici, addirittura.<br />
(7.3/10)<br />
gianCarlo turra<br />
lEnny KraVitz - blaCK and WhitE amEriCa<br />
(roadrunnEr rECordS, agoSto 2011)<br />
Genere: funk rock<br />
Suvvia: ormai Lenny Kravitz è un libro aperto. Potremmo<br />
riutilizzare quanto scrivemmo tre anni fa per<br />
It Is time For A Love Revolution e avremmo bella che<br />
pronta la recensione di questo nuovo Black And White<br />
America. Che tuttavia si merita qualche riga aggiuntiva,<br />
non fosse perché spiega ancor più e meglio la fenomenologia<br />
pop del musicista newyorkese. A partire dal titolo,<br />
che ammicca appunto il menù sonico del Nostro: da<br />
una parte rock bianco (impetuoso, turgido, incalzante)<br />
e dall’altra funk-soul (con propaggini errebì e psych).<br />
Aggiungete aromi artificiali sparsi ed eventuali e voilà,<br />
il gioco è fatto. Attenzione però, la sintesi è un’opzione<br />
non contemplata: Kravitz si esprime a compartimenti<br />
stagni. Egli è tipo che va dritto al sodo, o di là o di quà.<br />
Bando alle copule promiscue e alle sfumature. Il suo repertorio<br />
è una celebrazione della rock star dominante,<br />
capace di contenere musica “bianca” e “nera” che non<br />
s’incontrano mai davvero ma si alternano in Lui come<br />
nella suite di un albergo a ore d’alto bordo.<br />
In questo senso, la dichiarazione di voler pubblicare un<br />
disco composto da tutti potenziali singoli è una smargiassata<br />
perfettamente in linea col personaggio, e che<br />
trova in effetti riscontro nelle sedici tracce in scaletta.<br />
Ogni pezzo sembra infatti progettato per uscire immediato,<br />
accattivante, efficace. Sempre comunque limitandosi<br />
ad un sapiente utilizzo dei cliché, e ottenendone<br />
quindi una profondità emotiva paragonabile a quella<br />
della leggendaria tartaruga addominale dell’aitante<br />
newyorkese (il fenomeno Kravitz non può prescindere<br />
dalla sua bellezza e dalla prestanza fisica). Va detto che<br />
quando si cimenta con le categorie black è davvero un<br />
drago, non tanto per la blaxploitation annacquata della<br />
title track quanto per il James Brown esplicitamente<br />
omaggiato in Life Ain’t Ever Been Better Than It Is Now,<br />
per il Marvin Gaye trafelato Jamiroquai di Liquid Jesus<br />
o per i testosteroni bradipi Isaac Hayes di Looking Back<br />
On Love.<br />
Meno bene - nel senso che stazionano dalle parti della<br />
più scontata insulsaggine - vanno le escursioni powerpop<br />
virate wave di In The Black, la tamarrata Cars di Rock<br />
Star City Life, lo sdilinquimento da boy band di Dream, il<br />
David Bowie altezza Ashes To Ashes di I Can’t Be Without<br />
88 89
You, la piattezza da cartolina di Stand e persino quella<br />
specie di Hall & Oates apocrifo di Superlove. Peccato<br />
perché l’uomo è tutt’altro che sprovveduto, come ben<br />
sapete, e infatti una Come On Get It sciorina crossover<br />
ad alto voltaggio che si sbrana d’amblé tutto l’ultimo<br />
Red Hot Chili Peppers, mentre le due tracce con special<br />
guest non sono affatto male (più scontato lo pseudodancehall<br />
di Bongie Drop - assieme a Jay-Z e DJ Military<br />
- mentre Sunflower è tropical funky evoluto frutto<br />
della collaborazione con Drake). Tutto come previsto<br />
insomma. Massimo della confezione, minimo di sostanza.<br />
Successo, va da sé, garantito a prescindere.<br />
(5.8/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
maCE. - antEnnaS to hEll (muSiCaoltranza,<br />
luglio 2011)<br />
Genere: trip-hop ambientstep<br />
Il primo EP ufficiale del duo padovano formato da Andrea<br />
Maso ed Enrico Cesaro propone un’elettronica<br />
contaminata dalle ultime derive fourtet-radioheadiane,<br />
viaggiando su coordinate che ammiccano alle atmosfere<br />
cupe della bristol dei Massive Attack (Handful Of<br />
Dirt), tagliate con le passioni oniriche di Björk (il remix<br />
di I See Who You Are), passando per cut up da telegiornali<br />
e comunicati stampa che ricordano DJ Shadow<br />
mescolato con un attivismo d’antan e atmosfere postnucleari<br />
(il riferimento a Chernobyl nell’annuncio del<br />
telegiornale italiano del 26 aprile 1986 in Opiate For The<br />
Masses, sezionato con citazioni di Krishnamurti, Dalì,<br />
Giovanni Paolo II e i comunicati delle BR) e concludendo<br />
con un’electrostep da tunnel berlinese che ha in sè<br />
più di qualche ricordo dell’evergreen Adriano Canzian<br />
(Produce!Consume!Die!).<br />
Venti minuti che si rifanno alle storiche coordinate d’obbligo<br />
e che tentano di dire qualcosa di più della solita<br />
esibizione di nerdismo e di trick collegati alla scena. Un<br />
duo che con un approccio punk inizia a produrre tracce<br />
con un ritmo forsennato (l’EP è scaricabile dal sito<br />
dell’etichetta e negli ultimi tempi si sono moltiplicate<br />
le tracce sul loro account Soundcloud) e che potrebbe<br />
diventare la next big thing dell’ambient drone italica<br />
(vedi anche la colonna sonora di un video di Arvo<br />
Udtor). Check em out, guys.<br />
(6.9/10)<br />
marCo braggion<br />
malE bonding - EndlESS noW (Sub pop,<br />
agoSto 2011)<br />
Genere: inDie lo fi<br />
Ora che il quadro si fa più chiaro e che diverse band del<br />
sottobosco lo-fi garage di entrambe le sponde dell’oceano<br />
sono passate dall’altra parte dello specchio (ovvero<br />
dall’underground più carbonaro a quello capace di<br />
manifestarsi anche ai non iniziati) è il momento di fare<br />
il conto con fattori non sempre collegati all’hype, cose<br />
come originalità e ispirazione, ad esempio.<br />
Posto che la prima è materia più che rara, accontentiamoci<br />
di quest’ultima e salutiamo il secondo lavoro dei<br />
Male Bonding come il più ispirato di tutto il (fu) DIY<br />
britannico. Endless Now mette a frutto la formula del<br />
precedente album senza voli pindarici e superproduzioni<br />
(pur paventate in sede di intervista) ma perfezionando<br />
quel peculiare mix fra rumore e melodia che ne<br />
ha caratterizzato gli esordi.<br />
A partire dall’opener Tame The Sun, John Artur Webb e<br />
compagni ci srotolano dinnanzi una formula più semplice<br />
che mai, fatta di ritmiche pop punk, voci soavi che si<br />
stendono come glassa sulle chitarre infuocate. Rispetto<br />
all’esordio rinunciano a quei break ritmici che avevano<br />
fatto parlare un pò tutti di art punk evoluto (e aveva<br />
fatto balenare il nome della SST), preferendogli la linearità<br />
e il feroce appeal delle melodie. Quando (su What’s<br />
That Scene) rallentano il passo, riemerge quel clangore<br />
psichedelico che porta acqua al revival del grunge.<br />
Per il resto, quello di Endless Now è scintillante pop<br />
chitarristico targato 2011. Meno cervellotico rispetto<br />
all’esordio ma non certo meno stimolante. Come nel<br />
caso del primo singolo Bones: un vero e proprio mantra<br />
pop punk psichedelico, sei minuti di ritmiche furiose e<br />
vocalizzi angelici che ci segnalano come i Male Bonding<br />
restino degli stilosissimi figli dell’underground meno assimilabile.<br />
(7.1/10)<br />
diEgo ballani<br />
marC almond/miChaEl CaShmorE -<br />
FEaSting With panthErS (ChErry rEd<br />
rECordS, giugno 2011)<br />
Genere: crooner DecaDente<br />
Avvezzo a trafficare con la decadenza e le trascrizioni<br />
poetiche in un cantautorato sui generis, Marc Almond<br />
coglie l’occasione di far tutt’uno lavorando qui su poesie<br />
di Eric Stenbock con il compositore Michael Cashmore,<br />
stretto collaboratore di quel David Tibet che (ahem )<br />
benedì inconsapevolmente il progetto, regalando all’ex<br />
Soft Cell un volume di scritti del conte Stanislaus Eric<br />
Stenbock edito dalla sua Durtro. Attrazione fatale e<br />
istantanea sia tra i due che verso il poco noto poeta,<br />
poiché Mark allestiva una performance alla Queen Elizabeth<br />
Hall nel 2008 coi Current 93 e a lungo scambiava<br />
file sonori per via telematica con Cashmore, domiciliato<br />
highlight<br />
littlE dragon - ritual union (young turKS, luglio 2011)<br />
Genere: soul-tronica<br />
Giusto il tempo di ritrovare e apprezzare Yukimi nel singolo Wildfire dell’acclamato album di SBTRKT,<br />
in un brano che era una via di mezzo tra il grime e i Gorillaz, e ci ritroviamo a parlare un gran bene dei<br />
Little Dragon di Göteborg, formazione giunta splendidamente al terzo album con una miscela di (synth)<br />
soul elettronico e, in generale, una forbice larghissima di richiami r’n’b.<br />
Rispetto alle modalità del precedente Machine Dreams, e al discorso roots<br />
dell’esordio, l’aspetto più convincente della nuova prova è senz’altro l’avvicinamento<br />
della formula alle correnti elettroniche inglesi. Vengono aggiunte<br />
certe metronomie wave (Please Turn) ma, di fatto, il disco si presta in pieno<br />
alle speculazioni del dopo-dubstep e alla ventata uber soul del 2011 (l’opener<br />
Ritual Union, tra bassi cadenzati e stepping Uk Bass) .<br />
Feat. come Empire Ants su Plastic Beach (un rifforama synth sci-fiesque<br />
‘70) rilevano, inoltre, quanto i Dragons siano maturati come arrangiatori<br />
e liberato la fantasia: in Ritual Union li vediamo giocare con Kazu Makino / Madonna in tappeti disco<br />
mutanti Caribou via Residents (Nightlight), alle prese con sex funk à la Prince (ancora Ritual Union),<br />
Liquid Liquid e DFA (Brush The Heat), stepping secchi à la Ramadanman più cinematica assortita (When<br />
I Go Out), cineserie varie (Shuffle A Dream, Seconds) e le citate wave prontamente attualizzate (Little Man,<br />
Summertearz).<br />
Per l’estate più virtuale che reale che stiamo vivendo, la chiave è naturalmente e dannatamente soul<br />
(Wildfire, Ritual Union) e questa è world music nel senso più aggiornato e positivo del termine.<br />
Assieme a SBTRKT, Ritual Union disco del momento.<br />
(7.3/10)<br />
Edoardo bridda<br />
a Berlino. Non ne risente la compattezza di un album da<br />
fruire nell’assieme improntato a un romanticismo torbido<br />
d’ambiguità, lungo il quale Almond - mai prima così<br />
devoto a Maestro Scott Walker e al giovane Brian Ferry<br />
- poggia la perfetta padronanza dei propri mezzi vocali<br />
sui rigogli d’archi e corde, piano ed elettronica concepiti<br />
da Michael. Idea stimolante sulla carta e tuttavia la<br />
seduzione iniziale lascia spazio a un eccesso di uniformità,<br />
a una proposta che in un’ora smarrisce pian piano<br />
incisività e forza persuasiva per divenire puro estetismo.<br />
Consegnando così un disco coraggioso, mediamente riuscito<br />
quantunque piuttosto monocorde.<br />
(6.7/10)<br />
gianCarlo turra<br />
marCEllo milanESE - liKE a WolF in a<br />
ChiCKEn ShaCK (hEllEluJa, luglio 2011)<br />
Genere: blues<br />
Il blues è da sempre una sorta di riserva protetta. Un’area<br />
franca in cui sondare un immaginario talmente radicato<br />
nel tempo e nello spazio da giustificare ogni genere<br />
di replica. Lo era in origine, quando sulle stesse dodici<br />
battute gli afroamericani costruivano storie e suoni non<br />
troppo dissimili tra loro, lo è ancor oggi che di blues non<br />
si parla quasi più se non nelle sezioni “classic” di qualche<br />
rivista musicale. Aggiungete il fatto che in una provincia<br />
dell’Impero come l’Italia gli stili e le musiche arrivano per<br />
forza di cose di riflesso filtrate da una reinterpretazione<br />
che non disdegna gli stereotipi, e capirete il significato di<br />
un disco come Like A Wolf In A Chicken Shack: un sentito<br />
omaggio a una passione che viene da lontano da parte<br />
di un affezionato cultore.<br />
A far selezione, in questi casi, è la credibilità. E Marcello<br />
Milanese, pur non avendo l’estro di un Jon Spencer o<br />
la carica innovativa del nostro Samuel Katarro, porta a<br />
termine il suo onesto lavoro filologico con convinzione,<br />
potendo tra l’altro vantare una ventina d’anni spesi a<br />
trafficare con slide guitars e affini.<br />
Nelle corde del musicista di Alessandria ci sono l’Eric<br />
Clapton unplugged, il delta del Mississipi, il timbro vocale<br />
di Howlin’ Wolf, oltre alla voglia di riallacciarsi a<br />
una tradizione musicale popolare che sa anche di soul,<br />
rock & roll, folk. Attraverso brani autografi e cover di Tom<br />
Waits (Jesus Gonna Be Here), June Carter (Ring Of Fire),<br />
90 91
highlight<br />
maChinEdrum - room(S) (planEt mu rECordS, luglio 2011)<br />
Genere: Juke, future GaraGe<br />
È bastato poco più di un mese dopo l’uscita a luglio perché la stampa internazionale si scatenasse intorno<br />
a quest’album, tutti (quasi) unanimenente concordi nel porlo tra i dischi dell’anno ma ognuno a<br />
inquadrarlo in modo differente: tra chi l’ha definito l’Untrue del footwork (!) e chi un album dall’anima<br />
pop (!!), passando per derivazioni breakbeat, stepping e dance di ogni sorta, oggi urge sicuramente<br />
fare un po’ d’ordine.<br />
Certo, lui è Travis Stewart, uno che ha le mani in pasta in tutte le più interessanti<br />
evoluzioni elettroniche moderne. Uno che da dieci anni scatena<br />
un polverone ogni volta che si fa sentire: da quel Now You Know del 2001,<br />
che ha praticamente traghettato l’idm anni ‘90 nel nuovo millennio, è stato<br />
un susseguirsi di sperimentazioni ambient lungo tessuti abstract hip-hop,<br />
fino ad arrivare al 2010 e al progetto Sepalcure, vero e proprio laboratorio<br />
di ricerca post-dubstep messo in piedi nella Hotflush di Scuba. Con<br />
quest’ultimo Room(s) il girovago Machinedrum di fatto tira le fila delle sue<br />
espressioni e realizza un multifacciale anello di congiunzione tra juke, future<br />
garage e soulstep, uno di quei dischi avant che toccano disinvolti l’intero ventaglio di ibridazioni electro<br />
moderne e rendono naturali le discordanze interpretative.<br />
Partiamo dalla questione più spinosa, ossia il footwork. Che le mosse intraprese dai vari DJ Nate, DJ<br />
Rashad, DJ Diamond presto o tardi avrebbero trovato il perfezionamento formale era largamente<br />
prevedibile, ma quel che conta è la modalità: con tracce come GBYE e Come1, Machinedrum applica<br />
l’approccio cut’n’loop alla materia 2-step UK garage, raggiungendo la sintesi dei tempi ritmici e lasciando<br />
che i due pezzi dell’incastro si migliorino a vicenda. L’imprinting dance britannico ne esce potenziato<br />
dalla muscolarità importata da Chicago mentre il juke, da artificio musicale da strada, diventa nobile<br />
breakbeat con grandi potenzialità di ascolto (e headbanging annesso). Ciliegina sulla torta, Youniverse fa<br />
tesoro dello zeitgeist e sfuma il tutto su frammenti soul e divertissement Jamie XX. E il cerchio si chiude.<br />
È dunque presumibile che il footwork abbia trovato il suo nord, ma Room(s) non va considerato un album-manifesto<br />
perché è anche (soprattutto) tante altre cose. È l’alta definizione dell’ellissi post-dubstep,<br />
che supera la deepness UK bass ma non esagera in lallazioni. Stewart parte da un fondo di reminescenza<br />
jungle breakbeat (U Don’t Survive), passa attraverso le cornici soul del primo Burial (She Died There),<br />
raggiunge SBTRKT e lo supera dalla corsia centrale, non cedendo all’infatuazione melodica e restando<br />
saldamente dentro la bolla step (Lay Me Down, essenza soul e attitudine dance tenendo comunque<br />
lontana la pista di Katy B).<br />
Non sarà l’album epocale che vogliono farci credere (non con James Blake e SBTRKT alle spalle, quantomeno),<br />
ma il meccanismo è solido e conquista il baricentro della scena attuale, sfoderando una tecnica<br />
invidiabile e offrendo al contempo materiale che dura nel tempo: come Now U Know Tha Deal 4 Real,<br />
jungle meets ambient meets r’n’b-soul, con produzione monumentale e tuffo al cuore immediato. Il<br />
nuovo testamento per la generazione dei soulsteppers è tutto qui, ora si attendono le reazioni.<br />
(7.7/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
Ray Charles (Hallelujah I Love Her So), Willie Dixon (Built<br />
For Confort), John Campbell (Aint Afraid Of Midnight),<br />
Bert Berns (Cry To Me) e Arthur Crudup (That’s All Right<br />
Mama) riarrangiate voce, chitarra e stomp box.<br />
“No overdubs, no pedal effects, no electronics triks”, recitano<br />
i crediti del disco. Tanto per sottolineare che anche la<br />
conservazione della specie è un affare serissimo.<br />
(6.4/10)<br />
Fabrizio zampighi<br />
marCo notari - io? (libEllula muSiC,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: pop-rock<br />
In Marco Notari convivono da sempre due anime:<br />
quella “istituzionale” riconducibile a una scrittura tutto<br />
sommato classica sorta di via di mezzo tra pop ad<br />
ampio spettro, rock e canzone d’autore (ai tempi del<br />
primo disco il nostro finì anche su Rai Uno) e quella “avventurosa”<br />
ascrivibile invece a scelte stilistico-estetiche<br />
comunque ricercate. Scelte che all’ Oltre lo specchio del<br />
2006 valsero una nomination a miglior esordio dell’anno<br />
al PIMI e un certo interesse da parte di addetti ai<br />
lavori e pubblico.<br />
A seguire il concept (ennesimo link col cantautorato, in<br />
questo caso dei Settanta) di Babele, per un discorso musicale<br />
costantemente in evoluzione e portato avanti con<br />
gli amici Madam. Fino ai giorni nostri, raccontati da un<br />
Io? che rimescola ulteriormente le carte facendo assomigliare<br />
Notari a un Lele Battista appena più edulcorato:<br />
stessa cura per i dettagli, stesso rispetto per la forma<br />
canzone, stessa sovrastruttura strumentale impeccabile,<br />
diverso il suono. Nel caso dell’ex cantante dei La<br />
sintesi una forma canzone comunque legata agli amati<br />
anni Ottanta, in Notari un sentire evocativo, barocco,<br />
con qualche concessione a elettronica (Hamsik), wave<br />
(La terra senza l’uomo) e attualità (una Io? che rimanda<br />
alle complessità arrangiative del Sufjan Stevens di The<br />
Age Of Adz).<br />
Il terzo disco conferma la buona caratura del musicista<br />
torinese e lo smarca dagli esordi spiccatamente indie,<br />
concedendo meno spazio alle chitarre elettriche e lavorando<br />
di più sulle sfumature e gli arrangiamenti. Pur<br />
nell’ottica di una diversità che non spiazza, rimarcando<br />
invece stili e attitudini ormai consolidati.<br />
(6.8/10)<br />
Fabrizio zampighi<br />
marCuS daVidSon/ChriS WatSon - CroSSpollination<br />
(touCh muSiC uK, SEttEmbrE<br />
2011)<br />
Genere: fielD recorDinGs<br />
Touch pubblica un altro capitolo del lungo libro che<br />
Chris Watson sta scrivendo sul mondo che ci circonda.<br />
Figura fondamentale nell’ambito della sperimentazione<br />
sonora, field recordist tra i più creativi e appasionati e<br />
firma che regge con dovizia di argomentazioni, la marea<br />
di dibattiti teorici che puntualmente si abbatte su<br />
un campo che attira troppi presuntuosi dal microfono<br />
pronto e la mente scevra di idee. Cross-Pollination è<br />
composto di due tracce distinte e separate. La prima,<br />
Midnight at the Oasis, è una classica escursione nello<br />
stile del Nostro, con il deserto del Kalahiri nelle ore notturne<br />
come scenografia di riferimento. Di solito non c’è<br />
molto di cui disquisire di fronte a questo tipo di opere.<br />
Il puro e semplice scatto ambientale come documento<br />
sonoro che fotografa l’eterno presente della realtà è<br />
quello che si nasconde dietro l’incessante proliferare di<br />
suoni provenienti dal mondo animale e che è alla base<br />
del lavoro di Watson fin dai tempi di Stepping into the<br />
Dark.<br />
Diverso invece il discorso che si nasconde dietro le pieghe<br />
di The Bee Simphony, piece sperimentale condotta<br />
da Marcus Davidson sulla base delle registrazioni che<br />
Watson fa di un gruppo di api in un giardino inglese.<br />
Davidson si accorge che la tonalità del ronzio degli insetti<br />
può fornire il tuning ideale per l’intonazione di un<br />
coro di voci umane che “imita” l’elemento naturale. Il<br />
risultato è un affascinante excursus che si pone sul crinale<br />
di una serie di lavori analoghi, come Nuna di Mira<br />
Calix e Adaptation And Survival dei Tribes Of Neurot.<br />
Poi da qui, tutto diventa possibile. Anche trovare paragoni<br />
con il canto degli aborigeni o con le musiche sacre<br />
delle prime registrazioni corali, come sostiene Davidson.<br />
Cosa che per altro avvicina moltissimo questo lavoro<br />
alla classica contemporanea di Penderecki, che proprio<br />
in questi territori si alimentava.<br />
(7/10)<br />
antonEllo ComunalE<br />
maya galattiCi - analogiC SignalS From<br />
thE Sun (garagE rECordS, luglio 2011)<br />
Genere: psych rock<br />
E’ ancora possibile divertirsi con la musica mischiando<br />
l’elettronica primordiale con i ben consolidati suoni<br />
acustici? Se pensiamo a tutto quello che gli anni 90 ci<br />
hanno propinato - riflusso negli anni zero compreso -<br />
istintivamente verrebbe da rispondere “assolutamente<br />
no”. E invece inaspettatamente capita che dal comune<br />
92 93
trevigiano il cui nome è un omaggio al primo re d’Italia<br />
- e che diede i natali ad un musicologo illustre come<br />
Alberto Gentili - Vittorio Veneto, arrivi un duo, nato nel<br />
2010 dalle ceneri dei ben più rockeggianti Chinaski, che<br />
riapra il discorso per certi versi lasciato a metà.<br />
Sia ben chiaro: niente crossover, né postrock, né riletture<br />
illuminate. I Maya Galattici (Marco Pagot e Alessandro<br />
Antonel), a parte il nome fino al prossimo anno in<br />
odor di apocalisse, nel loro album d’esordio Analogic<br />
Signals From The Sun, svolgono benissimo un compitino<br />
ben circoscritto fatto di psichedelie indie pop e<br />
venature vintage; sonorità transeunte che vanno a posizionarsi<br />
nel ricco panorama sperimentale odierno fatto<br />
di continui rimandi tra vecchio e nuovo, passato e presente,<br />
rock e futuro. Perché qualcosa di nuovo, forte e<br />
sufficientemente gradevole bisognerà pure inventarselo<br />
prima o poi. Senza paura di scommettere, con lucidità,<br />
coraggio e convinzione.<br />
Ecco allora che il sole dei Maya ci invia un esempio più<br />
che valido di come disporre sullo scacchiere dell’elettronica<br />
i sempreverdi intensi e autentici sapori analogici<br />
condendo il tutto con un pizzico di onirica, poetica<br />
presunzione. Senza voltarsi ossessivamente indietro,<br />
con quell’approccio di insaziabile follia che rende brani<br />
come Green Green Town o Mrs Death pezzi pregiati. Qui<br />
tutto è meccanico e tutto è umano. Noi siamo nel mezzo.<br />
Ci guardiamo intorno coinvolti e sorpresi (Mechanical<br />
Cock), divertiti e dondolanti (Sad &Tired), affascinati e<br />
schiacciati (Our House Is Burning Down This Summer) da<br />
un progetto che ha tutte le carte per diventare qualcosa<br />
di importante.<br />
(6.8/10)<br />
gianluCa lambiaSE<br />
mEmory tapES - playEr piano (SomEthing<br />
in ConStruCtion, luglio 2011)<br />
Genere: inDie-pop<br />
Dopo Within And Without di Washed Out, tocca al sophomore<br />
del jersey boy Davye Hawk / Memory Tapes<br />
stabilire le relative distanze dagli Eighties, dalla chillwave<br />
e dal fortunato Seek Magic (30.000 copie vendute).<br />
Registrato ancora una volta in casa, ma con pulizia e<br />
microfonazione a fare la differenza, Player Piano è<br />
un canzoniere psichedelico di un girl group che usa le<br />
tastiere al posto della classica strumentazione Sixties;<br />
sono le parole dello stesso Hawk e la definizione casca<br />
a pennello nelle cadenze di una batteria Kinks o in<br />
certi arrangiamenti spectoriani sparsi a prezzemolo nel<br />
platter. Ci troviamo dalle parti dei Belle And Sebatian<br />
e in qualche nuvoletta dei Mercury Rev ma, in pratica,<br />
domina un’urgenza (indie)pop californiana leggera e<br />
straniante (gli strumenti, registrati separatamente, sono<br />
spesso off key).<br />
Fell Thru Ice II e la rockish Trance Sisters le uniche eccezioni<br />
proteiche, il resto scorre in dormiveglia tra le epoche<br />
(quasi) senza l’aiuto degli espedienti indietronici che<br />
in passato dominavano la scena. Si va dalla Byrds-iana<br />
Sun Hits, alla melanconica aura Fleet Foxes in bottiglia<br />
di Yes I Know, dal giro di basso synth Eighties di Offers,<br />
agli innesti pop al tempo della discomusic di Today Is<br />
Our Life, o a cose più Settanta come Worries, fino a certi<br />
Cure bambineschi in Wait In The Dark.<br />
60 e 80 e ritorno, in un mo(n)do possibile e alternativo<br />
a quello di Ariel Pink: Hawk ha già i numeri per essere<br />
una pop star di classe. A mancare a questo punto è<br />
l’uscita definitiva dai ranghi dell’indie.<br />
(7.1/10)<br />
Edoardo bridda<br />
miKa Vainio - liFE (...it EatS you up) (mEgo,<br />
luglio 2011)<br />
Genere: inDustrial noise<br />
La premessa è che la vita solista di Vainio non è mai stata<br />
lontanamente paragonabile a quella con il gemello<br />
Vaisanen nei Panasonic/Pan sonic, o per meglio dire,<br />
difficilmente ha aggiunto qualcosa a quanto già detto<br />
e fatto. Stesse ambientazioni noise-industrial in clima<br />
post-umano, esercitate nel medesimo spirito artigianale.<br />
Naturale quindi che Life (...it eats you up) batta sempre<br />
lo stesso chiodo, anche se ad onor del vero è una delle<br />
migliori interpretazioni fornite dal nostro. E’ tutto chitarra/feedback/distorsioni<br />
il disco: un primo quarto d’ora<br />
sparato noise con tutti gli stridii e le abrasioni del caso,<br />
poi arrivano un paio di basi industrial a ricordare Gravitoni<br />
e dare ritmo al lavoro, per finire con l’apparentarsi<br />
ad un certo drone/doom metal tipo Sunn o))). In mezzo<br />
quella irriconoscibile versione di Open up and bleed degli<br />
Stooges, come servisse a ribadire che di classe qui,<br />
ne gira parecchia.<br />
Certo è ancora un disco da fan, ma anche uno degli episodi<br />
più interessanti per avvicinarsi al mondo di Vainio:<br />
un po’ perchè torna ad andarci giù pesante, un po’ perché<br />
il gioco pieni/vuoti è ben calibrato, e il lavoro scorre<br />
via fluido nella sua (quasi) ora d’ascolto. Quel che si dice<br />
un lavoro ispirato.<br />
(7/10)<br />
StEFano gaz<br />
miStEr hEaVEnly - out oF loVE (Sub pop,<br />
agoSto 2011)<br />
Genere: Doom wop<br />
Amori fatali, divertissement e passione per i ‘50: il primo<br />
disco dei Mister Heavenly, progetto nato dalla collaborazione<br />
di Joe Plummer (Modest mouse, Shins), Ryan<br />
Kattner (Man Man) e Nick Thorburn (Islands, The Unicorns)<br />
si può riassumere così; e c’è da credere si saranno<br />
divertiti non poco a comporre queste 12 tracce, che la<br />
Sub pop si è già preoccupata di etichettare come doom<br />
wop.<br />
E’ l’apogeo delle melodie facili questo Out of love. Provare<br />
per credere già dopo il primo ascolto ci si ritrova<br />
a canticchiare metà disco, soprattutto la prima metà:<br />
Bronx Sniper apre le danze con uno dei pezzi più indie<br />
del lotto sui binari Modest mouse, poi c’è spazio per gli<br />
amori al tempo dei Platters con Charlyne e i coretti di<br />
Mister Heavenly, e non ci si toglie più dalla testa nemmeno<br />
la ritmica in levare di Reggae pie che non fosse (anche<br />
qui) per qualche divagazione retrò potrebbe stare in un<br />
disco di Strummer e i Mescaleros. Il limite? Alla lunga il<br />
giochino stanca, e la seconda metà dell’album si fa più<br />
noiosa: l’atmosfera vintage non se ne va mai e qualche<br />
pezzo rimane trascurabile nella sua aria tra Grease e<br />
American graffiti (Hold my hands, Young girls).<br />
Nel complesso però, vuoi per la bontà degli arrangiamenti,<br />
vuoi per la spensieratezza di cui è imbevuto il<br />
disco, il risultato rimane accattivante. Come si diceva,<br />
ritornelli killer e storielle adolescenziali: è arrivato l’album<br />
dell’estate.<br />
(7/10)<br />
StEFano gaz<br />
mondKopF - riSing doom (Fool houSE,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: Doom rave<br />
A 2 anni di distanza dallo scorso Galaxy Of Nowhere, il<br />
francese Mondkopf continua a girare intorno al french<br />
touch rimanendone tuttavia a debita distanza. Orientamento<br />
già emerso con la prova precedente, in cui era<br />
esplosa la più volte espressa influenza della Warp idm<br />
classica, quella di Aphex Twin, Autechre e Clark: ne era<br />
venuta fuori una ambient-techno che solleticava il nurave<br />
con fare leggero e sbarazzino, lasciando intendere<br />
un possibile distacco dalle tesi di Ed Banger & co.<br />
Rising Doom, invece, torna a pestare i piedi per terra, ed<br />
alla consistenza eterea dell’altro album sostituisce un<br />
rigore maggiormente body-oriented. Un approccio più<br />
industriale che armonico, di un tenebroso a tratti demoniaco<br />
(vedi le ambientazioni mystical-horror di Moon’s<br />
Throat o il finale armageddon di Fossil Lights), in pratica<br />
l’opposto del gaming adolescenziale di Rival Consoles.<br />
Quasi Mondkopf voglia pensare il tocco french a partire<br />
da tesi black metal: idea che risulta pressocché nuova<br />
tra le produzioni strutturate, ma che finisce per trovare<br />
diversi punti di contatto con realtà underground come<br />
i Covox dell’Infiltrator EP e gli ultimi Zoom-on-a-kill.<br />
L’ipotesi non è campata in aria, insomma, e offre discreti<br />
margini di espansione. Da una parte la durezza rave<br />
è filtrata attraverso i digital music maker e - come da<br />
prassi - assume sembianze trance che Pendulum e Deadmau5<br />
conoscono bene (quest’ultimo in particolare<br />
si fa sentire in Deadwood e Day Of Anger). Ma c’è anche<br />
un risvolto più carismatico, un buio electro che si allontana<br />
volentieri lungo tangenti witch appartenenti ad<br />
una parentesi ormai chiusa: quelle depressioni funeste<br />
di Where The Gods Fall, Sweet Memories e Girls Don’t Cry,<br />
che ricalcano i solchi aggressivi e senza mezze misure<br />
dei Salem.<br />
È lecito pensare che anche questa rimarrà un’evoluzione<br />
isolata, ma dopo l’eclettismo a 360° di SebastiAn e<br />
l’esperienza ludica di Rival Consoles i tasselli per un<br />
possibile nuovo volto nu-rave iniziano ad accumularsi.<br />
Per chi pensava non ci fossero più possibilità di mutazione.<br />
(6.6/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
motion SiCKnESS oF timE traVEl -<br />
luminariES & SynaStry (digitaliS,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: musica cosmica<br />
Le stelle ci guidano. Il movimento degli astri, la loro<br />
ascedenza sul vivere quotidiano, sul comportamento<br />
delle persone, sulle relazioni umane. La trascendenza<br />
per eccellenza e il zodiaco come mappa mentale, psichica,<br />
sensoriale. Rachel Evans è una ragazza originaria<br />
di La Grange, Georgia, protagonista di un serpeggiante<br />
e rumoroso hype che dal sottobosco delle cassette l’ha<br />
catapultata nel giro di un annetto o giù di lì nel girone<br />
alla moda dei vinili in edizione limitata con confezione<br />
cd di corredo. Luminaries & Synastry è il suo secondo<br />
disco, dopo che il debutto dell’anno scorso Seeping<br />
Through the Veil of the Unconscious l’aveva fatta conoscere<br />
al mondo per il suo talento nel disegnare astratti<br />
congegni melodici al synth.<br />
Perché di questo si tratta. Rachel eccelle nei madrigali<br />
ultraterreni a base di minimalismi synth / trance onirici<br />
e ipnotici, collocandosi evidentemente sulla scia del<br />
maestro JD Emmanuels e del suo capolavoro Wizards,<br />
dove forse per la prima volta venne allestito un patto<br />
alchemico tra cosmo e terra usando le note del synth<br />
94 95
highlight<br />
mara CarlylE - FlorEat (aCCidEntal, agoSto 2011)<br />
Genere: cantautorato<br />
Fa uno strano effetto trovarsi tra le mani una novità discografica che è stata in<br />
realtà registrata nel 2008 per una major (EMI). Qualcosa si inceppò allora e non<br />
per colpa della musica di questa ragazza dello Shropshire, le cui doti artistiche<br />
erano testimoniate dall’esordio del 2004 (The Lovely), con in singolo (Pianni)<br />
finito in uno spot IKEA, ma per le logiche di un mercato che si stava contraendo<br />
e una crisi - eh sì - che ha colpito anche l’industria discografica. Fatto sta<br />
che solo la caparbietà e la tenacia di Mara le hanno permesso di ritornare in<br />
possesso dei mater e di farci arrivare alle orecchie questo Floreat.<br />
La fioritura del titolo è tutta per un pop orchestrale elegante (con la Royal Philarmonica<br />
Orchestra) e dagli echi classici, tentato tanto dal folk allegro (Weird Girl), da asciugature trip<br />
hop (Away With Those Self-Loving Lads), da delicato popsoul dal retrogusto bluesy (But Now I Do) e dal<br />
jazz più notturno delle ballad (Nuzzle). Il fil rouge del disco è nelle orchestrazioni che talvolta (Bowlface<br />
En Provence) possono arrivare al fiorito (per quanto appropriato), ma generalmente servono da supporto<br />
al duttile contralto della Carlyle. A completare l’opera c’è un’elettronica minima che tinge di trip hop o<br />
si mette semplicemente al servizio delle canzoni. Non manca qualche esperimento più ardito, come la<br />
chiesastica (As Will Be Well) o il quasi ambient di King.<br />
Rispetto all’esordio, con Floreat la Carlyle si è presa il suo spazio nel mondo del pop femminile. Chissà<br />
che il prossimo disco non si possa ascoltarlo prima del 2014, perché in questi tre anni e mezzo, avrà<br />
comunque composto qualcosa, no?<br />
(7.2/10)<br />
marCo boSColo<br />
valvolare senza andare a parare esplicitamente in territori<br />
kraut. Rachel segue le stesse coordinate che su<br />
questo secondo album, si focalizzano ancora di più sul<br />
taglio melodico, allegerendosi sensibilmente sul fronte<br />
del minutaggio e della durata media. Quello che si ottiene<br />
è un poco meno che sensazionale seguito di Wizards,<br />
visto dall’altra metà del cielo.<br />
Luminaries & Sinastry è un disco che tradisce ad ogni<br />
nota o arcana soluzione melodica il sesso della sua<br />
autrice, forte com’è di una circolarità uterina e di una<br />
visione delle cose prettamente femminile. Che siano le<br />
ondivaghe e svogliate nenie di Synastry, le lunari mareggiate<br />
di Late Day Sun Silhouettes o ancora l’agrodolce<br />
filastrocca di Day Glow e l’occulto droning interstellare<br />
di Eight Nineteen, Motion Sickness Of Time Travel riesce<br />
a raggiungere sempre un equilibrio magico tra rigore<br />
sperimentale e sostanza comunicativa collocandosi necessariamente<br />
tra i must have di quest’anno e non solo.<br />
(7.5/10)<br />
antonEllo ComunalE<br />
my morning JaCKEt - CirCuital (ato, giugno<br />
2011)<br />
Genere: inDie, rock, folk<br />
Riportare tutto a casa, tornare là da dove si era partiti<br />
tanto, tanto tempo prima, in un viaggio circolare. Mito<br />
affascinante quanto imperituro, quello dell’eterno ritorno.<br />
Un percorso che non pochi artisti si ritrovano a fare,<br />
a un certo punto di carriera, più o meno inevitabilmente.<br />
È il caso di Circuital, sesto album di quella che è una<br />
delle band indiestream (indie + mainstream, se ci concedete<br />
il neologismo) più famose e acclamate d’America?<br />
Per niente, nonostante il titolo e le entusiastiche presentazioni<br />
di Jim James prima che potessimo verificarle con<br />
l’ascolto. Ok, l’approccio spontaneo da “cinque musicisti<br />
in una stanza” sarà tornato forse quello che ormai dodici<br />
e più anni fa aveva animato i primi, misteriosi passi<br />
(quelli di The Tennessee Fire e At Dawn, pietre miliari<br />
della nuova mistica Americana, quando le gote di Robin<br />
Pecknold erano tutt’altro che irsute), e la title-track in tal<br />
senso è una sorta di manifesto. Ma questi My Morning<br />
Jacket non sono altro che quelli che avevamo lasciato<br />
tre anni fa alle prese con gli “sperimentalismi” pop a tutto<br />
tondo di Evil Urges. Quelli che si erano - si sono - messi<br />
in testa di essere Radiohead, Wilco e Flaming Lips, pur<br />
alla loro maniera; e di poter fare coi generi un po’ quel<br />
che cavolo gli pare. A ragione, aggiungiamo, ché dopo<br />
un disco come It Still Moves (2003) puoi anche incidere le<br />
canzoni dei Muppets (cosa che hanno fatto per davvero,<br />
ma questo è un altro discorso).<br />
A ogni modo, a fronte della calda accoglienza di critica<br />
e pubblico (numero 5 di Billboard all’uscita, che non è<br />
il primo posto dei Decemberists - con cui condividono<br />
il produttore Tucker Martine - ma siamo lì), sorge<br />
il dilemma se in fin dei conti non sia tutto un grande<br />
abbaglio, il beffardo destino di una band che conosce<br />
la fama quando quel fuoco si è attenuato. O meglio, se<br />
sornionamente Jim James sia talmente genio da arrivare<br />
al successo di massa con un LP che contiene una canzone<br />
chiamata Holdin’ On To Black Metal (sic!) e non è altro<br />
che la rielaborazione di una canzone soul thailandese<br />
degli anni ’60 (E-Saew Tam Punha Huajai, di Kwan Jai &<br />
Kwan Jit Sriprajan; cercatela sul tubo e divertitevi). Alla<br />
fine a gente così puoi solo voler bene, anche perché,<br />
aldilà dei proclami e dei fuochi d’artificio, in cose piccole<br />
piccole come Wonderful, Slow Slow Tune, Movin’ Away c’è<br />
tutto quello che ha portato i My Morning Jacket lì dove<br />
stanno adesso. Meritatamente, senz’altro.<br />
(6.5/10)<br />
antonio puglia<br />
nEro - WElComE rEality (mErCury, agoSto<br />
2011)<br />
Genere: D’n’pop-step<br />
Dopo il botto commerciale di Magnetic Man, negli UK<br />
al primo posto in classifica c’è finito Nero, duo formato<br />
da Daniel Stephens e Joe Ray, vincitori, nel 2010, del<br />
premio Beatport come miglior gruppo dubstep. Come<br />
ci sia finito un gruppo drum’n’bass à la Pendulum ai<br />
vertici di una tal classifica non è dato sapere, ma ci basta<br />
scorrere brevemente il catalogo passato per comprendere<br />
la storia di un sound che da un nucleo dei classici<br />
cassa rullante anni Novanta (il singolo del 2005 Ragga<br />
Puffin / Torture su Reformed) passa rapidamente a vocals<br />
sempe più farciti e sample sempre più orchestrali e à la<br />
page (ne è un esempio eclatante Requiem, del 2006, su<br />
Formation, mitica etichetta jungle anni Novanta).<br />
Sentito il mix sonico proposto dalla coppia e la mega<br />
produzione da autoscontro di Chase And Status (praticamente<br />
i Tiësto del d’n’b, se ci concedete il paragone)<br />
non c’è affatto da stupirsi. Nero mastica e risputa un<br />
mega strato-proteico mix di nostalgia rave (vedi appunto<br />
Benga, Skream e Artwork ne “l’uomo magnetico”),<br />
fidget (Justice in Innocence), soul-step (con la brava vocalist<br />
Alana Watson), e in coda, synth-pop e old house.<br />
In definitiva è un condensato di elettro-pop (Me And<br />
You) e, al di là dei gusti, è una cartina tornasole per chi<br />
vuol farsi un’idea di cosa ballano le masse dance più<br />
pilotate, ma non solo: anche gli elettro nerd resteranno<br />
soddisfatti per la varietà di trattamenti melodici adottati<br />
(vedi l’ottimo mesh della citata Innocence). Ovviamente,<br />
chi viaggia dritto per la strada dei singoletti e delle<br />
autoproduzioni lo odierà.<br />
(6.9/10)<br />
marCo braggion<br />
niCola ratti - 220 tonES (diE SChaChtEl,<br />
maggio 2011)<br />
Genere: ambient electro<br />
Ci ricordiamo ancora tutti quando, ormai più di un lustro<br />
fa, Nicola Ratti fece la sua apparizione in solo con Prontuario<br />
Per Giovani Foglie, dopo o durante le esperienze<br />
collettive di Pin Pin Sugar e Ronin. Soffusamente,<br />
delicatamente, quasi in punta di plettro, pur lasciando<br />
emergere una sensibilità altra rispetto al mero chitarrismo<br />
più o meno intimista e di ricerca. Sempre alla ricerca<br />
cioè di una contaminazione tra linguaggi elettrici ed<br />
acustici e interessato a tessere trame elaborate su field<br />
recordings ed effettistica<br />
Strumenti vari e necessari per poter far esplodere il caleidoscopio<br />
della propria sensibilità artistica fatta di visioni<br />
tenui, a colori pastello, dai contorni labili e sfocati<br />
eppure sempre ben delineata nella propria evoluzione.<br />
Con Ode, in solo, o in progetti di coppia (Bellows, con<br />
Giuseppe Ielasi, o Lieu con Attila Faravelli) Ratti ha via<br />
via affinato in chiave digitale il proprio sentire musicale<br />
che ora con 220 Tones trova una sua elaborazione, anche<br />
teorica, di primo piano.<br />
Riallacciandosi all’ultima traccia di Ode e affidandosi a<br />
strumenti che si nutrano esclusivamente di tensione<br />
elettrica. Perciò sintetizzatori (analogici, ovviamente),<br />
Farfisa, giradischi, registratori a nastro sono gli strumenti<br />
coi quali Ratti elabora piccole orchestrazioni di sfrigolii<br />
e fruscii, energia elettrostatica e contatti, private o<br />
quasi dell’apporto della chitarra o di ogni riconoscibile<br />
sorgente sonora.<br />
Il tutto finisce con l’assumere forme malinconiche e<br />
delicate, quasi fossero melodici origami di suono sublimato<br />
in volute psichedeliche (Air Resistance), in textures<br />
increspate che si fanno raga infiniti (Untitled #1), in<br />
simil-techno subacquea (Doom Set) o in minimalismo<br />
ambient d’epoca (Cathrina).<br />
La chiosa affidata alla chitarra di Empire ci ricorda come<br />
il percorso musicale di Ratti viva di una sua coerenza<br />
interna e che, medium a parte (dalla chitarra + forma<br />
canzone degli esordi ai nastri/vinili + forme sperimen-<br />
96 97
highlight<br />
maria minErVa - CabarEt CixouS (not not Fun, agoSto 2011)<br />
Genere: weirDness Disco-pop<br />
L’universo delle musiche weird aggiunge ogni mese nuove latitudini alla sua caleidoscopica geografia.<br />
Stavolta tocca all’Estonia, una tra le più piccole repubbliche baltiche dell’ex URSS, mostrarci i suoi<br />
gioielli. Maria Minerva, all’anagrafe Juur, è una piacente 23enne trapiantata a Londra dove comincia a<br />
trafficare, complice l’attività di stagista da Wire, con musiche “altre” tanto che tempo qualche mese ce<br />
la ritroviamo a pubblicare addirittura con Not Not Fun, l’isola più freak dell’arcipelago weird di questo<br />
scorcio di millennio.<br />
Cabaret Cixous non è in realtà l’esordio tout court, perché sempre per NNF la nostra ha rilasciato la tape<br />
Tallin At Down, mentre l’outfit 100% Silk marchiava un 12” dal titolo Noble Savage. Roba al confine tra<br />
disco e weirdness psych con un retrogusto da “famolo strano”, per formati, artwork, immaginario, giustamente<br />
trattata nel nostro spazio Gimme Some Inches.<br />
Ora la bella stagista si presenta con questo full-length vinilico e rinnova la<br />
tradizione del clash culturale della label con un riuscito mix di cultura pop<br />
alta e bassa in nome di disco-music bislacca, psichedelia soffusa e reverie<br />
post-hypnagogic. Sì, perché la chiave di lettura delle musiche contenute in<br />
Cabaret Cixous è proprio quel senso di torpore e di sfocata percezione che<br />
abbiamo avuto modo di notare spesso ultimamente, soltanto applicato qui<br />
ad una forma avant-pop, accattivante e ricercata, della disco-music. Ne esce<br />
una sensuale mistura di spectral disco, beat sostenuti e fumose ambientazioni, tutto fatto in casa, nella<br />
cara cameretta-simulacro dell’under-25 medio. Roba in apparenza sciatta ma che invece riluce come le<br />
strobo o la mirrorball del nostro immaginario a furia di raga spacey increspati da dubbose cavernosità<br />
(Once Upon), acid-jazz etno-sensuale (Ruff Trade), new-age electro tutta bagliori e oblio (Lovecool), postchill-out<br />
ritmato (I Luv Ctrl), quasi tutti impreziositi dalla voce sensuale e provocante di Maria (vedere/<br />
ascoltare il censurato video del numero soft-disco-porno Soo High per la riprova).<br />
Nel mixtape per Fact Mag c’è modo di entrare un po’ più nel profondo nel background di una tipa abbastanza<br />
agguerrita, che a citare tutto ciò che viene in mente non basterebbe un articolo. Qualcuno ne<br />
ha parlato, e non a torto, come se i Throbbing Gristle o Chris & Cosey avessero fatto il loro album r’n’b<br />
del XXI secolo. D’altronde, it’s the “net generation”, baby. Prendere o lasciare.<br />
(7.4/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
tali), sia sempre più spesso la sensibilità dell’artista a<br />
fare la differenza.<br />
(7.4/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
onE Sixth oF tommy - EVErything\’S oK<br />
(hElium, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: pop folk<br />
Oramai va così, anche nel mondo del folk: ci si fa notare<br />
a un talent show (vedi il compagno di scuderia Sam<br />
Brookes) oppure ci si incontra a un workshop nel fine<br />
settimana. Gli insegnanti ti chiedono per esercizio di<br />
scrivere una canzone. A loro pare funzionare davvero<br />
e la spediscono a un’etichetta: eccoti servita la nuova<br />
band pop-folk pronta a infrangere i cuori dei maschietti,<br />
composta com’è da sole ragazze.<br />
Tutte polistrumentiste e tutte autrici, Jordan Martin,<br />
Jorja Bates e Joanna Grennan vengono dalla countryside<br />
inglese, ma il loro sound affonda le radici nel cantautorato<br />
americano in salsa folk, declinandolo in fresche<br />
tonalità pop da tune radiofonico. Le tre si muovono<br />
con discreta disinvoltura tra il suono tardo 90s di Lene<br />
Marlin (The Pact), pruriti springsteeniani (Not Listening)<br />
filtrati Arcade Fire e Tegan And Sara, ballate soffuse<br />
(I’m Still Yours, For Always) che ricordano Emiliana Torrini<br />
e Polly Paulusma, midtempo solari (The Pact) e<br />
sottolineati da armonie vocali sempre delicate e aeree<br />
(Cotton Pockets).<br />
Canzoni semplici e caramellose basate su pianoforte e<br />
chitarra acustica, giusto un po’ sporcate di sintetizzatori,<br />
perfette per prolungare l’estate di qualche mese. Difficile<br />
che ce ne ricorderemo a primavera.<br />
(6.4/10)<br />
marCo boSColo<br />
orEn ambarChi/Jim o’rourKE - indEEd<br />
(mEgo, giugno 2011)<br />
Genere: experimental<br />
Oren Ambarchi e Jim O’ Rourke ci devono aver preso<br />
gusto a lavorare assieme. Dopo Tima Formosa di un<br />
anno fa, i due si ritrovano per dar vita a Indeed. Sebbene<br />
Ambarchi abbia dimestichezza con i suoni pesanti<br />
per la sua ormai consolidata collaborazione con i Sunn<br />
O))) e O’ Rourke abbia attraversato fasi noisy, sembra<br />
che fosse Keiji Haino l’elemento perturbatore nel disco<br />
precedente.<br />
In Indeed Ambarchi e O’ Rourke lavorano tutto di silenzi<br />
e di vuoti a imbastire flebili tessiture su spazi bianchi. La<br />
prima facciata (il disco è disponibile solo in vinile) inizia<br />
con lapilli eruttivi di synth e chitarra che si spengono<br />
lentamente in un placido stagno in cui gocciolano note<br />
lievi e soffuse. Il secondo lato prosegue sulla falsariga<br />
del primo alzando a tratti le frequenze atmosferiche su<br />
tuoni acuti e disarmonici. Pur non essendo un disco per<br />
tutte le orecchie, l’oltre mezz’ora di sperimentazione di<br />
Indeed risulta fruibile ad un pubblico più vasto dei soli<br />
appassionati del genere. Un lavoro che non sorprende<br />
ma in grado comunque a tratti di catturare.<br />
(6.8/10)<br />
FranCESCo aSti<br />
paul KalKbrEnnEr - iCKE WiEdEr (paul<br />
KalKbrEnnEr muSiK, giugno 2011)<br />
Genere: berlin techno<br />
Visti con gli occhi del presente, i dischi dell’ascesa Zeit e<br />
Self suonano tanto come l’affilatura preparatoria delle<br />
armi techno e minimal. Quelli erano gli anni dei “lavori<br />
di ottima qualità”, ma la dimensione da star di cui gode<br />
oggi Paul Kalkbrenner è esplosa di fatto con il riuscitissimo<br />
progetto Berlin Calling, il film diretto da Hannes<br />
Stöhr che lo ha visto nel ruolo di protagonista principale<br />
(un dj berlinese che cerca di sfondare) e soprattutto autore<br />
della (lo diciamo a denti stretti) strepitosa colonna<br />
sonora. Tralasciando il privilegio di esser stato scelto tra<br />
tanti per un’opportunità tanto ambiziosa e stimolante<br />
(conquista ottenuta per merito: Stöhr era stato conquistato<br />
proprio da Self), il film aprì al grande pubblico<br />
un ampio squarcio del mondo clubbing berlinese, e la<br />
soundtrack fu il picco irripetibile con cui Kalkbrenner<br />
vergò la lettera d’amore per la propria città, realizzando<br />
il mix perfetto di malinconia deep ed entusiasmo notturno<br />
peculiare dell’ambiente tedesco.<br />
Dopo averne sollevato il coperchio, oggi il dj tedesco è<br />
determinato a dar fondo alla pentola d’oro (sarebbe stato<br />
sciocco non farlo) e le nuove produzioni della neonata<br />
Kalkbrenner Musik vanno proprio in questa direzione:<br />
il 2010 - A Live Documentary, registrato nei backstage<br />
delle tappe del suo ultimo tour, e il nuovo lavoro in studio<br />
stanno puntando tutto a disegnarsi come oggetti<br />
di culto della techno germanica. Icke Wieder vuole dunque<br />
bissare il successo di Berlin Calling giocando sugli<br />
stessi punti di forza: livelli di produzione da urlo, rifiuto<br />
di formule di ascolto articolate o innovative e brani a<br />
presa immediata, pescati a mani nude dalla club culture<br />
metropolitana e precisi tanto nel trasmettere la sadness<br />
cittadina quanto nell’esaltarne la piega dancey.<br />
Difficile negare come un’apertura come Boexig Leise, coi<br />
suoi 4/4 di decadenza autunnale, sia esattamente quello<br />
che il pubblico si aspetta da Kalkbrenner. E anche brani<br />
come il singolo Jestruepp o Sagte Der Baer incarnano il<br />
volto più elegante e suggestivo della techno made in<br />
Berlin, in cui durezza industriale e assetto geometrico<br />
rispondono in assonanza alle esigenze liberatorie della<br />
metropoli moderna. Quella di ripetere un capolavoro<br />
forgiandone un gemello è però impresa (quasi) impossibile,<br />
e il risultato è che il disco si imbatte a tratti in<br />
pantani di manierismo, soprattutto nel suo versante<br />
techno-core: con Schnakeln o Des Stabes Reuse l’ascolto<br />
inciampa su combinazioni semplici e statiche, in cui<br />
l’assenza di una spinta creativa mette in risalto l’animo<br />
poco coraggioso dell’album. Sono imperfezioni che è<br />
possibile mimetizzare in opere di fattura impeccabile<br />
(e Icke Wieder rientra in questa categoria) ma che non<br />
si possono eliminare totalmente.<br />
In una strada battuta da tutti in lungo e in largo ci sono<br />
solo due modi per mettersi in vista: cercare la novità, o<br />
perfezionare uno stile già formato. Negli ambienti techno<br />
teutonici, della prima via si sta occupando Kadebostan;<br />
Kalkbrenner ha scelto la seconda e merita ancora<br />
grande rispetto, a patto che si fermi prima di toccare il<br />
fondo della ripetitività. Lui ha la nostra fiducia a tempo,<br />
noi un altro disco da tenere in loop perpetuo.<br />
(7/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
primuS - grEEn naugahydE (ato, SEttEmbrE<br />
2011)<br />
Genere: crossover<br />
Una dozzina di anni senza brani nuovi per Les Claypool,<br />
se è della sua “creatura” più nota e geniale che parliamo.<br />
98 99
highlight<br />
matt bErry - WitChazEl (aCid Jazz rECordS, marzo 2011)<br />
Genere: folkpoppsychproGrock<br />
Un comunicato stampa - che non ci è pervenuto, rendendo la quasi casuale scoperta di questo disco<br />
una totale sorpresa - avrebbe potuto iniziare informandoci che Witchazel è il terzo album di Matt Berry,<br />
pubblicato da lui stesso nella primavera 2009 solo su web (in download gratuito per un giorno) e finalmente<br />
stampato e distribuito dai signori di Acid Jazz.<br />
E chi diavolo sarebbe questo Matt Berry? Potremmo saltare la domanda e arrivare dritti al punto, dicendo<br />
che Witchazel è uno di quei dischi che non ci capitava di ascoltare da un bel po’. MGMT, Syd Barrett,<br />
Genesis, Pet Sounds, vecchie colonne sonore blaxploitation, Incredible String Band, Doors tutto<br />
frullato insieme con gusto massimalista e squisitamente citazionista, in una sorta di concept avventuroso<br />
ma leggero - e provvidenziale - come un bicchier d’acqua in agosto. E però non possiamo non dirvi che<br />
Matt Berry, come mestiere principale, fa il comico (in Inghilterra, con show televisivi di culto come Snuff<br />
Box e The IT Crowd; roba da noi pressoché sconosciuta).<br />
Lo scarto, volendo, è tutto qui. Perché fare un album - e per “fare” intendiamo scrivere, interpretare,<br />
arrangiare, produrre, suonare quasi interamente - che sia contemporaneamente omaggio e parodia,<br />
facendolo apparire dannatamente serio (nella fedeltà formale, nella genuinità dell’ispirazione, nella<br />
puntualità dei riferimenti) e insieme dannatamente ironico (il gusto per il cliché, la citazione musicale<br />
intelligente e spudorata, i testi sopra le righe), converrete che non è proprio da<br />
tutti. Basterebbe questo, davvero. O basterebbe ascoltare Woman, ballatona<br />
strappacuore alla Moody Blues che quando arriva l’assolo di chitarra non puoi<br />
non chiederti “ma ci è o ci fa?”, e poi tornare a riascoltarla perché ti commuove<br />
e ti fa ridere. Perché non c’è niente di più serio di un comico quando fa sul serio,<br />
o niente di più comico di un comico quando fa sul serio.<br />
Oppure basterebbe dire che Matt Berry è nato nel 1974, e che quindi il suo<br />
esercizio di emulazione è reso ancor più impressionante dal non esser stato<br />
testimone diretto di quella stagione musicale in cui folk, prog, psichedelia e acid rock convivevano<br />
beatamente tra i solchi di doppi LP dalle copertine evocative e pretenziose. Un universo misterioso di<br />
foreste, campagne, falchi, uomini incappucciati, tarocchi, elfi, maghi, streghe, incanti pastorali, scenari<br />
e filastrocche à la Wicker Man. Affrontato sempre nel modo di cui sopra.<br />
Oppure basterebbe dire che Matt Berry, quando gli capita di suonare dal vivo, sul palco fa salire Geno<br />
Washington (sì, oh-oh-oh-Geno!). Oppure basterebbe dire che Matt Berry, se chiede a Paul McCartney di<br />
fare un salto in studio e cantare due versi nella sua Rain Came Down, quello lo fa (e il fatto che entrambi<br />
sembrino piuttosto high non fa che accrescere il fascino della cosa). Oppure basterebbe dire<br />
(7.6/10)<br />
antonio puglia<br />
Non che sia rimasto inattivo, il funambolico bassista,<br />
benché ai progetti intrapresi nel frattempo difettasse<br />
il senso d’avventura di Pork Soda e Sailing The Seas Of<br />
Cheese, capolavori di crossover tra musica nera e hard<br />
rock la cui grandezza stava nel trascendere lo stile e attingere<br />
anche altrove, cioè da squadrature progressive<br />
(i King Crimson e Rush fusi nella mini suite Jilly’s On<br />
Smack e girati in dub candeggiato per l’ottima Moron<br />
TV), da venature etniche - tanto Medio Oriente anche<br />
qui - e da un blues-folk beefheartiano degno di Tom<br />
Waits. Il quale figurava anche in Antipop, scivolata nel<br />
manierismo come del resto il precedente Brown Album.<br />
Aggirati da Green Naugahyde nell’unico modo possibile<br />
per un’avanguardia oggi classica: guardando indietro in<br />
termini d’ispirazione, metodologia (produce lo stesso<br />
Claypool; l’album esce per la sua Prawn Songs con l’appoggio<br />
della ATO) e line-up, col sempiterno chitarrista<br />
Larry LaLonde e il primissimo batterista Jay Lane che<br />
non riuscì a comparire sull’esordio Suck On This. Bene<br />
così, siccome il passato riporta vigore e asciuttezza a<br />
un funk-metal contorto e oscuro, intriso di stranezze da<br />
baraccone e sarcasmo tagliente; a una miscela personalissima<br />
mai scaduta in macchietta come per i Red Hot<br />
Chili Peppers ridicolizzati dalla clintoniana Tragedy’s A’<br />
Comin’.<br />
Intatta la tecnica esecutiva - strabiliante mai fine a se<br />
stessa - e scontati siparietti e qualche lungaggine, piacciono<br />
soprattutto la convulsa cavalcata Hennepin Crawler<br />
e una sinistra Last Salmon Man (sorta di floydiana<br />
One Of These Days infarcita di cabarettistici stacchi), il<br />
curioso spirito post-lisergico di Green Ranger e la riassuntiva<br />
sarabanda Extinction Burst. Cose che suonano<br />
“come vent’anni fa” con la saggezza odierna, e miglior<br />
complimento crediamo non ci sia.<br />
(7/10)<br />
gianCarlo turra<br />
pruriEnt - bErmuda drain (hydra hEad,<br />
luglio 2011)<br />
Genere: noise-wave<br />
Con Dominick Fernow aka Prurient avevamo perso i<br />
contatti da un paio d’anni a questa parte. Le antenne<br />
radar dei noise-addicted lo avevano avvistato al fianco<br />
dei Cold Cave in Cherish The Light Years o su qualche<br />
sotterraneo split vinilico in edizione limitata. Ora mr. Hospital<br />
Productions riesuma il suo progetto madre e, quasi<br />
a mettere le cose in chiaro, sciorina un disco-bomba<br />
in cui da un lato addolcisce la propria incompromissoria<br />
offerta musicale, dall’altro gioca sullo stesso terreno dei<br />
rigurgiti -wave di questi anni ’00 e li schianta tutti.<br />
Bermuda Drain sembra infatti la summa del Fernowpensiero<br />
degli ultimi due anni, ovvero il sadico attacco<br />
noise della casa madre applicato alle suggestioni black<br />
(il progetto black-metal Ash Pool), minimal techno (Vatican<br />
Shadow) e cold-wave targate Cold Cave, modulate<br />
in una forma-canzone quasi definita.<br />
Tra attacchi black-metal synthetico truce e ossessivo,<br />
squarciato da voci malefiche e lampi di noise su tessuti<br />
synth-wave cadenzati (l’opener Many Jewels Surround<br />
The Crown), ebm posseduta (A Meal Can Be Made), ambient<br />
drogata e narcolettica (una Palm Tree Corpse che<br />
parte da Vangelis e si slabbra verso modalità Wolf Eyes<br />
macilente e putrefatte) e le incessanti derive texturali<br />
ora ambient-industrial (Sugar Cane Chapel), ora limitrofe<br />
alla kosmische (Myth Of Sex, ovvero dal pulviscolo harsh<br />
noise alle lande cosmiche di un romanticismo e una solitudine<br />
abbacinante in 5 minuti scarsi), l’album offre<br />
una interessante via di fuga dal noise estremo tipico<br />
della casa.<br />
E la cattiveria, si chiederanno gli hardcore fans più esigenti?<br />
C’è eccome. Nascosta più tra le pieghe delle lyrics<br />
(take a tree branch and ram it inside you apre la citata<br />
Palm Tree Corpse) e nel senso del tutto, disturbante e<br />
annichilente nella sua algida grazia as usual, che esibita<br />
in muri di suono harsh come in passato. Un disco che<br />
segna lo spartiacque tra il Prurient che fu e quello che<br />
sarà e che si offre come la più credibile manifestazione<br />
del futuro noise a stelle&strisce, necessariamente alla<br />
ricerca di nuove modalità per uscire dalle paludi di un<br />
suono ormai cliché.<br />
(7.2/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
randy nEWman - SongbooK Vol. 2<br />
(nonESuCh, maggio 2011)<br />
Genere: classico americano<br />
Se parole come “Genio” e “incompreso” hanno un qualche<br />
significato, potete trovarne un’ampia fetta in Randy<br />
Newman. Miracoloso a sé che, senza partire dal country<br />
e/o dal folk, ha creato una cifra autoriale unica mettendo<br />
assieme le colonne sonore scritte dagli zii e la scrittura<br />
pianistica, i musical e il gospel, George Gershwin,<br />
Cole Porter e Ray Charles. Se vi pare poco, c’è sempre<br />
l’umanità cinica e impietosa con cui sferza e tratteggia<br />
personaggi e racconta storie. Che si tratti dell’amato sud<br />
degli Stati Uniti, delle persone di bassa statura o dello<br />
schiavismo, in quaranta e rotti anni di carriera abbondano<br />
i Grammy in bacheca e - cosa più importante - le<br />
Canzoni con la maiuscola qui oggetto di “rilettura”.<br />
Secondo pannello di una trilogia, The Randy Newman<br />
Songbook Vol. 2 scarnifica (come il predecessore e come<br />
l’uomo suole fare dal vivo) le sonorità a voce e pianoforte<br />
permettendo così alla scrittura di brillare ulteriormente.<br />
Sedici brani scorrono agili la gamma tra tristezza<br />
e sarcasmo e tracciano un arco di quattro decenni<br />
dal debutto, AD 1968, fino al più recente Harps And<br />
Angels; a ogni passo si impongono una raffinatezza e<br />
una sincerità senza pari, che rafforzano ritratti di vita<br />
amari, ironici e talvolta assurdi di fatto inscindibili dalle<br />
liriche. E che invogliano l’ascoltatore a tornare su classici<br />
conclamati, oppure riscoprire cose a torto considerate<br />
“minori” mentre l’autore si guarda indietro con la voce<br />
di oggi. La propria essenza nelle canzoni, costui gioca<br />
un ennesimo ineffabile (s)gambetto.<br />
(7.2/10)<br />
gianCarlo turra<br />
rEd hot Chili pEppErS - i’m With you<br />
(WarnEr muSiC group, agoSto 2011)<br />
Genere: pop rock<br />
Dopo cinque anni di silenzio tornano i Red Hot Chili<br />
Peppers col decimo album di inediti. Notizia nella no-<br />
100 101
highlight<br />
roll thE diCE - roll thE diCE (lEaF, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: elettronica ‘80<br />
Non c’è niente di più contemporaneo dell’inattuale, del kitch, del retrò. La storia delle musiche elettroniche<br />
(e non) di questo ultimo paio d’anni è tutta un reverse in direzione storia delle storie, come dire:<br />
guardiamo le ombre che precedono i nostri passi, in mancanza di una direzione precisa da prendere.<br />
Chissà se tra qualche anno, il caos evidente di questi giorni sarà inquadrabile all’interno di un excursus<br />
più o meno evolutivo. Di fatto, ora come ora, il recupero nostalgico delle vecchie cadenze ’80 (soprattutto)<br />
e ’90, genera una serie di espressioni che non solo cercano nel retro-gusto<br />
una propria ragion d’essere, ma quasi una sostanza ineludibile per esserci nel<br />
qui ed ora del suono attuale. Oneohtrix Point Never ha un po’ rotto gli argini<br />
ed, assieme a lui, fenomeni come Expo ‘70, Jonas Reinhardt, Emeralds nella<br />
loro estetica new kraut hanno aiutato al recupero creativo del vecchio synth<br />
valvolare.<br />
L’analogico sempre più come valvola di sfogo per un digitale omologato, impalpabile,<br />
insapore. I Roll The Dice, arrivano al momento giusto quindi. Il duo<br />
svedese, originario di Stoccolma, composto da un ex Fever Ray, Peder Mannerfelt e da uno che si è fatto<br />
le ossa con soundtrack per film e TV, Malcolm Pardon, è abbastanza abile da rappresentare una sintesi<br />
sufficientemente personale di tutto quanto detto fino ad ora. Da un lato un’elettronica improvvisata<br />
chiaramente coordinata sulle istanze della vecchia synth analogica anni ’80, con corredo di strumentazione<br />
vintage e grammatica valvolare che recuperano inflessioni che nemmeno il Jean Michael Jarre di<br />
Oxygene, dall’altro un evidente gusto per il sinfonismo androide post kraut, ulteriore evoluzione della<br />
tradizione Cluster. Quando gli ingredienti vengono amalgamati alla perfezione, il duo è capace di erigere<br />
affascinanti costrutti cosmici con un gusto horror- claustrofobico che si affianca alle contemporanee<br />
derive dei vari Xander Harris e Umberto. Ma più che nell’horror tout court, qui siamo dalle parti di una<br />
sci-fi malmenata e polverosa, come le micidiali convivenze tra Tangerine Dream e Barry De Vorzon<br />
(quello della ost dei Guerrieri della Notte per intenderci ) dei capolavori Maelstrom e Cause And Effect.<br />
Una maniera prettamente cinematografica guida la mano dei due verso il minutaggio esteso, verso le<br />
scenografie di corredo con i rumori d’ambiente e le note sostenute di piano a servire le composizioni<br />
nel suo farsi (The Skull Is Built Into The Tool). Disco più sofisticato e meditato del precedente su Digitalis,<br />
con cui Leaf cerca di prendersi una propria fetta della grande torta nostalgica attuale.<br />
(7.5/10)<br />
antonEllo ComunalE<br />
tizia, I’m With You vede debuttare il nuovo chitarrista<br />
Josh Klinghoffer, dal momento che John Frusciante<br />
è di nuovo - pare definitivamente - uscito dal gruppo.<br />
Poco male: l’irrequietezza indolente e lunare di John<br />
viene sostituita dal più dinamico, acido e scabro stile di<br />
Klinghoffer (riecheggiante a tratti il caro vecchio Andy<br />
Summers), conferendo al sound il giusto grado di ruvidità<br />
e stranezza. Sia chiaro: ruvidità e stranezza sì ma<br />
perfettamente funzionali ad un progetto dalle evidenti<br />
finalità, ossia rifornire le playlist del globo con questo<br />
nuovo carburante marca RHCP.<br />
Si punta parecchio sulla non ancora troppo sbiadita<br />
fama di sobillatori di incroci tra inneschi hard-funk e<br />
spasmi hip-hop, divenuti col tempo sempre più civet-<br />
tuoli e disposti a conciliare le istanze della più rassicurante<br />
ballad folk-pop. Ok, confesso: non avevo troppa<br />
voglia di ascoltare questo disco. Il singolo The Adventures<br />
Of Raindance Maggie mi aveva sconcertato per la<br />
piatta ruffianeria, tutto un insulso strofeggiare melodia<br />
dolciastra in un guazzetto danzereccio variegato di ricami<br />
chitarristici glam. Ma qualcuno doveva pur farlo, ed<br />
essendo stato tra i pochi a non aver disdegnato (senza<br />
esagerare) il precedente doppio Stadium Arcadium,<br />
che volete farci, mi toccava espiare. Ebbene, in queste<br />
quattordici tracce ho trovato esattamente ciò che mi<br />
aspettavo: una affabile professionalità, tanto più innocua<br />
quanto più estrosa.<br />
Ci provano i quattro a smuovere le acque coi funkettini<br />
affilati post-punk (Factory Of Faith), svisando tra le parentesi<br />
liquide (vagamente flaminglipsiane) di Goodbye<br />
Hooray o sprimacciandosi il cuore con la struggente ma<br />
prevedibilissima ballad Brendan’s Deat Song (dedicata<br />
all’amico scomparso Brendan Mullen). Ci provano appunto<br />
ma non riescono a fare altro che mettere a lucido<br />
il blando sfavillio d’un marchio che non è (più) in grado<br />
di smuovere nulla oltre un’epidermica radiofonia. E che<br />
ovviamente, anche in ragione di ciò, otterrà il successo<br />
preventivato.<br />
Chiudo con la consapevolezza che al ritmo di un album<br />
a lustro - e cambiando chitarristi a piacimento - Kiedis<br />
e compagni potranno continuare praticamente in eterno,<br />
raccogliendo ogni volta i frutti del caso. Messa così<br />
somiglia a un incubo. Forse perché non si tratta di un<br />
incubo.<br />
(4.8/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
riChard youngS - ampliFying hoSt<br />
(JagJaguWar, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: psych folk<br />
Harry Dean Stanton vaga in mezzo alla Monument Valley<br />
mentre la chitarra di Ry Cooder si stende languida<br />
sulle immagini, carica di una compassione ultraterrena<br />
verso le umane miserie. Cooder prese come modello di<br />
ispirazione per la leggendaria OST di Paris, Texas il classico<br />
blues di Blind Willie Johnson, Dark Was the night,<br />
Cold was The Ground. Sullo stesso sentiero o per lo meno<br />
lungo questa direzione, ma con una sua grafia chiara<br />
e riconoscibilissima, sembra porsi oggi Richard Youngs<br />
che ritorna a battere il sentiero folk, continunando il discorso<br />
lasciato a metà con Autumn Response.<br />
Ad essere protagonista è, ancora una volta, una visione<br />
diagonale e distorta della chitarra folk. Il motivo dominante<br />
delle sei tracce che compongono questo nuovo<br />
disco è l’arpeggio dissonante, con l’intervento scoordinato<br />
di una chitarra distorta che acuisce una senso<br />
di precarietà, di incertezza su come l’armonia debba<br />
procedere. Come saltare su un confine molto labile tra<br />
la grazia e l’orrido.<br />
Come fanno notare dalla Jagjaguwar è un po’ lo stesso<br />
mix che reggeva le arcane volte del tormentato Six &<br />
Six di Jandek, ma senza quel buio più nero del nero<br />
che in quel disco inghottiva i lamenti del solitario del<br />
Texas in un’alienazione metafisica. Youngs è e rimarrà<br />
sempre votato ad un lirismo prettamente inglese che<br />
gli evita anche questa volta le risacche più nere e contorte.<br />
Semmai, stavolta si avvicina a Scott Tuma e al suo<br />
indimenticato capolavoro Hard Again e ad amplificare<br />
questa sensazione arriva anche l’intervento di Damon<br />
Krukowski alle spazzole delle percussioni, così come a<br />
sorreggere le cattedrali di polvere e rimpianti di Tuma<br />
intervenne all’epoca Jim White.<br />
(7.3/10)<br />
antonEllo ComunalE<br />
rinF - VolKSproduKtE (goodFEllaS, maggio<br />
2011)<br />
Genere: wave<br />
Ritorno davvero inatteso per i Rinf, gruppo dell’area<br />
wave fiorentina di inizio anni ‘80 riemerso recentemente<br />
dall’oblio grazie al lavoro della Spittle records, che tra<br />
ristampe e compile (Chaosjugend Strasse e Silence<br />
over Florence 82-84) ne ha riconosciuto il ruolo chiave<br />
all’interno della suddetta scena. Roba da vero underground<br />
insomma...<br />
Volksprodukte è, incredibile ma vero, il primo lp sulla<br />
lunga distanza, dopo un unico 12” uscito nel lontano<br />
1983. Dieci tracce in cui è fisiologica l’impronta del passato,<br />
ovvero quel sound neue deutsche welle che con<br />
ogni probabilità continuerà a mietere vittime tra vecchi<br />
e nuovi wavers. Ma non è tutto qui. Anzi, qui entra in<br />
gioco il bagaglio di originalità che ha da sempre contraddistinto<br />
il lavoro dei Rinf: ritornano le derivazioni<br />
Pil nell’apertura di Bamelo, le digressioni dei sax a-là<br />
Blurt/Contorsions nella splendida Panic Trotter (angst),<br />
abrasioni no-wave affacciate in Sprengkörper e nell’incedere<br />
ossessivo di Lichtvater, per finire con un pò di body<br />
music nella fermezza in 4/4 di World e Kauf.<br />
E’ un back to the past meticcio e sfumato, che potrebbe<br />
far scuola a tanti revivalisti anche in questo 2011.<br />
Ed invece la scelta è ancora per il culto feticcio: disco<br />
stampato solo il vinile, ovviamente a tiratura limitata,<br />
con lo splendido artwork dell’ inglese Jordan Mckenzie<br />
a campeggiare in copertina. Gente a cui non manca<br />
davvero lo stile.<br />
(7.2/10)<br />
StEFano gaz<br />
robotS in diSguiSE - happinESS V SadnESS<br />
(prESidEnt rECordS, giugno 2011)<br />
Genere: electro pop<br />
Arrivate troppo tardi per godersi il boom dell’electroclash,<br />
alle electro punk girls Robots In Disguise va riconosciuta<br />
per lo meno una certa coerenza. In dieci<br />
anni tutto è cambiato ma loro continuano imperterrite<br />
a propinare una zuccherosa mistura di art rock ed electro<br />
pop, che nel corso di quattro album ha subito solo<br />
marginali aggiustamenti.<br />
Va da sé che le ritmiche di questo Happiness v Sadness si<br />
allineano a questi tempi più fluidi rinunciando a quella<br />
102 103
highlight<br />
St VinCEnt - StrangE mErCy (4ad, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: avant pop<br />
A un ascolto immediato, Strange Mercy - terzo album di St Vincent alias Annie Clark -, chitarrista e<br />
polistrumentista americana, ex-Polyphonic Spree e Sufjan Stevens band, appare ambizioso e si pone<br />
quale ideale continuazione del precedente elaborato Actor, che un paio di anni fa ne aveva confermato<br />
il talento cristallino e cinematico.<br />
Un avant pop orchestrale il suo che mette in evidenza il virtuosismo chitarristico (ne ha dato prova negli<br />
ultimi tempi nella collaborazione con Bon Iver per lo score di Twilight: New Moon, e con David Byrne per<br />
un progetto che sarà pubblicato prossimamente) e si arricchisce di nuove spezie sonore, propendendo<br />
anche per un versante più musicalmente sperimentale, dalle parti di una Laurie Anderson più pop,<br />
che aveva costeggiato già in Actor, e non a caso dei Talking Heads per alcune<br />
melodie poliritmiche qui presenti.<br />
“Questa volta volevo un disco più immediato e diretto”, rivela, “non troppo<br />
abbellito e molto guitar oriented“ e infatti la traccia sonora che guida Strange<br />
Mercy, al di là delle coloriture più avant, è proprio rivolta a un chitarrismo compatto,<br />
rivestito di synth, cinematicamente affascinante e più aperto del solito<br />
a un versante sbarazzino, che appariva spesso nell’esordio Marry Me; si veda<br />
la Cruel che sembra fare il verso simpaticamente ai 70 degli Abba.<br />
Il tutto come se la Annie Clark di oggi facesse il punto non solo musicale ma esistenziale del suo percorso<br />
artistico. “In pratica volevo un disco che suonasse più umano, dopo tutto“, e crediamo di interpretare il<br />
suo pensiero nel senso di una maggiore apertura musicale e solarità, pur nell’ambito di una musicalità<br />
non facilissima quale è quella della Nostra. Un venirsi incontro a metà strada tra divulgazione e avant<br />
pop. Molto affascinante.<br />
(7.4/10)<br />
tErESa grECo<br />
spigolosità che ne aveva caratterizzato gli esordi; contrariamente<br />
a quello che ci si sarebbe potuto attendere<br />
la chitarra di Delia Gaitskell assume un ruolo più preponderante,<br />
lanciando sul lavoro un’impronta wave arrivata<br />
forse fuori tempo massimo, ma si era capito che<br />
il tempismo non è mai stato il loro forte.<br />
Quello che non cambia sono le esplosioni emotive, la<br />
vocalità usata come strumento e a tratti brandita come<br />
una clava, tanto che i vocalizzi dell’opener Chains ricordano<br />
quelli di Björk ai tempi degli Sugarcubes.<br />
Definitivamente migliorata è la grana melodica dei pezzi:<br />
lasciate da parte le velleità artsy e DIY, le ragazze hanno<br />
affinato la capacità di scrivere brani pop tout court<br />
(solo qualche obliquità nel chorus impedisce a Hey<br />
Watcha Say di rappresentare il perfetto mix fra wave e<br />
europop) e perfezionato alcuni trucchetti da studio che<br />
permettono loro di fare della title track un avvincente<br />
synthpop psychedelico.<br />
(6.7/10)<br />
diEgo ballani<br />
rolo tomaSSi - EtErnal youth (dEStination<br />
moon, giugno 2011)<br />
Genere: post-hc<br />
Se prendi il nome da un personaggio di Ellroy, non puoi<br />
fare a meno di essere cupo ed efferato, oltre che un po’<br />
schizoide. O viceversa. Questo devono aver, infatti,<br />
pensato i cinque inglesi da Sheffield quando decisero<br />
di battezzare il loro post-hc corposo e aggressivo col<br />
nome di Rolo Tomassi, riassumendo in una figura sola<br />
un intero immaginario violentemente americano. Cosa<br />
che si riverbera pure a livello musicale essendo gli States<br />
di Converge e Dillinger Escape Plan il primo, ovvio<br />
riferimento a venire in mente all’ascolto delle musiche<br />
di Edward Dutton (batteria), Joe Nicholson (chitarra),<br />
Eva Spence (voce), James Spence (synth, urla), e Joseph<br />
Thorpe (basso).<br />
Eternal Youth, altro nomen omen, è in realtà una raccolta<br />
antologica in doppio cd per 36 brani che mette in chiaro<br />
origini e frattaglie sparse a margine della discografia degli<br />
inglesi. A fronte di soli due album ufficiali (Hysterics,<br />
del 2008, e Cosmology dell’anno scorso) in 6 anni di vita,<br />
il quintetto ha sparso una miriade di pezzi piccoli e soprattutto<br />
split con altre band del sottobosco rumoroso<br />
inglese difficili da recuperare.<br />
Cosa comprensibile, questa necessità espressiva, ascoltando<br />
la furia con cui i cinque di Sheffield macinano<br />
suoni al calor bianco, affrontando e fondendo input tra i<br />
più diversi: un certo vezzo prog e una spiritualità da jazz<br />
libero che è più d’attitudine che elemento strutturale, su<br />
tutti. E a ragione, visto che proprio queste tensioni stilistiche<br />
diversificano l’altrimenti riconoscibile panorama<br />
sonoro instillando una certa, rinnovata curiosità in un<br />
settore che sembra aver detto già molto se non tutto.<br />
(6.7/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
roSKa - JaCKpot Ep (rinSE, luglio 2011)<br />
Genere: uk bass, funky step<br />
Due release in un sol giorno dalla Rinse FM a nome Roska,<br />
e d’improvviso son grosse novità nella parabola<br />
UK step: l’una è il mixtape Rinse: 15 - Roska, che arriva<br />
puntuale a far da ago della bilancia lungo la lanciatissima<br />
tangente clubbing del fu dubstep, chiamando in<br />
causa per acclamazione tipini tutto pepe come Katy B,<br />
Redlight, Brackles, Ms Dynamite e tutta la crème dei<br />
fermenti londinesi; l’altra è questo eppì, che rappresenta<br />
la prima raccolta di inediti dai tempi della svolta dance<br />
premonitrice di inizio 2010.<br />
Se la compilation aggiunge un nuovo tassello (diciamo<br />
pure macigno) alla piega mainstream ormai dilagante,<br />
i nuovi brani non possono far altro che continuare il discorso,<br />
giusto? Macché: con due sonori schiaffi Jackpot<br />
e Roskallion riportano il calendario a due anni fa e distillano<br />
oscurità UK bass in piena regola. Una retromarcia<br />
vistosissima al Silkie del primo City Limits e alla claustrofobia<br />
dei dj-set degli orari più tardi, quelli che arrivano<br />
dopo le 2 A.M. per i survivors delle sale commerciali<br />
(Blame The Speakers: chi ha assistito al set conclusivo di<br />
Kode9 per il Meet In Town sa di cosa parliamo). Quasi a<br />
voler riconoscere all’estetica Magnetic Man i contorni di<br />
tendenza dilagante, (ri)assorbendo le depressioni dub<br />
come redivivo suono di rottura. E se la darkness tornasse<br />
di moda, qualcuno dovrà accendere un cero anche ad<br />
un certo Zomby.<br />
Jackpot EP ha però l’accortezza di non sputare nel piatto<br />
da cui suole servirsi, e soddisfa in chiusura le legittime<br />
fantasie dancehall, con una Leapfrog a riportare alla memoria<br />
Rinse Presents Roska (la rivalutazione qui è d’obbligo)<br />
e la cassa dritta che continua ad amoreggiare con<br />
le sfasature funky in 4th Blind Mouse e Wie Alt Bist Du.<br />
Un colpo al cerchio ed uno alla botte. E di nuovo quella<br />
netta sensazione che il ragazzo stia giocando in netto<br />
anticipo sui tempi...<br />
(6.9/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
ruFuS party - With uS (bluEbout<br />
rECordingS, luglio 2011)<br />
Genere: power blues<br />
Un tempo erano un power trio, i Rufus Party. Una decina<br />
d’anni passati a spellare palcoscenici nel segno del<br />
garage-blues prima dell’esordio Civilization & Wilderness,<br />
anno 2006. Oggi, un lustro dopo, al triangolo famigerato<br />
chitarra-voce-batteria aggiungono il basso ed<br />
un organo hammond, guadagnando in corpo, varietà ed<br />
intensità quel che pagano di ferocia. Ed ecco il sophomore<br />
With Us, prodotto da Andrea Rovacchi dei Julie’s<br />
Haircut: una corroborante dozzina di tracce declinate<br />
blues e power-pop, vagamente psichedeliche e quando<br />
occcorre gustosamente groovy.<br />
Piace soprattutto la devozione che mettono nel fare i<br />
nipotini infervorati dei Traffic (Father’s Song, In A Little<br />
While) o una filiazione iperadrenalinica degli Stones via<br />
Dandy Warhol (Panic In Gairo), impastando la morbida<br />
versatilità dei Gomez, la leggerezza arguta dei Cake e<br />
la tracotanza dei Flamin’ Groovies. Mediamente gradevoli,<br />
riescono a suonare irresistibili con pezzi quali Get<br />
Out Of My Way - lo schiaffo punk-blues che colma lo iato<br />
tra un facinoroso Jon Spencer ed i più trafelati Soundgarden<br />
(!) - e quella Death Of An Indie Chic che sciorina<br />
intrigante scioglievolezza come dei Suede contagiati da<br />
languori Roxy Music.<br />
(6.7/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
S.C.u.m. - again into EyES (mutE, SEttEmbrE<br />
2011)<br />
Genere: pop wave<br />
Ecco i nuovi ragazzi prodigio della Mute records. Si<br />
chiamano S.c.u.m., quintetto londinese dall’aria college-dandy<br />
che nel giro di un paio d’anni si è regalato<br />
un’escalation da primi della classe: il contratto con la<br />
Mute appunto, che li ha spinti nelle serate short circuit,<br />
poi un altro assaggio di grande pubblico nel palco<br />
Atp curato dai Portishead, e ora il debutto prodotto<br />
da Ken e Joylon Thomas, che nel curriculum vantano<br />
gente come Psychic tv, Bowie e Sigur Rós. Quando si<br />
dice nati sotto una buona stella....<br />
Venendo al disco, le coordinate sono presto dette: Again<br />
into eyes è indirizzato verso una pop-wave già matura<br />
e pronta per il mainstream. Un po’ come pensare agli<br />
Arcade fire trapiantati in terra d’Albione, perchè in fin<br />
104 105
highlight<br />
StEphEn malKmuS/thE JiCKS - StEphEn malKmuS and thE JiCKS - mirror traFFiC<br />
(matador, agoSto 2011)<br />
Genere: lo-fi rock<br />
Tra le cose che ci si potevano aspettare da una collaborazione tra due protagonisti assoluti dei Novanta<br />
alternativi come Stephen Malkmus e Beck, forse la migliore è accaduta davvero. Ovvero, la visione sonica<br />
di Mr. Hansen - qui in veste di producer - e quella dell’ex-Pavement si fondono come due immagini<br />
sovrapposte, armoniche ma impercettibilmente sfalsate, e alla fine - come è giusto - a prevalere è quella<br />
del rocker di Santa Monica, che in questo disco - il quinto e migliore firmato assieme ai fidi Jicks - azzecca<br />
forse la sua più sbrigliata incarnazione.<br />
Se trova sostanziale conferma la piega psichedelica che si è andata definendo nella decade abbondante<br />
di carriera solista, su di essa pare altresì posarsi la glassa serafica di chi ha<br />
raggiunto una nuova e inedita fiducia nei propri mezzi. Tanto da accantonare<br />
l’ansia di mostrarsi all’altezza anzi più forte di quel passato che ben sappiamo,<br />
tornato ad essere un patrimonio prima che un ingombro. E’ un po’ come se il<br />
buon Stephen si fosse immerso nello stesso lago denso che fruttò a Beck la<br />
ponderata irrequietezza di Sea Change, uscendone a suo modo pacificato,<br />
per certi versi compiuto. Il risultato è un’Americana sghemba, cazzona e sferzante<br />
ma appassionata e solida. Spesso vicina a certi esiti Wilco, quelli delle<br />
malinconie semiacustiche (l’accorata Share The Red), quelli dinoccolati (l’andazzo birbone di Tigers) e<br />
quelli delle mattane ruvidelle (il boogie’n’roll di Tune Grief).<br />
Proprio come nel miglior repertorio della band di Tweedy, è palpabile il senso di spaesamento consapevole<br />
e furore composto in vista d’una mezza età che sa guardarsi indietro, dentro e intorno senza<br />
fare sconti (in primo luogo a se stessa). In questo senso, una solida coerenza sottende l’arco emotivo<br />
che va dal sarcasmo screanzato di Senator al trasporto allibito (massimamente beckiano) di Asking Price,<br />
passando dalla puncicata Stones ammorbidita Gram Parsons di Gorgeous Georgie e dal torpore folkrock<br />
- vagamente Fred Neil - di No One (Is As I Are Be) e Long Hard Book (perturbazioni Seventies incluse).<br />
Senza scordare l’indie pop fuori giri - più disincanto che abbandono - di Stick Figures In Love (da qualche<br />
parte tra This Might Be Giant, Vaselines e La’s), i fantasmini Spirit e Moby Grape di All Over Gently ,<br />
l’indolenza scafata di Brain Gallop e quella estatica di Fall Away. Un disinvolto peregrinare estetico che<br />
individua in scioltezza gli estremi tra il fiabesco spacey-psych - figuratevi i Flaming Lips immersi nella<br />
lanolina - della strumentale Jumblegloss e l’obliquità scabra - i Nineties trapanati garage psych - di Spazz.<br />
C’è insomma una sorta di magia in questo disco, e credo risieda principalmente nella dimensione che<br />
ha saputo imporsi: una sintesi spigliata tra azzardo sbruffone e profonda consapevolezza, tra fluidi<br />
carotaggi stilistici e congiunture contemporanee, tra impertinenza esistenziale e più o meno implicita<br />
crepuscolarità. Proprio quello che ti aspetti da uno che si ostina (artisticamente) a vivere nella proverbiale<br />
linea d’ombra che unisce e separa il ragazzo dall’adulto. Non è da tutti giocare al fanciullino eterno<br />
ventottenne - come confessa lo scanzonato scozzo errebì/power pop di Forever 28 - senza sembrare<br />
patetici anzi ricavandone una cazzuta chiave di lettura. Infatti Stephen Malkmus non è uno qualunque.<br />
Ok, non ci voleva certo Beck per scoprirlo. Ma ha dato una grossa mano, mi pare.<br />
(7.7/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
dei conti ad emergere è la natura squisitamente english<br />
del lavoro: qualche riferimento al post punk sul sentiero<br />
di Manchester (specie nella voce di Thomas Cohen),<br />
tastiere che si rifanno al synth pop più glaciale dei primi<br />
Depeche Mode (Sentinal bloom), ed intrusioni nei ‘90<br />
con qualche tirata shoegaze vedi Summond the sound.<br />
Poi, giusto per smuovere un po’ le carte in tavola, spazio<br />
per una ballatona vagamente dark come Paris e per il<br />
finale poppettone stile Pet Shop boys di White Chapel.<br />
Il puzzle funziona: oltre tutte le patinature del caso (Amber<br />
Hands) c’è della sostanza, che non replica l’effetto-<br />
Funeral ma rimane comunque una diligente rielaborazione<br />
della storia in formato pop. Buon debutto.<br />
(7.2/10)<br />
StEFano gaz<br />
Sam brooKES - Sam brooKES (hElium, luglio<br />
2011)<br />
Genere: folk<br />
Motivi di interesse giornalistico attorno alla figura di Sam<br />
Brookes, ventiquattro anni inglese e folksinger esordiente,<br />
ce ne sarebbero a bizzeffe. Primo, il fatto che nel 2008<br />
abbia vinto un talent show con la sua band precedente<br />
The Volt - pare - incantando i giudici per la sua scrittura<br />
superiore. Secondo, perché ha girato la terra di Albione<br />
in compagnia di un grandissimo vecchio della musica<br />
inglese, Ray Davies, che pare con un francesismo lo abbia<br />
definito “fucking brilliant”. Terzo, perché ancor prima<br />
di pubblicare il suo disco d’esordio era su uno dei palchi<br />
del Glastonbury del 2011.<br />
L’eponimo disco d’esordio fa un po’ ridimensionare il giudizio<br />
dei talent scout, ché si sa che la televisione “allarga”,<br />
ma comunque ci mostra un giovane folksinger (che nelle<br />
foto promozionali assomiglia vagamente a un giovane<br />
Kid Rock) in grado di dominare il piè classico dei sound<br />
british, a cavallo tra il primo Donovan, Nick Drake, Davy<br />
Graham e Bertie Jansch ma “sporcandolo” un po’ con<br />
qualche eco americano, che a tratti ricorda gli esordi di<br />
Ryan Adams (Like a Butterfly) o con qualche atmosfera<br />
Constellation (In Design). Non c’è un brano che più degli<br />
altri si stampigli nella memoria dell’ascoltatore, però -<br />
hype a parte - la voce potente e duttile di Sam Brookes<br />
è da segnare sulla mappa.<br />
(7.1/10)<br />
marCo boSColo<br />
SElah SuE - SElah SuE (bECauSE, marzo 2011)<br />
Genere: r’n’b<br />
E’ belga. Ha 22 anni. E i brani del presente debutto in area<br />
nu soul li ha scritti tutti tra i 13 e i 19 anni. Ha già aperto<br />
un concerto di Prince. Selah sembra il classico surrogato<br />
dei contest canori e sul lato più masticato e noioso della<br />
frittata potrebbe essere ricondotta a una sorta di Josh<br />
Stone continentale condita con gli amati 70s di un Lenny<br />
Kravitz e aggiornati al reggae di I Blame Coco. Per<br />
fortuna, rispetto alla scontatezza dell’opener This World<br />
(le cui basi ricordano anche un famoso brano di Eminem)<br />
s’aggiungono varie influenze a rendere la sua proposta<br />
diversa dal solito copiaincolla mainstream: quello innanzitutto<br />
per Lauryn Hill e M.I.A. (l’ottimo trip-hop girato<br />
grime di Peace Of Mind fa davvero scintille) ma soprattutto<br />
per Erykah Badu (Crazy Vibes, Fyah Fyah), magari,<br />
in combutta con una (già) grande come Santigold.<br />
In particolar modo, da quest’ultima - e dall’Inghiterra<br />
trasversale di Andreya Triana - Sleah prende quel che le<br />
riesce meglio: brani ritmati e sanguigni, r’n’b cangianti a<br />
cui la ragazza di Leuven aggiunge una personale passione<br />
per il Ragamuffin, magari piroettato art-folk Cocorosie<br />
/ Joanna Newsom (vedi l’ottima traccia omonima e<br />
Black Part Love), perché no in levare (la citata Fyah Fyah<br />
tra citazioni Hendrix e Marley, Crazy Suffering Style), oppure<br />
mescolato a un eclettico impianto trip-hop su basi<br />
suonate dal vivo (batteria, chitarra, tastiere). In produzione,<br />
Patrice e Farhot (ma non solo), in particolare nei<br />
rimandi cinematografici americani e in generale nei tagli<br />
70s, ci mettono parecchio i Novanta di Tricky e Fugees,<br />
si notano sia nelle modalità post-moderne d’utilizzare il<br />
vintage (fiati stax e piano ragtime) sia nell’utilizzo delle<br />
sintetiche (tastiere analogiche, hammond).<br />
Varia proprio come la Janelle Monáe di The Archandroid<br />
ma non ancora spendibile a quei livelli, soprattutto per la<br />
calligrafia e l’eccesso tecnico nelle ballad (Explanations,<br />
Mommy) e in altri episodi xfactoreschi (pallosa Summertime,<br />
telefonatissimo il twang cinematico Please con il<br />
featuring inflazionato di Cee Lo Green), Sleah parte comunque<br />
bene. Chissà che farà da grande, visto che ora<br />
sono i grandi a decidere per lei.<br />
(6.5/10)<br />
Edoardo bridda<br />
SilKiE - City limitS Vol 2 (dEEp mEdi muSiK,<br />
giugno 2011)<br />
Genere: uk step<br />
City Limits Volume 2, ovvero, anche Silkie prova a cimentarsi<br />
negli orizzonti post-step UK. Dopo essere andato<br />
a fondo tra le pieghe UK bass con il volume 1 del 2009,<br />
il producer londinese mette da parte le ormai obsolete<br />
claustrofobie dub e insegue le nuove formule recentemente<br />
pervenute: a porsi in evidenza in questo caso<br />
sono le ambizioni space-ambient di Feel, che seguono<br />
gli ultimi passi di Starkey (ripasso obbligato alla notevole<br />
serie di EPs Space Traitor) e mosse come Selva Nova<br />
106 107
o Boogie Boy che gettano furbamente l’amo nelle mode<br />
dance londinesi (gesto non plateale come nei Magnetic<br />
Man, ma trattasi della stessa intuizione destinata al<br />
successo).<br />
Il versante bass storico è comunque coltivato, con Lucky<br />
e New York City a rispolverare quelle forme già scolpite<br />
ad arte nel My Demons di Distance. Il vero faro-guida<br />
però continua ad essere Skream, non solo per il featuring<br />
d’autore in Untitled ma in generale per il carattere<br />
d’approccio alla materia dubstep: non si azzardano salti<br />
nel vuoto ma spostamenti di rotta nel complesso contenuti,<br />
sempre accompagnati da un’ossatura comunque<br />
classica. Se Outside The Box vi aveva preso male per le<br />
derive eccessive, potrete apprezzare il maggior rigore di<br />
questo suo discendente. Ma non provate a lamentarvi<br />
per mancanza di innovazione.<br />
(6.7/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
Son lux - WE arE riSing (antiCon, luglio<br />
2011)<br />
Genere: electro-pop<br />
Ryan Lott c’aveva messo tre anni per registrare, tutto da<br />
solo, pezzetto dopo pezzetto, il buon debutto At War<br />
With Walls & Mazes (2008). Ne ha fatti passare altrettanti<br />
per dare alle stampe il seguito, e però lo ha registrato in<br />
meno di un mese, rispondendo al ‘call of paper’ del blog<br />
All Songs Considered del network National Public Radio,<br />
che gli ha chiesto appunto di realizzare un intero album<br />
in soli 28 giorni (febbraio 2011).<br />
Detto, fatto. ‘With a little help from his friends’ My<br />
Brightest Diamond, DM Stith e yMusic Sextet (e cioè<br />
Antony, Sufjan Stevens - entrambi dichiarate influenze<br />
del progetto Son Lux - e The National). Sulla carta poteva<br />
essere un pastrocchio tremendo, ma evidentemente<br />
i pezzi c’erano e, per una volta, la necessità è davvero<br />
stata madre dell’invenzione: perché ne sono venuti fuori<br />
intensi gioiellini electro-pop intrisi di romanticismo decadente<br />
come Flickers, All the Right Things, Rising, Let Go<br />
(con i suoi fiati giocherelloni) e Rebuild.<br />
Questo disco (ma Son Lux più in generale) ricorda un po’<br />
gli Sparks, capace com’è di mettere assieme con grande<br />
equilibrio formale, pur tra mille eccessi, colore (leggi pop:<br />
melodia e cantabilità, kitschume anni Ottanta) e dolore<br />
(leggi teutonico: cori lirici, densità orchestrali, Nico).<br />
Ferma restando l’antipatia che il personaggio può anche<br />
suscitare.<br />
(7.2/10)<br />
gabriElE marino<br />
Sun araW/EtErnal tapEStry - night<br />
gallEry (thrill JoCKEy, agoSto 2011)<br />
Genere: psych-kraut<br />
La joint-venture che non t’aspetti assume le sembianze<br />
di un carrarmato psych-rock delirante e notturno. Da un<br />
lato, la combriccola di freaks psych-kraut cresciuta esponenzialmente<br />
negli ultimi anni, soprattutto col passaggio<br />
alla Thrill Jockey (vedi alla voce Beyond The 4th Door);<br />
dall’altro, uno degli hypna-eroi primigeni, quel Cameron<br />
Stallones a.k.a. Sun Araw uso a mischiare psych e deliqui<br />
hypnagogici tra Magic Lantern e, appunto, la presente<br />
sigla in solo.<br />
Galeotto, per l’unione di forze in apparenza distanti -<br />
corposi e kraut-spacey i primi, drogato e lento il secondo<br />
- fu il festivalino Neon Comune Fest curato dalla NNF<br />
nel 2007, in cui l’allora Magic Lantern Stallones saldò<br />
una amicizia rinverditasi ogni qualvolta i tre di Portland<br />
scendevano a suonare - e condividere il palco, ovvio - in<br />
California.<br />
L’occasione per questo Night Gallery è invece legata al<br />
SXSW dello scorso anno, quando dopo un pomeridiano<br />
live congiunto in un parcheggio, gli ET invitarono Sun<br />
Araw a registrare un live in una radio studentesca. Il risultato<br />
è in queste quattro omonimi movimenti suonati live<br />
in circolo con i Tapestry in formazione allargata (Ryan<br />
Carlile al sax, Yoni Kifle al basso completano il quintetto)<br />
e Stallones a chiudere il cerchio con le volute sonnacchiose<br />
della sua chitarra. In realtà, viste anche le forze<br />
numericamente in campo, a prendere il sopravvento è la<br />
psych reiterata dei primi, come nella ascensionale Night<br />
Gallery I - lontani echi orientali pian pianino soffocati in<br />
effluvi di wah-wah - o nella Spacemen 3 oriented Night<br />
Gallery II. La conclusiva, fluviale Night Gallery IV dilata<br />
ancor di più gli orizzonti dell’estemporanea formazione<br />
abbandonandosi tra assonnate volute di fumo e sfocati<br />
paesaggi da psichedelia orientale, mettendo in evidenza<br />
la mano calda di Stallones. Estemporaneo quanto si vuole,<br />
ma Night Gallery è più che un divertissement tra amici.<br />
(7/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
tarWatEr - inSidE thE ShipS (burEau-b,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: inDietronica, wave<br />
Duo di culto fino alla metà dei Duemila su Kitty YO, fiore<br />
all’occhiello del Morr sound a cavallo tra il 2005 e il 2007,<br />
i berlinesi Tarwater hanno disegnato, parallelamente a<br />
una compagine più allargata musicisti tedeschi e non,<br />
un proprio modo di traghettare le passioni giovanili (il<br />
post punk più elettronico, il kraut rock) alla fascinazione<br />
techno (nonché ai lavori di sonorizzazione per cinema<br />
e teatro) in un’indietronica visuale fatta di folk/pop/reading<br />
e fiera germanicità. Nei Noughties hanno assistito<br />
all’opus e al declino del genere che avevano contribuito<br />
fortemente ad imporre e deciso di continuare per la loro<br />
strada stoici, rilassati, seduti su un filo di depressione ma<br />
caparbi, a loro modo entusiasti, pronti a soppesare nuovamente<br />
l’intingolo, togliendo, dosando, aggiungendo<br />
nuovi e vecchi elementi.<br />
Accasati nella tedeschissima Bureau B (Faust, Kreidler,<br />
Cluster, Roedelius...), Ronald Lippok e Bernd Jestram, coadiuvati<br />
da un musicista Klezmer come Detlef Pegelow<br />
conosciuto ai tempi di Ornament & Verbrechen (1980-<br />
1983), arrivano dunque all’undicesimo album sulla scorta<br />
di una sintesi sonora che conserva tuttora il fascino<br />
dell’artigianato di qualità e un’indubbia weltanschauung.<br />
Mettono tra parentesi il pop e gli spazi aperti americani<br />
di Spider Smile, i Tarwater di Inside The Ships. Si dedicano<br />
un suono elettroacustico maggiormente pastoso,<br />
intarsiato di nuovi elementi “brass” apportati, appunto,<br />
da Pegelow. Lungo la tracklist s’infilano tuba, sassofono,<br />
tromba e trombone, tutti ottimamente trattati e fusi da<br />
un mix che ne esalta la tattilità. Il jazz dunque, s’avvicina<br />
alle squadre kraute, alle drum machine, ai synth e<br />
ai vocoder e, naturalmente, alla chitarra 80s di Jestram.<br />
Ne emergono canzoni di paciosa ma fiera retroguardia<br />
tra le consuete cover - Do the Oz (cover di John Lennon<br />
and Yoko Ono) e Sato Sato (prima canzone a contenere<br />
liriche in tedesco del duo nonché adattamento di un testo<br />
dei DAF di Alles Ist Gut) - e inediti - Inside the Ships, la<br />
ballad wave+theremin Radio War, la residentsiana There<br />
Never Was A Night o la notturna Place At 5 AM.<br />
All’inizio, ovvero due anni fa, il disco doveva rappresentare<br />
un concept, una Space Opera, poi l’idea dell’album<br />
si è trasformata in un contenitore aperto e ricco di smalti<br />
kraut-etno-jazzati già noti alla discografia del duo ma<br />
approfonditi in maniera differente, lontani cioé dagli<br />
umori trip hop di Atoms, Suns & Animals (o dalla ricerca<br />
di un Mapstation). Quest’ultimi sono gli aspetti<br />
più interessanti di un lavoro mediano da punto di vista<br />
lirico (eccezion fatta per la bella Sato Sato) ma riuscito<br />
negli excursus strumentali che, al solito, sono anche finiti<br />
nell’ennesimo cortometraggio indipendente (The Eagle<br />
Is Gone di Mario Mentrup and Volker Sattel).<br />
(6.8/10)<br />
Edoardo bridda<br />
thE drumS - portamEnto (moShi moShi,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: pop<br />
Odiavano la definizione di One Hit Wonder. Hanno sempre<br />
affermato che volevano essere presi sul serio. Non<br />
erano una band di pin up (e basta). L’idea di un’America<br />
ossessionata dalla California e dagli anni 50, dal surf e<br />
l’innocenza di quegli anni, era stata spontanea ma consapevole,<br />
come pure il formato surf-pop condito con<br />
passione vintage e amore per gli eighties, tutto curato<br />
in ogni aspetto: dal taglio cinematico in produzione, ai<br />
videoclip (Let’s Go Surfing), alle buffonate on stage e al<br />
taglio di capelli.<br />
Di converso, l’Inghilterra, come al solito ossessionata<br />
dalle istituzioni e dai passaggi di consegne li aveva incoronati<br />
troppo presto. A scatola chiusa, aveva comprato<br />
90.000 delle 200.0000 copie dell’esordio di una band che<br />
non era esattamente l’erede degli Smiths.<br />
Melodicamente, i Drums avevano un tiro pop davvero<br />
potente, ma vivevano di singoli e le strofe di Morrissey<br />
erano ancora più lontane così come un futuro, all’epoca,<br />
quantomai incerto. Ci sono state parecchie litigate. Una<br />
defezione. Ed ora il ritorno proprio con un bel singolo,<br />
Money, che se è il miglior trait-d’union con la solarità<br />
dell’esordio, è anche il più diretto confronto con il Moz<br />
che Pierce e Garham abbiano mai tentato.<br />
Proprio in senso smithsiano, Portamento segna una svolta<br />
più meditata e sofferta della passata formula. “erano<br />
happy times, ora è calato l’inverno (da In The Cold)” recita<br />
un agrodolce Pierce su testi autobiografici e un’esecuzione<br />
che si è fatta più severa, ampliando le parti elettroniche<br />
e variegando l’impianto.<br />
I cambi di line up - l’abbandono di Adam Kessler e la<br />
sua sostituzione da parte del batterista Connor Hanwick,<br />
il passaggio di Graham ai synth, e la drum machine al<br />
posto della batteria - hanno sicuramente condizionato<br />
lo sviluppo di un album che è in definitiva il classico<br />
sophomore ma anche il segno di una band maturata<br />
che perfeziona gli equilibri e cerca nuove vie espressive.<br />
Alla mancanza di hit folgoranti, risponde una scaletta più<br />
omogenea, al carattere spensierato e cinematico dell’eppì,<br />
una scrittura più solida.<br />
I Drums non hanno perso il tocco leggero, lo hanno caricato<br />
di una (auto)produzione più accurata, smalti postpunk<br />
mancuniani (gli ovvi Joy Division e New Order) e<br />
qualche fuori programma synth-kraut memore - parole<br />
loro - di vecchi ascolti Kraftwerk e Windy & Carl.<br />
Inaspettatamente, Portamento nel suo essere ombroso<br />
e malinconico finisce per essere un disco riuscito, l’avvio<br />
di una carriera di prospettive e canzoni da diario.<br />
(7.1/10)<br />
Edoardo bridda<br />
108 109
thE StEpKidS - thE StEpKidS (StonES throW,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: funksoul psych<br />
Mamma mia che bello questo disco, che goduria, sembra<br />
registrato nel 1971. In epoca di retrologie e retromanie<br />
generalizzate i tre Stepkids Tim Walsh, Jeff Gitelman e<br />
Dan Edinberg propongono direttamente il tuffo nel passato,<br />
senza troppi gradi di separazione dai modelli, senza<br />
finti scarti, mascheramenti o update: solo passione,<br />
scrittura (melodia) e cura per il dettaglio.<br />
Cresciuti nel circuito jazz & r’n’b della East Coast, con anni<br />
di carriera anche solista alle spalle, in questo debut album<br />
su Stones Throw (ovviamente) mischiano ad arte funksoul<br />
e West Coast in salsa psichedelica, puntando ad una godibilità<br />
pop, tra bonghi, cori in falsetto, tastiere elettriche,<br />
chitarra wah-wah, basso pulsante e inserti d’archi.<br />
Il risultato è sorprendente, sorprendentemente fresco, la<br />
soundtrack perfetta per il remake di un musical colorato<br />
e multietnico alla Jesus Christ Superstar. Ascoltare per<br />
credere (il canale Youtube della band; il video ufficiale<br />
della torbidamente psichedelica e spacey Wonderfox).<br />
(7.4/10)<br />
gabriElE marino<br />
thE WEEKnd - thurSday (SElF rElEaSEd,<br />
agoSto 2011)<br />
Genere: r’n’b nu-soul<br />
Il 2011 è finora soprattutto l’anno della riscoperta del<br />
soul in salsa dubstep e dintorni (James Blake) e indiefolk<br />
(Bon Iver). Tanti hanno fiutato lo spirito del tempo<br />
e sono andati sulla scia, soprattutto sul versante electro<br />
della faccenda (tra alti, SBTRKT, ma a suo modo anche<br />
Clams Casino, e bassi, Jamie Woon, CHLLNGR), e tra<br />
questi anche Abel Tesfaye aka TheWeeknd, classe ‘90,<br />
canadese di Toronto con genitori etiopi, che ne offre<br />
adesso la declinazione r’n’b e supercantata.<br />
A fine 2010 il debutto sul web con una manciata di pezzi<br />
sfusi, confluiti poi nel mixtape - ma in pratica è un album<br />
vero e proprio - House of Balloons (6.8/10; marzo 2011);<br />
adesso arriva questo Thursday, che alza decisamente<br />
il tiro, e già è stato annunciato un Echoes of Silence<br />
che chiuderà la trilogia in autunno (trovate tutto in free<br />
download sul sito ufficiale).<br />
House era un esordio ancora non completamente a fuoco,<br />
che però metteva in luce il metodo del ragazzo (un<br />
r’n’b electro intriso di dub e con abbocchi dubstep (certi<br />
stacchi di rullante), voce soul quasi femminile e non troppo<br />
effettata e sfumature ethno), con dentro un paio di<br />
pezzi bomba perfetti come biglietti da visita, la sensuale<br />
e scabrosa (vedi il video) What You Need e quella Loft<br />
Music che fin dal titolo fotografa ottimamente il mondo<br />
di Abel: una musica da appartamento che guarda al club,<br />
atmosfere notturne, produzioni levigate, avvolgenti e<br />
furbe, tanti ‘fuck’ e ‘nigger’ nei testi, un prodotto fichetto<br />
insomma, ma che nella maggior parte dei casi funziona<br />
alla grande.<br />
Thursday, sempre prodotto dal duo Doc McKinney & Illangelo,<br />
è meno pop, più atmosferico (i pezzi infatti si<br />
allungano), pigia sul pedale del pathos (l’iniziale Lonely<br />
Star) e inspessisce i riferimenti all’elettronica post-dub (le<br />
cadenze di Life of the Party, Heaven or Las Vegas) e al dubstep<br />
più minimal (Gone). Occhei, Rolling Stone sembra<br />
un pezzo di Craig David, ma la title track o un numero<br />
come The Zone sono fascinose nei loro sdilinquimenti<br />
(e si sente in trasparenza l’origine africana) senza essere<br />
stucchevoli. E questo è un ottimo ottimo risultato.<br />
(7.2/10)<br />
gabriElE marino<br />
thEE oh SEES - CaStlEmania (in thE rEd<br />
rECordS, luglio 2011)<br />
Genere: 60s psych-rock<br />
Lo dicevamo all’epoca di Warm Slime (un anno fa o poco<br />
più), e lo ribadiamo ora: John Dwyer non soffre di sindrome<br />
del foglio bianco, se è vero che pubblica dischi<br />
come niente fosse. A dimostrarlo, se ce ne fosse bisogno,<br />
il fatto che insieme a questo nuovo comeback rilascia<br />
anche il doppio vinile Singles Compilation Vol. 1 & 2 per<br />
la propria Castleface in cui raccoglie i pezzi piccoli sparsi<br />
qua e là.<br />
Stavolta però qualche novità c’è. Sembrerebbe infatti<br />
che il tatuato chitarrista abbia diretto quasi tutto in solitaria:<br />
chitarre, basso, drumming e ammennicoli vari (tra<br />
cui anche flauto, clarinetto, tromba, armonica ), registrazione<br />
compresa, sono suo appannaggio quasi esclusivo<br />
con i sodali (Bridget Dawson alla voce in I Won’t Hurt<br />
You e What Are We Craving?) e gli amici (Ty Segall in un<br />
paio di pezzi) relegati a figure di sfondo. Con uno come<br />
Dwyer però mai fidarsi fino in fondo e non si sa bene<br />
quanto e chi abbia contribuito.<br />
Di certo c’è che Castelmania è un gran bel disco che si<br />
stacca dalla solita cifra stilistica del progetto. O meglio ne<br />
amplifica certe peculiarità e ne mette in secondo piano<br />
altre. Forse c’entra il fatto che tutto o quasi sia creazione<br />
di Dwyer ma c’è un atteggiamento di maggiore padronanza<br />
dell’insieme e messa a fuoco di referenti e rimandi.<br />
In poche parole, Castlemania guarda indietro, trasforma<br />
il garage in attitudine, riprende la stagione d’oro del<br />
flower-power e la intorpidisce inanellando una serie di<br />
piccole gemme di jangle-pop talmente retrò da perdere<br />
quasi ogni connotato di modernità. Coretti, slanci acustici,<br />
testa che ciondola, non manca nulla (vedi alla voce<br />
highlight<br />
thE rapturE - in thE graCE oF your loVE (dFa, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: Disco-wave<br />
Cosa aspettarci dai Rapture finiti i Noughties? C’era forse una via d’uscita auspicabile dalla disco punk,<br />
p-funk di Echoes o dagli 80s di Pieces Of The People We Love? Sul fatto che questi ragazzi si completassero<br />
soltanto con produttori eccellenti non c’erano mai stati dubbi: dietro al successo dei singoli<br />
dell’esordio c’erano gli allora amici James Murphy e Tim Goldsworthy, dietro il make up del sophomore,<br />
un plotone formato da Paul Epworth, Ewan Pearson e niente meno che Danger Mouse. Ora che in<br />
consolle spunta un altro grande, quel Philippe Zdar (metà dei Cassius) che diede l’impronta decisiva al<br />
successo dei Phoenix, quel che rimane da aspettarci sono dei sintetizzatori angelici<br />
e circolari sopra a una formula che ha segnato un’epoca oramai lontana.<br />
Tocca ricredersi. Dopo cinque anni dallo sfortunato seguito di Echoes, abbiamo<br />
un album che mastica, coriaceo, innamorato, sincero, un torbido dance-rock<br />
newyorchese dove riconosci i riferimenti semplicemente facendo i conti con<br />
la storia della città dalla quale questi ragazzi provengono.<br />
How Deep Is Your Love, traccia scelta per introdurre il disco lo scorso giugno,<br />
diceva già molto, se non tutto, quello che bisognava sapere sulle nuove coordinate:<br />
è disco music imbastardita di cultura rock targata seventies (In The Grace Of Your Love), la pronuncia<br />
urbano/vissuto/annichilita di velvettiana memoria, i Television e i Neon Boys del caso e la cultura I will<br />
survive delle dive black. Il pezzo inoltre è pre-house senza essere vintagista, revisionista ma non citazionista<br />
e il gioco in produzione valorizza il backbone grezzo di piano, clapping, charleston e infine sax,<br />
contrasto di volumi che poi enfatizzano l’ingresso di una cassa a basso bpm.<br />
Nel disco inoltre, spiccano ballate macchiate di r’n’b che erano già nelle pieghe della discografia dei<br />
Rapture: nella conclusiva It Takes Time To Be A Man, Zdar mette sub bassi sotto intimismi strumentali,<br />
riff al piano da prima colazione, fiati Stax distratti, chitarrina rockish, soul espettorato e una coda di urli<br />
al cielo che manco gli Animal Collective. E’ il finale di un disco che in tracklist al secondo posto ha Miss<br />
You, e lì sì, c’è la synth-delia al cielo utilizzata con i Phoenix, Blue Bird invece, fonde tre canzoni in una<br />
mescolando carica post-punk, intermezzi psych-60, aperture kraut-cosmiche, Come Back To Me si prende<br />
una vacanza francofona campionando una fisarmonica infilandola in un ritmo in cassa, controcanti afro<br />
e il tipico canto wavey degli esordi, la traccia omonima si ributta nell’old skool sempre tagliando con<br />
ritmiche in presa diretta. La sola Never Gonna Die Again riprende certe soluzioni funky con cassa in levare<br />
che riportano diritti al 2003, idem per Can You Find A Way? che riporta ai primi Klaxons.<br />
Abbonando Children, cagata radiofonica 90s, il disco è dominato da quest’idea di prosopoea melodica<br />
(l’euro disco Sail Away, Roller Coaster uno degli esempi migliori) dove si sale e si scende. E dove allo slancio<br />
bianco trovi sempre questa spiazzante quotidianità black in contropartita. I Love New York.<br />
(7.3/10)<br />
Edoardo bridda<br />
Stinking Cloud). Ma l’occhio/orecchio di Dwyer stavolta<br />
sembra aver guardato anche al di qua dell’oceano, verso<br />
l’Albione psych-folk più mutante. Un disco che si fa<br />
classico, ma non della storia discografica del progetto,<br />
quanto dell’intera epopea del (psych)rock da un cinquantennio<br />
a questa parte. Il che non è affatto poco.<br />
(7.3/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
thEgiornaliSti - Vol. 1 (boombiCa,<br />
SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: inDie rock<br />
Ci sbaglieremo, ma dietro l’aspetto stiloso e il sound<br />
Strokes-oriented dei romani Thegiornalisti potrebbe<br />
nascondersi altro. E’ come se la formazione di Tommaso<br />
Paradiso, Marco Primavera, Marco Antonio Musella<br />
ed Emanuele Guidoboni avesse scelto consapevolmen-<br />
110 111
te la via di fuga più facile, senza accorgersi che invece i<br />
dieci brani di questo Vol. 1 avrebbero avuto la caratura<br />
per meritare un trattamento diverso. Ce lo suggeriscono<br />
certi testi misto di immediatezza, quotidianità ma anche<br />
brillanti intuizioni e una scrittura ricca di citazioni scollegate<br />
dall’estetica di riferimento. Materiale che si posiziona<br />
decisamente su un altro livello rispetto a produzioni<br />
analoghe per stile e attitudine.<br />
Alla fine non si tratta solo di canzonette, anche se chi<br />
suona sembra far di tutto per farle passare come tali.<br />
Rischiando così di catalizzare l’attenzione di un pubblico<br />
che forse non le apprezzerà fino in fondo, rapito invece<br />
dagli aspetti più glamour ed esteticamente riconoscibili<br />
di una formula che banalizza (un po’ come fa la bic in<br />
copertina) le buone cose contenute in questo esordio.<br />
Tra queste il DNA melodico nostrano rubato agli anni<br />
Cinquanta già de I Cosi in E allora viva! o Il Marinaio, le<br />
cadenze western sdoganate dagli ultimi Baustelle di La<br />
mano sinistra del Diavolo, l’Ivan Graziani traviato dai Libertines<br />
di E menomale e in generale un’anima autoriale<br />
nascosta tra batterie sincopate e chitarrine stropicciate.<br />
C’è di rallegrarsi, insomma, ma anche di che riflettere.<br />
L’impressione comunque è che da queste parti possa<br />
accadere qualcosa di importante.<br />
(6.8/10)<br />
Fabrizio zampighi<br />
tigEr & WoodS - through thE grEEn<br />
(running baCK, maggio 2011)<br />
Genere: Disco<br />
Il dj-set al MeetInTown di Roma è stata l’occasione ideale<br />
per toccare con mano lo spirito dei Tiger & Woods, misterioso<br />
duo comparso praticamente dal nulla quest’anno<br />
e gettatosi nella mischia con l’acclamatissimo singolo<br />
Gin Nation (che ricuce con maestria Music And Lights degli<br />
Imagination) ed un album, questo Through The Green, che<br />
gronda disco-boogie americana anni Ottanta da tutti i pori.<br />
Di Larry Tiger e David Woods si continua a sapere pochissimo,<br />
nonostante se ne sia fatto un gran parlare: voci di<br />
corridoio ipotizzano la comparsata di Marco Passarani<br />
alla cabina di regia; noi possiamo solo dirvi che si son<br />
presentati due ragazzi cool in tenuta sportiva e cappellino<br />
di fronte agli occhi.<br />
La loro musica, invece, si apre lampante già dal primo<br />
ascolto: il sound gioca tutto su groove pulitissimi, saldamente<br />
piantati su synth possenti, e loop vocali a stretto<br />
giro che erigono un monumento alla ripetitività come<br />
perno fondante della dance del loro stile oltre il tempo.<br />
Un richiamo neanche tanto velato per la strategia di<br />
marketing e musicale alla visione Daft Punk / DJ Sneak<br />
(amico in evidenza sulla loro pagina myspace), richia-<br />
mando opportunamente in Time tutto il gusto sampledelico<br />
di Discovery con qualche arco in più e in El Dickital<br />
la magia dei filtri french.<br />
La ricetta è di quelle che, anche se non promuovono<br />
alcuna novità, possono risultare esplosive, soprattutto<br />
a ritmo spedito: il top è raggiunto negli intrecci ipnotici<br />
di voce e ritmo di Don’t Hesitate, Dr. Burner o Love In<br />
Cambodgia, che centrano in pieno il cuore della faccenda<br />
dance riscoprendone dal passato i risvolti più gioiosi<br />
e solari. Il vero problema dell’album però sta nel fatto<br />
che è, appunto, un album: questa musica può offrire il<br />
meglio in pista, dove ciclicità e tempi lunghi sono una<br />
scommessa vinta in partenza, mentre il formato d’ascolto<br />
evidenzia tutti i limiti del mezzo, attenuati solo in<br />
parte da espedienti come il soul in potenza di Curb My<br />
Heart o il cut’n’paste d’antan di Gin Nation. Il caldo suggerimento<br />
è di buttare via le cuffie e andarveli a godere<br />
direttamente alla consolle. Il disco giusto per il prossimo<br />
party in piscina. Durerà anche dopo l’estate?<br />
(7/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
tiny tidE - thErE’S a girl that nEVEr goES<br />
out (KingEm, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: shoeGaze pop<br />
Ormai è chiaro che si tratta di una patologia. Di quelle<br />
sane, se mi passate l’ossimoro. Sia chiaro, la malattia di<br />
Mark Zonda è una di quelle che augureremmo ai nostri<br />
più cari amici. I sintomi: s’innamora perdutamente di situazioni<br />
pop disparate, con ovvia predilezione per quelle<br />
che vedono protagoniste figure femminili. Gli effetti<br />
collaterali: produce musica a ritmo continuo, roba che<br />
nemmeno nei fibrillanti anni Sessanta. Gettando il cuore<br />
oltre l’ostacolo dei non trascendentali mezzi a disposizione.<br />
Ma tanta è la fregola, e così ampia e dettagliata,<br />
che porre l’argine sarebbe deleterio.<br />
Insomma, ancora devo riprendermi dalle buone sensazioni<br />
suscitate da Plato’s Summer Stars, successore del<br />
buon Febrero uscito appunto lo scorso febbraio, ed ecco<br />
seguire a ruota il qui presente There’s A Girl That Never<br />
Goes Out, nel quale si celebra appunto la “popfilia” del<br />
leader dei Tiny Tide. Dieci tracce di pop gasato shoegaze<br />
e glassato synth-wave, in (dis)equilibrio sul crinale tra<br />
gioco e abbandono, tra sogno e struggimento. Come potrebbe<br />
un Patrick Wolf immerso in caligini My Bloody<br />
Valentine e colto da sparsi spasmi Elvis Costello, tremori<br />
Scott Walker e persino certe impalpabili languiderie<br />
Brian Wilson. Altrettanti frutti di ossessioni declamate,<br />
dalla Nina Persson dei Cardigans di Short Stories ‘Bout<br />
Nina alla Yuka Honda (delle Cibo Matto) di Thinking<br />
‘Bout Yuka, da Charlotte Hatherley (ex-chitarrista degli<br />
highlight<br />
tinariWEn - taSSili (CoopEratiVE muSiC, agoSto 2011)<br />
Genere: Desert sounD<br />
Proprio quando si poteva temere una caduta nel clichè, questi magnifici rivoluzionari con le chitarre ci<br />
sorprendono nuovamente. Ammesso e non concesso che il loro stile - attenzione: nuovo solo per noi<br />
occidentali - tra John Lee Hooker e dei Grateful Dead più asciutti possa aver stancato (non lo ha fatto,<br />
no), spetta a Tassili esplicitare una vivida volontà di sperimentazione. E, per la<br />
solita questione di prospettive, per costoro significa anche contaminare quanto<br />
gli viene naturale con l’occidente che li ammira. Difficile pertanto trovare<br />
un atto di “ribellione” più sensato che far convivere radici e futuro. Questo il<br />
significato ultimo di registrare nel pieno del deserto invitando ospiti d’eccezione<br />
e qualità che si integrano perfettamente; e, nel frattempo, approfondire<br />
i toni meditativi attraverso chitarre più del solito acustiche e un pugno di<br />
malinconiche “ballate”.<br />
Facendo così anche quadrato di fronte alla dipartita di Abdallah Catastrophe,<br />
prossimo all’esordio solista, nello stesso momento in cui Kyp Malone e Tunde Adebimpe dei TV<br />
On The Radio ipotizzano un Peter Gabriel che negli ’80 elegge il Sahara a teatro delle sue indagini in<br />
Tenere Taqhim Tossam, Nels Cline presta con gusto e discrezione le corde alla tesa Imidiwan Ma Tenam<br />
e la Dirty Dozen Brass Band ondeggia tra errebì atavico e free jazz nell’abbagliante Ya Messinagh.<br />
Assi calati in apertura di un lavoro il cui cuore si rinviene però in radici che, ridotte all’essenziale, pulsano<br />
vive e più che altrove nel traslucido, struggente raccoglimento di Asuf D Alwa, Walla Illa e nel commiato<br />
Iswegh Attay/Takest Tamidaret. Segnali di un costante movimento, tipico dei classici conclamati da<br />
prendere a fulgido esempio.<br />
(7.6/10)<br />
gianCarlo turra<br />
Ash) di Haterley a Marina Diamandis (AKA Marina And<br />
The Diamonds) di A Diamond For Marina.<br />
Non di solo cantantesse si compone però l’iperuranio<br />
sentimentale di Zonda, che anzi si concede escursioni<br />
nella fiction - vedi Come Along Pond, dedicata all’assistente<br />
di Doctor Who Amy Pond, e Rachel Green, ovvero il<br />
personaggio di Friends interpretato da Jennifer Aniston -<br />
e nell’immaginario fumettistico (dall’anime Katsuragi, It’s<br />
Me... agli ineffabili nonché intramontabili Peynet Lovers).<br />
Amori impossibili - come recita il sottotitolo - che si agitano<br />
travolgenti dietro la cortina fumogena del rumore,<br />
emblema di peculiarità emotiva ed esistenziale che va<br />
a confessarsi nella conclusiva Blinded By The Pop Stars,<br />
ritornello vagamente rubacchiato al Billy Idol di Dancing<br />
With Myself e la parafrasi smithisana che dà il titolo<br />
all’album come una tenera, meritata catarsi. L’ispirazione<br />
non è sempre al top, ma l’ascolto non è mai meno che<br />
gradevole. E l’insieme vale più della somma.<br />
(7/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
tiny tidE - plato’S SummEr StarS (KingEm,<br />
agoSto 2011)<br />
Genere: Dream pop lo-fi<br />
Sei mesi dopo il buon Febrero, ecco puntuale la nuova<br />
prova firmata Tiny Tide. Ovvero, l’ennesimo frutto<br />
della irrefrenabile ossessione che muove il cesenate<br />
Mark Zonda. Il pop come una onnipresente vibrazione<br />
sognante e scabra, cortina fumogena ideale su cui proiettare<br />
le circostanze emotive ed i palpiti mnemonici.<br />
Undici tracce che sbocciano dalla scorza straniante della<br />
bassa fedeltà, tutto un aleggiare di vampe deragliate e<br />
impeto traslucido, melodie che rotolano tenere e febbrili<br />
in un formidabile precariato sonoro che chiama a<br />
testimoniare l’art-wave primordiale di Brian Eno, caligini<br />
allucinate Teenage Fanclub, la languida protervia dei<br />
Morrissey e dei John Lennon, certe fatamorgane 4AD<br />
come se le sognassero quei malandrini della Elephant<br />
6, e via discorrendo.<br />
I cromatismi sghembi di Nimesulide EG, il tumulto farraginoso<br />
di Shoes Got An Hold Me, la bambagia radiante<br />
112 113
di Back To The Beach: canzoni trafelate come sogni di<br />
rincorsa, cui sembra sempre mancare qualcosa ma non<br />
l’ingrediente che ti aggancia, ti avvince come un dolce,<br />
ammaliante fastidio. Questo disco vuole essere un po’ il<br />
tributo di Zonda all’estate come stagione delle memorie<br />
che s’imprimono a caldo. Un’estate cittadina perché i soldi<br />
sono finiti e allora le vacanze diventano due settimane<br />
di fregola creativa rigorosamente DIY. Ora, il fatto che<br />
i soldi siano finiti perché c’era da produrre il video del<br />
nuovo album - non questo, un altro - è l’anello che salda<br />
la catena e rende ubriacante la pedalata. Per i primi di<br />
settembre è infatti prevista l’uscita di There’s A Girl That<br />
Never Goes Out, che sarebbe tecnicamente il successore<br />
del qui presente. C’è bisogno di aggiungere altro?<br />
(6.8/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
tyVEK - FaSt mEtaboliSm (m’lady’S, luglio<br />
2011)<br />
Genere: shit-Gaze<br />
Dopo due album che, pur con le dovute eccezioni, non<br />
rendevano l’impatto sbilenco e la freschezza psicotica<br />
dei primissimi singoli, arriva (a grande richiesta, verrebbe<br />
da dire) la raccolta di questi ultimi.<br />
Il gruppo di Detroit è stato infatti uno dei nomi caldi della<br />
già tramontata stagione shit-gaze e Fast Metabolism<br />
(precedentemente edito in solo CDr) è qui a ricordarcelo.<br />
Nove brani che deflagrano schegge impazzite di postpunk<br />
lo-fi disturbato e indisponente, dove le ritmiche a<br />
dir poco infantili sorreggono nenie vocali e chitarristiche<br />
drogate ed ebbre e dove il malessere, più istintivo che<br />
ragionato, del vivere in una metropoli così putrescente<br />
si riversa in brevi pezzi, concepiti in garage e inzuppati<br />
di demenza urbana.<br />
Ne sono prova inconfutabile Mary Ellen Claims e Air Conditioner,<br />
due dei pezzi migliori in assoluto che mostrano<br />
la cifra dissennata del gruppo at his best, come non è più<br />
stato in grado di mostrarsi se non in sporadici episodi.<br />
Ben venga dunque questa operazione nella speranza<br />
che in futuro i cinque nerd ci regalino ancora qualche<br />
chicca per cui valga la pena amarli e seguirli.<br />
(7.3/10)<br />
andrEa napoli<br />
undErground railroad - WhitE night<br />
Stand (onE littlE indian, giugno 2011)<br />
Genere: GrunGe, post-punk<br />
Nati parigini, ma londinesi d’adozione, gli Underground<br />
Railroad giungono con White Night Stand al terzo lavoro<br />
in studio, affinando la propria commistione di grunge,<br />
post-punk e vaga psichedelia. Rispetto ai due dischi<br />
precedenti, Twisted Trees e Sticks and Stones (rispettivamente<br />
2007 e 2008) le atmosfere si sono fatte più cupe,<br />
complici i continui riferimenti al cinema di David Lynch,<br />
che sta diventando uno degli oggetti di culto di molto<br />
indie-mondo di oggi.<br />
Indecisi tra vaghe pulsioni da stadio che fanno tanto Foo<br />
Fighters come in Ginkgo Biloba e Rude Awakening (ma è<br />
innegabile che sotto a tutto il loro DNA sia forgiato a partire<br />
dal grunge primevo) e seguire il solco dei Sonic Youth<br />
meno sperimentali (Yellow Suite, The Orchid’s Suite), i tre<br />
riescono bene laddove cercano di mescolare elettronica<br />
povera con l’atonalità (Lucky Duck) e un incedere circolare<br />
(Russian Doll), o con un tocco bluesy (8 millimetres).<br />
(6.4/10)<br />
marCo boSColo<br />
VEgEtablE g - l’almanaCCo tErrEStrE (ala<br />
bianCa, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: pop<br />
Mantenendo la tradizione di un disco ogni due anni, i<br />
Vegetable G tornano con un nuovo album - per la prima<br />
volta interamente in italiano - che abilmente si districa<br />
in quel pop sperimentale ora filosofico ora giocoso che<br />
tanto piace all’eclettico Giorgio Spada. Anticipato dal fin<br />
troppo ammiccante singolo La filastrocca dei nove Pianeti<br />
e con l’incursione ai fiati dell’onnipresente Enrico<br />
Gabrielli, L’almanacco terrestre è un passo in avanti per<br />
la band di Monopoli compiuto solo per metà. Diviso tra<br />
riferimenti in Battiato, Bluvertigo e Max Gazzè, ma con<br />
l’aggiunta dei lampi di preziosa creatività a cui il gruppo<br />
ci ha abituato negli ottimi lavori precedenti, L’almanacco<br />
è un disco che se in parte convince sul terreno dell’originalità<br />
nelle soluzioni stilistiche, dall’altro non completa<br />
quel salto di qualità (ma leggasi anche maturità) che ci<br />
si auspicava col passaggio alla lingua italica.<br />
Brani come La voce di Pan, L’uomo di pietra, L’idea del<br />
Plancton, suonano come germogli, piccole perle, pronti a<br />
sbocciare ma a cui manca ancora qualcosa per uscire definitivamente<br />
dal selciato dell’indie. Le liriche evocative e<br />
immaginifiche non sempre convincono e spesso litigano<br />
con un sound di matrice anglofona poco incline a unirsi<br />
con la nuova lingua. I Vegetable G scelgono spesso di<br />
giocare sulla difensiva, con gli esterni bassi, come li chiamerebbero<br />
oggi, svolgendo bene il compitino ma nulla<br />
più. E la bellezza evocativa di un concept album infuso<br />
in un pop gioioso, stellato, innamorato d’amore e ricco di<br />
immaginazione e di rimandi, rivelatore di un suggestivo<br />
scenario surreale legato al ciclo armonioso legato alla<br />
natura e all’esistenza, rimane in parte incompiuto.<br />
Lo scambio tra antico e futuro rimane un’idea, le stelle<br />
ascoltano e lanciano un plauso alla gioiosa gentilezza<br />
highlight<br />
toddla t - WatCh mE danCE (ninJa tunE, agoSto 2011)<br />
Genere: soulstep, post-raGGa<br />
Un disco che come nella miglior tradizione dei sophomore si distanzia dalle<br />
origini e prende una strada nuova. L’arma della smarcata col passato fa bene<br />
a Tom Bell, che da quel bruciante esordio in fissa con la cultura ragga (Skanky<br />
Skanky) ne ha fatta di strada. Ora il ragazzo, emigrato da Sheffield a Londra, ha<br />
infatti una trasmissione su BBC Radio 1, ha prodotto tracce per Roots Manuva,<br />
Ms Dynamite e altre star della scena urban, ha una pletora di remix e pure<br />
un’etichetta (la Girls Music, in cui bazzica pure Roska).<br />
Come avevamo già anticipato qualche giorno fa, lo stesso Toddla ha dichiarato che il disco è dedicato a<br />
quei clubbers che vogliono riposarsi o ascoltare qualcosa prima di arrivare al lavoro, e quindi si inserisce<br />
in un contesto urban che fa l’occhiolino al post-dupbstep invischiato con il pop soul (vedi il rimando a<br />
Katy B e alle produzioni house Novanta in Take It Back con il feat di Shola Ama), ha ancora qualche puntatina<br />
drum’n’bass tagliata con melodie sciccose (Cruise Control) e ovviamente si riconosce in un’eredità<br />
elettrica che ha le sue basi sempre a Kingston, ma le muta con i Soul II Soul più 80 che mai (Cherry Picking<br />
trasfigura Tina Turner oggi), con la cultura a 8-bit della cheap music (stupendo il singolo ‘in opposition’<br />
Streets So Warm) o con il taglio banghra-vocoderato che è suo marchio di fabbrica (Body Good).<br />
Anche se le dichiarazioni dell’uomo volano basso su un presunto rallentamento del beat, la presenza<br />
nei credits di gente come Skream e Roots Manuva (suo il featuring in uptempo funk un po’ alieno dal<br />
contesto globale nel singolo che dà il nome all’album) ci fa capire come le tracce saranno ben presto<br />
sciacallate da una pletora di remixers (vedi le buone prove già effettuate da SebastiAn e Dillon Francis)<br />
o di DJ, che riusciranno a farci ballare sulle note del soul di inizio millennio. Senza sputtanarsi, Bell crea<br />
il giusto compromesso tra la moda del momento (il soulstep), le roots’ (il ragga della conclusiva Fly) e<br />
il pop. Dancehall di classe per Tod.<br />
(7.3/10)<br />
marCo braggion<br />
musicale del gruppo pugliese ma anche la richiesta<br />
incondizionata di un ulteriore passo in avanti, magari<br />
senza aspettare altri due anni (aggiungo io).<br />
(6.6/10)<br />
gianluCa lambiaSE<br />
ViVa brothEr - FamouS FirSt WordS<br />
(gEFFEn, agoSto 2011)<br />
Genere: Gritpop<br />
Perplime non poco la stampa britannica che da quarant’anni<br />
ha smaniato per l’arrivo dei nuovi Beatles e<br />
ora si ritrova a cercare con il lanternino i nuovi Oasis. I<br />
Viva Brother sono di Slough vi dice qualcosa? Provate a<br />
dare un occhiata alla wikipedia e fatevi due risate amare:<br />
Slough è famosa per la puzza (the Slough stench), per<br />
il fatto che dai Settanta a oggi è la stessa identica città<br />
(parole del comico locale), per degli indici di criminalità<br />
e narcotraffico tra i più alti del Paese, e perché sempre a<br />
questo benedetto posto dimenticato dal KGB, la BBC ha<br />
dedicato una miniserie intitolata - e non è uno scherzo<br />
- Making Slough Happy.<br />
Slough è l’archetipo della città derisa e sfigata e i Viva<br />
Brother il prototipo del gruppo autentico per eccellenza.<br />
Roba che la Manchester dei Gallagher e la Sheffield dei<br />
Pulp perdono a tavolino in un gioco delle parti stampa/<br />
band a rendere il tutto ancor più comico. I Viva Brother<br />
fanno la scheda stampa e NME scrive. Influenze? Una santa<br />
trinità di Smiths, Stone Roses e Blur (no gli Oasis non<br />
ci sono). Slogan provocatori? If anyone here doesn’t want<br />
to see the future of music, leave now. Genere? In autodefinizione,<br />
rubando alla critica il giochino preferito, ovvero<br />
coniando il Gritpop da britpop e grit, un britpop risoluto, in<br />
pratica. Producer? Naturalmente Stephen Street, l’uomo<br />
delle grandi occasioni dalle stelle dei Novanta a oggi.<br />
E’ troppo bello per essere vero: Famous first words è una<br />
delusione totale. Immaginatelo un sound che rimbalza dai<br />
114 115
highlight<br />
WilCo - thE WholE loVE (dbpm, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: folk-rock-pop<br />
L’inizio è un funky robotico, sincopi algide e polverose scarabocchiate sulla piattaforma krauta. D’un<br />
tratto si alza una cortina di mellotron come un sipario fibrillante, ed ecco avviarsi la canzone col suo<br />
tribolare soul futuribile, senso di allarme e angoscia pastosa nella litania stropicciata del canto, ma anche<br />
quel retrogusto di familiarità differita, rifratta, sparsa. Tanto è radioheadianamente riuscita che Thom<br />
Yorke si morderà i gomiti. Poi, quando sospetti che il solco sia stato già del tutto tracciato, s’imbizzarrisce<br />
la vena elettrica dapprima con foga controllata à la Wire e poi tutto un affilare e deragliare di watt, una<br />
concitata incandescente acuminata scompostezza, atto di sacrosanta devozione al dio del rock acido<br />
(sempre sia benedetto l’ingresso in squadra di Nels Cline).<br />
Questi, più o meno, sono i sette minuti abbondanti di Art Of Almost, traccia d’apertura di The Whole<br />
Love, ottavo lavoro targato Wilco. Uno di quei pezzi che stabiliscono il centro di gravità, e che ti fa venire<br />
voglia di esserci ogni volta che lo eseguiranno dal vivo. E’ il tipico modo di Tweedy e soci di scombussolare<br />
la gerarchia dei segni, di smarcarsi da una pur arguta e accoratissima consuetudine. Proprio come<br />
la malattia, il disagio, certi cataclismatici incroci di eventi ti fanno deviare dal flusso confortevole della<br />
quotidianità. La musica dei Wilco in fondo è (solo) questo: un doppio filo che intreccia calore e disagio,<br />
l’uno e l’altro necessari per tenere in piedi la carcassa, mentre sullo sfondo si consuma il conflitto muto<br />
tra ciò che resta del Sogno Americano e la semplice, implacabile evidenza della realtà. E’ uno specchio<br />
rotto in un milione di pezzi, la realtà vista dal pianeta Wilco. E questo spiega quel procedere dei testi<br />
attraverso frasi che sembrano frammenti di una narrazione sfuggente, mai del tutto definita se non<br />
lungo il filo pastoso - pastosamente indefinibile - delle emozioni.<br />
Le undici tracce che completano il programma ondeggiano con una certa scaltrezza tra verve errebì<br />
contagiata power pop (il boogie screziato fuzzy di Standing O, la battente acideria di I Might, l’accorato<br />
disincanto vagamente Kinks di Whole Love) e ballate country folk impegnate a mitigare solennità tristarelle<br />
con un filo di speranzosa morbidezza (il tepore allibito e l’estatico vitalismo à la Jim O’Rourke<br />
di Rising Red Lung, la mestizia amniotica di Open Mind, il Brian Wilson sognato dai Mercury Rev di<br />
Sunloath). Tutto molto più canonico quindi rispetto alla opening track, eppure tra i fili della trama e nei<br />
margini sbrecciati si annidano pur sempre quei tipici vibrioni d’irrequietezza post-contemporanea, che<br />
siano dissonanze elettriche, perturbazioni sintetiche o il respiro onirico degli archi a spaesare le palpitazioni<br />
da front-porch (Black Moon).<br />
Con questo disco insomma i Wilco tornano alla grande in carreggiata, recuperano<br />
il senso del loro percorso rispetto all’eccesso di normalità del pur non<br />
disprezzabile predecessore. La sensibilità frantumata e ricomposta di Tweedy,<br />
quella meravigliosa sensazione di sgretolamento emotivo scampato d’un<br />
soffio ma sempre in agguato appena dietro l’angolo, può così affiorare anche<br />
in circostanze apparentemente sdrammatizzate come l’incalzante Born Alone<br />
(ritornello Tom Petty e incandescenze flaminglipsiane) e nello swinghettino<br />
à la Randy Newman di Capitol City. Per poi infine spalmarsi con struggente<br />
gravità orizzontale nella lunga One Sunday Morning, via crucis soffice che assolve la mestizia celebrandone<br />
la presenza ineluttabile come una lenta, ripetitiva, liberatoria rivelazione. Non è l’album migliore<br />
dei Wilco solo perché ci hanno già consegnato i loro capolavori. Ma è un ottimo album di una band<br />
(ancora) straordinaria.<br />
(7.4/10)<br />
StEFano SolVEnti<br />
Blur agli Oasis e dagli Oasis ai Blur sopra un retino da ping<br />
pong firmato Supergrass. Un gioco serissimo dove l’amato<br />
houmor inglese non c’entra proprio. Parte New year’s day<br />
e via di a-a-a-ao alla Girls and Boys, poi è il turno di Electric<br />
day e sotto con i falsetti dei Gallagher che neanche in Live<br />
forever. Il resto è fotocopia, un susseguirsi riff tintinnanti che<br />
non infilano una strofa-ritornello con un minimo di personalità<br />
(Darling buds of may o Still here) e lo fanno con dei<br />
testi che l’Inglese è proprio meglio non saperlo.<br />
La loro forza sono 36 minuti di scanzonatezza. Niente<br />
che non diventi trascurabile al secondo ascolto. Dopo i<br />
Viva Brother, i Beady Eye vi sembreranno migliori e Noel<br />
Gallagher sarà John Lennon.<br />
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&am<br />
p;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;<br />
(4.5/10)<br />
Edoardo bridda<br />
WEyES blood and thE darK JuiCES - thE<br />
outSidE room (not not Fun, SEttEmbrE<br />
2011)<br />
Genere: DesertshorinG<br />
Di tutte le epigoni di Nico, Weyes Blood merita di essere<br />
considerata una delle più rispettose, ancorchè una delle<br />
più efficaci. Tolti gli esperimenti di Fursaxa che con<br />
Kobold Moon dimostrava di sapersi sganciare dal verbo<br />
di Marble Index per arrivare ad un’espressione del<br />
tutto propria, Natalie Mering al suo debutto su Not Not<br />
Fun dopo una serie di episodi a bassissima circolazione,<br />
si accomoda padrona e sicura sul cavallo bianco di Desertshore.<br />
Da li, parte per un suo excursus personale che<br />
se da un latro prende in prestito i goticismi astratti e sepolcrali<br />
dell’austrice di Janitor Of Lunacy, dall’altro centra<br />
un melodismo austero, minaccioso e intimidatorio che<br />
la porta dalle parti di una Catherine Ribeiro meno aggressiva.<br />
La strumentazione è quella d’ordinanza: organi<br />
da sepolcro perduto messi al servizio di un ensemble distorto<br />
e sfumato che la produzione di Graham Lambkin<br />
ex Shadow Ring si impegna nel valorizzare aumentando<br />
il senso di distacco temporale da una musica già sufficientemente<br />
“eterna” di per sé. Madrigali devozionali che<br />
virano verso un goticismo storto e malevolo come nelle<br />
nenia drogate e di-sfatte di Storms That Breed o Candyboy<br />
o ancora meglio come nell’evocazione esoterica su<br />
chitarra arpeggiata di Dream Song e nell’inno putrefatto<br />
e senza pathos di Romneydale fino agli episodi conclusivi<br />
che mostrano altrettanti ipotesi di percorso verso un<br />
futuro più incerto che mai.<br />
Da un lato, l’astrattismo surrealista di In The Isle Of Agnitio<br />
su cui moltissimo influisce il gusto per il vuoto distratto<br />
di Lambkin, dall’altro l’austerità monastica di His Song<br />
che vira sempre di più verso una decadenza maligna<br />
sull’onda di un droning psichedelico ed effettato che fa<br />
tremare le ossa. Nel suo genere un piccolo capolavoro.<br />
(7.5/10)<br />
antonEllo ComunalE<br />
WhitE hillS - hp-1 (thrill JoCKEy, giugno<br />
2011)<br />
Genere: space rock<br />
Aspettavamo al varco i White Hills per sapere che direzione<br />
avrebbero preso dopo la svolta iniziata un anno<br />
fa con il disco omonimo. Il nuovo Hp-1 da una risposta<br />
parziale, lasciando aperti ancora parecchi conti.<br />
I suoni muscolari da rock’n’roll in pelle duro e puro<br />
vengono in parte accantonati, pur prevalendo ancora<br />
quando i White Hills si adagiano nella sicurezza di tirate<br />
spacey (No Other Way) e hard (The Condition Of Nothing).<br />
Una vena sperimentale traspare comunque forte del disco:<br />
il battito motorik sporcato di noise di Paradise, il<br />
glitch tribale di Monument, la doppietta d’elettronica<br />
ambientale A Need To Know / Hand In Hand.<br />
Un buon disco in cui alla fine rimane la sensazione che<br />
sia il peso degli ospiti a tirare fuori il meglio. In particolare<br />
in Paradise e nella stupenda Monument la mano di<br />
Kid Millions si sente tutta. Quando sono lasciato a loro<br />
stessi, i White Hills tornano spesso a un più canonico<br />
hard-space-rock (Hp-1, Upon Arrival).<br />
(6.8/10)<br />
FranCESCo aSti<br />
WilEy - 100% publiShing (big dada<br />
rECordingS, giugno 2011)<br />
Genere: urban / Grime<br />
Wiley è uno dei prominent man del collettivo Roll Deep,<br />
nato nella Londra garage nel 2002 e diventato presto<br />
uno degli act chiave della scena grime, vivaio di gente<br />
come Dizzee Rascal e Skepta. La sua Eskimo, rappata<br />
da Dizzee, è tra i classici assoluti del genere.<br />
Per questo settimo album l’uomo lavora in completa autarchia,<br />
scrive produce e rappa tutto da solo, rap ragga<br />
serrato e appiccicoso e basi fatte da bassi profondi e pulsanti<br />
con trame di tastiera vagamente minacciose e secchi<br />
clap. La supercommerciale Boom Boom Da Na, Your<br />
Intuition con una base sorprendentemente trattenuta e<br />
cesellata, I Just Woke Up che sembra quasi un pezzo degli<br />
Antipop Consortium, Wise Man & His Words praticamente<br />
jazzata, Talk About Life supersmooth, Pink Lady lo sketch<br />
con inciso autotune.<br />
Al di là dei singoli brani, un album molto equilibrato e<br />
misurato nel fotografare, da una prospettiva comunque<br />
autorale, l’evoluzione commerciale, leggi dancefloor e<br />
116 117
highlight<br />
zola JESuS - ConatuS (SoutErrain tranSmiSSionS, SEttEmbrE 2011)<br />
Genere: Dark-wave<br />
Dimenticate la ragazzetta intrisa fino al midollo di zozzeria lo-fi. Nika Roza Danilova<br />
aka Zola Jesus è ormai una signora e Conatus il suo figlio prediletto.<br />
L’evoluzione della ragazza del Midwest è innegabile, l’abbandono del sottobosco<br />
pure. E non parliamo solo dell’aspetto estetico che l’ha vista passare<br />
da dark lady dalla chioma corvina alla ossigenata/patinata, spettrale presenza<br />
velata della cover attuale.<br />
Dai tempi dei primi singoli - melodie sofferte annegate in cumuli di caligine<br />
in bassa fedeltà con velleità sperimentali piuttosto marcate - alle prime prove<br />
lunghe in cui il cripto-goticismo la faceva da padrone ergendo la nostra a capostipite<br />
della “crimson-wave”, Zola Jesus si è via via avvicinata ad una forma più compiuta di pop dalle<br />
venature apocalittiche e costellate sempre da umori darkeggianti. Ora il passo successivo è quello della<br />
via 2.0 ad una nuova forma di mainstream, ovvero abbandonare le lande del culto underground per una<br />
accessibilità di più ampio respiro senza perdere una stilla in credibilità e appartenenza.<br />
Zola Jesus come l’anti-Lady Gaga? Nika come la Madonna del terzo millennio? Non siamo a questi livelli,<br />
ma è innegabile che le scelte non solo compositive quanto meramente produttive - cristalline, 90s oriented,<br />
piene di ganci e rimandi a un esemplare e ampio background - pongono la chanteuse d’origine europea su<br />
un livello superiore rispetto all’artista outsider e sperimentale che conoscevamo. In grado cioè di elaborare<br />
il proprio sentire musicale, personale e intimo - pur ancorato sempre ad una sensibilità dal taglio goth,<br />
intrisa di malinconia, ancestralmente oscura e haunted - in forme più accessibili e compiute.<br />
L’accompagnamento musicale, di stampo sintetico seppur intriso di corde (ad aiutare ci sono la viola e il<br />
violino di Sean McCann e il violoncello di Ryan York), è sempre austero e rigoroso, filiazione innegabile della<br />
wave più eterea e dell’electro-pop meno radicale, ma in Conatus ritroviamo slanci “altri” a dimostrazione<br />
dell’apertura di cui sopra: il romanticismo lirico nato dall’interazione tra macchine algide e il caldo dell’acustico<br />
(Shivers ne è esempio plausibile, così come la scheletrica piano/voce Skin) ma soprattutto la accentuata<br />
apertura ritmica, quasi disco (Seekir) che innerva le composizioni segna uno dei maggiori scarti con<br />
la Zola Jesus primigenia. Su tutto, una performance vocale di altissimo livello: sofferta, profonda, enfatica.<br />
Se The Spoils arrivava a “raffreddare una estate troppo calda” (cit. Comunale), Conatus è il perfetto album<br />
autunnale, trabordante malinconia e struggenti melodie vocali, e fin dal titolo, è un vero e proprio “sforzo”<br />
per superare i propri limiti e confini, per muoversi oltre. Verso visioni musicali nuove, che sono, allo stesso<br />
tempo, rielaborazione di input pregressi e slancio verso il nuovo: che sia il battito a cassa dritta (Ixode,<br />
acido electro-beat per capannoni in disuso), la pulsazione corrotta di stampo glitchy, il rumorismo di<br />
sottofondo (la Bjork sottesa a Swords o al singolo Vessel) o l’atavico marchio 4Adiano (l’inno autunnale<br />
In Your Nature, la pastorale post-apocalittica Avalanche).<br />
Non più Diamanda Galas, la Lunch o una Siouxie giovane e agguerrita. O meglio, tutto questo ma anche<br />
molto di più. Zola Jesus è ormai una moderna artista capace di mettere a fuoco un percorso, di compiere<br />
quel “conatus” che è il cuore dell’album, con grazia e stile (quasi) unici.<br />
(7.5/10)<br />
StEFano piFFEri<br />
pop, del grime; più incompromissorio e meno superprodotto<br />
di Dizzee, di cui infatti, di rovescio, non ha il<br />
breaking appeal pop.<br />
(6.5/10)<br />
gabriElE marino<br />
zoom-on-a-Kill -<br />
“l∆”lol₡ᴓ<br />
(autoprodotto, maggio 2011)<br />
Genere: 8bit / witch / rave<br />
Nei tempi dominati dal web 2.0 la rete diventa lo strumento<br />
indispensabile per toccare con mano i fermenti musicali<br />
nascosti sotto la soglia dell’informazione giornalistica. Fenomeni<br />
di sottocultura generazionale come chip music,<br />
glo-fi o witch-house usano da sempre blog e social network<br />
come casse di risonanza per condivisione e autopromozione,<br />
e questo rende le varie scene tanto dispersive e frammentate<br />
da rendere impossibile applicarvi concetti come<br />
“discografia” o “tendenza”. Piccole guide di orientamento<br />
son molto utili, e noi nel nostro piccolo proseguiamo tra<br />
articoli e recensioni a fornirvi spunti di approfondimento.<br />
Gli Zoom-on-a-kill sono tra i nomi più interessanti emersi<br />
recentemente dal tam tam della rete. Trattasi di un misterioso<br />
progetto 8bit messicano, col suo classico blog bandcamp<br />
che, come spesso accade, è anche il portale che<br />
ospita le proprie pubblicazioni (tre fino ad ieri, tutte nella<br />
stessa area chip-punk/rave dei Covox). L’ultimo &Dagger<br />
;L∆‡Lol₡ᴓ (se proprio dovete,<br />
pronunciatelo Tlatelolco) è però particolarmente affascinante<br />
per l’inedito mix stilistico offerto. Il manifesto del disco<br />
sta tutto in Quiero Café: 160 bpm di rave pompatissimo,<br />
iniettato di organi malaticci virati witch, blips Amiga e canti<br />
esoterici assortiti. Per chi non si accontenta.<br />
La smania per l’esagerazione tipica dei Crystal Castles<br />
(che del filone witch house possono esser considerati<br />
i precursori) la si ritrova anche in The Brand New Wolf,<br />
mentre invece brani come Tequila Fantasmal ambiscono<br />
più al versante thriller/darkwave della faccenda. Eppure<br />
la nuova infatuazione per le streghe convive bene con<br />
l’anima chiptune del team, che sempre senza timore<br />
sposa i ritmi acidi dei party anni ‘90 (Cruzadee) o quando<br />
va bene accede alle piste techno (Circuit Robot, Bazooka)<br />
o trance (Cyfresh Sex). Se a tutto questo aggiungiamo<br />
la disinvoltura dark-step dall’imprinting Zomby di<br />
Ϛobviṅ∆‡ioṇ Touch, le<br />
possibilità tech-ambient di Comptine D’un Autre Été e il<br />
delicato tocco french de La Valse D’Amelie, a venirne fuori<br />
è un profilo dotato di grande padronanza dei mezzi e<br />
irriverenza nerd con tendenza a strafare. Dieci ad uno<br />
che dietro ci si nasconde un manipolo di ventenni.<br />
(6.8/10)<br />
Carlo aFFatigato<br />
118 119
— vhs Grindhouse<br />
prEdator<br />
John mctiernan (u.s.a., 1987))<br />
È il 1987 e un Arnold Schwarzenegger ancora lontano<br />
dalla poltrona di governatore della California si presenta<br />
al David Letterman Show per promuovere il suo nuovo<br />
film, Predator. Fotografato in questo momento della sua<br />
carriera, siamo in presenza di un Arnie ancora abbastanza<br />
grezzo. L’accento austriaco è molto marcato e certe<br />
ruvidità mitteleuropee sono lungi dall’essere limate . eppure<br />
che uomo dello spettacolo! Che scaltrezza politica<br />
nel sapersi intingere nel ridicolo per uscirne subito dopo<br />
come nuovo! Letterman ci va a nozze. Scherza sulla pronuncia<br />
esatta di “Schwarz’n ‘eggahhh” e sul significato del<br />
cognome che in austriaco starebbe per “Black Plow Man”,<br />
più o meno “Uomo nero dell’aratro”, e via di lì, con battute<br />
su battute e un Arnie che tiene testa al grande matteur<br />
en scene televisivo e piazza i suoi fendenti sapendola<br />
lunga su quello che bisogna fare nel cinema business<br />
hollywoodiano degli anni ’80, ovvero battere il ferro finché<br />
è caldo e plasmarsi a nuova icona mitologica della<br />
cultura pop. “If you’ve loved Terminator, then you will love<br />
Predator”. Grazie Arnie, cosa sarebbero stati questi anni<br />
senza di te? Un uomo che prima della svolta politically<br />
correct de I Gemelli con Danny De Vito (e da lì l’inevitabile<br />
parabola discendente con la sua versione friendly<br />
anni ’90 e il passaggio anche molto iconico di Termi-<br />
nator 2, dove diventa ahinoi buono) piazza cult movie,<br />
uno dietro l’altro, con la stessa metodica insistenza di un<br />
Uzi 9mm: Conan Il Barbaro, Conan Il distruttore, Terminator,<br />
Commando, Codice Magnum, L’implacabile,<br />
Danko e dulcis in fundo Predator.Un film come non se<br />
ne fanno più e lo abbiamo capito al cospetto del nasone<br />
di Adrien Brody che cerca in tutti i modi di fare il macho<br />
nel terrificante Predators di Robert Rodriguez. Giammai!<br />
“Solo Arnie può uccidere Predator” sentenzia un anomino<br />
commentatore su youtube e lo sappiamo benissimo<br />
dopo un decennio di esperimenti crossover chiamati<br />
Alien Vs Predator che hanno via via ammazzato il prototipo<br />
originale in una marea di popcorn stantii e unti,<br />
il cui unico pregio è quello di farci vedere Roul Bova<br />
accoppato nel primo dei due film. Ma qui no. Qui siamo<br />
nel 1987 e le cose si fanno ancora come comanda Dio.<br />
Tra questo primo film della serie (ma anche il secondo<br />
con Danny Glover è ancora un buonissimo film .) e tutti<br />
gli altri venuti dopo, c’è la stessa differenza che passa tra<br />
una protesi al silicone e la cara vecchia carne donataci<br />
da madre natura. John McTiernan utilizza la carne, gli<br />
altri la plastica. E di carne al fuoco, appunto, ce n’è molta.<br />
Regista che parla la lingua action con una padronanza<br />
carismatica, McTiernan all’epoca veniva da un horror di<br />
culto chiamato Nomads, con Pierce Brosnan e Adam<br />
Ant. Dopo il successo planetario di Predator, verrà ripa-<br />
gato a dovere con una sfilza di progetti ad alto budget<br />
e altri film di successo stratosferico come Trappola di<br />
Cristallo e Caccia a Ottobre Rosso prima del default<br />
di Last Action Hero che preluderà alla depressione e<br />
alla condanna a quattro mesi di carcere per aver mentito<br />
all’F.B.I. e aver fatto mettere sotto controllo i telefoni di<br />
importanti figure di Hollywood.Ma qui siamo ancora lontani<br />
da tutto questo e il progetto è solidissimo nella sua<br />
filosofia di base: fare un film di guerra con un elemento<br />
fanta-horror a fare da nemico. Per fare la guerra ci vogliono<br />
i militari e il plotone che viene mandato in missione<br />
in una intricatissima giungla sud-americana, spruzza testosterone<br />
ad ogni inquadratura. Innanzitutto Carl Weathers.<br />
E’ uno dei primi che si vede e li per li, stai quasi<br />
a chiederti cosa ci faccia Apollo Creed in un film con i<br />
militari, poi si capisce che Weathers, caratterista della<br />
vecchia scuola, sta cercando in qualche modo di uscire<br />
fuori dal cono d’ombra di Rocky e Predator è il primo<br />
atto di un fallimento che lo vedrà l’anno successivo nel<br />
tentativo di ergersi ad icona black, con il mitico Action<br />
Jackson. Passando rapidamente in rassegna il plotone,<br />
impossibile non notare poi Bill Duke, quello che in Commando<br />
si becca la mitica: “I berretti verdi me li mangio a<br />
colazione” e che prima di passare dietro la macchina da<br />
presa, fa un milione di comparsate in film di scarso o ampio<br />
respiro, a seconda del budget; c’è poi Jesse Ventura<br />
che ha cominciato come wrestler professionista, è passato<br />
per i film action con Arnie, ed è poi riuscito a farsi<br />
eleggere come sindaco di Brooklyn Park, sobborgo del<br />
Minnesota e che dire poi di Sonny Londham? L’indiano<br />
pazzo che ha cominciato come attore porno, è apparso<br />
in quasi tutti i film più maschi della decade, si è più volte<br />
candidato al ruolo di governatore del Kentucky e da<br />
cui la troupe del film doveva essere protetta tramite un<br />
bodyguard appositamente chiamato per far fronte alle<br />
sue irrazionali esplosioni di violenza ed ira. Poi, infine,<br />
c’è lui. Il Predator. McTiernan poteva sprofondare rapidamente<br />
nel ridicolo con la faccenda dell’alieno, perché<br />
nonostante ¾ del film siano esclusivamente dedicati al<br />
plotone e alla guerriglia para-vietnamita, la sostanza del<br />
progetto va a parare nel fantastico e nel soprannaturale<br />
e la miscela se non calibrata a dovere può scoppiarti tra<br />
le mani. Non è questo il caso. McTiernan sa benissimo<br />
che meno si vede meglio è e la felice trovata della vista<br />
a fasce termiche aiuta a calare tutto il film in un umore<br />
paranoide e ansiogeno che non fa altro che preparare il<br />
terreno per lo scontro finale. Il messaggio ultimo del film<br />
sembra abbastanza chiaro nella sua filosofia di fondo.<br />
L’uomo è soltanto un anello debole nella più vasta catena<br />
dell’universo e in qualsiasi momento da cacciatore<br />
può trasformarsi in preda. Filosofia che lascia il tempo<br />
che trova, perché fondamentalmente di fronte ad uno<br />
Schwarzy d’antan, con il sigaro in bocca, il sorriso sornione<br />
e il bicipite tirato l’ultima cosa che ti viene naturale<br />
è fare riflessioni metafisiche sulla natura dell’universo.<br />
Piuttosto, ti viene voglia di mandare la vecchia vhs del<br />
film ad Adrien Brody con sopra un post-it recante il seguente<br />
messaggio: “Veri Uomini si nasce, non si diventa”.<br />
antonEllo ComunalE<br />
120 121
Gimme Some<br />
Inches #19<br />
Riprendiamo lo scandaglio dei formati minori dopo la torrida<br />
estate. Ci accompagnano, tra gli altri, Zola Jesus e Fabio Orsi,<br />
Martial Canterel e Spettro Family, LA Vampires e Cult Of Youth.<br />
Dopo un’estate bollente che ha quasi<br />
fatto squagliare i nostri vinili, ricominciamo<br />
il consueto scandaglio<br />
dei formati minori con qualche 7”<br />
digitale a segnare ritorni importanti.<br />
Il primo è per Nika Roza Danilova,<br />
aka Zola Jesus e del suo Vessel, brano<br />
in digitale che funge da apripista<br />
per Conatus, il full-length in arrivo a<br />
fine settembre. Cinque minuti scarsi<br />
di musica in cui rumorismi Bjorkiani<br />
ed eleganza wavish, uniti ad una<br />
voce mai così profonda e sensuale,<br />
fanno venire l’acquolina in bocca e<br />
contare i giorni che mancano alla<br />
release dell’album.<br />
L’altro invece è targato synth-pop<br />
made in nyc fino al midollo. Xeno<br />
& Oaklander anticipa il nuovo album<br />
Sets And Lights con The Staircase,<br />
elettro-barocchismo meets ebm<br />
beats con eterea voce femminile,<br />
e Not Afraid, un funereo incedere<br />
tanto marziale nei ritmi quanto perversamente<br />
romantico nell’immaginario.<br />
Anche in questo caso, l’attesa<br />
sembra troppo lunga.<br />
Lasciando il digitale per il reale, segnaliamo<br />
il 7” di una band italiana<br />
che, nonostante il nome, è un progetto<br />
in solo. Spettro Family, aka<br />
di mr. Vade Retro Records Stefano<br />
Iannone, esordisce in vinile col 7”<br />
Strigoi (riedizione di una tape ormai<br />
esaurita) mostrandosi affine a certe<br />
sonorità wave-industrial cupe e cinematiche,<br />
come una versione contemporanea<br />
di atmosfere Goblinoriented<br />
e esoterismo rumoroso alla<br />
Ain Soph. Sensazioni gelide e in b/n<br />
limitrofe a certe uscite alla Umberto,<br />
per capirsi, e molto più credibili<br />
dei triangolini targati witch-house<br />
et similia. A breve il full-length Candelora<br />
per Brave Mysteries, la label<br />
di Burial Hex.<br />
Ultima segnalazione prima di addentrarci<br />
nell’underground statunitense,<br />
segnalazione d’obbligo per il<br />
nostro Fabio Orsi. Il prolifico berliner<br />
d’adozione ha appena pubblicato<br />
un cd 3” per la francese Taâlem:<br />
Light Was The Day è drone-music<br />
pregna di malinconiche aperture,<br />
umorali saliscendi e deliziosi contorni<br />
sfumati in un flusso di coscienza<br />
di quasi 25 minuti a base di fieldrecordings,<br />
filtri, chitarra ed effetti.<br />
Ingredienti comuni nel vademecum<br />
per il giovane droner 2.0. A fare la<br />
differenza, come al solito, è la sensibilità<br />
illuminante dell’artista.<br />
A breve distanza dall’uscita<br />
dell’omonimo album su Sacred<br />
Bones i newyorkesi Cult Of Youth<br />
ritornano con un singolo nuovo di<br />
pacca prodotto dalla Blind Prophet<br />
dello stesso main-man Sean Ragon.<br />
The Devil’s Coals è uscito nel cuore<br />
dell’estate per accompagnare il tour<br />
americano della band e propone<br />
nuove tracce con cui il combo darkfolk<br />
prosegue nella svolta intrapresa<br />
nell’ultimo Cult Of Youth, con la titletrack<br />
che scandisce ritmiche marziali<br />
e battagliere, mentre il lato B<br />
è un’efficace cover di Sidestreets del<br />
menestrello minimal-synth Martial<br />
Canterel. Le 500 copie tirate paiono<br />
essere già sold-out, fortunato quindi<br />
chi si è mosso per tempo per procurarselo.<br />
Rimanendo in ambiti oscuri segnaliamo<br />
l’imminente uscita per Distort<br />
Reality di un nuovo 7-pollici per i<br />
goth-punks Lost Tribe (il cui fulllength<br />
vedrà a breve la luce sempre<br />
su Blind Prophet). Come già detto in<br />
occasione della tape The Dawn (da<br />
cui recuperano per l’occasione la<br />
title-track Unsound) i ragazzi di Richmond<br />
tessono trame nerissime cucendo<br />
insieme brandelli di T.S.O.L.,<br />
Christian Death e Killing Joke e qui<br />
non fanno che riprovarlo al meglio.<br />
Rimanete sintonizzati se vi gustano i<br />
suoni mefitici perché l’album si preannuncia<br />
una vera messa in nero.<br />
Spostandoci sulla costa ovest degli<br />
States e cambiando completamente<br />
sonorità ci imbattiamo nel nuovo<br />
lavoro, ancora una volta collaborativo,<br />
di LA Vampires aka Amanda<br />
Brown (NNF e Pocahaunted per i<br />
pochi che ancora non lo sanno). EP<br />
di quattro brani realizzati inseme<br />
ad Ital (il progetto solista di Daniel<br />
Martin-McCormick, già Black Eyes,<br />
Mi Ami e Sex Worker), Streetwise<br />
prosegue sulle coordinate bleachdisco<br />
di So Unreal, nonostante una<br />
qualità più lo-fi che svilisce un po’<br />
la qualità delle registrazioni. Quindi<br />
ancora bedroom beats frullati<br />
nel Minipimer, vocals sbiascicate e<br />
synth fuori scala. Se queste parole<br />
non rendono l’idea di cosa vi aspetta,<br />
date un occhio alle grafiche di<br />
copertina e vi renderete conto di<br />
cosa intendiamo per elettronica<br />
vintage alla candeggina.<br />
Rientrando in Europa troviamo due<br />
nuovi singoli freschi di stampa ad<br />
attenderci. Il primo è uno split tra<br />
due dei personaggi più in vista del<br />
panaroma minimal-synth internazionale:<br />
parliamo del 7-pollici condiviso<br />
da Martial Canterel e Tobias<br />
Bernstrup, rilasciato dalla romana<br />
Mannequin. Il primo, newyorkese,<br />
non ha bisogno di presentazioni,<br />
data la crescente attenzione che<br />
gli si sta concentrando intorno; il<br />
secondo, svedese, è un nome cult<br />
per gli aficionados già dai primi anni<br />
Duemila. Cosa propongono nei solchi<br />
del vinile corto è quasi superfluo<br />
dirlo: un pezzo a testa per tappeti di<br />
synth d’antan, beat anni ’80 e voci<br />
filtrate e riverberate come ricetta<br />
comanda. Se siete fan del genere<br />
sapete già cosa fare. Chi invece<br />
forse non conoscete ancora sono<br />
i Vernon Sélavy, nuovissimo duo<br />
torinese capitanato da Vincenzo<br />
dei Movie Star Junkies, al debutto<br />
con un EP su Shit Music For Shit<br />
People, label che, come abbiamo<br />
già avuto modo di constatare, si sta<br />
facendo notare per l’attenzione ai<br />
suoni garage-country-folk nazionali<br />
ed europei. E che ci sia la firma<br />
del chitarrista dei Movie si sente<br />
fin dalle primissime note di Apple<br />
Seeds: riverberi surf, stomp blueseggiante,<br />
tamburelli gitani e voce<br />
rauca irrorata al bourbon, come una<br />
versione domestica ed acustica del<br />
gruppo principale appena accennato.<br />
Se quindi sentite la mancanza<br />
del sound sfascione dei piemontesi<br />
buttavi a colpo sicuro su questo<br />
7-pollici e non ne rimarrete delusi,<br />
garantito.<br />
StEFano piFFEri,<br />
122 123
Re-Boot #18<br />
Morbido disimpegno e scudisciate ombrose, umori terrigni e insidie<br />
acide. Come al solito è disparata la nostra selezione di emergenze<br />
rock italiche. Saluti all'estate, benvenuto autunno.<br />
All’uscita di Kollaps degli Einsturzende<br />
Neubauten (1981) in pochi<br />
avrebbero scommesso che quei<br />
velenosi semi siderurgici potessero<br />
germogliare e dar vita ad una vitale<br />
ed infettante progenie musicale:<br />
proprio da quella lontana esperienza<br />
traggono oggi ispirazione i partenopei<br />
Nembrot ed il piemontese<br />
Andrea ICS Ferraris, che con Il<br />
suono dell’olifante (6.7, Zero Sonico<br />
Records/HYSM?) propongono<br />
senza soluzione di continuità 7 interessanti<br />
pezzi rumoristici, alienati e<br />
destrutturati, dall’evidente impronta<br />
estetica DIY. Napoli che reinventa<br />
Berlino, atmosfere industrial che<br />
fanno tabula rasa di pizza & mandolino<br />
e servono sul piatto dissonanze<br />
dilatate ed elettronica, desertificazioni<br />
urbane e paesaggi musicali<br />
psicotici. Questo disco è lo specchio<br />
impietoso del drammatico contesto<br />
in cui oggi versa la città campana;<br />
trae linfa vitale dagli scarti della società<br />
del consumo, usa e rigetta tut-<br />
to con violento disincanto: in modo<br />
indifferenziato.<br />
Per chi avesse voglia di confrontarsi<br />
col meglio della produzione<br />
dei due Vasco nazionali (Brondi e<br />
Rossi) ecco il bel disco omonimo<br />
dei Prof. Plum (autoproduzione,<br />
6.4/10): solide tessiture rock, suonate<br />
con giusta energia e piglio di<br />
derivazione post-punk sostengono<br />
liriche intelligenti, disarmate e disperate,<br />
condite qua e là di un sano<br />
umorismo nero. Non tutto colpisce<br />
per originalità e non tutto è a fuoco<br />
nei 5 pezzi di questo EP, ma i sensi<br />
di ragno vibrano. Da seguire.<br />
Orbite (autoprodotto, 6.1/10) è<br />
l’ep di esordio dei L’Elide, duo romano<br />
impegnato in un hardcorepunk<br />
virato noise con palpabili elementi<br />
emo, come un cozzo Marlene<br />
Kuntz-Nirvana e primi Radiohead.<br />
C’è il piglio giusto, c’è la voce con le<br />
adenoidi a repentaglio, c’è l’urgenza<br />
tra il problematico e lo psicotico. E<br />
c’è l’arredo: riff incalzanti, arpeggi<br />
Un mese di ascolti<br />
emergenti italiani<br />
uncinati, drummin gtumultuoso,<br />
melodia preda di pulsioni facinorose<br />
e fatalistiche agnizioni. Insomma,<br />
quanto ad applicarsi non c’è davvero<br />
male. A questo punto s’attende la<br />
zampata della peculiarità, la piega<br />
inedita delle cose. Ovvero, il difficile.<br />
Umori folk rubati alla Calabria<br />
terra d’origine ma anche analogie<br />
con i Love (Ballata), piani elettrici<br />
jazzati (Evviva evviva la società)<br />
e dialetto (Terra d’acqua e focu),<br />
Kurt Weill, (L’oste di sorte) e omaggi<br />
nemmeno troppo velati al Fabrizio<br />
De André delle collaborazioni con<br />
Massimo Bubola (Circuito assente).<br />
Maria Teresa Lonetti sintetizza nel<br />
suo disco d’esordio La grande danza<br />
(6.5/10, Sciopero Records) un immaginario<br />
regionale e istituzionale<br />
al tempo stesso. Terreno di confine<br />
tra quella canzone d’autore ai limiti<br />
della world music che dal già citato<br />
cantautore di Genova in poi detta<br />
legge e un background esperienziale<br />
eclettico vicino a pop e fusion.<br />
Fuori dai soliti schemi, insomma, e<br />
con un debito di riconoscenza verso<br />
gli Yo Yo Mundi rimarcato dalla<br />
cover de La danza dei pesci spada.<br />
Al solito spigolosi i Retrolover,<br />
tanto più nel loro nuovo Ep Ma<br />
voi siete moderni (6.6/10, autoprodotto).<br />
Il disco esce a due anni dal<br />
Retrolover omonimo già recensito<br />
su queste pagine e aggiusta il tiro<br />
verso una wave ai confini col noise<br />
(Ricordati) che ci pare più compatta<br />
rispetto al passato. Chitarre serrate,<br />
batterie minacciose, ma anche la capacità<br />
di elaborare geometrie strutturate<br />
e in qualche maniera inusuali.<br />
Come accade nella strumentale<br />
Enzo o magari in una Oh! che parte<br />
post-rock per poi incrociare synth,<br />
rigurgiti hard-core e stratificazioni<br />
strumentali.<br />
Artefatto, liquido e alternativo<br />
a qualsiasi contesto, questo Demo<br />
(autoprodotto, 6.3/10) d’esordio<br />
firmato Fiori di plastica è un seducente<br />
invito ad immergersi in quella<br />
musica che difficilmente potrete<br />
ascoltare in compagnia. Ci siete<br />
soltanto voi, Arlecchini nostrani immersi<br />
nel guazzabuglio alchemico<br />
dei giorni nostri. Voi e quelle gocce<br />
che scorrono tra tintinii di monete,<br />
un omaggio a Brian Eno e un’occhiata<br />
alla new wave. Qui è tutto<br />
un videogioco e voi per il momento<br />
state vincendo, ma occhio al mostro<br />
finale (e a dei cantati inascoltabili).<br />
Malgrado un accattivante package<br />
biologico - composto da due<br />
tavolette di legno rilegate con un<br />
filo di lana e coperte da una foglia<br />
a identificare la copertina – il nuovo<br />
EP Sleepy River (autoprodotto,<br />
6.1/10) che segue di tre anni il debutto<br />
del palermitano Claudio Cataldi,<br />
è un’escursione tra diversi lidi<br />
musicali – indie pop, acid folk, shoegaze<br />
- affrontati ora con sguardo<br />
maturo e talvolta poetico (Windmill,<br />
Inside My Car) ora con tentazioni<br />
sperimentali ancora piuttosto vaghe<br />
e indefinite (Sleepy River, Home).<br />
Urge un lavoro più composito – e di<br />
maggiore durata – per un giudizio<br />
più ampio e completo.<br />
Disimpegno a go go quello dei<br />
Chocolate Collective. Non sai bene<br />
quanto professato o rappresentato,<br />
fatto sta che il loro EP di debutto Tonite?<br />
(autoprodotto, 6.8/10) è tutto<br />
uno sgranchire le articolazioni all’insegna<br />
d’un electro-funk ora turgido<br />
e minimale (Broda&Sista, Revolution),<br />
poi smerigliato da un gioioso<br />
afflato pop-soul (Understand, RBN).<br />
Una leggerezza disinvolta che convince,<br />
tanto quanto stupisce questo<br />
strabismo estetico (poniamo tra il<br />
dance floor digrignato dei Rapture<br />
e certi miraggi estatici Flaming<br />
Lips) di cui al momento non s’intravede<br />
la sintesi. Non contenti, i<br />
quattro bresciani ci propongono<br />
in chiusura di scaletta la versione<br />
acustica di Revolution, come a dire<br />
c’è un’anima folk-blues dietro ogni<br />
cazzone elettronico. E quindi? Comunque<br />
sia, buone, buonissime<br />
potenzialità.<br />
nino Ciglio, StEFano SolVEnti,<br />
Fabrizio zampighi, Fabrizio gElmini,<br />
gianluCa lambiaSE<br />
124 125
R e a r v i e w M i r r o r<br />
— s p e c i a l e la mano del diavolo<br />
Forse perché in posizione minoritaria (non più del 10%<br />
della popolazione usa la mano sinistra) sono sempre stati<br />
considerati “altri”, e perciò temuti e messi ai margini. Di<br />
certo c’è che i mancini sono sempre stati storicamente<br />
considerati “diversi” e la storia è piena di pregiudizi, credenze<br />
e proibizioni relative all’uso della mano sinistra.<br />
La cosiddetta “mano del diavolo” era in passato quella<br />
associata agli “invertiti”, ai “rovesciati”, ad una devianza<br />
dagli schemi antropologici prestabiliti. A pensarci bene,<br />
anche l’etimo stesso del termine rimanda ad aspetti negativi,<br />
siano essi gli aspetti avversi o sfavorevoli, o come<br />
Starfuckers<br />
Sinistri per forza di cose...<br />
Una delle formazioni più ostiche e coraggiose della sperimentazione “rock” italiana<br />
torna con la ristampa del primo, lontano esordio. Ripercorriamone la storia<br />
con Manuele Giannini e Alessandro Bocci.<br />
Testo: Stefano Pifferi<br />
sinonimo di incidente, disastro, sciagura. In tempi recenti,<br />
però, i mancini hanno avuto la loro rivincita venendo<br />
rivalutati in maniera positiva come creativi e originali.<br />
Diversi, ma accettati.<br />
Non è pertanto un caso che sia proprio “sinistri” il termine<br />
che spesso e volentieri ha toccato trasversalmente<br />
la storia degli Starfuckers. Dal titolo del loro album del<br />
1994 che li consacrò come i più avanguardistici ricercatori<br />
sonori larvatamente rock presenti sul territorio italiano,<br />
fino alla decisione di ribattezzarsi definitivamente<br />
come Sinistri, con la maiuscola questa volta, avvenuta<br />
un decennio più tardi, quando l’ingresso in formazione<br />
del compianto Dino Bramanti ne spostava ancor di più i<br />
labili confini sonori verso l’elettronica di ricerca e la musica<br />
concreta…<br />
Una parentesi, quella a nome Sinistri, tra le tantissime<br />
che si sono sempre aperte e chiuse nella storia della<br />
band italiana, con un procedimento per sottrazione che,<br />
invece che impoverire ha arricchito lo spessore artistico<br />
e concettuale della parabola Starfuckers.<br />
Di queste ellissi è costellato un percorso discografico<br />
caratterizzato da un sentire musicale “altro” rispetto a<br />
canoni e definizioni comuni. Spazi (deformati e destrutturati)<br />
che sembrano chiudersi ma che si legano alle<br />
riaperture successive: il rock che vira verso la sperimentazione,<br />
la sperimentazione che muove verso la ricerca,<br />
la ricerca che si sposta verso la non-musica e il silenzio<br />
concettuale. Il tutto in maniera sempre coerente e coesa,<br />
apparentemente senza strappi, come se si potesse<br />
idealmente tirare un filo lungo tutta una discografia e<br />
scioglierla come farebbe un prestigiatore dopo averla<br />
annodata ritrovandosi tra le mani un percorso lineare<br />
ed unico.<br />
Ardore e irrequietezza nella ricerca sonora sono, insomma,<br />
le peculiarità del nucleo principale del progetto.<br />
Ma anche lucidità di intenti e programmatica ideologia<br />
vogliono la loro parte. Manuele Giannini (chitarre), Roberto<br />
Bertacchini (batteria) e Alessandro Bocci (elettro-<br />
126 127
niche varie), amici d’infanzia, cresciuti insieme non solo<br />
musicalmente condividono l’esperienza Starfuckers praticamente<br />
da sempre. Fin da quel Sinistri che rappresenta<br />
il lavoro che per la prima volta mise in luce l’ampio spettro<br />
sonoro e la caleidoscopica tavolozza di colori – via via<br />
sempre più evanescenti verso un b/n spettrale e sfocato<br />
– a cui gli Starfuckers potevano far ricorso.<br />
Prima però, c’erano ragazzi che, diversamente da Morandi,<br />
non amavano i Beatles, quanto Rolling Stones e<br />
Stooges. Dai primi trassero l’ispirazione per il nome della<br />
band (notevole l’aneddoto del pezzo di Goat’s Head Soup<br />
intitolato alle groupies, chiamate appunto “starfuckers”,<br />
e poi rifiutato dalla casa discografica in cambio di un più<br />
consono Star Star); dai secondi l’impostazione ruvida e<br />
riduzionista dell’approccio al rock. Era la preistoria del<br />
rock italiano. Giornalisti musicali che facevano i talentscout.<br />
Ragazzi di provincia intrisi di miti anglosassoni<br />
che armeggiavano con ampli e distorsori. Il rock alla<br />
sua misura primordiale: ribellione post-adolescenziale<br />
e possibile via di fuga. Metallic Disease, la cui ristampa<br />
per Holy Mountain è di pubblicazione proprio in questi<br />
giorni, uscì per Electric Eye, l’etichetta di Claudio Sorge<br />
nel 1990 e mostrava una band classica nella formazione<br />
quanto nel suono, ascrivibile al garage-rock revival del<br />
tempo e ben presente nel catalogo della label (Sick Rose,<br />
Steeplejack, Not Moving, Ugly Things tra gli altri).<br />
Il quintetto base era formato da Paolo Casini (basso),<br />
Gianfranco Verdaschi, Gianni Ginesi (chitarre), Giannini<br />
(voce) e Bertacchini (batteria), con l’ospite occasionale<br />
Paolo Vasoli al sax. In questa sua primigenia incarnazione<br />
la band registrò sia le 10 tracce dell’esordio, comprese<br />
alcune outtakes finite in compilation, sia il mini-lp Brodo<br />
Di Cagne Strategico, rilasciato sempre dalla Electric Eye in<br />
combutta con la etichette/distribuzione romana Helter<br />
Skelter l’anno successivo.<br />
iT’s onlY roCk’n’roll. ovvero, mai<br />
Fidarsi delle apparenze<br />
Metallic Disease è un album che poco sembra avere a<br />
che fare con gli Starfuckers che conosciamo, quanto con<br />
un qualsiasi gruppo di giovani alle prese col rock’n’roll<br />
“classico” di marca Stooges/Rolling Stones innervato da<br />
puntate Velvet, MC5, 13th Floor Elevators e Suicide. Dieci<br />
pezzi registrati in soli 3 giorni dopo la buona accoglienza<br />
di un primo demo in cassetta, immolati al re iguana e<br />
al marcio del rock’n’roll tutto e, udite! udite!, cantati in<br />
inglese perché “l’italiano non era lingua da rock”. Quando<br />
abbiamo fatto questo disco e sostenevo che bisognava<br />
smettere di cantare in inglese – affermava Giannini in una<br />
datata intervista – i vari Umberto Palazzo o altri dicevano<br />
che il cantato in italiano non si confaceva al rock. Adesso<br />
invece Umberto riconosce che avevo ragione. Proprio quel<br />
Palazzo che fu uno dei fondatori del gruppo che meglio<br />
di tutti seppe offrire la nuova via all’italiano nel rock, i<br />
Massimo Volume.<br />
Il bluesaccio rock sporco e malefico con un Giannini<br />
frontman iggypoppiano (Dead Metal City Blues), una<br />
U.S.A. da incrocio tra Stooges e Suicide, il garage irrefrenabile<br />
di Love You sono la dimostrazione della fase<br />
zero del quintetto. Quella ingenuamente e crudamente<br />
rock’n’roll.<br />
Già dal cuore di alcuni pezzi dell’esordio, però – la<br />
Cold White Cancer poi ripresa in forme “altre” e italianizzata<br />
nel titolo e nei testi (Freddo Cancro Bianco) nel minilp<br />
seguente, gli inserti di sax deformatamene stoogesiani<br />
e aperti al free – e dalle limitrofe outtakes registrate<br />
grossomodo con la stessa formazione, si può notare lo<br />
spirito avventuriero e libero della formazione toscoemiliana<br />
così come la volontà di esondare dai confini<br />
troppi stretti dei generi codificati. Da un lato la rude e<br />
ferrea matrice anarchica e l’aspra natura semi-selvaggia<br />
e non antropizzata delle terre d’origine (la Lunigiana,<br />
Massa); dall’altro la creatività borderless della adottiva<br />
Bologna e il costante piattume del paesaggio. Tra questi<br />
dicotomici paesaggi sembrano muoversi le pulsioni che<br />
portano all’omaggio ai Sonic Youth di Death Valley ’69,<br />
uscito nella compila Gioventù Sonica della solita Electric<br />
Eye nel 1990; alla “superdose di paranoia sonora” di<br />
Grado Zero uscita nel 1992 per il n.7 di Punto Zero, il foglio/compilation<br />
della storica Toast; alla programmatica<br />
Strategie Operative/Saturazione pt. 2 in Bloom Live Vol. 1<br />
dello stesso anno; alla robotica e malata ossessività della<br />
Mechanical Man del 10” picture Comin’ Down Fast, tributo<br />
mansoniano edito dalla Helter Skelter nel 1993; finanche<br />
alla tarda rendition della beatlesiana Dear Prudence affidata<br />
al n. 11 della rivista americana Bananafish nel 1996<br />
ma in realtà registrata un quinquennio prima.<br />
Il passo è dunque breve, ma la distanza infinita. Tra il<br />
luglio ’89 delle registrazioni di Metallic Disease e il marzo<br />
’91 del mini, l’allegro quintetto pone le basi per un<br />
cambiamento radicale. Di suoni, atteggiamento e prospettive.<br />
Brodo Di Cagne Strategico è il nuovo che avanza sotto<br />
le mentite spoglie del vecchio. Un mini. Pochi minuti.<br />
Una manciata di canzoni. Dense però di idee e elaborazioni<br />
in divenire che vedranno la luce in forma compiuta<br />
di lì a poco. L’omaggio intrinseco al Miles Davis elettrico<br />
e rivoluzionario del titolo con l’aggiunta di una volontà<br />
strategica comprensibile solo a posteriori la dice lunga<br />
sul valore illuminante del mini-lp. La scelta dell’italiano,<br />
innanzitutto. Mossa strategica che, come detto, pone<br />
fine, o meglio inizio, alla questione della lingua nel rock<br />
italiano aprendo la strada a Massimo Volume et similia<br />
(vedi alla voce Acre Stil Post). Non è casuale che Giannini<br />
abbia per un periodo diviso l’appartamento bolognese<br />
con Emidio Clementi e che nelle foto promozionali<br />
del primo demo del quartetto bolognese quest’ultimo si<br />
facesse ritrarre con una t-shirt degli Starfuckers.<br />
Voce declamata, testi da cut-up insurrezionale, suoni<br />
in totale libertà. (Quasi)anthem come “alza il volume, scegli<br />
il rumore” (Saturazione Parte II) o “la legge è potente<br />
perché le obbedisci” (Calma Piatta) fanno il paio con un<br />
approccio musicale che è, se non rivoluzionario, per lo<br />
meno liberatorio. Schegge di Stooges si mischiano a<br />
slanci free Ayleriani o di matrice Coltrane; l’iconoclastia<br />
no-wave all’impro radicale (Conseguenze); l’ala protettiva<br />
dei Sonic Youth più rudi a benedire dall’alto (l’opener<br />
Saturazione) sposta pesantemente l’asse compositivo<br />
degli Starfuckers ampliandone gli orizzonti e slegando<br />
i legacci culturali.<br />
La radicalità del progetto miete però le prime vittime.<br />
Mano a mano, i componenti della band cominciano a<br />
defilarsi (Verdaschi e Casini, quest’utimo prematuramente<br />
scomparso nel 1994) mentre acquisisce sempre più<br />
interesse in seno alla band (Bocci è lì lì per entrare in<br />
formazione in pianta stabile) l’allontanamento da forme<br />
musicali note e statiche e l’esplosione di una intera galassia<br />
sonora, fino ad allora estranea al panorama “rock”.<br />
sCegli il rUmore! (e lasCialo da<br />
parTe…)<br />
L’anno 1994 d.C. è quello dello stravolgimento più evidente.<br />
Cambia la formazione (Bocci è stabilmente in<br />
formazione, ormai quartetto). Cambiano le prospettive<br />
(si declama in italiano, si abbandona il rock in senso classico).<br />
Si allargano gli orizzonti.<br />
Sinistri esplode con un rumore di ferraglie che tira in ballo<br />
tutto il Novecento musicale colto: dodecafonia, serialità,<br />
minimalismo, musica aleatoria, concreta, elettroacustica<br />
finendo con l’essere (parole di Manuele Giannini stesso<br />
in una datata intervista ad Etero Genio) “un riassunto del<br />
Novecento musicale […] non composto con una ‘metodologia<br />
rock’”.<br />
Terminate le prime due fasi in cui gli Starfuckers stessi<br />
suddividono cronologicamente e ideologicamente la<br />
propria esperienza sonora (per esteso, 1987-1990 The<br />
Proto-Punk Period, ’91-’92 Early Experimentation) inizia quella<br />
della Disintegration Of Standard (’93-’96). A seguire le altre<br />
fasi saranno le due parti della Nonmetric Solution: la prima,<br />
Concrete Rock and Roll, compresa nel biennio ’97-’99<br />
(Infrantumi) e la seconda, Black Roots, tra 2000 e 2003 (Infinitive<br />
Sessions), a chiudere un cerchio esplorativo nelle<br />
lande ancestrali delle musiche rock e blues.<br />
Non vezzi da artistoidi in disarmo, quanto la tangibi-<br />
128 129
le manifestazione di una lungimiranza e di una lucidità<br />
di intenti d’ampio respiro: ideologica e filosofica, prima<br />
ancora che esclusivamente musicale e, come tale, con<br />
pochi eguali.<br />
Sinistri vede la luce nel 1994, numero 2 del catalogo<br />
di un negozio di dischi bolognese riciclatosi in label:<br />
l’Underground Records fu l’artefice anche dell’esordio<br />
dei Massimo Volume, Stanze, non casualmente prodotto<br />
proprio da Manuele Giannini. Un album di rottura, senza<br />
indugi. Con pochi, lontani antecedenti (i pluricitati Area)<br />
e quasi nessun epigono successivo.<br />
L’unico pezzo larvatamente rock del lotto è Ordine<br />
Pubblico, rimando ellittico alla già citata Saturazione per<br />
impatto heavy e iconoclastia manifesta, mentre ad aleggiare<br />
sul tutto è la scelta di tecniche aliene al rock, con<br />
padri putativi come Stockhausen, Xenakis, LaMonte<br />
Young e il “padre del silenzio” John Cage. Così tra slanci<br />
da contemporanea aleatoria (Zentropia), brevi sketches<br />
d’impro (In Primo Luogo), vuoti sospesi e sospensioni jazzate<br />
(Mutilati), gli Starfuckers mettono a segno il proprio<br />
capolavoro, inspiegabile a parole. Questo disco è noioso.<br />
questo disco fa schifo, questo disco è sbagliato, dicono in apertura.<br />
La storia ha voluto e dimostrato il contrario.<br />
THe sHape oF silenCe To Come<br />
L’utilizzo strategico del silenzio ci ha permesso di superare<br />
quei tabù che riteniamo assolutamente nocivi a quello che<br />
noi consideriamo musica (dalle note su Infrantumi scritte<br />
da Manuele Giannini).<br />
L’era del silenzio istituzionalizzato – do you remember<br />
tutte le menate del “silence is the new loud”? – trova<br />
negli Starfuckers gli sperimentatori più radicali e gli avventurieri<br />
più spinti.<br />
Reticolati di segni e significati che si stravolgono senza<br />
che apparentemente i musicisti possano (e vogliano)<br />
avere voce in capitolo, in totale balia di ciò che sgorga<br />
autonomo dai propri strumenti: Infrantumi abbandona<br />
sin dall’inizio l’idea di composizione, il musicista non è colui<br />
che crea, decide e coordina una struttura musicale (noi rifiutiamo<br />
il concetto di musica come struttura), egli si limita ad<br />
innescare dei meccanismi per cui la musica possa comporsi<br />
da sé (musica come processo). Perché ciò sia consentito il<br />
musicista deve necessariamente farsi da parte e limitare<br />
al massimo ogni sorta d’intenzione (distruzione dell’io vs<br />
autorappresentazione); solo il silenzio è privo d’intenzione<br />
(imparare a tacere). (dalle Note d’accompagnamento).<br />
È un mondo sonoro etimologicamente Infrantumi<br />
quello attivato nella terza fase dall’ormai stabilizzato<br />
terzetto della Lunigiana. Imploso e frantumato in un<br />
insieme di schegge di suoni avant, singulti ritmici,<br />
abrasioni free-jazz che predilige il non-detto rispetto al<br />
detto. Che si nutre delle pause e del silenzio, oltre che<br />
dell’asincronia ritmica, per (de)costruire una idea musicale<br />
atavica eppure ormai perduta nel mare magnum<br />
della sovrastruttura. La fase della Nonmetric Solution si<br />
articola in due parti. La prima, spiazzante come al solito,<br />
riprende il discorso del silenzio e lo amplifica. Lo dilata,<br />
lo spezza, lo accelera, manco fosse il Cern di Ginevra alla<br />
ricerca della particella di Dio. Il risultato è una implosione<br />
del suono, un ripiegamento su se stesso, un accartocciamento<br />
in cui gli strumenti (chitarra su tutti) sembrano<br />
rattrappiti (Distribuisce Pastiglie o lo stop&go epilettico di<br />
Colei Con Cui), dissolti in una nebulosa apparentemente<br />
inintelligibile, nonostante intorno al terzetto ruotino numerosi<br />
musicisti “rock”, inclusi i Massimo Volume in toto.<br />
Il cuore di Infrantumi è l’annientamento della volontà<br />
creatrice, la sua totale spersonalizzazione attuata mediante<br />
ciò che è massimamente privo d’intenzione: il<br />
silenzio. Lo scarto con Sinistri risiede lì, nel principio generatore<br />
del silenzio e del vuoto. Nella funzione violenta<br />
e disgregatrice che silenzio, vuoto, pausa, frammentazione,<br />
asincronia possono assumere. In poche parole, il<br />
Concrete Rock and Roll.<br />
Con questo disco noi intendiamo: superare il tabù della<br />
musica come struttura per elaborarla come processo; superare<br />
il tabù della sincronia; superare il tabù dell’intonazione;<br />
liberarci dal nostro proprio io (musicale). Superare<br />
quindi non ogni limite, ma l’idea stessa di limite…(dalle<br />
Note).<br />
mUsiC is a pollUTion oF Time. ossia,<br />
l’eTerno soUndCHeCk.<br />
La leggenda narra che sia stata addirittura Lydia Lunch<br />
a coniare il termine, assistendo ad un live degli Starfuckers.<br />
Sia come sia, la definizione del famoso concerto<br />
del 1999 al Link di Bologna (sei ore ininterrotte di concerto<br />
con visuals) è applicabile anche a Infinitive Sessions,<br />
di cui guarda caso Eternal Soundcheck è parte integrante.<br />
Segnando cioè la fine di una fase (quella culminata nel<br />
disco precedente) e l’apertura di una nuova, interessata<br />
alle musiche nere, attenta alla ricerca delle (e sulle) ancestrali<br />
origini del rock.<br />
Dietro la definizione Black Roots si celano il funk, Hendrix,<br />
il jazz elettrico, il blues, James Brown, l’onnipresente<br />
Miles Davis ma, sottoposti al trattamento post-Infrantumi<br />
divengono una personale via alla (re)interpretazione<br />
dei canoni basata sulla tessitura sonora “per sottrazione”.<br />
La formazione si è ormai da tempo stabilizzata in trio.<br />
Infinitive Sessions è però il primo vero lavoro sul quale<br />
i tre lavorano senza ospiti o supporti esterni. Anche la<br />
voce è bandita. Un disco in cui la copertina nera, dopo le<br />
due bianche dei precedenti, non collima col senso del disco,<br />
ma rimanda alla matrice dei suoni in esso contenuti.<br />
Una mega-jam iniziale (Off-On-Off) fratturata in 3 canzoni<br />
(Blues Off, Drive On, Off Blues) su cui aleggia lo spirito<br />
benevolo del Davis elettrico virato i singulti di Arto<br />
Lindsay. Un corpo centrale, quell’Eternal Soundcheck doveroso<br />
tributo alla fase intermedia culminata nel live al<br />
Link, in cui prende corpo una psichedelia spettrale, fatta<br />
di flash in b/n, spezzone dopo spezzone a passo 1. A<br />
chiudere, la doppietta XX: Funked X e Vamped X, omaggi<br />
al re del funk James Brown e a se stessi: un power-trio<br />
che suona funk asincrono, scomponibile come fosse un<br />
gioco per bambini.<br />
Sottrazione di suoni al rumore, piuttosto che somma<br />
di suoni al silenzio, affermeranno i tre in seguito, riassumendo<br />
una delle possibili interpretazioni di un prisma<br />
sonoro.<br />
sinisTri, di nUovo. l’Universo<br />
sTarFUCkers in disgregazione (o in<br />
ripresa)<br />
Il presente non esiste. Per lo meno a nome Starfuckers. O<br />
forse sì. Progetto in stallo, in una di quelle pause miste a<br />
silenzi su cui l’epopea Starfuckers si è modellata prima,<br />
forgiata poi. E sarebbe strano pensare in termini di tempo<br />
lineare per un progetto che dell’incontro/scontro col<br />
tempo e sul tempo ha fatto un punto di forza.<br />
A prendere il sopravvento, dal 2004, è Sinistri, nuova<br />
ragione sociale per un nuovo cambio di formazione e di<br />
sostanza. Entra Dino Bramanti, apprezzato sound-artist<br />
prematuramente scomparso, che con le sue tecniche di<br />
rielaborazione del suono in tempo reale, sposta l’asse<br />
dalla chitarra/batteria a quello delle elettroniche. Se<br />
ne notano i frutti nell’unico album rilasciato, Free Pulse<br />
(Hapna, 2005), elaborato in base ai precetti della Nonmetric<br />
Music e del manifesto ideologico che guida l’ormai<br />
quartetto non solo nelle esplorazioni elettroniche/strumentali<br />
dell’album, ma anche in una definizione teorica<br />
del proprio procedere artistico/filosofico.<br />
Di lì in poi, la frantumazione sonora ricercata da un<br />
decennio abbondante sembra materializzarsi in una discografia<br />
aliena al formato-album, sparpagliata tra mp3,<br />
net-label, cd-r, sonorizzazioni e commistioni extra-musicali<br />
(Mattino, reading di presentazione del libro Mattino<br />
di turbinio d’agonia con bautte in seta di Cina, di Gian<br />
Paolo Guerini) con ultima manifestazione tangibile lo<br />
split 10” con gli OvO, volume 3 della Phonometak Series<br />
dei validi Mirko Wallace Spino e Xabier Iriondo.<br />
L’apparizione prima della ristampa Ordine ’91-’96, la<br />
riproposizione, in live sempre meno sporadici, del per-<br />
130 131
corso musicale dei 3 (vedi il live a Bologna dello scorso<br />
anno, disponibile in 5 parti sul tubo), ora la ristampa del<br />
primo vagito della band, ci fanno notare come, nonostante<br />
ognuno porti avanti una propria carriera “solista”<br />
(M16 per Bocci, Weight And Treble per Giannini, Shipwreck<br />
Bag Show per Bertacchini), l’epopea Starfuckers è<br />
lontana dal morire. Alla faccia del tempo, grande scultore<br />
e amico d’infanzia.<br />
inTervisTa a manUele giannini e<br />
alessandro BoCCi<br />
Due ristampe e qualche sporadico live nell’ultimo<br />
anno. È il caso di dire bentornati?<br />
(Manuele) Mah, più o meno, anche se per il momento<br />
non abbiamo progetti concreti, siamo lì, indolenti e sospesi,<br />
in attesa di qualcosa che magari non verrà mai...<br />
ognuno di noi è più impegnato con i rispettivi nuovi<br />
progetti: Weight And Treble, M16 e Shipwreck Bag Show.<br />
Il segno tangibile degli Starfuckers ’00 è affidato ai<br />
primi passi: Brodo Di Cagne Strategico e Metallic Disease.<br />
Sarebbe interessante sapere cosa scattò in voi tra il<br />
primo e il secondo album…<br />
(M) Decidemmo di formare un gruppo e suonare punk<br />
rock per la nostra devozione assoluta agli Stooges e gli<br />
Stooges sono sì i pionieri del punk, ma i loro primi due LP<br />
contengono i germi dell’avanguardia, dal minimalismo<br />
al free jazz, è andando in quelle direzioni che ci siamo<br />
evoluti (in senso darwinista ovviamente).<br />
Come ricordi questo primo vagito discografico? Oggi<br />
a ristamparlo è una etichetta quotata come la Holy<br />
Mountain, ma decisamente aliena al panorama sonoro<br />
degli Starfuckers/Sinistri…<br />
(M) Non siamo mai stati famosi, in vent’anni non abbiamo<br />
mai avuto un picco di notorietà e siamo sempre stati<br />
scarsi imprenditori di noi stessi e soprattutto totalmente<br />
incapaci di fare i paraculi, ma abbiamo sempre trovato<br />
qualcuno che ci producesse i dischi, che hanno sempre<br />
venduto poco, ma a livello internazionale e con continuità,<br />
anche a molti anni di distanza dall’uscita.<br />
E poi siamo sempre stati amati e stimati da musicisti<br />
stranieri famosi, molti di loro comprano i nostri dischi<br />
e apprezzano la nostra musica, alcuni la copiano anche<br />
(vedi i Matmos che ci hanno pesantemente campionato<br />
su The Civil War senza nemmeno segnalarlo nei credits),<br />
per cui va da sé che di noi probabilmente se ne continui<br />
a parlare e che, a qualche discografico, magari venga<br />
l’insana idea di ristamparci.<br />
Con Metallic Disease torniamo alla preistoria. Bologna,<br />
primi anni ’90. Chi c’era, lo sa, ma molti dei nostri<br />
giovani lettori magari non sanno che, nell’humus che<br />
portò al fiorire della Bologna mecca del rock italiano<br />
(vedi alla voce Massimo Volume), c’eravate voi.<br />
(M) Non ricordo molto, erano anni burrascosi, ma a Bologna<br />
era di moda soprattutto l’Hardcore e l’Hip hop,<br />
nel resto d’Italia c’era stata una scena Garage ormai in<br />
declino. Noi non ci sentivamo di appartenere a niente,<br />
tutto correva veloce e se nell’’89 suonavamo cover degli<br />
Stooges, nel ’92 già facevamo concerti in cui l’improvvisazione<br />
radicale e le pratiche vicine alla musica aleatoria<br />
e elettroacustica erano la norma … e intanto era arrivata<br />
la Techno.<br />
Com’era la Bologna di quei tempi? Voi avete circuitato<br />
l’ala rock e quella sperimentale, partendo dalla<br />
prima e smarcandovi decisamente verso territori altri<br />
nel breve volgere di qualche anno.<br />
(M) Non esisteva una scena sperimentale (né a Bologna<br />
né altrove in Italia), per lo meno non legata al rock. E in<br />
un certo modo non esisteva nemmeno una scena rock<br />
italiana che non fosse puramente derivativa. Brodo di Cagne<br />
Strategico è un disco seminale in questi due sensi, da<br />
un lato anticipa il rock italiano “emancipato” e dall’altro<br />
quello sperimentale.<br />
Il famoso concerto da sei ore al Link di Bologna<br />
nell’aprile del 1999, quello battezzato Eternal<br />
Soundcheck è ancora vivo nella memoria di chi vi<br />
partecipò…si chiudeva una fase (Infrantumi), se ne<br />
apriva un’altra (Infinitive Sessions)…tutto qui o c’era<br />
qualcos’altro?<br />
(Alessandro) Il concerto delle 6 ore al Link è stato un<br />
esperimento con più finalità volte tutte alla ricerca<br />
dell’estremo. Allo stesso tempo questo progetto doveva<br />
prendere forma e svilupparsi.Tutte le registrazioni dovevano<br />
essere editate per poi essere raccolte in un doppio<br />
cd per l’etichetta americana Drunken Fish, purtroppo<br />
per problemi tecnici derivati dalla registrazione il progetto<br />
non andò in porto. I nastri delle sessions erano<br />
parzialmente inutilizzabili e tutto quanto è rimasto in<br />
un cassetto. Ancora oggi rimane sempre l’intenzione di<br />
ripubblicarlo in una nuova veste con un editaggio e un<br />
mastering accurato<br />
(M) Suonare ininterrottamente per quasi sei ore, dopo<br />
essere saliti sul palco senza aver alcuna idea di quello<br />
che sarebbe successo, lasciandosi andare completamente<br />
per permettere che la musica divenisse, minuto dopo<br />
minuto, il più possibile, solo se stessa, fu un’esperienza<br />
molto interessante e appagante, e come dici tu, forse<br />
chiuse definitivamente la fase Infrantumi.<br />
Le vostre musiche sono state sempre ben accolte da<br />
critica, pubblico (d’elite) e colleghi; nonostante ciò<br />
siete rimasti sempre una mosca bianca nel panorama<br />
italiano, se non mondiale. In senso positivo, ovvio.<br />
Come avete vissuto questa vostra dimensione?<br />
(M) … frustrazione?!? Non so, mi sarebbe piaciuto vendere<br />
qualche disco in più, non mi è mai interessato rivolgermi<br />
ad un pubblico di nicchia, non ho mai voluto<br />
chiudermi in un ghetto, non ho mai creduto che rivolgersi<br />
a pochi fosse più fico che rivolgersi alle masse, ma<br />
quella era l’unica musica che potevamo fare.<br />
… e poi siamo sempre stati irriducibili, per cui, senza<br />
scendere a compromessi, non abbiamo potuto fare della<br />
nostra musica una vera e propria professione, questo<br />
fatto ci ha, da un lato, resi più liberi, dall’altro ha accresciuto<br />
la nostra inerzia.<br />
(A) Diciamo che le tue affermazioni sono in parte corrette<br />
e diciamo così in parte non propriamente esatte.<br />
Nel panorama italiano siamo stati emulati e presi come<br />
punto di riferimento da moltissimi artisti, sicuramente<br />
alcuni di questi sono diventati “più famosi” ed hanno<br />
avuto più visibilità più riscontro di pubblico.<br />
Nel panorama mondiale abbiamo avuto le nostre soddisfazioni;<br />
con infrantumi siamo stati primi nelle classifiche<br />
delle radio universitarie americane, tutta la nostra discografia<br />
è sempre state recensita sulle principali riviste<br />
musicale americane ed europee, tra le altre cose che mi<br />
vengono in mente... un duo molto quotato che viene da<br />
San Francisco (due onesti personaggi!!!) ha campionato<br />
e derubato alcuni frammenti da Infinitive Sessions<br />
senza neppure menzionarci nei credits. Beh sono delle<br />
soddisfazioni, non credi?<br />
Ad oggi i nostri dischi li puoi trovare sia in Europa che<br />
negli States e in Giappone. Un disco come Sinistri è stato<br />
ristampato tre volte, Infrantumi ha avuto una stampa<br />
europea e una americana lo stesso vale per Metallic Disease.<br />
Sicuramente siamo stati considerati sempre un<br />
gruppo di culto con un seguito di pubblico proporzionale<br />
alla nostra visione della musica, sinceramente non<br />
abbiamo mai vissuto una dimensione, forse sarebbe<br />
interessante vivere in un’altra dimensione.<br />
L’era Sinistri iniziò in maniera programmatica col manifesto<br />
in cui rivendicavate una posizione ideologica<br />
piuttosto, o prima, che musicale…Ideologia o musica,<br />
se doveste scegliere?<br />
(A) L’era Sinistri ha generato una mutazione che si è<br />
espressa attraverso un idea una filosofia e un approccio<br />
musicale<br />
(M) Le posizioni ideologiche servivano per dare una chiave<br />
di lettura ad una musica che poteva risultare, soprattutto<br />
ai tempi, un po’ ostica. In ogni caso né musica, né<br />
ideologia, solo rock and roll.<br />
E musica o silenzio? Tempo o suono? O giocando col<br />
nostro nome, sentire o ascoltare?<br />
(A) Queste domande mi piacciono !!! Suono e spazio,<br />
ritmo e timbro, diciamo spazializzare<br />
(M) Credo che la musica abbia a che fare più con il tempo<br />
che con il suono. Cosa sia il tempo però, non lo sa<br />
nessuno…<br />
132 133
CAMPI MAGNETICI #6<br />
Matia Bazar Pere Ubu<br />
tango (Emi, marzo 1983)<br />
Anni di piombo, creste selvagge e tossicità, i Settanta:<br />
i Matia Bazar - band fondata a Genova nel ‘75 sulle<br />
ceneri dei soft-prog Jet - invece a pasturare l’auditorio<br />
del belcanto, sfornando un hit dietro l’altro, da Stasera...<br />
che sera! a C’è tutto un mondo intorno, da Cavallo bianco<br />
a Solo tu, concedendosi persino la vittoria a Sanremo<br />
con la sdolcinatamente epica ...E dirsi ciao. Artefice<br />
principale quel Piero Cassano dal fiuto sensibilissimo<br />
per le melodie sbranaclassifiche. Il cui abbandono nel<br />
1981 coinciderà con l’ingresso in formazione di Mauro<br />
Sabbione, quindi di un rinnovato ordine di riferimenti,<br />
intenzioni e idee. Vedete un po’ voi: Cassano diverrà la<br />
penna dietro al fenomeno Eros Ramazzotti, per il quale<br />
comporrà i principali successi, mentre Sabbione si presenta<br />
dichiarando di ispirarsi a Kraftwerk, Ultravox e<br />
Joy Division tra gli altri.<br />
Questo dovrebbe spiegare più o meno tutto ciò che accadde<br />
di lì a poco. Ma c’è una continuità nella frattura.<br />
La svolta new wave di Berlino, Parigi, Londra (1982)<br />
cambia sì scenografie, ambiti, obiettivi, tuttavia resta la<br />
stessa progettualità di fondo: confezionare un pop di<br />
pura evasione che non rinunci al fascino della complessità,<br />
percorrere il riflusso culturale dei tardi Settanta/primi<br />
Ottanta col più arguto dei disimpegni, lasciando che<br />
nello stanzino del melodismo italiano spirassero brezze<br />
arty, avanguardie robotiche e rigurgiti d’ogni epoca e<br />
latitudine. Tango è in questo senso il loro capolavoro<br />
e un capolavoro del pop italiano di ogni tempo. E non<br />
avrebbe potuto esserlo senza la sua verifica nazionalpopolare.<br />
Intendo, ovviamente, Sanremo. Quello dell’83, vinto per<br />
intendersi da Tiziana “quarto d’ora di celebrità warholiana”<br />
Rivale. I cinque Matia Bazar si presentarono sul<br />
palco dell’Ariston come alieni azzimati sul ponte di una<br />
crociera post-moderna, come nostalgici ciber-manichini<br />
in fuga da un patinato altroquando di telefoni bianchi<br />
e daiquiri letterari, mossi da un’eleganza algida e sincopata<br />
al cospetto d’un computer perentorio. Probabilmente<br />
quelli di Vacanze Romane furono i due minuti e<br />
134<br />
mezzo - questa la durata massima consentita, il pezzo<br />
fu incautamente sfumato all’altezza del secondo chorus<br />
- più contemporanei della storia del festivalone. Era, ed<br />
è, una canzone formidabile, satura di fantasmi felliniani,<br />
riverberi operistici, cabaret sintetico e brezze latine (tra<br />
queste ultime la dichiarata devozione per Yma Sumac,<br />
straordinaria vocalist peruviana celeberrima nei Fifties).<br />
Pezzo che ancora oggi ammalia malgrado l’usura, accomodante<br />
senza pretenziosità eppure frutto di intrigante<br />
stratificazione: ovvero, il pedigree del pop migliore. Inevitabile<br />
sceglierlo ad inaugurare la scaletta composita<br />
di Tango, ricca di ammiccamenti Japan (Intellighenzia)<br />
e Ultravox (I bambini di poi), fregole Kate Bush strinite<br />
Yellow Magic Orchestra (Palestina), ma soprattutto di<br />
techno-pop dal tiro ibrido, balzano e inquietante come<br />
Elettrochoc e Il video sono io. Tutta roba che sorprese per<br />
la padronanza quasi irriverente, viatico per la definizione<br />
d’una calligrafia unica segnata dall’utilizzo disinvolto<br />
di espedienti, trovate testuali all’insegna d’un para-nonsense<br />
degno del Panella prossimo venturo (Tango nel<br />
fango) e - ovviamente - del soprano duttile ed enfatico<br />
però mai fuori luogo di Antonella Ruggiero.<br />
Una formula che non seppe ripetersi allo stesso livello<br />
nel pur buono Aristocratica (1984), dopo il quale<br />
Sabbione concluse la sua troppo breve avventura nella<br />
band. Che da allora non mancò di cogliere ulteriori successi,<br />
ma sempre più sulla scorta d’un passato - ahnoi,<br />
ahiloro - irripetibile.<br />
StEFano SolVEnti<br />
classic album<br />
thE modErn danCE (blanK, gEnnaio 1978)<br />
Quando si era ragazzini era normale leggere all’italiana<br />
quello strano insieme di lettere, Pere Ubu, un nome che<br />
suonava così bene eppure così maledettamente misterioso.<br />
In una parola: affascinante. Solo qualche anno<br />
più tardi sarebbe stato invece obbligatorio citare Alfred<br />
Jarry, francese di fine Ottocento autore di un teatro<br />
grottesco, a tratti anche brutale e osceno, che di fatto<br />
anticipava il surrealismo con questa strana cosa chiamata<br />
patafisica, “la scienza delle soluzioni immaginarie<br />
e delle regole che governano le eccezioni”, che aveva già<br />
stregato Robert Wyatt e i Soft Machine. Riascoltando a<br />
33 anni dall’uscita e a quasi 10 dal primo ascolto personale<br />
The Modern Dance però, tutti i fattori contestuali<br />
possibili (e attorno c’erano Television, Patti Smith, PiL,<br />
Joy Division, Pop Group, Gang of Four, Talking Heads,<br />
la No Wave) non superano mai il rango di indizi di una<br />
grandezza e di una irripetibilità che sono da cercare<br />
semplicemente in una ispirazione speciale.<br />
La danza moderna è un agitarsi scomposto, muoversi<br />
con l’eccitazione febbrile di chi sa di poter perdere tutto<br />
ma anche che questo tutto è niente. Il disco continua ed<br />
espande il mood apocalittico - fin dai titoli - inaugurato<br />
dai singoli 30 Seconds Over Tokyo (1975) e Final Solution<br />
(1976), con un concept paranoico dove la condizione<br />
post-industriale (gli Ubu nascono dalle ceneri dei Rocket<br />
from the Tombs, in quello stesso Ohio che sa poco<br />
di fattorie e tanto di ciminiere e fumi e che in parallelo<br />
darà i natali ai Devo) fa da cornice a storie d’amore tutte<br />
amare, deluse, concluse. Parable di una non più arable<br />
land, di una terra non più addomesticabile, desolata,<br />
sterile, fredda, indifferente, morta ammazzata. La danza<br />
moderna è un folk urbano messo ad essiccare under<br />
a big black sun (Over My Head è praticamente un desert<br />
western), è un punk-rock spigoloso e stilizzato, in bianco<br />
e nero, come la copertina: la batteria essenziale di Scott<br />
Krauss, il basso modellatore di Tony Maimone, le rasoiate<br />
synth di Allen Ravenstine, la chitarra-camaleonte<br />
di Tom Herman, che ora tratteggia con piccoli tocchi<br />
arpeggi sottili, ora innesca brucianti riff punk, ora take<br />
quasi-reggae alla Redondo Beach (Humor Me, che chiude<br />
beffarda, riuscendo nell’impresa di non lasciare l’amaro<br />
in bocca). Sopra tutto, ovviamente, la voce di David<br />
Thomas, figlio di un professore di letteratura inglese, un<br />
“ciccione che canta come un mingherlino”, dirà Stefano<br />
Tamburini/Red Vinyle in una intervista con Arto Lindsay,<br />
vocalist e lyricist delirante come sarà poi il Black<br />
Francis dei Pixies e come lui perfetta trasfigurazione<br />
musicale dell’ebete Eraserhead lynchiano, a chiudere<br />
una circolarità di ferino isterismo che ha nel Capitano il<br />
proprio capostipite e vate.<br />
Dalla sirena da evacuazione di Non-Alignment Pact, alle<br />
sfrangiature avant della intro fiatistica di Laughing, da<br />
quella Street Waves che è praticamente la versione postpunk<br />
del blues di Beefheart (il cui spirito aleggia nelle<br />
chitarre sghembe di tutti gli interludi strumentali dell’album)<br />
e di Electricity in particolare, alla teatralità espressionista<br />
di sceneggiate come Chinese Radiation, dall’inno<br />
“blank generation” Life Stinks (firmata dal primissimo<br />
chitarrista dei Pere, Peter Laughner, morto di eccessi a<br />
24 anni; per lui un toccante requiem scritto dall’amico<br />
Lester Bangs), alla marcia arrancante Real World, vicinissima<br />
ai pezzi più scuri e geometrici dei Devo di Are We<br />
Not Men . Giù giù e giù fino a quel Sentimental Journey<br />
che è un incubo claustrofobico tra Pierre Schaeffer,<br />
ovviamente Beefheart, gli Stooges di Fun House e i<br />
Residents. Senza mezzi termini, un capolavoro.<br />
Il percorso dei Pere Ubu sarà ancora splendido almeno<br />
per tutti i primi anni Ottanta e regalerà anche inattesi<br />
recenti colpi di coda. Quello del Thomas solista, sempre<br />
più o meno affiancato dai due fidi ragazzi pallidi Keith<br />
Moliné e Andy Diagram, discontinuo e irregolare, sospeso<br />
tra sperimentazioni vocali, teatro e ripetizione di<br />
sé; ma illuminato da lampi di vera ispirazione poetica<br />
e sempre rivolto alla caparbia esplorazione di luoghi<br />
immaginari - Erewhon, Spoon River contemporanea,<br />
non meno desolata dell’Ohio della gioventù - che sono<br />
specchi obliqui del reale.<br />
gabriElE marino<br />
135
sentireascoltare.com