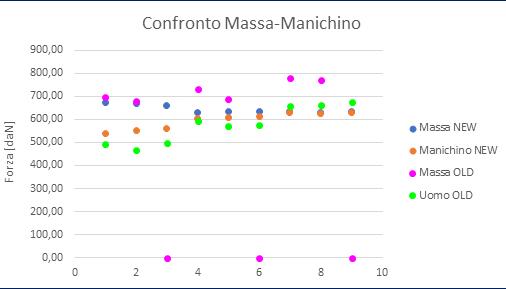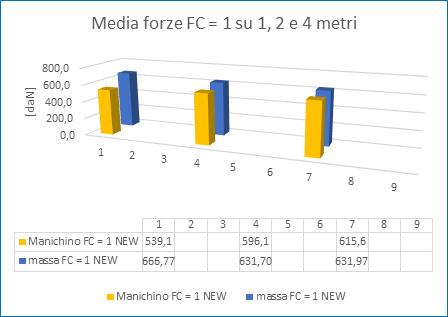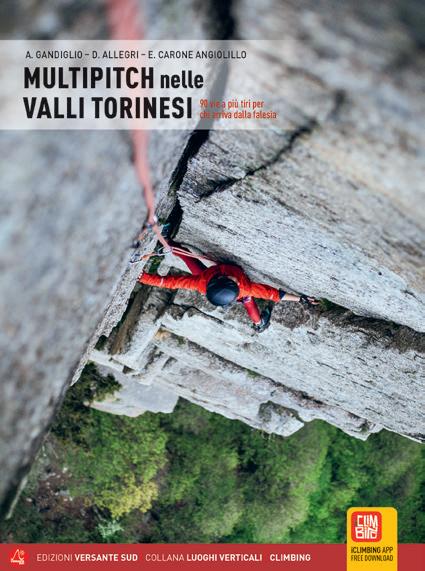Autunno 2022
I N S E R T O S P E C I A L E
CAI - ALPINISMO - GIOVANI

contributi di Antonio Montani, Alessandro Gogna, Marco Berti, Francesco Bruschi, Gino Montipò. Matteo Della Bordella, François Cazzanelli, Federica Mingolla, Martino Peterlongo, Davide Martini, Valter Pasquetto, Marina Pasquetto, Giona Pasquetto, Beppe Guzzeloni
M. Della Bordella
Spedizione al Siula Grande
D. Eynard
La solitudine sulla via degli Inglesi
C. Piovan
Brenta: una traversata a quota 3000 Gruppo 4 Gatti
Profumo di caffè e luce calda
F. Canobbio
Vie nuove nel gruppo dell’Adamello
G. Pozzoni
Il gigante buono
S. D’Eredità
Il valore dei passi
C. Confente e M. Leorato Oldies but goldies
W. Polidori
Una vera via invernale?
D. Filippi
Nadelhorn
F. Manoni
Pensieri corsari di un alpinista

L. Danieli
Perchè no?
Giulia
Non è uno sport, è molto di più
M. Bertolotti
Cento meno uno
E. M. Cipriani
Marmolada
F. Cammelli
Il generale Cantore e Maria Faßnauer
G. Montermini
Ivo Iori
G. Bressan, M. Polato e C. Zoppello
Un nuovo studio sulle longe
18

Si diventa vecchi quando si smette di essere curiosi e pronti a stupirsi di tutto, preferendo soffermarsi sui ricordi invece che sui desideri. In questo senso la vecchiaia può arrivare a vent’anni come può non arrivare a ottanta. Massimo Gramellini
LO ZAINO n. 18 - Autunno 2022: Matteo Bertolotti, Marcello Noseda, Manuel Porro, Antonio Radice, Davide Martini, Fabio Cammelli, Carlo Piovan, Saverio D’Eredità, Marco Berti, Beppe Guzzeloni, Diego Filippi, Matthias Stefani, Eugenio Maria Cipriani, Angelo Lìbera, Gino Montipò, Walter Polidori. Hanno collaborato: Antonio Montani, Alessandro Gogna, Valter Pasquetto, Marina Pasquetto, Giona Pasquetto, Matteo Della Bordella, François Cazzanelli, Arianna Proserpio, Emilio Aldeghi, Fabrizio Manoni, Federica Mingolla, Francesco Bruschi, Gianpaolo Montermini, Dario Eynard, Martino Peterlongo, Federico Canobbio, Christian Confente, Manuel Leorato, Claudio “Caio” Getto, Giorgio Pozzoni, Diego Dellai, Marco Toldo, Gruppo Roccia 4 Gatti, Giuliano Bressan, Massimo Polato, Cristiano Zoppello, Luca Danieli, Giulia, Roberto Capucciati, Damiano Sessa, Tommaso Bacciocchi. Prossimo numero: LO ZAINO n. 19 - Primavera 2023: invia il tuo materiale a lom.cnsasa@gmail.com e will80@sassbaloss.com. In copertina: Marco Majori al Siula Grande lungo uno dei tiri finali del pilastro (foto di Matteo Della Bordella); a sinistra: Giulio Zanoli sulla via Sinergie alla Pietra di Bismantova (foto di Nicola Bertolani); pagina successiva: tramonto sulla Croda da Lago, Pelmo e Pelmetto, dai pressi della Forcella Fontananegra (foto di Fabio Cammelli); terza di copertina: Laura Bozzoli sul primo tiro della via Goduria alla Cima d’Ambiez (foto di Matteo Bertolotti). Supplemento a “Il Rosa – Giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca” n° 2/2022 - Via Monte Rosa 75, 28876 Macugnaga (VB) – www. ilrosa.info – direttore responsabile: Paolo Crosa Lenz – Registrazione Tribunale di Verbania n° 295 - 29 novembre 1999

Editoriale?
Un numero diverso, che non a tutti piacerà.
L’intento è solo uno: cambiare.
Perchè così non può più continuare.

A tutti noi è richiesto un po’ coraggio.
Ognuno faccia la sua parte.
Matteo Bertolotti


SPECIALE CAI - ALPINISMO - GIOVANI 18
CLUB ALPINO ITALIANO

Da architetto sono abituato, quando affronto un nuovo tema progettuale, a farmi preliminarmente delle domande che mi aiutano ad inquadrare il problema e, solo dopo aver trovato risposta a queste domande, iniziare a immaginare un edificio nuovo, una ristrutturazione o un restauro dell’esistente.
Le domande che mi sono posto in questi ultimi anni sul Club Alpino Italiano sono ricorrenti e le riporto di seguito:
L’offerta alpinistica che il CAI fornisce è adeguata per chi volesse avvicinarsi a questa pratica?

Le sezioni del CAI nelle varie città sono ancora luoghi dove trovare esperti di alpinismo?
La rivista del CAI è ancora un luogo di dibattito sui temi dell’attualità alpinistica?
L’articolo 1 dello statuto laddove dice che il CAI… ha per iscopo l’alpinismo… è adeguatamente attuato?
Ed infine la marzulliana domanda: “i numeri dei praticanti dell’alpinismo classico sono in costante calo perché il CAI non lo promuove convintamente, o il CAI non promuove convintamente l’alpinismo classico perché i numeri sono in costante calo e quindi non c’è interesse?”
Naturalmente ho già avuto modo di dare una personale risposta ai quesiti. Tuttavia, alle mie conclusioni, dovranno affiancarsene altre che possano dare forma ad un vero e proprio progetto per il futuro del Sodalizio. In conclusione, devo ammettere, che la “vera” domanda che tutti noi dovremmo, in un primo momento molto intimamente e poi sempre più apertamente, porci è se come dirigenti e titolati del CAI possiamo fare qualcosa per invertire questa tendenza, e riportare il CAI al centro del mondo alpinistico.
8
Antonio Montani lungo la Cresta Segantini in Grignetta (foto Marco Morosini)
Antonio Montani, Presidente Generale del CAI
Gli articoli che trovano ospitalità in questa bella rivista della Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo
Scialpinismo e Arrampicata Libera, vogliono essere un primo momento di riflessione su codesti interrogativi, nella speranza di innescare un ampio dibattito interno ed esterno al Sodalizio, che ci aiuti a comprendere le ragioni profonde di alcune dinamiche sociali ormai note, definendo “sociali” come riferimento sia all’associazione che alla società tutta.
Inizierei la mia breve riflessione proprio dai cambiamenti sicuritari che negli ultimi decenni sono stati mutuati dalle società anglosassoni ed in particolare da quella americana. Oggi, infatti, il tema della responsabilità è, non solo prioritario, ma addirittura preliminare rispetto a qualsivoglia iniziativa. Questo atteggiamento è per certi versi giusto e per certi versi comprensibile, ma appare chiaro come possa facilmente diventare castrante per un’attività particolare quale è l’alpinismo. Atto che non può e non potrà mai eliminare completamente il rischio. Cosa può fare una grande associazione come il CAI a questo proposito?

Lavorare su due fronti, ovvero assumere tutte le azioni possibili per ridurre il rischio, e non meno importante, ribadire incessantemente, in tutte le sedi possibili, che per alcune attività il rischio zero non esiste.
Invero è indiscutibile come alcune categorie, ad esempio i lavoratori, non debbano essere esposti al rischio, tuttavia non possiamo ritenere che questo concetto possa essere applicato a chi liberamente sceglie, per propri motivi, di dedicarsi ad un’attività ludica. In questi casi chi decide di svolgere saltuariamente o continuativamente quell’attività deve essere messo a conoscenza dei rischi che corre, deve poter usufruire di tutti gli strumenti informativi necessari per la valutazione del rischio ma infine deve consapevolmente prendersi la propria autoresponsabilità. In questo ambito credo il CAI abbia molto su cui lavorare, sia in termini di comunicazione del rischio alla “popolazione” alpinistica, sia in termini di interlocuzione con l’autorità pubblica per vedere riconosciuta questa autoresponsabilità.
La seconda riflessione mi porta subito dentro l’organizzazione del Club Alpino Italiano. L’alpinismo oggi dentro il CAI è fatto esclusivamente dalle Scuole attraverso corsi formativi. L’offerta dei corsi, che è proporzionale al numero di istruttori attivi, non riesce il più delle volte a soddisfare le richieste del pubblico. Quindi viene spontaneo l’interrogativo se sia possibile aumentare il numero di istruttori, naturalmente senza ridurre la qualità formativa,
e se ciò abbia o meno un senso. A questo proposito sono davvero molte le considerazioni che si possono fare, così come sono diversi i possibili punti di vista.
Mi chiedo quale sia il numero massimo di giornate che un istruttore può dedicare agli altri senza che la cosa diventi “patologica”: quanto è giusto chiedere a un volontario?
Inoltre se vogliamo davvero essere intellettualmente onesti, dobbiamo avere il coraggio di chiederci se il volontariato puro rappresenti nella società di oggi la risposta adeguata. Ciò che è certo è che la sola idea di porsi questa domanda ci esporrà alla critica dei veri professionisti, che in questo campo sono le guide alpine.
Ecco allora che immediatamente si innesca una seconda domanda riguardante proprio il tipo di rapporto che CAI e istruttori dovrebbero avere con le guide alpine.
Resto personalmente convinto che aprirsi, fare rete, confrontarsi sia un’attività produttiva molto più che vivere ognuno arroccato dentro il proprio recinto con una concezione medioevale. Anche qui ci vorrebbe un aperto e sereno dibattito, ma dove se non in un luogo proposto dal CAI?
Concludo con un terzo ed ultimo argomento, un tasto dolente per così dire: i giovani.
Il CAI ha fatto, alcuni decenni fa, la scelta di non occuparsi di arrampicata sportiva: è facile giudicare con il senno del poi, tuttavia mi limito a registrare le conseguenze di quella scelta che ha portato sicuramente molti giovani iscritti a rivolgersi a palestre indoor e ASD.
Un avvicinamento all’arrampicata attraverso l’indoor gestito dal CAI avrebbe forse consentito più facilmente il passaggio all’arrampicata “in ambiente” di coloro meno portati per le competizioni o chi, a fine carriera, desidera continuare a scalare in falesia anche su alte difficoltà.
È possibile oggi per il CAI ripensare questa scelta? Cosa
9
Festival di Trento, 1959. Tenzing Norgay, lord John Hunt (capo della vittoriosa spedizione Everest 1953) e Achille Compagnoni davanti al Gran Hotel Trento. Archivio hotel Compagnoni, Cervinia.
comporterebbe a livello sociale in un momento in cui una sezione come Bergamo (forse la seconda in Italia in termini di numero di soci) si vede costretta, per utilizzare la propria palestra del Palamonti, ad affidarne la gestione ad un asd, proprio per il grande impegno richiesto agli istruttori, non gestibile con il volontariato puro?
Torniamo infine ai giovani, a quei ragazzi e ragazze che tra i 15 e 16 anni dimostrano scarso interesse per l’Alpinismo Giovanile, che cercano qualcosa di più avventuroso, quale offerta dà loro il CAI? È possibile immaginare spazi nuovi?

Mi rendo conto che ogni versante da cui si intende affrontare questo tema apre nuovi e diversi interrogativi, così come mi rendo conto che l’attuale dirigenza è chiamata a sciogliere questi interrogativi, sforzandosi di indagare tutte le possibili soluzioni.
Se c’è una risposta che proprio non ho mai accettato alla domanda “Perché fai questa cosa in questo modo?” è “Perché si è sempre fatto così”. Intendo pertanto continuare ad interrogarmi, a creare spazi di dibattito, a sollecitare riflessioni, e spero che in questo processo avrò l’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Club Alpino Italiano, in primo luogo dei nostri titolati.
10
Matteo Della Bordella in arrampicata in Patagonia, al Fitz Roy

IL CAI E I GIOVANI
Alessandro Gogna
È fuori di dubbio che in questi due ultimi decenni la considerazione che i giovani hanno del Club Alpino Italiano sia assai diminuita rispetto al secolo scorso, nel migliore dei casi rarefatta in un indifferente distacco. Ciò a dispetto dell’accresciuto numero dei soci, giusto vanto del Sodalizio. Sarebbe interessante avere una statistica sull’età media del socio del CAI: io credo che si scoprirebbe che è aumentata di parecchio. Si è cominciato con le critiche per nulla velate che apparivano sui forum più in vista: è lì che è stato affibbiato, con evidente significato dispregiativo, il nomignolo di “caiano” a quel socio CAI che acriticamente segue le direttive e soprattutto le vetuste mode di un attempato modo di intendere associazionismo e modo di andare in montagna. Se ci si prende la briga di visitare un po’ di profili facebook, con annessi e connessi post e commenti,
si vede che la parola “caiano” è ormai diventata d’uso comune: a certuni sembra che l’essere iscritto al CAI sia una nota di demerito. E non è più uno scherzo. Tutto questo può apparire assai impietoso e inaccettabile a chi ha creduto e crede nel CAI, un’associazione alla quale ha dato e dalla quale spesso anche ricevuto. In questi individui, la conseguenza più immediata è l’allontanamento da ogni tentativo di comprendere almeno qualche perché. Eppure gli esempi storici che c’insegnano che questo genere di processi è del tutto normale non mancano di certo: ne cito, per brevità, solo due. 1) All’inizio del secolo XX, specialmente subito prima del primo conflitto mondiale, nacquero parecchie associazioni che, a vario titolo, si distaccavano radicalmente del Club Alpino Italiano, rivendicando altri scopi e altri modi di andare in montagna: che diventava quindi anche “operaia”
Festival di Trento (1966?). Da sin. 1afila, Claude Barbier, Gaston Rébuffat, x, Marino Stenico, Michel Vaucher; 2a fila, Cesare Maestri, Georges Livanos, x, Riccardo Cassin, Walter Bonatti, Toni Hiebeler, Bepi De Francesh, Pierre Mazeaud; 3a fila: Gigi Alippi, x, Romano Perego, Roberto Sorgato, Luigino Airoldi, x, Yvette Attinger Vaucher, x, x, x, x (che nasconde una donna), x, x, x, x; 4a fila: donna, x, John Harlin.

12
e non soltanto appannaggio di nobiltà e borghesia.
2) Posteriormente ai moti del 1968, le acque dello stagno furono assai agitate dal Nuovo Mattino, che abbatteva il mito della vetta e della conquista ad ogni costo, ma anche dall’articolo di Reinhold Messner L’assassinio dell’impossibile, che rivendicava senza mezzi termini la necessità di un ritorno immediato all’arrampicata libera e quindi l’abbandono, da parte dell’istituzione CAI, del modo di celebrare le imprese, fino a quel momento impostato sulla conquista (senza badare al come si conquistava). È un dato di fatto che il CAI, da almeno una quarantina d’anni, ha dato ben poca importanza nelle sue pubblicazioni e nella sua attività culturale all’alpinismo nuovo, ai giovani. Se si escludono le serate organizzate dalle Sezioni del CAI in onore di nomi nuovi, accanto a quelli vecchi, non rimane nulla. La mia opinione è che se si trascura l’alpinismo dei giovani, ci sarà (come in effetti è stato) un generale loro allontanamento (anche di coloro che non scalano ma sono appassionati di montagna) da un’associazione che mai potrebbero sentire consona ai loro bisogni.
Aggiungiamo la frammentazione dell’alpinismo che si è verificata, con una serie di discipline assai diverse che non sto neppure a elencare. Nessuno, a livello generale, ha seguito con attenzione l’evoluzione di questo fenomeno, neppure il Club Alpino Accademico, che più di tutti avrebbe dovuto farlo. Tanto è vero che oggi il CAAI è tra le associazioni a più alta età media dei soci.
Non sostengo che il CAI avrebbe dovuto inseguire tutte queste singole discipline: al contrario avrebbe dovuto (come ha fatto, in qualche caso controvoglia) scortare e favorire il passaggio a organizzazioni più dedicate,
intavolando però con loro una seria collaborazione.
Ricordo i Festival di Trento degli anni Settanta, ma anche degli Ottanta: erano pieni zeppi di vita, pochi eventi ma tanti invitati, il fior fiore degli alpinisti da tutto il mondo. Si facevano due convegni, non di più, accanto alla regolare proiezione dei film in concorso. Ma quelle riunioni sono risultate memorabili in più occasioni, con lo scontro appassionato di persone che ci credevano. Oggi un normale Festival di Trento ha anche fino a cento eventi, piccoli e grandi: ma in nessuno si verifica l’accensione di quella scintilla che nel passato portava i protagonisti, dopo essersi massacrati nelle discussioni pubbliche, a fare vere amicizie a suon di birre fino alle tre del mattino e a programmare imprese e scalate assieme. Nessuno di questi eventi ci fa battere le mani fino a spellarcele, tutti in piedi. Altro che “social”! Oggi si preferisce invitare il grande personaggio, quello che fa rumore sui giornali e presso il grande pubblico: e ci si dimentica della base (costituita guarda caso dai giovani): e senza la base che soffia sul fuoco non c’è fiamma, non c’è passione. Non escludo affatto che il CAI possa recuperare il terreno perduto: si tratta di comprendere i perché, fare autocritica e ascoltare con pazienza. Si tratta di capire che il futuro è in mano ai giovani e che, se vogliamo aiutarli, non è accettabile l’arroccamento su posizioni prestabilite e ufficiali, considerate le uniche possibili. Non deve cadere nell’errore che basti dotarsi di strumenti social alla moda (LinkedIn, Instagram, Twitter) per mettersi al passo con i tempi. Il cambiamento dovrà essere radicale, al posto di qualche piccola battaglia ego-riferita dovrà essere soffio vitale nelle pieghe di qualunque riunione del CdC, nelle assemblee, nei consigli di Presidenza, nella rivista del CAI, nei comunicati, nei rapporti con le associazioni ambientaliste, ecc.

Nessun giovane ha mai contestato il Bidecalogo ma, guarda caso, questo prezioso strumento è tra i più disattesi nella pratica quotidiana di CAI e Sezioni!
Sarà una via molto difficile e parecchio esposta a errori e fallimenti. Però l’alternativa è la fine del CAI: prima si verificherebbe la progressiva dispersione dell’autorevolezza culturale fino all’annullamento, in seguito la frammentazione totale in un arcipelago di Sezioni, e infine il crollo delle adesioni.
13
Gian Carlo Grassi al Trento Film Festival
LARGO AI GIOVANI!
Marco Berti
In questo numero de Lo Zaino è nostra intenzione interrogarci sul futuro del CAI e di come nel corso del tempo il rapporto tra le diverse generazioni sia mutato e purtroppo, in alcuni casi, fortemente fratturato. C’è chi ha saputo riadattarsi e chi ha lasciato che l’acqua scorresse lungo il fiume, ma c’è stato anche chi ha fortemente combattuto perché qualcosa cambiasse e, dopo innumerevoli lotte contro i mulini a vento, ha fatto la scelta più naturale: andare altrove. Oggi più che mai occorre prendere coscienza dei numerosi treni perduti e mai rincorsi.
Ho chiesto a Marco Berti, ex socio del CAI e da anni collaboratore de Lo Zaino di raccontarci la sua esperienza; di provare a contestualizzarla anche con altre realtà di oltre confine. Il risultato risponde perfettamente alle mie attese. Qualcuno storcerà il naso, qualcun’altro apprezzerà. Di certo, dalla sua analisi si può, con umiltà e consapevolezza, iniziare a riflettere senza inganni. Forse non tutto è perduto. Matteo Bertolotti
Il titolo sottintende ad un tema di riflessione che spesso affronto con numerosi amici, non solo appartenenti al Club Alpino Italiano, ma anche ad altre associazioni sportive o culturali.
Il C.A.I. comprende all’interno dei suoi valori entrambe queste componenti, sport e cultura, che sommate al connotato della precarietà e caducità che caratterizza ogni attività svolta nell’ambiente naturale fonda di fatto l’alpinismo come pratica. Questa è la sua peculiarità, il suo valore e sicuramente la sua forza.
Elementi, sport e cultura, che non si realizzano separatamente, ma convivono in simbiosi e in continua evoluzione, proiettati in un futuro che è obbligatoriamente e fisiologicamente legato alla gioventù con il suo vigore, il suo disincanto e una indispensabile e corposa dose di entusiasmo sognante.
Sport e cultura come inclusione sociale, strumenti efficaci per superare le differenze, per creare il senso di comunità e incoraggiando il dialogo.

14
Disegno di Caio - www.caiocomix.com
Non so se Largo ai giovani! è un titolo azzeccato (forse sarebbe stato più corretto W i giovani!) perché spesso viene impiegato da quelle persone di età avanzata che non vogliono lasciare lo scettro e rivestono ruoli apicali all’interno delle aziende o nei sodalizi come il C.A.I.. Frase ripetuta quasi come uno scaramantico mantra per scongiurare il rischio di dover cedere quanto conquistato, lasciando un illusorio spazio solo a qualche brillante, ma ossequioso quanto inutile, giovane yes man
Consapevole di avventurarmi in un tema complesso, in cui l’esperienza di vita vissuta può talvolta farmi perdere il senso generale a favore di singoli accadimenti, ho voluto mettere a fuoco l’insegnamento tratto da quarant’anni di esperienze dirette nell’ambito delle quali ho avuto modo di conoscere, oltre al C.A.I. a livello sezionale, altre realtà simili come l’Alpenverein Südtirol, l’American Alpine Club e il Sierra Club.
In ogni ambito associativo, i giovani, in particolare quelli concentrati su l’aspetto più sportivo, troppo frequentemente si scontrano con un esasperato conservatorismo, altre volte con un ridicolo arrivismo dal sapore politico, non ultima l’ottusità di chi ha paura del cambiamento o chi preferisce vivere in un tutelante campanilismo che non accetta contaminazioni.
In ogni associazione, ogni generazione rappresentata dovrebbe operare in maniera sinergica con le altre. Riflessione banale e scontata, ma che in certe situazioni o con certe cariatidi, appare più complicata se non impossibile del salire con dei sandali infradito il versante Kangshung dell’Everest (anche se l’alpinismo e l’arrampicata continuano ad insegnarci che l’impossibile, il limite, è lungi dall’essere definito).
Quanti giovani all’interno delle associazioni – qualsiasi - si sono dovuti scontrare con dei sepolcri imbiancati? Giovani che nel trovarsi ad affiancare questo tipo di persone, inizialmente entusiasti e orgogliosi di poter portare un loro contributo, rimangono basiti, impotenti e carichi di una delusione che li porta ad allontanarsi dal gruppo pur continuando a praticare l’attività che è la loro passione e il cui terreno di gioco è fatto di roccia, neve e ghiaccio. Elementi che sono lì per divertirsi e godere del momento, non condizionabili dalle bassezze umane.
E poi, continuamente, vedo nascere gruppi che organizzano attività in montagna. Alcuni durano il tempo di una stagione, anche perché nati spontaneamente e senza aspirazioni gerarchiche al loro interno. Altri, più strutturati, conquistano l’attenzione di molti appassionati senza voler
essere alternativi al C.A.I., ma spesso lo diventano a livello territoriale.
Alcuni soci, accompagnatori o istruttori del C.A.I., si indispettiscono per il nascere di queste realtà, ma perché non si pongono una domanda e si danno una risposta ricordando un noto conduttore e giornalista televisivo e come ci dovrebbe insegnare il buonsenso. L’essere parte di una struttura istituzionale come il C.A.I., per chi vuole andare in montagna non è più importante come un tempo.
Altrettanto vale per la F.A.S.I. e tutte quelle associazioni che attirano i giovani verso il mondo dell’arrampicata, perché è lì che si trova il futuro di tutto quello che può essere legato alle attività che portano a quell’alpinismo che per alcuni sembra debba rimanere relegato a codici antichi e conseguentemente obsoleti.
Volendo operare una disamina sulle fasce generazionali che caratterizzano questo mondo possiamo riconoscere:
i giovani, quelli che lo sono realmente, di mente e di spirito, non solo anagraficamente. Puntualizzo questo aspetto perché ne ho conosciuti alcuni che fanno apparire gli ottocenteschi presidenti dell’Alpine Club di Londra come dei novelli Jim Morrison. Giovani che con i loro sogni, entusiasmi, obiettivi alti, realizzabili o irrealizzabili (tutto da dimostrare), possono essere la forza motore per dare colore ad un ambiente che a volte – spesso - si ingrigisce;
i Nel mezzo del cammin di nostra vita, quelli un po’ più giovani di me, che possono avere ancora entusiasmo, magari più equilibrato, e pregni, ancora, di energia da vendere;
i più vecchi, ai quali mi sto avvicinando (il più lentamente possibile), che possono regalare quell’esperienza che è frutto di errori, conseguenza di antichi entusiasmi, spesso ipocritamente dimenticati. Esperienza che non deve essere un muro invalicabile, ma due braccia che sono in grado di tenere il volante anche sulle strade più sconnesse e tortuose della burocrazia e delle regole, smettendo di denigrare chi ha “la colpa” di essere nato molti anni dopo di loro.
Nell’invecchiare mi sono convinto che c’è chi, in là con gli anni, vive i giovani come un nemico, senza capire che quest’ultimi sono l’entusiasmante oggi del nostro ieri.
Quando ho iniziato a scalare, era la fine degli anni ‘70, aveva preso spazio il concetto di montagna senza cima perché il terreno di gioco si era ampliato sulle pareti
15
di bassa quota facendo nascere una nuova e concreta disciplina che nel tempo ha sempre avuto meno a che fare con l’alpinismo. Quell’arrampicata libera (da preconcetti) che all’epoca agitò gli animi di certi ambienti del C.A.I. e che ancor oggi è in continua evoluzione, libera alle interpretazioni, in crescente pratica tra severe regole e etica, ma comunque obbligatoriamente aperta al cambiamento e all’evoluzione.
Io ricordo la diffidenza e la lentezza con la quale il C.A.I. si è avvicinato e adeguato ai cambiamenti degli anni ‘70 e ‘80. Arrampicata sportiva che è figlia di quel free climbing importato dalla California anche con il suo stile Woodstock E se il festival musicale del 1969 è noto anche come ‘3 Days of Peace & Rock Music’, quello che giunse dalla Yosemite Valley per la scalata fu ugualmente una totale ricerca di libertà dai rigidi stereotipi europei dove le Joan Baez e Janis Joplin, i Jimmy Hendrix e Joe Cocker si chiamavano Warren Harding, Royal Robbins, Chuck Pratt e Jim Bridwell.
Conseguenza di quella ricerca di libertà fu l’affrontare pareti di roccia che fino a quel momento non erano state degnate di uno sguardo o semplici palestre per prestigiosi obiettivi. Inizio di un percorso che vede la sua prima sintesi ne I Cento Nuovi Mattini dove Alessandro Gogna cercava di capire dove collocare questo nuovo modo di scalare, nel quale la ricerca delle difficoltà era portata alle sue estreme conseguenze utilizzando terrificanti – perché finte -protezioni dal conscio effetto placebo o con l’utilizzo degli spit.
In Italia, questa rivoluzione ebbe dei trascinatori in personaggi come Roberto Bassi, Manolo, Mariacher e Luisa Iovane che nella Valle del Sarca trovarono il
loro parco-giochi; Ivan Guerini in Val di Mello sul finire degli anni ’70 diede vita al “Gioco-Arrampicata” al quale seguirono altri giovani valtellinesi, tra i quali Jacopo Merizzi, Paolo Masa e Giuseppe Miotti che furono gli animatori del gruppo dei Sassisti. Quel nome, inizialmente, era un termine dispregiativo affibbiato da qualche solone

del C.A.I., ma come successe a Cézanne, Degas, Monet e altri, artisti inizialmente denigrati come Impressionisti, i destinatari lo metabolizzarono e lo fecero proprio. Quella dei sassisti fu una volontaria rottura con un ambiente alpinistico stretto dentro abiti e tradizioni che altri avevano confezionato nei decenni precedenti. Niente statuti, comitati, presidenti e consiglieri, solo un nuovo modo di intendere l’alpinismo e l’arrampicata tra libertà e creatività.
Sicuramente quei giovani di un tempo non avranno un sasso che vale 98 milioni di euro come un quadro di Monet, ma quel loro bisogno di cambiamento ha lasciato il segno e quella storia continua.
E il C.A.I. dove stava in tutto questo? Tolto qualche illuminato, primo tra tutti l’immenso Riccardo Cassin, il resto stava a guardare senza particolare attenzione, un po’ spocchioso, spesso indifferente, altre volte infastidito.
Nel 1985, a Bardonecchia vengono organizzate le prime gare di arrampicata del mondo occidentale. Non che a tutti i top climber piacque l’idea di mettersi in competizione, ma fu l’inizio di un qualcosa di veramente diverso dallo stereotipo del ‘rocciatore’ conosciuto dalla massa. E ancora il C.A.I.? Alla conferenza stampa, Cassarà, uno degli organizzatori, dichiara «Non abbiamo trovato, salvo poche eccezioni, una vera ostilità da parte delle autorità
16
Disegno di Caio - www.caiocomix.com
alpinistiche italiane, innanzi tutto il CAI, e siamo grati alla Presidenza Generale del sodalizio per la... benevola astensione». L’elegante vena ironica di Cassarà dà l’impressione che il C.A.I. c’è, ma preferisce mantenere un ruolo di osservatore; è sempre attendista quasi non volesse cogliere al volo il vento del cambiamento. Sempre nel 1985 nasce il magazine ‘Alp’ che porta una ulteriore innovazione, più vicina al mondo che cambia e allo stile richiesto, affiancandosi al già consolidato ruolo della più matura Rivista della Montagna, alternative alla Rivista del CAI e allo Scarpone sempre un po’ in affanno nel capire che il mondo dello sport in montagna stava diventando un’altra cosa.

Uno degli indicatori di questi mutamenti nell’attuale evoluzione dell’arrampicata e dove ritengo sia utile prestare attenzione, è il defunto Melloblocco, manifestazione nell’ambito della quale si promuoveva il bouldering; appagante ed economica attività sportiva dove sono sufficienti un paio di scarpette da arrampicata, magnesite e un crash pad Si raggiunge un masso che ha catturato la nostra attenzione, si sale senza corda, senza imbrago, immersi nella natura praticando un divertente gioco tra inesistenti appigli, appoggi e complicati movimenti. Bouldering che attira i giovani verso la montagna e l’arrampicata. Qualcuno dice che i raduni come il Melloblocco sono una perdita di tempo per ragazzi che non accettano la severità delle alte cime. Quindi? Dove sta il problema? Sono numerosi i boulderisti, poi diventati eccellenti climber e poi alpinisti ammirati perché hanno portato sulle grandi pareti delle Alpi
l’esperienza dell’esasperazione della difficoltà sui massi. Il Melloblocco era indubbiamente uno stimolante evento che creava feeling tra montagna e giovani.
Oggi, molti millennial si avvicinano all’arrampicata non tramite le scuole di alpinismo del C.A.I., ma con il passaparola, nell’apparire di belle foto o video su instagram o nel ricevere qualche bella immagine tramite whatsapp da un compagno o una compagna di classe aggrappati su un piccolo appiglio di un solitario sasso adagiato su un prato. Provano a fare dei blocchi, si divertono, e lì comincia la sintonia con la roccia o anche con la plastica delle palestre indoor per poi cercare sempre di più.
Ai miei anni era diverso, per molti come me è stato diverso. Sognavo le montagne, si andava a fare le gite (oggi trekking) per raggiungere i rifugi, poi le ferrate finché un giorno, al rifugio Carestiato, vidi un vero alpinista giungere con corde, moschettoni e chiodi tintinnanti e penzolanti. Emozione.
Eravamo nella seconda metà degli anni ’70 e con un giovane coetaneo mi inventai rocciatore. Cordino da 8 mm lungo venti metri, l’imbragatura intera comprata per le ferrate, gli scarponi da alpinista acquistati dopo un’estenuante tortura cinese ai danni di mia madre, chiodi comprati senza sapere come usarli e un martello rubato dagli attrezzi del papà.
Trovata una parete provammo a salirla. Partivamo di nascosto e passavamo le ore, i giorni, le settimane, che poi diventarono anni, per salire solo quindici metri di quella parete verticale e strapiombante.
Finché un giorno mio padre scoprì il perché di quelle
17
Disegno di Caio - www.caiocomix.com
strane fughe verso quelle pareti nascoste tra i boschi, e capendo che non poteva fermarmi mi iscrisse al C.A.I. e poco dopo al corso roccia.
Questa è una storia comune a molti. Il C.A.I. era il tempio dell’andare in montagna, il luogo dell’alpinista e lì e solo lì, almeno da cittadino, potevi iniziare a pensare di poter realizzare il tuo sogno verticale. Ricordo quando ricevetti la tessera. L’emozione fu grande. Oggi non è più così, i giovani trovano alternative. Il C.A.I. non è più quel luogo nel quale il diventare socio era quasi ricevere una medaglia o perlomeno l’entrare in un gruppo per pochi eletti; almeno io, adolescente, ancora pregno di una buona dose di retorica, la vivevo così.
È facile sostenere un giovane dotato che dopo il classico corso roccia si presenta con il potenziale per lasciare un segno nella storia della sezione o molto di più, ma spesso questi non hanno bisogno del C.A.I., al massimo di un buon mentore. Mentore che si rende disponibile - a volte - per l’interesse di chi vede in quel ragazzo lo strumento per prolungare la propria vita alpinistica, arricchendo un curriculum in fase discendente, mentre altri lo fanno con il genuino piacere di accompagnarlo in strade a loro note per poi aiutarlo nello spiccare il volo verso altre mete, lasciandolo andare nella giusta direzione e far diventare realtà i sogni più alti.
Premesso che tutto quello che viene svolto all’interno del C.A.I. si basa sul volontariato e conseguentemente ha tutto il mio rispetto e la mia ammirazione, non sono così convinto che la disponibilità e la dedizione sia un valore unico e assoluto per fornire stimoli e strumenti a quei giovani che vedono la montagna nel loro futuro, sia a livello dilettantistico che professionale. Un’attività che si basa sul volontariato, porta certe persone a far diventare lo spazio conquistato come un proprio feudo, ma in un’associazione non esiste la proprietà, sia formalmente che come conseguenza di una disponibilità e dedizione che non è imposta. Molto tempo fa, nel mio parlare, anche stupidamente, senza filtri e spesso senza spiegare, ripetevo una frase per descrivere certi istruttori di alpinismo del C.A.I. “un alpinista fallito che ha il suo unico momento di gloria quando ha accanto un allievo neofita”. Ovviamente esageravo e se guardato nell’ampio e complesso mondo delle Scuole di Alpinismo, è un’affermazione sbagliata e sproporzionatamente irrispettosa, ma se qualcuno si fa un esame di coscienza qualcosa di vero c’è e quando intendevo fallito, non la pensavo in quanto tale, ma fallito nelle sue aspettative di alpinista e nel suo ridicolo pavoneggiarsi sul poco o niente.
Avere un istruttore senza storia, con poco attività, con niente da raccontare e che vive l’alpinismo solo nel periodo del corso, è come guardare un documentario sulle Alpi su un televisore spento.
Ma devo dire la verità, la realtà sezionale che molti anni fa mi ha fatto elaborare questa frase, adesso la vedo vitale, con istruttori in continua attività e gioia di trasmettere la propria passione. Guarda che coincidenza: istruttori giovani.
È vero, a volte bisogna aspettare un obbligato cambio generazionale e trovare chi si renda disponibile a rinunciare ad un po’ della sua attività alpinistica per dedicarsi ai corsi, ma delle volte si perde il treno della continuità perché questo cambio è impedito e anche perché il volontariato porta ad una ondivaga qualità. Ma perché non pensare di condividere, in maniera organica e strutturata, la progettualità e la gestione delle Scuole di Alpinismo del C.A.I. con le guide alpine? Io lo vedrei come un valore aggiunto e non come un disturbo.
Ma se i vecchi devono aprire la mente, i giovani non devono essere distruttivi. Distruttivo che è controproducente per l’ambito associativo e per loro stessi. Rompere per ricostruire è sempre più difficile e complicato.
Le nuove generazioni devono avere la capacità di ascoltare e raccogliere. I vecchi di sostenerli, regalando il loro vissuto nei suoi pregi e nei suoi difetti, senza nascondersi dietro un “ma ai miei tempi” o con un ironico o altezzoso, paternalistico accontentati, convinti che l’andare oltre di questi ragazzi potrebbe oscurare la loro effimera fama. Io sono sempre stato convinto, a differenza del noto proverbio, che chi si accontenta non gode
Il giovane dovrà metabolizzare e trasformare quanto ricevuto per farlo proprio.
Ma se un ragazzo o una ragazza sono nati nei primi anni del XXI° secolo, è colpa loro se il mondo della montagna è cambiato e conseguentemente lo spazio di avventura è più limitato e sicuramente diverso?
Ovviamente no! Semmai è colpa di chi li ha preceduti.
Ognuno inizia il suo viaggio per un suo intimo motivo e l’alpinismo è stato il mio strumento per realizzarlo. Ero uno dei tanti appassionati, determinato a vivere tra le montagne ed in particolare sulla catena himalayana, affascinato da quel mondo e dall’opportunità di avventura che ancora offriva, dalle popolazioni che lì vivevano e ovviamente dalle sue alte montagne.
Tutto in completa autonomia e senza avere una famiglia come sponsor (beati quelli che ce l’avevano).
18
Disegno di Caio - www.caiocomix.com

Non fu facile, ma i soliti sepolcri imbiancati, vivevano come un disturbo il mio piacere di condividere, tra accuse di presunzione e imprudenza, in un continuo mettere in discussione la mia attività, ironizzando in maniera pesante sulla mia persona e sulle mie aspirazioni. È la storia che ho vissuto (dovuta a singole stupidità) e che ho ritrovato ascoltando altri alpinisti, ma fu una utile scuola di vita che mio malgrado, mi ha portato gradualmente ad allontanarmi e a godere delle montagne con quella parte di mondo che viveva e vive il C.A.I. per i meri aspetti assicurativi e per gli sconti nei rifugi. Solo la caparbietà, un minimo di capacità organizzativa, il saper affrontare e metabolizzare i numerosi errori fatti nelle prime esperienze, mi permisero di trasformare quella passione in una professione. Nessuno può o deve pretendere dal sodalizio un aiuto materiale o esperienziale, ma buonsenso e rispetto reciproco porterebbe ad evitare di appesantirgli le difficoltà del raggiungimento dell’obiettivo, non mettendolo in condizione di trovarsi ai margini perché non segue la linea retta e definita o perché ha voluto andare oltre i muri, disturbando chi nel C.A.I. ha trovato una comfort zone. Lì dove tutto si è appiattito accontentandosi dell’abitudine, potente antidoto contro la voglia di assumersi un rischio (quando l’alpinismo vero ci ha sempre insegnato il contrario). Il mondo è fatto di cambiamenti ed è solo facendo il passo più lungo della propria gamba (anche studiato e preparato, dove, ovviamente, rimane un margine
di pericolo) che si possono produrre novità e risultati. Non c’è niente di più appagante del rompere la catena delle abitudini.
L’entusiasmo di un giovane non va mai frenato, anzi, va alimentato, perché se limiti il suo spazio di movimento tra tutelanti sicurezze, non gli insegni a vivere, ma a sopravvivere, impendendogli di godere appieno di un’esperienza intensa e ricca come quella offerta dal mondo delle montagne.
Al fine di comprendere meglio questo fenomeno sarebbe interessante promuovere un sondaggio tra i soci dai 10 ai 110 anni (possibilmente, i più giovani, liberi di dire quello che pensano, non consigliati o condizionati dai genitori).
Altrettanto utile sarebbe un’indagine fatta intervistando chi se n’è andato dal sodalizio, in particolare chi l’ha fatto tra i 20 e i 30 anni. Capire quali aspettative sono state disattese e cosa ha causato l’allontanamento.
Chi guida il sodalizio dovrebbe mettersi dalla parte di Nicandro, al quale Plutarco si rivolse dicendo che è necessario imparare ad ascoltare per trarne valore. Partendo dall’ascolto si può fare sintesi delle singole esigenze, trovando i punti di incontro e valorizzandoli potendo creare le condizioni per promuovere un andare in montagna evoluto, che va incontro ad ogni aspirazione, senza tarpare le ali, ma insegnando a volare, sostenendo progetti e facendo in modo che anche gli amanti della
19
burocrazia, ritornino a parlare di esperienze tra sentieri e crode e un po’ meno di numeri, leggi e regole.
Da anni non sono iscritto al Club Alpino Italiano anche spinto da situazioni come quelle che ho sopra descritto e subìto, pur ritenendo che non abbiano mai rappresentato il C.A.I. nella sua interezza, ma questa è la mia esperienza, anche se non nascondo che la passione, l’intelligenza e l’umiltà dei giovani e attivissimi amici de ‘Lo Zaino’ mi stanno facendo riflettere e guardare con interesse al futuro del sodalizio.
E con la stessa attenzione e curiosità seguo i gruppi come i Ragni di Lecco la cui eccezionale storia non ha mai avuto fine in un continuo rinnovarsi con giovani che riescono a coniugare la grande storia del passato con l’evoluzione del presente.

Cedendo un po’ a quel campanilismo da me prima criticato, sento il bisogno di citare i giovani de i Gransi di Venezia che negli ultimissimi anni stanno ridando vita a una storia che renderebbe orgogliosi i soci fondatori, ormai
tutti scomparsi per raggiunti limiti di età. Non ultimi i Ghiri di Romagna, gruppo di energici ragazzi nato a Forlì nel 2014, dei quali ho visto muovere i primi passi con un entusiasmo al limite del commovente. E il valore di questo bisogno di aggregazione, sia nel passato che nel presente, non è dato dagli 8a o dagli ABO, ma dal piacere di svolgere un’attività di buon e alto livello e condividerla in una unità di intenti che promuova il piacere della pratica alpinistica o puramente arrampicatoria. Sono solo degli esempi perché ne esistono molti altri lungo tutto lo stivale ed è triste che nonostante i più siano nati all’interno delle locali realtà del C.A.I. e alcuni membri diano il loro contributo nelle scuole di alpinismo, ci sia spesso una idiosincrasia con il resto della vita della sezione.
20
Disegno di Caio - www.caiocomix.com
Non ho mai smesso e mai smetterò di consigliare (se mi viene chiesto) e supportare quei giovani che sentono il bisogno di salire in montagna, sia da escursionisti che da alpinisti e siano essi di associazioni alpinistiche o un po’ anarchici.
Alcuni di questi li leggo, li seguo sulle riviste, poi ci sono quelli che si sono allontanati dalle crode per altri interessi, altri vagano, silenziosi, tra cime e pareti nascoste, indifferenti al modello alpinistico proposto alla massa, così come non dimentico quelli che sono stati fermati per sempre nella loro passione, a volte per pura sfortuna, altre volte per un esasperato arrivismo che ha presentato un conto esageratamente alto. Ma tutti, tutti e in diversa maniera, mi hanno regalato emozioni, stimoli, mi hanno fatto crescere, confermandomi che l’andare in montagna rimane l’esperienza umana più appagante che io abbia conosciuto.
E penso a quelli che scrivono che la cima non è importante, tipica frase per giustificare la rinuncia, quando invece la vetta è importante quanto il percorso che ha permesso di raggiungerla.
Senza la cima non c’è il percorso che a volte cambia perché anche le montagne crollano, si trasformano e in qualche maniera evolvono.
Ogni associazione ha bisogno di un miglioramento continuo dove il cambiamento ha il solo scopo di regalare strumenti e prospettive concrete e coinvolgenti. Forse non cambierà mai perché i giovani diventano vecchi e il ciclo continua. C’è solo da sperare che i giovani di oggi non diventino vecchi, ma solo dei giovani più maturi.
Voglio ringraziare Claudio Getto - Caio Comix per la sua disponibilità nel colorare queste mie riflessioni regalando sorrisi e qualche utile risata.

21
Disegno di Caio - www.caiocomix.com
PER CREARE UN FUTURO
Francesco Bruschi
Non è mai facile ritornare con la mente indietro negli anni, ma a volte è importante ricordare il passato, ancora prima di pensare al futuro. Perciò, colgo al balzo l’occasione e ripenso con immensa nostalgia alla limpida fanciullezza ormai da diciottenne. Mi accorgo improvvisamente di quanti viaggi e di quante avventure invernali e estive immerso nella natura avevo avuto la fortuna di vivere mano nella mano dei miei genitori, senza alcun obbligo, ma solo e soltanto col piacere di essere lì alla ricerca di un raro animale selvatico, di un silenzioso bosco immerso fra le alte rocce delle montagne o di una via non ancora scalata da nessuno. Sempre gli occhi rivolti verso il confine fra le guglie rocciose e il cielo, alla ricerca di una sfida profonda e sincera con sé stessi, e con l’intento, passo dopo passo, di andare oltre senza mai dimenticare la sicurezza, con la consapevolezza di essere, in fin dei conti, alla ricerca di un qualcosa che forse non riusciremo mai a trovare. Quando qualche anno dopo mi iscrissi all’Alpinismo Giovanile nella sezione Cai di Firenze. Non avevo poi chissà quale intento, anche perché nel mentre, in quegli anni, giocavo a calcio e avevo anche l’impegno dell’atletica ad alto livello, perciò a spingermi era semplicemente una voglia immensa di scoprire la montagna in ogni suo lato. Fin da subito cominciai a conoscere tanti altri ragazzi, spesso più grandi di me, seppur con la voglia comune di respirare un’aria genuina lontano dalla città. I giovani, almeno a Firenze, non mancavano, il problema è arrivato con il tempo, quando gli stessi, da assidui frequentatori sono cominciati a mancare senza un apparente motivo. Per quanto mi riguarda, pur avendo ormai lasciato andare il percorso dell’AG da diversi annetti, con l’aspirazione di viaggiare verso altri lidi e con il bagaglio di formazione tecnica ed umana, da loro donatomi, penso che quello all’interno del Cai Firenze sia stato davvero un percorso di formazione indimenticabile grazie alla condivisione con gli altri ragazzi, fra tutti l’amico inseparabile, compagno di tante tante avventure Francesco Tomè, e le figure imprescindibili degli accompagnatori ormai sempre in minor numero ogni anno che passa.
Infatti, al di là del proseguire inesorabile degli anni non è certo facile far fronte alle difficoltà burocratiche legate anche alla responsabilità delle loro figura nei confronti delle famiglie considerando anche le restrizioni legate a qualche avvenimento di cronaca o ad incidenti più o meno gravi.
Pur essendo un discorso complesso e delicato vorrei riuscire a lasciare ai lettori un concetto a mio modesto avviso importante sulla responsabilità: nonostante le leggi statali e civili non consentono di agire così liberamente fino alla maggior età è al contempo vero che quando si è in montagna, si deve cominciare a comprendere che la responsabilità ricade sul singolo e che in certe situazioni si devono avere delle capacità per riuscire a cavarsela anche da soli muovendosi sempre con attenzione scrupolosa e con rispetto assoluto.
Ma prevenire, anziché curare, è importante. Per questo motivo, per coloro che fossero propensi a intraprendere un percorso spiccatamente alpinistico, sarebbe importante poter accedere ai corsi di formazione più tecnici anche prima dei diciott’anni di età consentendo così di avere una formazione più dettagliata e accurata per svolgere tali attività. Anche perché il ragazzo, potrebbe comunque imparare delle nozioni sbagliate che una volta in ambiente diventerebbero pericolose per la sua stessa vita. In questo penso che il Club Alpino Italiano abbia una delle più grandi sfide degli anni a venire: è importante che si riesca a creare una classe di studenti eccellenti dotati di senso critico, teorico e pratico senza lasciarsi limitare da un eccessivo militarismo capace di inibire la creatività di un ragazzo volenteroso di imparare e di vivere certe esperienze in montagna, che viste dagli occhi di alcuni possono essere impensabili o estremamente pericolose. Questo non significa che ogni sezione giovanile debba diventare un percorso settoriale di alpinismo per un ristretto gruppo di ragazzi. Anzi è bene dire che, per chi vuole vivere in un certo modo la montagna, ritengo sinceramente che il Club Alpino Italiano riesca a fornire già allo stato attuale molto sostegno. Considerazione che ben
22
si adatta, sia a coloro che vivono da anni la montagna, sia a coloro che da poco tempo la approcciano, ritrovando così in questa istituzione un punto di riferimento imprescindibile. Quanto invece vorrei dire è che manca, per certi aspetti, un percorso spiccatamente alpinistico, finito quello in una realtà di Alpinismo Giovanile, che abbia l’intento di garantire ai giovani una formazione impeccabile senza per forza attendere. Un percorso che stimoli gli stessi alla ricerca di avventure, vicine o lontane che siano, senza porre bastoni fra le ruote alla loro vena creativa e alla voglia di andare oltre.

Ma ritornando al discorso di poco fa, l’importante non è quindi solo riuscire ad attirare i giovani, ma anche e soprattutto non lasciarli andare via una volta presi con sé. Troppo spesso infatti, ripensando agli anni scorsi, é capitato di vedere lasciare a metà un percorso cominciato da bambini perché la voglia o gli stimoli finiscono.
Un aspetto senza alcun dubbio di rilievo è chiedersi quanto effettivamente si investa nelle sezioni giovanili non solo a livello nazionale perché immagino sia piuttosto complicato stare dietro a un simile impegno, ma anche e soprattutto a livello di singola sezione, quanta cura e dedizione riserviamo ai giovani?
Non penso manchino i giovani volenterosi di vivere la natura, sognatori di piccole o grandi avventure, anche se certamente non saranno mai il numero di quelli che invece aspirano ad altro.
Per questo motivo è essenziale non lasciarli andare questi ragazzi una volta che intraprendono il percorso. Certo non
dipende solo al Club Alpino Italiano se un ragazzo decide di dire basta, ma sicuramente gioca un ruolo fondamentale, specie da piccoli, l’essere incantati da certi ambienti, l’essere impegnati in un’attività soddisfacente nonostante la fatica e l’essere incuriositi da storie di alpinisti del passato.
Poi qualora l’afflusso cresca a farsi più pesante sarà anche l’impegno di ogni sezione affinché si riesca a educare ognuno di loro, in ogni aspetto del vivere la montagna. Sarebbe davvero meraviglioso creare, senza illudere nessuno, una realtà tangibile di possibilità per i giovani che sognano mattina e sera di vivere di una passione così lontana dalle distrazioni di tutti i giorni, così inutilmente utile, così vera e sincera.
Non voglio avere la pretesa di cambiare tutto e tutti ma in fin dei conti ritengo doveroso provarci, nonostante poi possa uscirne un mero tentativo infruttuoso. Un processo non è poi così diverso dal salire montagna: provare, fallire, riprovare ancora e fallire meglio con la consapevolezza che ciò che conta è provarci fino alla fine. Non importa solo e soltanto il fine e l’utile, ma anche l’inutile importanza dei sogni di ogni ragazzo.
Pertanto non può che essere un nostro onere e un nostro onore avere la premura di accompagnarli passo dopo passo anche nella comprensione che è la passione a spingerci a svolgere questa attività.
“Non sono niente. Non sarò mai niente. Non posso volere d’essere niente. A parte questo, ho in me tutti i sogni del mondo…” Fernando Pessoa
23
Francesco Bruschi e Francesco Tomè



24
Francesco Bruschi e Francesco Tomè, preparazione progetto from Florence to Mont Blanc
Francesco Bruschi
Francesco Bruschi
Fino al 2018 molte attività svolte con i ragazzi di terza fascia (14 – 17 anni) erano in un ambito non prettamente escursionistico: sia come attività sezionali che nazionali e internazionali.
Si svolgevano, all’interno dei corsi avanzati di alpinismo giovanile, giornate dedicate all’alpinismo su difficoltà contenute, alla speleologia (sempre in collaborazione con speleologi) e all’arrampicata su monotiri (in alcune falesie specifiche e in collaborazioni con istruttori e sezioni). Oltre ai corsi di alpinismo giovanile venivano svolti corsi monotematici, in collaborazioni con istruttori, soprattutto di arrampicata, scialpinismo, sci di fondo escursionismo, di cicloescursionismo.
Molti gruppi sezionali organizzavano salite estive su varie vette di 3000 e 4000 metri (Cevedale, Marmolada, Gran Paradiso, varie cime del Monte Rosa, ecc.), si erano organizzate spedizioni internazionali sia da parte della CCAG/ SCAG che da singole sezioni (ad esempio Ararat nel 2013, Ande Peruviane nel 2018) e a livello internazionale i nostri giovani partecipavano alle attività UIAA: stage su cascate di ghiaccio, salita al Gran Paradiso, ecc.
Con l’emanazione dell’atto 2 del 2018 molte di queste attività si sono fermate, soprattutto quelle alpinistiche organizzate dalle sezioni, a causa della indisponibilità materiale e temporale delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera occupate a gestire già i propri corsi.
Si sono interrotte anche le spedizioni estere e, a causa della decisione di uscire dall’UIAA, gli incontri con i gruppi giovanili di altre nazioni.
A “macchia di leopardo” sono proseguite le attività di arrampicata, mentre non si sono praticamente mai interrotte quelle dei corsi monotematici di sci di fondo escursionismo e cicloescursionismo. Infine i gruppi sezionali che già praticavano attività speleologica continuano a svolgerla grazie alla collaborazione con i gruppi speleo.
Proprio grazie a questa collaborazione, che non si è mai interrotta, quest’anno si è riusciti ad organizzare l’attività nazionale speleologica che abbiamo chiamato “Viaggio al centro della terra” che ha visto la partecipazione di circa 70 ragazzi e di una trentina fra accompagnatori di alpinismo giovanile e speleologi, ponendo un limite massimo di partecipanti per motivi di sicurezza e causa della fragilità dell’ambiente ipogeo.
L’interesse per i ragazzi di terza fascia era ed è molto elevato ed apprezzato per queste attività “alternative”
I giovani continuano a richiederle e a chiederci perché, in alcuni casi, non si siano più svolte, il medesimo apprezzamento arriva anche da parte dei genitori.

25
Avvicinamento al Monte Bianco in bicicletta, progetto from Florence to Mont Blanc
SIAMO TUTTO
DISCORDI SIAMO NULLA”
Le restrizioni (e le paure) imposte dal COVID, ed anche una maggior attenzione della letteratura e dei media, hanno determinato un balzo in avanti notevole del turismo montano, che, vista la conformazione del nostro Paese, possiamo definire anche di prossimità. Il mercato della montagna, già in fase di modificazione da un paio di decenni, si sta rapidamente adeguando alla nuova e “informe” domanda. Le proposte, le strutture (e tra queste la rete sentieristica e funamboliche/illogiche ferrate), i messaggi propagandistici, sono volti a formare un immaginario collettivo delle terre alte come il mercato desidera percepirle, piuttosto che promuoverle quali sono: con pregi, difetti, rischi, limiti e fragilità. Il mercato richiede luoghi dai grandi orizzonti naturali e spirituali; luoghi dove il rapporto con la natura e i suoi ritmi (?) diventa medicina per il fisico e per lo spirito; luoghi “educativi” dove mettere
alla prova le proprie capacità fisiche guidati da una rete di servizi efficiente e protettiva. Luoghi nei quali si può salire abbastanza tranquillamente perché la “sicurezza” è garantita dalla qualità dell’offerta e, dove ciò non bastasse, da ordinanze e divieti.
In poco tempo, quella che per comodità possiamo definire la coda della visione romantica della montagna e delle sue risorse spirituali e naturali si è sgretolata, culturalmente e, purtroppo, anche materialmente. Probabilmente era inevitabile, considerati i modelli sociali egemoni, la ricerca di un legittimo benessere materiale delle popolazioni residenti e la trascuratezza storica delle cosiddette aree interne da parte delle varie Istituzioni che ha lasciato spazio ad improvvisazioni e sperimentazioni di corto respiro.

26
La Pietra di Bismantova è situata nel cuore dell’Appennino Emiliano - foto Nicola Bertolani Gino Montipò “UNITI
per
un rinnovato impegno del CAI verso l’alpinismo
Ormai così stanno le cose e non sono tutte negative, basti pensare allo spopolamento e alla miseria delle terre alte fino ad una cinquantina di anni fa, a parte rare eccezioni. Quelle che sono poi diventate modello e “miraggio” per ogni valle…
Tuttavia si sta diffondendo, in questi ultimi anni, una maggior consapevolezza dei limiti di quella che possiamo definire un’offerta energivora e arida di contenuti, e si allarga di valle in valle un protagonismo importante di una nuova generazione di montanari, autoctoni o acquisiti. Quelli che sanno stare connessi con il mondo (e lo hanno pure girato) ma intendono custodire e mettere a frutto le risorse più importanti della propria terra: la natura, la cultura, l’identità. Beni preziosi, sempre più apprezzati e richiesti, anche se fragili e non sempre rinnovabili.
È con questa e per questa generazione che vale la pena di tornare a ragionare sui contenuti e sulle forme dell’andar per monti, con particolare riferimento, in questa sede, all’alpinismo; che vale la pena di provare a contrastare l’idea di una montagna “oggetto” (il riferimento a vecchi slogan femministi è voluto e, a mio parere, pertinente), dove tutto è garantito: dal sentiero allo spit, dal ricovero (ormai di lusso e costoso anche in certi rifugi), al soccorso alpino “a la carte”.
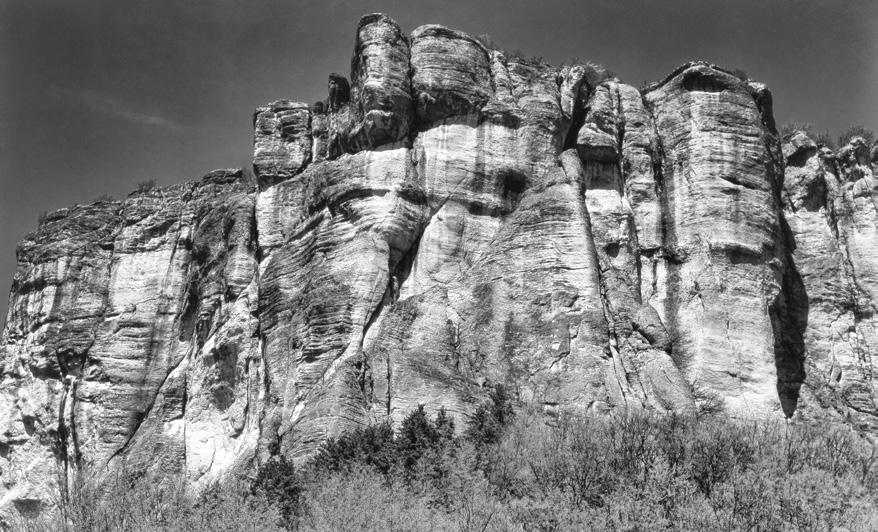
È tempo (per la verità sarebbe già stato tempo da un pezzo) di una riflessione sul come e sul perché ci siamo lasciati andare ad una frantumazione dell’alpinismo in mille sottoprodotti e specializzazioni che ne hanno indebolito,
se non annullato, assieme all’Ente che da sempre lo raccoglieva e lo rappresentava (il CAI), la storica primazia sulle attività e sulle “passioni” dei frequentatori della montagna. Una primazia tecnica, culturale e politica che permetteva al CAI di essere riconosciuto, dalla legge e dalla comunità, come il più importante interlocutore degli appassionati, ad ogni livello tecnico.
Certo, dalla “Pace coll’Alpe” al “Nuovo Mattino” arrivarono grandi mazzate alla visione eroica dell’alpinismo: tutto bufere, morti, miti e sacrificio, e molti giovani si sono a lungo dissetati a quella fresca fonte. Ma forse non fu abbastanza chiaro di come quella trasgressiva visione manteneva comunque un rapporto profondo con la montagna e le sue emozioni, non foss’altro perché la generazione che l’aveva prodotta era ancora segnata dalle esperienze precedenti. Le palestre d’arrampicata non erano ancora diventate “falesie” e rimanevano luoghi di formazione: luoghi di sosta e di partenza per nuove avventure. Forse non fu chiaro ai più, che i mitici “Cento nuovi mattini” che Alessandro Gogna propose all’inizio degli anni ottanta, erano pur sempre un invito alla ricerca, all’esplorazione, all’avventura in una nuova dimensione del verticale: meno oppressiva, ma non banale sia da un punto di vista tecnico che motivazionale. Dove la “ri-creazione” (e non la ripetizione, come veniva spiegato nella presentazione; che merita una rilettura…) della via dava senso e gioia ad una pratica in via di definizione. Una sollecitazione a muoversi in nuovi territori alla ricerca di nuove emozioni; tutto l’opposto di una ricerca di sole nuove prestazioni.
27
La Pietra di Bismantova - foto Nicola Bertolani
Il messaggio, come detto, non fu ben compreso e, travolto da un’enorme, immediato, interesse per la fisicità della proposta, non tardò a “spiaggiarsi” negli interessi del mercato; non ci fu più il tempo, la voglia e lo spazio per chiarirlo. Qualcuno provò ad avvertire del pericolo di una disarticolazione (leggere Motti nella sua Enciclopedia della Montagna), ma prevalse una semplificazione che fece comodo a tutti.
Ci siamo arresi all’idea che le diverse specialità (dall’escursionismo alle ferrate, dal boulder al monotiro alla cosiddetta arrampicata libera ben protetta, dallo scialpinismo alle cascate, dalla plastica alle competizioni, ecc.) fossero indipendenti l’una dall’altra, portate ognuna da una propria cicogna e portatrici ognuna di specifiche esigenze e identità.
Al contrario! Dovevamo urlarlo ma non l’abbiamo fatto: è stato il seme di Balmat, di Paccard, di Carrel, di Winkler e di molti altri, che ha ingravidato la montagna e le ha fatto partorire tutti noi. Sì, anche l’agonista della velocità su resina e quello che prova per una stagione quei pochi metri di roccia ben protetta; solo che loro non lo sanno e nessuno si prende la briga di dirglielo, per evitare il rischio di patetiche discussioni da reduci o gli sbadigli supponenti dei più.
E invece… penso che sia stia aprendo uno spiraglio per riprendere un percorso interrotto oltre trent’anni addietro. Me ne sono vieppiù convinto l’altro giorno, gironzolando dalle mie parti, alla Pietra di Bismantova alla luce del tramonto, sotto i monotiri del Torrione Sirotti: roba dura. Ragazzi e ragazze (l’ho detto tante volte: il più bel dono della cosiddetta arrampicata libera) abili e gioiosi, pur nell’ingaggio richiesto dalle difficoltà. Faccio il “reduce” e li provoco con nomi di cime e vie dolomitiche, avendo la presunzione di indicare loro “la via giusta” alla montagna.
Mi zittiscono elencandomi, orgogliosi e non spocchiosi, una serie di vie blasonate ripetute di recente, dalla Roda di Vael al Brenta alle Lavaredo, e mi parlano dei futuri progetti.
Intravedo nei loro occhi quella luce che ho conosciuto, e nell’imperfezione della descrizione di luoghi e cime, un desiderio di saperne di più, e una certa disponibilità a farsi aiutare da qualcuno che per quel percorso c’è già passato. Sono salito sul pianoro sommitale, scusandomi della mia presunzione, e mi son detto che potevo e dovevo accettare l’invito di Matteo Bertolotti a scrivere questo articolo.

28
In arrampicata al Torrione Sirotti - foto Nicola Bertolani


“Uniti siamo tutto discordi siamo nulla” ammoniva il mio conterraneo Camillo Prampolini a fine ottocento del millennio scorso, in un ben altro contesto. Un ammonimento che ci può tornare utile, in un periodo nel quale mi pare si sia indebolita la “spinta propulsiva” verso l’alpinismo e le sue motivazioni, storica prerogativa del CAI, ma nel quale, per contro, mi pare possa prendere vigore un “desiderio d’alpinismo” da parte di giovani falesisti (lasciatemi semplificare…) insospettabile fino a poco tempo fa. Ragazzi che non ripudiano e non rinunciano alla falesia, ma sono incuriositi e spinti da nuovi interessi e da qualche ritrovato “valore”; anche come reazione ad un narcisismo ripetitivo del gesto che inaridisce la fonte del divertimento. Senza parlare, poi, della fisiologica trasgressività
generazionale verso l’eccesso di codici e canoni sociali omologanti e condizionanti che, in nome di false sicurezze, limitano creatività, autonomia e responsabilità.
Insomma: “C’è vita in falesia” e credo ci sia la possibilità di un rinnovato protagonismo del CAI per recuperare, riordinare ed indirizzare la galassia degli appassionati, ad ogni livello, sparpagliati in mille luoghi e forme.
Certo, occorre ora saper pazientemente ricucire rapporti, pensieri, generazioni, per ridare loro quel peso politico oggi indispensabile per fronteggiare un’insensata tendenza alla società “securitaria” che produce ordinanze, divieti, limitazioni, prescrizioni, vincoli.
Occorre saper indicare la via giusta (ammesso che ne esista una sola) tra prestazioni ed emozioni, tra frequentazione e conservazione, tra il “confezionato” e l’avventura.
E chi se non il CAI potrebbe riprendere la direzione di questo vasto e disunito movimento? Ricongiungendosi con le proprie articolazioni (Guide, Soccorso Alpino e Accademico sembrano quasi associazioni a parte…), rivedendo e semplificando la ridondanza degli Organi Tecnici, dando spazio e tutela alla creatività, alla responsabilità, alla visibilità delle sezioni e alle competenze dei volontari che le reggono. Promovendo un migliore e più argomentato “ascensore sezionale” verso l’alpinismo, e motivando a questo obiettivo le grandi risorse già presenti (alpinismo (!) giovanile, escursionismo, ecc.), così apprezzate e richieste.
Ridimensionando norme, “titoli” e gerarchie che, pur motivati dal desiderio di offrire sempre maggior qualità, rischiano di rimanere il fine di pochi e non il mezzo per molti; lasciando comunque insoluto il problema delle responsabilità individuali e collettive. Gli esempi non
mancano. Tra l’altro, penso che quest’ultimo aspetto non riguardi solo il CAI ma la sterminata platea del volontariato italiano, così osannato in ogni occasione, ma scarsamente tutelato in quanto tale.
Ricercando, nel CAI e nelle sue sezioni, la dimensione territoriale e numerica più idonea a sviluppare condivisione, autoresponsabilità, autogoverno, iniziativa; in altre parole rilanciando con coerenza l’immagine del “sodalizio” che, mi pare, da qualche tempo abbia lasciato il posto a quella di “agenzia di servizi”. Spesso ottimi, qualificati, richiesti, ma “gracili”, visto il proliferare di molte altre agenzie, se non fortemente ancorati alla storia e all’art. 1 dello statuto.
Certo l’alpinismo, anche quello che si cimenta sui gradi inferiori della scala delle difficoltà, rimarrà comunque un’attività piuttosto selettiva rispetto alla gran massa di turisti, escursionisti, villeggianti, studiosi che frequentano le terre alte, e non potrebbe essere altrimenti considerando i rischi che inevitabilmente comporta (che terrorizzano mamme mogli e morose), ma senza l’Alpinismo la montagna sarebbe come un piatto insipido: più difficile da far apprezzare a tutti i suoi frequentatori.
31
Il Dente del Gigante - foto di Luca Galbiati
A MATTEO DELLA BORDELLA
Il suo stile parla chiaro. Basta dire “by fair means” per capire di cosa stiamo parlando: solo mezzi leali, nessun artifizio. La più bella dichiarazione d’amore che un alpinista può fare alla montagna. È questo l’approccio di Matteo Della Bordella al mondo verticale. Ritenuto uno dei più forti alpinisti della sua generazione Matteo scopre la bellezza dell’arrampicata durante l’adolescenza, quando insieme al papà Fabio si diverte in falesia tra prese e appigli arrivando ad affrontare il mitico Pesce, in Marmolada. Ma l’avventura, quella con la A maiuscola, arriva quando i Ragni di Lecco (di cui sarebbe poi diventato Presidente) lo invitano a diventare parte del gruppo. I Ragni sono un gruppo di elitari scalatori cresciuti tra la Grigna e le montagne limitrofe. Alpinisti visionari, che negli anni hanno tracciato linee superbe sulle montagne più belle del Pianeta. Le stesse di cui si sarebbe innamorato
Matteo quando, nel 2011, raggiunge per la sua prima volta la Patagonia. L’obiettivo? L’apertura di una linea sull’allora inviolata parete ovest della Torre Egger, l’ultimo grande problema della Patagonia. La salita gli richiede tre spedizioni, la costanza e la capacità di continuare a perseguire un certo tipo di strada senza lasciarsi abbattere dai continui fallimenti a cui la parete lo sottopone. Dopo sono venute altre linee, tutte tecniche e difficili, tra Patagonia, Himalaya e Alpi, dove lo spazio esplorativo esiste, ma richiede occhi esperti. Matteo oggi è una conferma per l’alpinismo italiano, grazie alla sua attività continua che ogni anno lo porta in spedizione alla ricerca di nuovi obiettivi e nuove linee ancora da tracciare. Chi, se non un alpinista così attivo e in continua ricerca, può fornirci un quadro su quello che è lo stato dell’alpinismo italiano oggi?

32
Matteo
Della
Bordella
con
Arianna Colliard
in
cima al Naranjo de Bulnes, Picos
de Europa INTERVISTA
a cura della Redazione
Matteo, partiamo da una considerazione generica. Negli ultimi vent’anni hai visto cambiare qualcosa in Italia?
Quando ho scelto di dedicare la mia vita professionale al mondo dell’alpinismo c’erano meno ragazzi tra i 20 e i 30 anni in giro con progetti e realizzazioni interessanti. Oggi è più facile trovare compagni di cordata o essere coinvolti da idee nuove e fresche, semplicemente perché è cresciuta la comunità.

Sicuramente negli anni ho visto crescere il numero degli appassionati praticanti e con loro è cresciuto anche il livello, sia quello tecnico, sia quello legato alla scelta degli obiettivi. Basta guardare a quest’ultima estate per comprendere quanto il livello sia alto.
Cosa intendi?
Ci sono state tante spedizioni interessanti. La cordata valdostana che con una semplicità disarmante ha raggiunto gli Ottomila, con le salite in velocità di François Cazzanelli. Quella di Francesco Ratti, Alessandro Baù e Leonardo Gheza, che ha aperto una nuova via sulla parete est dell’Uli Biaho Spire, in Karakorum. E ancora Federica Mingolla e Niccolò Bartoli partiti alla volta del Kirghizistan, dove hanno tracciato un nuovo itinerario su big wall. Ma anche la nostra spedizione in Perù, con la SMAM (Sezione Militare di Alta Montagna).
Quattro spedizioni, con quattro obiettivi di prestigio anche a livello internazionale. Anni fa, se tutto fosse andato bene, ne avresti avuta una o al massimo due.
Secondo te a cosa va il merito di questo? Una migliore comunicazione?
In realtà trovo un sempre maggior distacco tra la percezione e la comunicazione dei veri valori alpinistici. Per spiegarmi meglio trovo che ci sia una sempre maggior separazione tra chi realizza salite interessanti e chi invece riesce a raggiungere un pubblico mainstream grazie alla comunicazione. Sono molti gli alpinisti italiani, oltre a quelli già citati, che ogni anno terminano la stagione con un curriculum ricco di realizzazioni. Molto spesso però la maggior parte rimane argomento di discussione tra noi del settore. Mentre altre prestazioni, molto meno interessanti, riescono a raggiungere un vasto pubblico, grazie a un grande lavoro di comunicazione. Ecco trovo che ci sia una separazione sempre più grande, come se fossero due mondi completamente diversi. Qualche anno fa questa era meno marcata, forse anche perché le realizzazioni erano numericamente inferiori.
Questo può avere delle conseguenze?
Nel settore no, ma agli occhi di un appassionato esterno a questo mondo può avere un’influenza importante. Perché diventa difficile distinguere tra le varie salite, tra quelle che effettivamente meritano un posto nella storia dell’alpinismo e quelle che, pur rimanendo prestazioni sopra la media, non portano a una crescita o a uno sviluppo dell’ambiente alpinistico italiano. Ma, al contrario porta a un inaridimento dell’ambiente.
Se esiste un colpevole, a chi va imputata la colpa?
È colpa di tutti. Sia nostra, che a volte non badiamo molto agli aspetti comunicativi, sia dei giornalisti che dovrebbero avere le competenze per distinguere tra una salita e l’altra senza inseguire le mode o i nomi del momento. Credo sempre più fermamente che la crescita non arrivi dal business, ma dalla voglia di ingaggiarsi con qualcosa di nuovo e ancora sconosciuto. Secondo me è questa la chiave a cui dovremmo guardare per scovare nuovi talenti e per trovare una crescita alpinistica.
Pensi esista un divario tra il livello italiano e quello estero?
No. All’estero ci sono tanti forti alpinisti, ma noi in Italia abbiamo tutte le capacità per fare qualcosa di bello, e lo facciamo! La differenza principale che noto tra Italia ed estero sta proprio nella comunicazione: gli alpinisti più comunicati sono anche quelli che effettivamente lavorano per portare qualcosa di nuovo, per innovare questo mondo.
33
In arrampicata in Canton Ticino sulla via Leap of Faith al Poncione d’Alnasca
Basta guardare alla comunicazione di Alex Honnold, il suo livello è altissimo, così come la sua comunicazione è ormai globale. Dovremmo prendere spunto, mentre a livello di capacità non abbiamo nulla da invidiare.
Andiamo verso la fine di questa intervista. Cosa vedi nel domani dell’alpinismo italiano?

Sicuramente oggi è più facile trovare compagni di cordata con cui condividere progetti, anche impegnativi. Già solo una decina di anni fa trovare la giusta persona era molto più difficile. Se poi penso a tutto il movimento e guardo quante proposte di spedizioni ricevo ogni anno, non posso che essere felice per la frenesia con cui tutto si sta muovendo. È come se avessimo messo l’acceleratore e penso che per un bel po’ di anni ancora andremo avanti in un crescendo di opportunità.
Una tua sensazione o motivata da qualche esempio?
Si possono solo ipotizzare risposte. Può essere una moda?
Per qualche ragione le persone sentono l’esigenza di andare in montagna, di scoprire cosa si cela oltre i boschi, sulle pareti verticali. Io penso che i numeri continueranno a crescere ancora, ma potrei anche sbagliarmi. So anche che, come avviene in tutti i campi, prima o poi la curva raggiungerà il suo apice e inizierà a scendere. Ovviamente spero di no, ma spero anche che l’alpinismo mantenga la sua sfera, sicuramente più allargata, senza diventare così mainstream come il calcio.
Secondo te il CAI può essere un valido aiuto per i giovani che vogliono approcciarsi al mondo verticale?
Per iniziare sicuramente si, può avere un ruolo centrale. Nel CAI ci sono tante scuole con istruttori esperti e preparati, oltre ai numerosi corsi di avvicinamento offerti dalle sezioni. Quando però, con tutte le conoscenze e l’esperienza del caso, si iniziano a immaginare salite di alto livello credo che si debba andare con le proprie gambe. Quello che il Club Alpino potrebbe fare è la creazione di corsi per giovani che già hanno un buon livello. Una sorta di scuola di alta specializzazione alpinistica, che permette a questi ragazzi di formarsi e magari raggiungere il traguardo di una spedizione extraeuropea. Non è un’idea innovativa, ma qualcosa che già esiste in Austria, Svizzera, Spagna e molti altri Paesi con risultati ottimi. Questo permette di scovare nuovi talenti e di offrigli la giusta formazione per inseguire la loro passione alla ricerca della via meno battuta.
34
Sul Cerro Torre lungo la via dei Ragni - foto di
Nicola Lanzetta

A FRANÇOIS CAZZANELLI
cura della
Nato all’ombra del Cervino, in un freddo giorno del gennaio 1990, la sua vita è stata segnata ancor prima di venire al mondo. I cognomi Cazzanelli, da parte di padre, e Maquignaz, da parte di madre, sono legati al mestiere di Guida Alpina da oltre un secolo. Così anche François Cazzanelli, raggiunta la maturità ha scelto di prendere picche e ramponi trasformandoli in attrezzi da lavoro. La sua quotidianità è fatta di albe frizzanti d’alta montagna, di corde che scorrono, di roccia e di ghiaccio. Sul Cervino è salito quasi 100 volte e la passione l’ha portato alla scoperta delle più alte montagne della Terra, su cui ama mettersi alla prova con salite in velocità, a tempo di cronometro. Negli anni l’abbiamo visto salire e scendere dal Manaslu, in sole 17 ore e 43 minuti! L’estate 2022 ci ha invece raccontato di una salita sul Nanga Parbat, per una via parzialmente nuova lungo la parete Diamir; di una bella prestazione sul Broad Peak, sfortunatamente interrotta oltre quota ottomila
dove François sceglie di fermarsi in soccorso a un alpinista britannico precipitato e poi deceduto; e ancora sul K2, un sogno coltivato per anni e condiviso con l’amico e maestro Marco Camandona.
Ma l’alpinismo di François Cazzanelli non si ferma agli ottomila con il cronometro. Nel suo curriculum ci sono nuove vie sul Cervino, un nuovo itinerario sul Pilastro Rosso del Brouillard. Una cavalcata invernale attraverso Catena Furggen, Cervino, Catena delle Grandes Murailles, Catena delle Petites Murailles. Scalatore poliedrico dal 2012 è membro della storica e rinomata Società Guide del Cervino, mentre prima è stato un atleta di alto profilo, parte della nazionale italiana di sci alpinismo, e ancora oggi continua a gareggiare nelle più importanti competizioni internazionali su lunga distanza. Chi, meglio di lui, può portarci all’interno del variopinto panorama alpinistico italiano?

36
INTERVISTA
a
Redazione
François, pratichi il mestiere di guida alpina da 10 anni. Ripensando ai primi anni noti delle differenze in chi si avvicina al mondo alpinistico?

Oggi noto un crescente afflusso di persone in montagna. Sia sui sentieri, che sulle classiche vie alpinistiche si incontrano sempre più cordate appassionate e vogliose di scoprire il nostro territorio. Quello che non è cambiato è l’approccio.
Cosa intendi?
Molte persone si approcciano alla montagna in modo corretto e preparato, con le idee chiare su quelli che sono i percorsi e gli iter da seguire per assorbire determinate nozioni. In molti altri casi si incontrano persone non del tutto formate su itinerari che richiedono preparazioni specifiche. Questa differenza, ovviamente, emerge in modo ancora più evidente al crescere dei numeri. Sicuramente chi si avvicina alla montagna grazie a un percorso di formazione con le guide alpine, o con il Club Alpino, ha un approccio più professionale e competente.
La crescita del numero degli appassionati si rispecchia in una crescita del livello alpinistico? Sicuramente in Italia l’alpinismo sta vivendo una fase
fiorente, di riscoperta. Questo grazie a nomi come quelli di Matteo Della Bordella, Federica Mingolla, Luca Schiera, Tomas Franchini, David Bacci e molti altri. Ognuno con il proprio stile sta costruendo un percorso, ovviamente personale, di cui giova tutto l’alpinismo italiano grazie a prestazioni e idee fresche che portano qualcosa di nuovo nell’ambiente. Tra tutte quelle che abbiamo potuto vivere e seguire quest’estate mi viene subito in mente la spedizione di successo portata avanti da Francesco Ratti, Alessandro Baù e Leonardo Gheza sull’Uli Biaho. Purtroppo è stata poco mediatizzata, ma il risultato è veramente notevole e importante.
Abbiamo tanti validi esponenti, che stanno cancellando il mito dell’alpinista super eroe. Siamo una generazione di ragazzi che vive di una passione incredibile e totalizzante. Abbiamo voglia di metterci in gioco prima di tutto per soddisfare il nostro desiderio esplorativo, senza bisogno di sentirci migliori o peggiori degli altri.
Abbiamo qualcosa da invidiare al mondo estero? No. Spesso si pensa che l’erba del vicino sia sempre la migliore, ma non sempre è così. In Italia abbiamo una lunga tradizione alpinistica e continuiamo a coltivarla, e a innovarla grazie a realizzazioni e competenze di altissimo livello.
All’estero ci sono molti fuoriclasse, anche figure da cui prendere spunto e grazie a cui iniziare a immaginare quello che potrebbe essere il futuro. Uno tra tutti secondo me è Tom Livingstone. Un ragazzo della nostra generazione che guarda due passi avanti rispetto agli altri. Ma anche Alex Honnold o Tommy Caldwell.
Quindi, ci stai dicendo che il futuro arriva dall’estero? No, non voglio essere frainteso! All’estero, come in Italia, c’è una base di alpinisti preparati e forti, capaci di grandi prestazioni, mentre i nomi che davvero possono illuminare una strada per il futuro si contano sulle dita di una mano. Esattamente come accade qui da noi: abbiamo una base che spicca ogni anno per il numero di spedizioni e di realizzazioni, da questa emergono poi quei nomi che davvero stanno scrivendo nuove pagine di storia dell’alpinismo. Loro, insieme agli alpinisti esteri, devono essere i punti di riferimento per chi vive la passione ricercando un continuo miglioramento.
Spostiamoci per un attimo in Himalaya. Tra i tuoi obiettivi alpinistici degli ultimi anni ci sono anche gli Ottomila. Si può ancora portare innovazione a quelle quote o lo spazio è terminato? Sostengo da sempre che l’alpinismo non finirà mai finché gli alpinisti avranno fantasia. Quello che forse manca oggi
37

sugli Ottomila non è tanto lo spazio per fare qualcosa di nuovo, ma il fatto che pochi alpinisti osano mettersi in gioco seguendo una strada diversa da quella perseguita dalla maggior parte degli scalatori. Inoltre, penso ci sia una grande mancanza dal punto di vista della comunicazione.
In che senso?
Soventemente, ma non sempre, si tende a fare di tutta l’erba un fascio. Che sia una via nuova, una solitaria o una salita in velocità se vengono realizzate durante il periodo di maggior afflusso, quando le agenzie portano in quota i clienti, spesso vengono messe sullo stesso livello della salita fatta con il supporto di un team di portatori. Quello che intendo dire è che non ci sono solo le invernali sugli Ottomila, basta guardare alle realizzazioni di molti forti scalatori degli ultimi anni. Cerchiamo spazio sulle più grandi montagne della Terra? Esiste! Basta guardarsi intorno per trovare vie vergini, itinerari nuovi. Serve l’originalità per uscire dal tracciato battuto e immaginare nuovi stili e nuove possibilità.
Quando non sei sugli Ottomila, ti dedichi a un alpinismo tecnico… sei molto polivalente… La polivalenza è sicuramente la qualità che più apprezzo di me stesso. Se dovessi pensare alla mia vita come focalizzata su un unico obiettivo mi annoierei dopo poco. Variare, cambiare ambiente e stile rende molto più variegata la mia attività, e anche le mie possibilità.
Cerchiamo di tirare le somme su tutto quanto emerso in questa intervista. Secondo te quale può essere il ruolo del CAI nel panorama alpinistico italiano?
Penso che si debba lavorare molto sulla comunicazione, per far conoscere il nostro mondo e renderlo più appetibile. Far comprendere cosa significa vivere le montagne nella loro sfumatura verticale. Sicuramente attraverso il CAI e le Guide Alpine si possono avvicinare i giovani attraverso gli step più corretti, fornendo una preparazione di base fondamentale per un primo approccio al terreno senza traumi che, al contrario, non fanno altro che allontanare le persone.
Il secondo step sta nel far crescere i talenti, nel fornirgli l’opportunità e gli strumenti per alzare il proprio livello, per guardare alle montagne ricercando un obiettivo da perseguire.

Quali sono gli strumenti che secondo te vanno forniti per scovare nuovi talenti?
Fornire ai ragazzi il numero di Marco Camandona. (ride) A parte le battute figure come Marco Camandona, Franco Nicolini e molti altri sono fondamentali per il lavoro di volontariato che stanno portando avanti nelle loro valli avvicinando sempre più giovani al mondo della montagna. Grazie alle loro competenze permettono anche ai giovanissimi di scoprire la bellezza delle terre alte e dello sport in ambiente outdoor, poi starà a ognuno di loro scegliere la strada da seguire. Chi diventerà guida alpina, chi un fuoriclasse dello sci alpinismo, chi andrà verso mete lontane a disegnare itinerari visionari. Loro lo fanno a titolo personale, ma l’ideale sarebbero delle strutture organizzate. Ricordandoci sempre che l’obiettivo non è scovare fuoriclasse, ma nuovi amanti della montagna vogliosi di portare la loro fantasia sulle cime alpine e del mondo.
39
A FEDERICA MINGOLLA
Torinese, 27 anni, vive in Valle d’Aosta. Alla montagna ha scelto di dedicare la sua vita professionale, ma questa è prima di tutto una grande passione. Stiamo parlando di Federica Mingolla, la conferma femminile dell’alpinismo italiano. Avvicinatasi alla montagna da giovanissima, grazie al papà, Federica scopre l’arrampicata sportiva a 14 anni, innamorandosene istantaneamente. Ai primi approcci seguono le competizioni sportive, che la consacrano tra le migliori a livello italiano ed europeo. Ben presto nasce però la voglia di sperimentare e mettersi alla prova su terreni inviolati. Il richiamo all’alpinismo è grande. Talmente grande da spingerla in poco tempo verso la ricerca di spazi sempre nuovi e motivanti. Nascono così ripetizioni da sogno, come quella di Digital Crack (8a), sul Monte Bianco. Federica è la prima italiana e la seconda donna al mondo a riuscire nella salita di quella che è ritenuta una delle più difficili pareti del Monte Bianco. Poco dopo tocca alla Via Attraverso in Pesce,

icona della Marmolada, su cui Federica segna la prima libera femminile. E ancora Tomowak Dance, al Caporal. Ma la vita di Federica è fatta anche di spedizioni extraeuropee e nuove vie. In Pakistan è stata due volte, nel 2017 e nel 2022, riportando sempre interessanti risultati alpinistici. Senza dimenticare le esperienze in Groenlandia e sul Monte Bianco. A completare il ricco pacchetto di esperienze che caratterizzano il curriculum di Federica Mingolla, la scelta di intraprendere il percorso per diventare guida alpina.
Federica, che significato dai al mestiere di guida alpina? Penso che questo lavoro non debba ridursi all’aiuto di chi si accompagna. Il rapporto tra guida e cliente deve essere prima di tutto umano, ed è su questo che ritengo debba essere fondato il rapporto di fiducia per le salite che si intendono realizzare insieme.
40
La parete sud della Marmolada INTERVISTA
a cura della Redazione
Non sono ancora molte le donne che scelgono questa professione in Italia…
Ci sono molte donne che vanno in montagna, tante appassionate. Quelle che scelgono il professionismo sono poche, è vero. È una strada che richiede passione e molto tempo. Oggi, purtroppo, andare in montagna rimane un’attività complicata per le donne. Spesso, quando si ha la maturità per vedere nella montagna determinati obiettivi, si è anche in quella fase della vita dove bisogna prendere delle decisioni tra famiglia e carriera. La società ancora oggi vede nella donna un determinato ruolo e servono ancora cambiamenti prima di avere un’immagine del tutto emancipata dai vecchi canoni. Le donne hanno il potenziale per fare meglio degli uomini, per realizzare prestazioni interessanti e che davvero possono aggiungere qualcosa alla storia dell’alpinismo.
A proposito di alpinismo, in che fase siamo in Italia? Qual è il nostro livello?
Abbiamo un livello molto alto, anche se forse non ce ne rendiamo conto. Basta guardare le salite che si realizzano ogni anno, sia sulle nostre Alpi sia sulle più importanti montagne del mondo per comprendere quanto sia ricco l’attuale panorama alpinistico italiano. Sugli Ottomila
spiccano i nomi degli alpinisti italiani che portano a termine nuove realizzazioni e salite in velocità. Ogni anno abbiamo due o tre spedizioni che raggiungono pareti inviolate in luoghi remoti del Pianeta, mettendosi alla prova con difficoltà estreme. Cosa potremmo chiedere di più?
Secondo te, quindi, non manca nulla all’alpinismo italiano?
Forse la consapevolezza dei propri limiti da parte di molti appassionati.
Cosa intendi?
Oggi andare in montagna è molto più facile, grazie sia allo sviluppo dell’attrezzatura sia grazie ai minori costi.
Anche grazie a questo stiamo assistendo a un aumento esponenziale degli appassionati. Ben venga, ma con maggior formazione. Non tutte le montagne sono accessibili senza una preparazione specifica. Serve sia per gestire la salita in sicurezza, sia per evitare brutte conseguenze. Per questo consiglio sempre a tutti quelli che mi scrivono di seguire corsi e formarsi quando vogliono fare qualcosa che va oltre il trekking.
Secondo la tua esperienza negli anni sono aumentate le persone che si rivolgono a una guida alpina o a un corso di alpinismo?
Non saprei quantificare rispetto al passato. Posso però dire che oggi molte persone scelgono di chiamare una guida alpina, almeno per le prime uscite. Anche i corsi hanno un sempre maggior successo tra gli appassionati.
Oltre a quanto viene già fatto, quale potrebbe essere in futuro il ruolo dei corsi?
Sia il CAI che le guide alpine attraverso le loro attività formative possono diventare luoghi di formazione per bravi alpinisti. Oltre a fornire le informazioni basilari per un approccio in sicurezza alla montagna possono diventare trampolino di lancio per nuovi talenti, che poi devono avere la voglia e la forza per continuare in autonomia la propria strada. Certo, avere un maestro all’inizio è un grande aiuto.

41
In arrampicata al Monte Bianco
ALPINISMO, CAI E GUIDE
Martino Peterlongo
La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera ha deciso di realizzare un approfondimento sul tema dell’alpinismo in vista del congresso degli Istruttori Nazionali del prossimo ottobre.
Mi è stato chiesto un intervento su questa rivista sul tema delle possibili collaborazioni e sinergie tra il Club Alpino Italiano e il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane per lo sviluppo dell’alpinismo nel nostro paese. Ho accettato con piacere poiché non ritengo scontato l’aver ricevuto questo invito.
Il tema è ovviamente impegnativo e molto aperto.
Per non rischiare l’inutilità vorrei circoscrivere le mie riflessioni sulle pratiche dell’alpinismo su roccia e, solo limitatamente, di quello su neve e ghiaccio. E vorrei avanzare la proposta di pochi progetti pratici che, almeno in questo inizio, potrebbero interessare la collaborazione tra il Club Alpino Italiano e le Guide Alpine.
Vorrei iniziare con alcune riflessioni che spero siano condivisibili.
L’alpinismo non è una pratica univoca o almeno non lo è più per l’appassionato medio. Si è specializzato e compartimentato in discipline (vie ferrate, arrampicata su roccia, cascate di ghiaccio, arrampicata in alta montagna, scialpinismo, sci fuoripista con l’ausilio di mezzi meccanici, ecc.) che hanno i propri appassionati e comunità di riferimento. Alcune sono diventate discipline sportive agonistiche e sono entrate o stanno entrando tra gli sport olimpici. In generale tutte sono accomunate dal crescente numero di praticanti e dalla motivazione di muoversi all’aria aperta e in un contesto che valorizzi il senso dell’avventura.
L’alpinismo è, anche, un insieme di valori che accomunano o dovrebbero accomunare le diverse pratiche e che sono meritevoli di essere conservati. È stato nominato, non da molto, patrimonio immateriale dell’Unesco.
L’alpinismo è, in ultimo (ma per me solo per la presente elencazione), un patrimonio materiale di itinerari che percorrono le montagne e che è altrettanto meritevole di
essere conservato e lasciato alle prossime generazioni. Auspicabilmente non solo come testimonianza “museale” delle imprese e dell’audacia degli alpinisti (di alcuni uomini che hanno segnato la storia dell’alpinismo). Penso che, non da oggi ma da almeno due decenni, ci troviamo ad affrontare due fenomeni complessi che stanno trasformando l’alpinismo dalla sua forma “classica” ad una che potremmo chiamare “sportiva” o che i più scettici potrebbero definire una non forma o uno stato di anomia. Il primo è l’inversione del rapporto di iniziazione all’alpinismo. Quando ho iniziato ad arrampicare, non avendo parenti alpinisti a cui affidarmi, i miei genitori mi hanno fatto iscrivere al corso di alpinismo della Scuola Graffer di Trento, ho cominciato ad andare in Dolomiti e nelle palestre di roccia della mia città (al tempo un luogo minore dove allenarsi). Poi ho “scoperto” l’arrampicata in falesia che di sportivo aveva poco. Penso che questo sia stato il percorso di molti miei coetanei a cavallo tra gli anni ottanta e novanta dell’ormai secolo passato (sic!). Chi oggi si avvicina all’arrampicata non trova più “disponibile” questo percorso. Il numero di persone che arrampicano è aumentano ma il modo in cui si avvicinano all’arrampicata ha cambiato direzione: dalla falesia e, in particolare, dalle palestre indoor all’alpinismo. E, in modo ancora molto disperso in termini di luoghi, in numeri limitati.
Il secondo è il cambiamento climatico e l’evidente degrado delle condizioni della montagna (soprattutto di quella alta). Cominciamo a parlare di versanti o itinerari alpinistici non più possibili o difficilmente frequentabili se non in periodi limitati e con molta attenzione.
Per quanto questi fenomeni non siano correlabili, la conseguenza evidente di entrambi è che molti itinerari e molte montagne stanno subendo o potranno subire nel futuro un processo di abbandono (o minor frequentazione), degrado e conseguente ulteriore abbandono. A fronte del sovraffollamento di aree o itinerari che per le loro caratteristiche vedono affluenze e picchi di frequentazione
42

43 Sopra e nella pagina successiva - Foto di Martino Peterlongo



46
(stagionali e nei fine settimana) che diventano pericolosi. Prendersi cura delle montagne e del patrimonio materiale e immateriale espresso dalla pratica dell’alpinismo è uno dei compiti più importanti che spetta alle nostre associazioni (indipendentemente dalla forma in cui è svolto, professionale o volontaria). Altrettanto importante è prendere una posizione di merito e farsi interpreti del turismo dell’alta montagna, dei suoi trend, dei suoi modi di frequentazione e utilizzo. Se non lo facciamo o lo facciamo “sottovoce”, lo faranno altri soggetti.
In questo momento la mia personale posizione è che il modo corretto di frequentare la montagna sia basata sul rispetto dell’ambiente (se vogliamo possiamo anche chiamarla sostenibilità ambientale), un’etica trasparente e consapevole che non spinga oltre il limite personale tecnico e umano, che non finisca in errori grossolani causati dalla poca conoscenza dei fenomeni naturali della montagna e dalla sopravalutazione delle proprie capacità (l’inglese “overconfidence”) e impegni di conseguenza risorse umane ed economiche in soccorsi non necessari.
Su questi temi penso ci siano possibilità di avviare concreti progetti di comune interesse. Nel recente passato in forma locale ci sono già state alcune iniziative che hanno avuto apprezzamento e che potrebbero essere usati come modelli virtuosi. Penso alla rivisitazione e risistemazione delle falesie in Lombardia e nella Valle del Sarca e di alcune vie alpinistiche nella Grigna Meridionale e in Corna di Medale e alle vie normali nei gruppi dolomitici del Brenta e delle Pale di San Martino. E oggi il progetto di risistemazione delle falesie italiane proposto dalla CNSASA e finanziato dal Consiglio Centrale del Cai.
Tutti questi progetti sono accomunati dalla volontà di permettere un’“offerta” più ampia delle possibilità del territorio e una frequentazione “sicura” delle falesie e delle vie alpinistiche, per quanto possibile. Dove “sicuro” significa cercare di minimizzare i pericoli ambientali più frequenti attraverso le opere di disgaggio, pulizia e sostituzione del materiale alpinistico (chiodi, cunei, cordoni, tasselli meccanici, ecc.) che si usurano e perdono di affidabilità. Mentre non significa sottrarre gli alpinisti alla personale responsabilità del controllo dell’ambiente (“cosa sta succedendo intorno a me?”) e dell’uso delle attrezzature e delle tecniche alpinistiche (“so usare in maniera appropriata il materiale che ho addosso?”). So che questi progetti hanno toccato e toccano sensibilità e storie personali e suscitano dibattiti anche accesi. Ma se qualcosa di significativo è stato fatto fino ad oggi anche in zone con una lunga tradizione alpinistica, ciò vuol dire che possono essere estesi e portati avanti.
Perché abbiano successo ovvero trovino più apprezzamenti che polemiche sono necessari competenza nella stesura dei progetti e coinvolgimento di tutti gli attori in campo per raggiungere un accordo sui criteri di intervento e manutenzione.
Non ultimo, per quanto molto difficile da fare e valutare nei suoi risultati concreti, è necessario insistere e comunicare l’esercizio personale della responsabilità. La formazione di base fa parte degli scopi istituzionali delle Guide Alpine e delle Scuole del Cai. Entrambi ci troviamo a contrastare una comunicazione “sensazionalistica” le cui conseguenze si vedono dopo ogni incidente di alta montagna che raggiunge i criteri della notiziabilità. Grazie.

47
A sinistra: foto di Martino Peterlongo - sopra: disegno di Caio - www.caiocomix.com
RIMETTERE L’ALPINISMO AL CENTRO DELLE SCUOLE
Davide Martini
È risaputo che dobbiamo confrontarci con una società oggi, molto diversa da quella di pochi decenni fa: modalità lavorative, esigenze famigliari, reperimento d’informazioni ed esperienze note su cui estrapolare una propria azione e il tempo disponibile, sono tutti parametri essenziali mutati profondamente. Questo vale maggiormente per la montagna. La frequentazione è molto cambiata: tante persone, molte più di prima, vanno in montagna ma proprio per questa crescita ne è cambiato il modo, la modalità operativa ed i tipo di flusso. La montagna è diventata solo una delle tante offerte ludico/attrattive che si trovano oggi disponibili sul mercato e quindi l’approccio, primitivo, è solo e spesso quello del provare, del fare una cosa nuova, dell’esperienza occasionale. Non c’è approfondimento, non c’è desiderio vero o passione (*). Come dire, oggi proviamo rafting, domani facciamo una gara in go-kart, dopodomani c’è la montagna e per finire cucina etiope. Siamo solo una delle tante cose diverse nella routine che possiamo provare. Pure a bassissimo costo, perché una “giornata Guida” collettiva costa 150-250 euro, mentre uno dei nostri Corsi, che occupa mediamente 5-6 serate ed altrettante 5-6 giornate operative pratiche in ambiente, ha lo stesso prezzo o anche meno. Il CAI è lontano anni luce da quest’ottica. Il suo Statuto e la sua etica, sono saggiamente lontani da questa modalità consumistica.
Stesso discorso vale per la frequentazione di massa che si approccia per le prime volte alla montagna e in modo saltuario, escursionistica o arrampicatoria che sia. Ci sono però persone consapevoli di quello che fanno, che vanno in montagna e realizzano alpinismo e che non hanno legami con il CAI e non sentono il bisogno di averlo. Questo oggi perché è facile trovare informazioni in rete o sulle tante riviste e guide alpinistiche, condividerle; così pure, i luoghi fisici o virtuali d’incontro e confronto sono diventati tantissimi. Possiamo chiederci: fino a pochi decenni fa esistevano altri riferimenti per il mondo della montagna? Non credo, il CAI era l’unica strada. Un luogo, forse l’unico,
dove recarsi per confrontarsi e dove poter trovare chi condivideva le medesime esperienze. Oggi esiste ancora questa necessità?
È rilevante il caso degli alpinisti d’élite. Il CAI oggi non è più presente in questo gruppo, purtroppo in questo mondo esistono o prevalgono solo le sponsorizzazioni. Si diventa “grandi” solo tramite questa modalità e quindi non certo attraverso il CAI. Un tempo non esistevano gli sponsor e gli alpinisti non erano professionisti; spesso erano persone modeste che trovavano una modalità di realizzazione sociale o di sussistenza, attraverso la montagna ed il proprio coraggio. Fu il CAI uno dei primi tramite le Sezioni o le sue strutture Centrali a finanziare le prime esperienze e gli exploit. Oggi questa modalità “sponsor” è prevalente e così il CAI rimane estraneo all’élite. Purtroppo l’aspetto mediatico, oggi imprescindibile, ci penalizza fortemente. Per dire se questa lacuna è bene o male, dovremmo chiederci prima se è questo che vogliamo, se è la condivisione del clamore e dell’atto sensazionale quello di cui abbiamo bisogno, oppure se è solo un atto effimero di debolezza che sembra governare il nostro desiderio.
Abbiamo già ammesso più volte che rimanere distanti dall’arrampicata “sportiva” è stato un errore. Oggi il boom di questo sport penalizza notevolmente il CAI. Sull’aspetto indoor sempre in espansione, anche se è una delle tante opportunità occasionali che propone la nostra società nelle palestre attrezzate delle grandi città, si poteva pensare di attingere persone. Le palestre, salvo qualche caso particolare, sono il punto di riferimento per chi pratica alpinismo e si vuole allenare. Non è il CAI ma è la palestra. Quale enorme bacino di utenza di non alpinisti, ma di persone interessate alla montagna e non solo agli aspetti escursionistici, che il CAI fatica a raggiungere!
Credo che sia fondamentale per il CAI non perdere la propria identità culturale, ovvero non smettere di
48
promuovere una frequentazione delle montagne e anche un alpinismo consapevole. Il CAI deve restare questo, una Scuola, un luogo prima di tutto di formazione e condivisione, non un’agenzia turistica. Per fare ciò però bisogna creare consapevolezza culturale e la strada maestra per farlo è lavorare nelle scuole di primo e secondo grado, nei licei ed in tutti gli istituti superiori scolastici, ovunque e con i giovani. Creare cultura e seminare nei ragazzi il fascino di questa passione.
(*) Lo sappiamo bene come istruttori e ne abbiamo riscontro nei corsi: solo 2-3 persone su 10 sono davvero interessate ad apprendere quanto si propone, per il resto l’interesse primario è sulla performance che si realizzerà, ovvero sulla cima più alta conquistata o sul grado del passaggio che si è “superato” (da secondi di cordata e quindi con tutte le nostre obbiezioni facilitative del caso), ma per i più, perfetti metri di misura del proprio ego da postare immediatamente con l’immancabile “selfie” appena si riprende campo.
Da questa evidenza nasce spesso una crisi d’identità negli istruttori, che da volontari si sentono sviliti da questi giochi emotivi di falso clamore, ma che poi si estinguono pensando a quei 2-3 positivi e nei quali spesso ci si riconosce.

49
Patrick Falsiroli
CASA MATTEO VARESE
Valter, Marina e Giona Pasquetto
Sto immaginando il viso stupito con gli occhi sgranati del lettore abituale de Lo Zaino che, aprendo ad un certo punto la sua rivista, si trova foto di eleganti ed impeccabili giovani musicisti e di improbabili giovani… ‘artisti’ invece che immagini di atletici alpinisti e di splendide montagne… Ma la montagna c’entra anche qui. Nel numero 12 de Lo Zaino (1), Matteo della Bordella scriveva il suo saluto al nostro primogenito, Matteo Pasquetto, Aspirante Guida Alpina di Varese(2), che, sotto i suoi occhi, il 7 agosto 2020 è letteralmente volato via, dopo aver aperto con lui e Luca Moroni ‘Il Giovane Guerriero’, nuova via sulla parete est delle Grandes Jorasses, grande

sogno di tutti e tre. Il giorno del suo 26° compleanno, l’11 agosto 2020, in una gremita chiesa di Entrèves, noi sua famiglia, con la sua compagna, Marta, con numerosissimi amici tra cui anche molti alpinisti, con la sua cagnolina Pandora, abbiamo dato l’ultimo, caldo saluto a Matteo e presentato un desiderio che si è concretizzato prima in un Comitato ed ora in un Fondo: Casa Matteo Varese(3) Perché?
Abbiamo smesso quasi subito di chiederci perché per Matteo la vita si sia fermata così presto, troppo presto, in quel modo poi: conosceva bene la montagna, il Monte Bianco in particolare(4), aveva ottimi voti in sicurezza al Corso Guide. Abbiamo smesso quasi subito di chiederci il perché intuendo che sarebbe stato un esercizio inutile, sterile, che ci avrebbe inchiodati ad un divano a piangere e a maledire la sorte avversa, tradendo la sua memoria, il suo ricordo e compiendo un’ingiustizia grandissima nei confronti di Giona, suo fratello.
Allora nasce il Fondo Casa Matteo Varese perché Matteo ci ha regalato bellezza, entusiasmo, gioia di vivere, un pizzico di follia, competenza, determinazione, senso dell’amicizia e del dovere; senza spocchia, senza mettersi in cattedra: ‘solo’ vivendo, con la giusta dose di allegria e leggerezza. Buttereste via tutto ‘sto bendiddio?
Il Fondo nasce perché Matteo ci ha aiutato a diventare genitori, a capire che i figli vanno lasciati andare anche quando prendono strade difficili, un po’ fuori dallo standard, dove la tua ala di genitore protettivo non arriva. Il Fondo nasce perché ereditiamo un insegnamento profondo da Matteo che sentiamo la responsabilità di condividere il più possibile: se c’è qualcosa per cui vale la pena di vivere, questa è la felicità, intesa come il sentirsi al proprio posto, sulla strada della propria realizzazione, l’aver trovato il campo da gioco del proprio talento che rende felice sé e chi ci sta a fianco. Ricaviamo dai numerosi messaggi dei clienti di Matteo, delle persone che lo hanno conosciuto, questo stile di vita, questa realizzazione piena nonostante la giovane età. ‘Mamma, sono stra-felice!’
50
èIl Maestro Pagano Enrico dirige
l’Orchestra Canova nel concerto
K622
di
Mozart; al clarinetto Giona,
fratello di Matteo, ospite solista per l’occasione
una delle ultime conversazioni telefoniche dopo un’uscita particolarmente appagante con suoi clienti; lo tradurrei così: ‘come mi sento me stesso, come tocco il cielo con un dito, come sono soddisfatto e appagato quando vedo i sorrisi delle persone che ho accompagnato in cima ad una montagna!’ Di nuovo, buttereste via tutto ‘sto bendiddio? Ecco, Casa Matteo Varese nasce proprio per sostenere tutti coloro che a diverso titolo si occupano di liberare i talenti dei giovani, per appoggiare tutte quelle realtà che creano occasioni per le progettualità dei giovani; non sembri una distinzione di lana caprina ma ci teniamo molto: NON sosteniamo progetti che fanno azioni PER i giovani (negli anni ne abbiamo viste troppe e di fallimentari, servite per lo più a sostenere gli Enti che le pensano) ma sosteniamo progetti che, appunto, creano occasioni per i giovani o, meglio ancora, progetti di giovani per i giovani
Ecco allora il nostro sostegno al Maestro Enrico Pagano, fondatore e direttore dell’Orchestra Canova, una delle realtà giovanili più quotate in Italia che si spende molto per creare opportunità di lavoro a giovani talenti della musica(5)
Poi il nostro sostegno al progetto Happiness(6), intuizione di alcuni adulti ma a forte guida di due giovani educatori professionali che hanno aperto le porte e prestato orecchie e cuore per ascoltare gli adolescenti in piena era
post COVID e che si sta trasformando in un laboratorio pedagogico di attivazione di risorse adolescenziali (a volte nascoste, molto nascoste, quasi invisibili, se non ci credi un po’ e non ti ostini a scovarle) oltre che di sfida continua su strategie e metodi di relazione con questa fascia d’età che certo più di tutte ha sofferto i due anni di pandemia. Con l’aiuto di Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha lavorato con il Collegio delle Guide di Regione Lombardia, abbiamo istituto una borsa di studio(7) per un/ una giovane Aspirante Guida Alpina per darle una mano in quella fase del percorso di formazione in cui è più difficile tenere duro sul progetto, a causa dei costi, della fatica di crearsi un giro di clienti, in cui è facile spostarsi sul ‘piano B’, rischiando di infilare in un cassetto il sogno di svolgere il lavoro tanto desiderato. Crediamo che quella della Guida Alpina sia una delle professioni del futuro delle nostre Terre Alte: formata a dovere, sa dire la sua in momenti in cui l’opinione pubblica balbetta, fa cultura della montagna (ne sono esempio le decisioni di questa estate in merito al non mettere a catalogo alcune salite particolarmente pericolose) e sa aiutare a cercare alternative per un turismo che necessariamente dovrà riconvertirsi, ripensarsi, causa cambiamenti climatici e non solo. A proposito di talenti che non vanno sprecati, a favore

51
Selfie scattato con giovani clienti sul Piz Sella (Gruppo del Bernina) - fine luglio 2020
di un’intera comunità, no?
Ci sta capitando anche di dare una mano a fare bomboniere per il matrimonio di un amico di Matteo e per il Battesimo del figlio di una carissima amica; ci capita di pensare ad eventi di raccolta fondi cercando sempre un tema che riguardi i giovani e chi li coinvolga direttamente… stay tuned per Natale…
Con la competenza di un amico, abbiamo preparato una piccola mostra - 12 foto(8) - di scatti fatti da Matteo (in due casi, scatti che lo ritraggono) con lo scopo di trasmettere anche attraverso le immagini questa passione per la vita, questo desiderio di completezza, realizzato in assoluta naturalezza, che ha caratterizzato questo nostro figliolo. Ogni foto è corredata da una frase tratta dalla letteratura ed aggiunge un’apertura di senso o, forse, più semplicemente una nuova pista di riflessione e di impegno. Che è quello che sta succedendo a noi, dopo quel 7 agosto 2020 che ha ribaltato la nostra vita(9)
Note
(1) Lo Zaino, nr. 12, Autunno 2020, pagg.72-75.
(2) Per una biografia di Matteo, si può visitare il sito del comitato: https://www.casamatteovarese.it/biografia/
(3) A questo indirizzo si trovano tutte le informazioni relative al Fondo aperto presso Fondazione Comunitaria del Varesotto: https://www.fondazionevaresotto.it/funds/fondo-casa-matteovarese/
(4) Fabrizio Calebasso, Matteo Pasquetto, Monte Bianco, tutte le vie su roccia del versante italiano, Versante Sud, 2020, prima ristampa luglio 2021.

Un giorno Matteo arrivò a dire ‘Per fortuna che siamo in lockdown che così la finiamo questa benedetta guida!’; era uno dei sogni nel cassetto di entrambi, abbiamo fatto in tempo a vedere un orgoglioso Matteo che ce la presentava, stampata in tre lingue. Segnaliamo anche Up Climbing, giugno-luglio 2020, Versante Sud, rivista interamente dedicata al Monte Bianco con numerosi articoli di Matteo, di Fabrizio, di Korra Pesce ed altri autorevoli alpinisti.
Casa Matteo Varese coglie l’occasione per ringraziare Versante Sud che permette la vendita del libro durante le raccolte fondi destinando un contributo alle nostre iniziative. (5) https://orchestracanova.com/ (6) https://www.casamatteovarese.it/donations/happiness/ (7) https://www.casamatteovarese.it/donations/borsa-di-studioper-guida-alpina/ (8) https://www.casamatteovarese.it/gva_event/festa-del-borgo-dientreves/ (9) Chi volesse conoscere di più Casa Matteo Varese ci contatti tramite il sito. Saremo felici di conoscervi!
52
Matteo Bernasconi, Matteo Pasquetto e Matteo Della Bordella
in
Patagonia
nel febbraio 2020

MI FERMO QUI... E VADO OLTRE
Beppe
“A te si giunge solo attraverso di te. Ti aspetto” Pedro Solinas in “La Voce a te dovuta”
Io sono per l’azione. Sono però il primo a riconoscere che l’alpinismo non è soltanto azione, ma è azione che sgorga dalla contemplazione della natura e dalla conoscenza del proprio Io Giusto Gervasutti
Quando arrivi in cima continua a salire Walter Polidori
Giorni fa, Matteo “Will” Bertolotti, mi chiese se avevo voglia di scrivere un articolo per il nuovo numero de “Lo Zaino” su alpinismo e disagio sociale. Argomento difficile e complesso, almeno per me. Nonostante una certa mia esperienza sia professionale che nell’organizzazione di corsi di alpinismo per persone che il disagio sociale lo vivono sulla propria pelle, vite rinviate. Una richiesta che mi ha lasciato comunque perplesso. Avevo deciso di non scrivere più nulla sulla cosiddetta montagnaterapia, termine da me poco usato, in quanto la mia riflessione aveva raggiunto una sorta di saturazione, di un “troppo pieno”. Sentivo il bisogno di fermarmi e di chiarirmi le idee, ma allo stesso tempo emergeva in me il desiderio di andare oltre. Volevo trovare la strada che mi portasse a immaginare e realizzare progetti in cui l’alpinismo, e non il semplice accompagnamento escursionistico in montagna, diventasse strumento e opportunità di cambiamento per quelle persone che attraversano quotidianamente fragilità e vulnerabilità sociali, psico-fisiche ed esistenziali. Ed ecco che la “chiamata” di Will mi spiazza, cerca di rimettermi in gioco solleticandomi pensieri diversi. Seppur ancora confusi.
Nelle ultime mie riflessioni apparse su Lo Zaino riguardanti la pedagogia della montagna, scrivevo che la poesia ha la forza necessaria per recuperare le parole che ci mancano per descrivere ciò che di più profondo è
dentro di noi, quel senso musicale e vitale che ci sollecita ad un continuo sforzo di pensiero, di scrittura e di introspezione. Da qui la pedagogia della montagna come affinità tra fragilità e bellezza, come cammino utopico dove l’utopia è concepita come scoperta e ritrovamento di noi stessi. L’utopia e la speranza non sono dunque il regno dell’impossibile ma quello del “non ancora” e sono continuamente esposte al rischio e all’incertezza e richiedono impegno costante nella comprensione della realtà in cui agire con il coraggio di assumere come modello un nuovo rapporto quotidiano uomo-natura. E mi ponevo la domanda se la montagna è quel luogo che ci può offrire l’opportunità di scrivere, ognuno di noi, la sua poesia come sguardo utopico attraverso il quale, periodicamente, sentiamo il bisogno di affacciarci al suo punto di scopertura e di mistero. E il più delle volte è avvicinandoci al segreto delle cose, ma soprattutto delle persone che non hanno storia o nome, che si riesce a percepirsi a propria volta senza nome e senza storia: a toccare la notte ed essere la notte stessa. Come sempre la profondità è nella superficie delle cose.
Riflettevo, inoltre, come l’utopia è un bisogno radicato nell’uomo: vi è nella coscienza della persona umana un’inquietudine che nessuna riforma e nessun benessere materiale potranno mai placare, scriveva I. Silone. Il termine utopia, come sentimento puramente umano, è un altro nome per definire l’irreale, l’impossibile, un sogno fantastico o un’estrema speranza che presuppone una forte tendenza etica: una vera e profonda passione umana. È così che intendo la pedagogia della montagna: una risorsa verso un viaggio verticale che investe l’etica dell’andare in montagna come scelta personale e come proposta educativa per una nuova dimensione sociale dell’aver cura e del prendersi cura.
È noto che l’origine del termine utopia risale a Tommaso Moro, un termine dalla doppia valenza: ou-topia (luogo che non c’è) ed eu-topia (luogo felice) e cioè un luogo felice che non esiste. Connotazione visionaria e lontana dalla
54
Guzzeloni
realtà, ma che consente all’uomo di decidere di cercare di superare le difficoltà legate all’imperfezione della propria condizione, immaginando uno stare nella società e in montagna in un modo nuovo. Quindi l’utopia come progetto, come immaginazione e desiderio di realizzare una “salita” ritenuta, forse, impossibile; utopia come avvio di un percorso alimentato dalla speranza visionaria del possibile. “Il principio speranza” di Ernest Block che non fugge nell’irreale, ma valorizza le possibilità oggettive insite nel reale non rinunciando mai a credere per poterlo intuire e vivere con gli occhi della mente. La pedagogia della montagna intesa come utopia contemporanea, come ricerca di una vita autentica che agisce nella storia per aprire strade di speranza, verso la costruzione di progetti non illusori, ma delineando possibilità di certezze che superino il disagio, l’insicurezza e il senso di precarietà; esperienza che tende alla “visibilità”, come la pensava Italo Calvino, e cioè non come pronunciamento dell’Io, come spinta egotica, ma come volo di un messaggio, come proposta di cambiamento, come esigenza di integrità. La pedagogia della montagna come proposta per l’oggi che guarda all’orizzonte: più si avvicina, più si allontana invitandoci al continuo cammino, all’oltre. Pensare la pedagogia della montagna oggi è come riflettere sul significato delle condotte a rischio degli adolescenti che contengono una domanda dolorosa sul senso della vita. Esse sono modi per forzare il passaggio abbattendo il muro di impotenza che si avverte. Sono il tentativo di uscirne, di guadagnare tempo per non morire
perché si vuole vivere. E sono volutamente trasgressive. La trasgressione è una fabbrica dell’impossibile e della ricerca del “totalmente altro”. Ci si mette in una posizione pericolosa in modo deliberato, si conoscerà la paura, si sperimenterà a proprio rischio la possibilità di sconfiggerla o di essere sopraffatti, ma con la forte speranza di uscirne vivi e più forti rilanciando una possibile trasformazione di senso del vivere. Sì, la pedagogia della montagna diventa azzardo educativo, sguardo ulteriore dentro sé stessi e verso il mondo, invito a rompere gli schemi.
La montagna non ha nulla di umano, è un luogo in cui è difficile vivere, a volte pericoloso, perfino impossibile. E l’uomo vuole umanizzare la natura, non soltanto quella vivente, per sentirla più vicina, meno ostile o possibile da affrontare. La sacralità della montagna appartiene al regno della paura o del mistero, dell’elevazione. L’inospitalità appartiene ai nostri interrogativi. In montagna apriamo la porta su un mondo sconosciuto e ci appare una sorta di miracolo: veniamo invasi dai sentimenti più disparati, ci riempiamo di idee e di curiosità, sogniamo imprese che magari incutono paura e ci dissetiamo alla fonte della necessità di osare e rischiare.
Le montagne, prima di essere conquistate fisicamente, devono essere conquistate culturalmente. Che piova o nevichi, che splenda il sole o soffi il vento, a piedi o con gli sci, arrampicando o a cavallo di creste, la montagna va vissuta in ogni suo aspetto con molta considerazione. L’alpinismo per me è dare vita ai pensieri, perché salire significa generare. Nel silenzio delle montagne cerco la

55
Le tre cime di Lavaredo
solitudine che è dentro di me e che mi aiuta a comunicare con l’altro. Alpinismo è opportunità di vivere l’avventura che spinge ad andare oltre sé stessi (scalando una parete) per andare verso l’altro per accoglierlo mentre lo incrociamo sulla strada della sua sofferenza superando frammentazioni, disimpegno e individualismo. A questo punto, mi chiedo, quale rapporto ci può essere tra alpinismo e disagio sociale? Qual è il senso di tale domanda? Ci sono molte buone ragioni per le quali l’alpinismo (gli alpinismi?) dovrebbe chiedersi se la sua pratica possa contribuire a fornire una risposta esistenziale per coloro i quali attraversano le varie forme del disagio: sociale, esistenziale, psicologico, cognitivo, fisico… E questa è una domanda di fondo che l’alpinismo deve porsi e continuare a porsi. Vi sono state e vi sono
risposte e testimonianze significative a tal riguardo. Esperienze e storie di alpinisti che hanno preso su di sé “la fatica dell’altro” (E. Hillary, G. Rossa, R. Videsott, B. Bonali, F. De Stefani, solo per citarne alcuni), ma vi sono altrettante “storie minori” che parlano di un alpinismo “solidale”. Deve avvenire una conversione nel mondo dell’alpinismo e ciò è possibile se avviene una crisi d’identità, solo se esso viene travolto da uno sguardo altro, una presenza, quasi nascosta ai nostri occhi, che interpella la nostra libertà che noi diamo per scontata e che cerchiamo di conservare a tutti i costi attraverso le nostre scalate. Ma l’esistenza reale di questo sguardo altro, disagiato e disagiante, ci rivela l’inconsistenza di tale libertà. Paradossalmente, l’azione alpinistica non teme il nuovo, lo sconosciuto di una parete, anzi l’alpinismo è alpinismo di ricerca di un nuovo equilibrio tra vecchio e nuovo, ma si arretra volgendo altrove il proprio orizzonte di fronte ad una mano tesa che arriva dal mondo sofferente come uno tsunami improvviso e sconvolgente. Eppure, tale evento vissuto come rottura di continuità dentro di sé e fra sé e il mondo, potrebbe essere il punto di arrivo di un lungo processo maturativo che ha attraversato e attraversa tuttora le varie fasi della storia dell’alpinismo, potendo così diventare più consapevoli sperimentando, come inizio della conversione, il buio e la cecità che ci imprigionano.

Quale alpinismo e quale passione per la montagna possono essere un’opportunità di risposta e testimonianza per il mondo del disagio? Non certo intesi come una relazione esclusiva, assoluta tra il soggetto e l’oggetto, tra me e la montagna, dove l’Altro sociale è escluso. Una relazione in cui l’oggetto diventa indispensabile, esigenza indifferibile, un qualcosa che non può venir meno, un qualcosa che non può mancare, dove il rischio potrebbe diventare condotta ordalica che si spinge fino alla sfida nichilista.
La mia esperienza, la mia scommessa e la mia proposta, non si fermano al semplice, seppur importante e
56
Giuseppe Guzzeloni
significativo, accompagnare in montagna nel fare belle escursioni. Vorrei andare oltre, vorrei parlare e praticare l’alpinismo come opportunità di recupero di potenzialità, risorse e qualità, proprie dell’individuo, e da lui non più riconoscibili e utilizzabili prontamente, a causa delle limitazioni esistenziali derivate da deprivazioni relazionali, povertà economica e educativa. La montagna in quanto spazio naturale ricco di suggestioni metaforiche e simboliche, può diventare uno strumento di ricomposizione di sé; e l’alpinismo, in quanto attività umana, diventa linguaggio, assume su di sé un discorso e un modo di essere. Seguire un percorso di verticalità o raggiungere una cima per una cresta di misto o una nord, significa provare uno stato di eccitazione, di attività espansiva e di contatto con sè stessi che aiutano a comprendere “che ce la si può fare” ad inoltrarsi in cammini evolutivi. Inoltre significa raggiungere uno stato di maggior equilibrio psichico e di contenimento emotivo, di libertà espressiva. Un alpinismo ben cosciente di essere un’attività dagli elevati contenuti di imponderabilità, pur esprimendosi in una società dove incognite e rischi tendono ad essere ridotti al minimo. Un alpinismo di scoperta dentro di sé, una sorta di esplorazione verticale. Il passaggio dal fare al pensare è fondamentale e si intreccia con il fare con e il pensare con il contesto relazionale (istruttori ed educatori) attraverso le funzioni di accompagnamento, con i processi di ricostruzione e di ri-apprendimento, di riconoscimento e di confronto tra Sé e la realtà esterna.
Dove il pensare significa riprendere a vedere, capire, misurare, prevedere, intuire, ricordare, elaborare e comunicare ciò che si apprende dall’esperienza. Consente una costruzione o ri-costruzione di una rete di rapporti sociali che possa essere progressivamente interiorizzata, fatta propria. La fatica e la bellezza; l’impegno e la determinazione; la rinuncia e la conquista; la paura e il coraggio; la notte e la pioggia; il sole e la bellezza dei panorami; le pareti e le creste; legarsi in cordata e la fiducia; l’attenzione all’altro e la responsabilità; l’accettazione del limite e la trasgressione. Dove il “passo dopo passo” significa cambiamento, spostamento e incontro. Queste sono esperienze vitali che prendono forma attraverso il linguaggio. L’alpinismo e il vivere lo spazio alpino esprimono un nesso tra cultura e natura, tra mente e corpo. Ci si mette in gioco in un certo ambiente e nelle relazioni, nelle cose da fare, nell’agire nel creare esperienze. E tutto ciò attraverso il linguaggio. Sono esperienze educative, dove il concreto, l’agito, il “vissuto” interagisce con il pensiero; cioè sul perché faccio, agisco, scelgo, sento, cosa dice per me. È il setting terapeutico: l’esperienza diventa riflessione, elaborazione, creazione di senso, possibilità di cambiamento.
Alpinismo è apprendere una tecnica: come ci si muove in sicurezza in montagna, come si procede su un ghiacciaio, come si arrampica su una parete di roccia. Come si prepara uno zaino, come si fanno i nodi, come ci si prepara ad una salita e la si programma. Legarsi in cordata, oltre che apprendimento di una tecnica, assume pregnanza metaforica: è da un lato responsabilità, stima di sé, fiducia; ma dall’altro è costrizione, legame, vincolo; ma è anche condivisione nel raggiungimento di un obiettivo. Alpinismo significa provare a “cambiare il mondo”. Esistono molti modi per fuggire dal mondo pur restando nel mondo, pur essendo del mondo. Staccare il corpo da terra è un modo per fuggire dal nostro mondo. Arrampicare è uno dei suoi verbi. Il suo linguaggio. Arrampicare significa voler intraprendere un viaggio e per questo serve un motivo. L’alpinismo non è solo “salire delle montagne perché esistono” (Mallory), alpinismo è salirle perché mi parlano, mi attraggono, “hanno qualcosa da dirmi”, mi toccano dal di dentro, mi incutono timore nella loro saggezza. Molto del destino di ciascuno dipende da una domanda, una richiesta che un giorno qualcuno, una persona cara o uno sconosciuto, rivolge, mette in moto il desiderio: d’improvviso uno riconosce di aspettare da tempo quell’interrogazione, forse anche banale ma che in lui risuona come un annuncio, e sa che proverà a rispondere ad essa per tutta la vita.
Arrampicare, in alpinismo, è come avvolgersi in una preghiera, senza chiedere, ma solo per allontanarsi dal centro dell’esistenza, dalla quotidianità. Arrampicare è come entrare in una chiesa per tacere, per un angolo di silenzio, per svuotarsi la mente. Arrampicare è uno svuotarsi di ruoli, compiti, doveri. Apparenze. Arrampicare è come lo sciogliersi lento dei nodi dentro la bocca di un balbuziente che si ritrova svincolato da impedimenti, dopo una lotta per arrivare ai propri sogni. Arrampicare è scoprire l’emozione della bellezza come un estraneo che vive il senso dell’accoglienza. Arrampicare è il movimento della nostra esistenza verso lo sguardo benevolo del cielo che ci protegge, l’intorno che ci avvolge, la verticale che ci seduce; qualche appiglio che chiama le dita, un appoggio per i piedi cercato con dovizia e la spinta delle gambe per innalzarci accarezzando le vertigini del vuoto, fuori e dentro di noi. Non serve altro. È un modo umano “per cambiare il mondo”. Arrampicare implica una relazione con un qualcosa che non posseggo, che non comprendo, un qualcosa altro da me che provoca in me l’io sconosciuto che io sono. Ma che m’inchioda a quel me stesso da cui vorrei fuggire. Arrampicare è la nascita di un gesto che si intreccia a sentimenti ed emozioni che rompono l’idea di sé come una identità definita; concentrazione emotiva e cognitiva di
57

58 Al Monte Bianco - foto Francesco Bruschi
scoperta del proprio equilibrio. È gioia che danza. Cuore in gola. Ansia che blocca. Rinuncia che supera sé stessa. Arrampicare è dialogo con la vertigine, confronto con il vuoto, accoglimento della paura di cadere come fantasia di spiccare il volo, apertura alla libertà dove l’azione domina di nuovo, ha ripreso il sopravvento, e il sensibile ha ritrovato in noi il posto che gli spetta. Alpinismo è vertigine che cammina sull’opportunità e possibilità di cambiamento. E non si gioca impunemente con la vertigine (A. Lochmann,“Il bacio della vertigine”), così come con qualsiasi altra ebbrezza che possiamo imporci (alcol, sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo, stati d’animo eccitati, impulsività…) per scuotere la stabilità della nostra percezione. Il rischio è quello di perdervisi.
Arrampicare è la roccia che si apre a noi, che si manifesta in tutti i suoi segreti. La roccia si fa accarezzare, lo permette, crede in noi. La parete ci accoglie e la roccia è la sua parola. Bisogna porsi in ascolto. Sentirsi parte è l’arrampicata che si fa linguaggio. Ma non solo. Ogni volta che si sceglie di arrampicare si azzarda una nuova nascita delle proprie motivazioni, una nuova esplorazione di esse e di ciò che non conosciamo, che non sappiamo di essere né di avere.
Arrampicare è muoversi nella storia di persone che prima di noi hanno messo mani sugli appigli che noi oggi sfioriamo. Arrampicare è memoria storica…a volte nostalgia. Arrampicare è la verità eretica che si manifesta a noi come contraddizione: arrampichiamo con l’illusione

“grandiosa” dell’apparenza quando, invece, ci riveliamo per quello che siamo: essere mancanti e insufficienti.
Arrampicare è lo sguardo dell’altro, è la ricerca del suo volto; fiducia che si fa carne, gratitudine che si fa sorriso, condivisione che si fa abbraccio, stretta di mano da cui sgorga l’amicizia.
Il viaggio, come il sogno, può diventare esperienza introspettiva, esplorazione di sé, dei propri abissi. Contemplazione e azione, contrapposizione tra orizzontale e verticale, il domestico e il selvatico, tempo e spazio.
Il vuoto non è la nostra casa, viviamo l’ospitalità del passaggio, attori in scena che recitano qualcosa di sé. E alla fine del viaggio non si è più come prima. L’orizzonte si è capovolto. Un altro equilibrio è stato reinventato. Un’altra storia può essere raccontata. (E. Camanni). Alpinismo è perdersi e ritrovarsi. Poesia della scoperta di sé, possibilità di cambiamento nell’accoglimento dell’altro da me. La conversione dell’alpinismo, la nuova identità dell’alpinismo, secondo me, è il cammino della ricerca attiva di sé con la montagna vissuta come soggetto vivente e come partner in quel cammino verso l’espressione della sensibilità per l’umano con le sue fragilità e debolezze. Un alpinismo, incarnato storicamente, che si volge verso il volto dell’Altro come espressione di un’identità umana all’incrocio tra il visibile (reale) e l’invisibile (la sua essenza). Il volto dell’altro come fenomeno sociale, come l’estrema avanzata nel mondo, come prua del destino personale.
59
Il Monte Bianco visto da Courmayeur - foto Francesco Bruschi


Autunno 2022 18

UNA NUOVA AVVENTURA CON LA SEZIONE MILITARE DI ALTA MONTAGNA
Sono in molti ad avermi chiesto negli ultimi mesi perché abbia deciso di unirmi alla Sezione Militare di Alta Montagna (SMAM) del Centro Sportivo Esercito. Cercando di rispondere nella maniera più semplice possibile a questa domanda vi chiedo: quale calciatore non vestirebbe la maglia azzurra della Nazionale qualora avesse la possibilità di farlo?
In più di due decenni di alpinismo ho sempre seguito il mio istinto, rincorrendo i miei sogni sulle montagne più belle del mondo. Per la prima volta mi sentivo chiamato non solo a raggiungere un mio obiettivo, ma piuttosto a mettere a disposizione tutte le esperienze maturate in questi anni, per il raggiungimento di un obiettivo comune, ovvero il fatto di realizzare una salita prestigiosa, una nuova via che celebrasse il 150esimo anniversario delle Truppe Alpine. Dopo l’avventura e la disavventura dello scorso inverno sul Cerro Torre, a marzo 2022, non nascondo di essermi sentito piuttosto svuotato sia mentalmente che fisicamente. Pur essendo passato più di un mese da quei tragici giorni di fine gennaio, in cui dopo aver realizzato il sogno di una vita, ho vissuto l’incubo di aver perso un grande alpinista e amico come Korra Pesce, fino a poche ore prima con noi sulla stessa montagna, sapevo bene che il corpo e la testa avrebbero portato a lungo le cicatrici di quella esperienza.
Fatta questa premessa, penso proprio che il fatto di iniziare un percorso nuovo con la SMAM, sia stato il miglior modo per ripartire verso nuove avventure: quando ci siamo trovati per la prima volta in caserma a Courmayeur si percepiva tutto il fermento di un gruppo che si stava formando, la voglia di scrivere una nuova pagina nella vita della SMAM era tanta ed io non volevo assolutamente perdere questo treno che mi stava partendo davanti agli occhi proprio in quel momento!
In realtà conoscevo già alcuni dei miei futuri compagni di avventura: con Alessandro Zeni “Ale” avevo già arrampicato al Poncione d’Alnasca, ero stato testimone di
tutto il suo talento quando in due giorni di vita in parete si era portato a casa la prima libera della mia “Leap of faith” (8a+/b max 600m). Fisicamente non potevo sapere se fosse stato pronto ad un’esperienza ad alta quota radicalmente diversa, come quella che ci aspettava, ma mentalmente ero certo che sarebbe stato all’altezza della situazione. Marco Majori “Majo” lo conoscevo da parecchio tempo, sebbene avessimo scalato insieme solo in falesia. A detta di tutti era una certezza, era l’anima della SMAM, tanto che venne subito soprannominato “luogotenente”, che non era il suo grado militare, ma stava ad indicare che nella SMAM era “quello che ne aveva viste passare tante di avventure”. Filip Babicz invece lo conoscevo solamente di fama per le sue recenti performances, che lo avevano portato alla ribalta delle cronache alpinistiche, ed infine Stefano Cordaro, che avevo già avuto modo di conoscere quasi per caso alcuni anni prima a Yosemite, guida alpina e militare, “prestato” alla SMAM per l’occasione, con il ruolo di capo spedizione; era il tassello mancante, che avrebbe avuto il compito di amalgamare un gruppo di alpinisti e di esseri umani, dalle caratteristiche tecniche (ed anche dai caratteri) così diverse tra di loro.
L’idea di scalare la parete Est del Siula Grande (6344m) l’avevo proposta io, perché questo mi sembrava l’obiettivo giusto, per il quale ognuno di noi avrebbe potuto sfoderare i suoi punti di forza, per raggiungere un grande risultato di squadra: Ale nel difficile scudo di roccia centrale, Majo con la sua esperienza su terreno misto e di alta quota sarebbe stato fondamentale per raggiungere la vetta, Filip aveva tutte le carte in regola per essere protagonista sia su roccia che su misto, Stefano avrebbe gestito la squadra, dando anche il suo supporto in parete, ed infine io…beh “io speriamo che me la cavo!”.
Nel 2017 ci avevo già provato con Berna (Matteo Bernasconi) e Tito Arosio, ma in quell’occasione non eravamo stati molto fortunati: diversi imprevisti nel trovare il modo giusto per arrivare allo scudo di roccia ed il maltempo, ci avevano fatto tornare a casa a mani
A sinistra: tra roccia e ghiaccio sulla parte alta del pilastro del Siula Grande. Sullo sfondo è visibile lo scudo della parete Est e la zona da cui si originavano le cadute di sassi - nella pagina successiva: In cima al pilastro (ca. 5700) Matteo si carica il saccone prima di affrontare la corta cresta affilata. Sullo sfondo il Nevado Carnicero (5960 m) - entrambe le foto sono di Marco Majori
63 di Matteo Della Bordella


vuote. Poi nel 2019, i calatani Marc Toralles, Bru Brusom e Roger Carach, avevano dimostrato che quella parete era possibile: non solo avevano trovato il modo giusto per raggiungere lo scudo (grazie anche ad alcuni miei suggerimenti), ma ne avevano scalato più di metà. Da quel momento, ho sempre pensato che prima o poi sarei tornato al Siula, non per una competizione con i catalani, ma perché da sempre non mi piace lasciare le cose a metà e volevo avere almeno una seconda chance!
Dopo tanti incontri disseminati durante la primavera per conoscerci meglio ed arrampicare insieme, il 20 giugno finalmente partiamo alla volta del Perù. Il Siula Grande (6344m) si trova nel mezzo della bellissima Cordigliera Huayhuash. Nonostante viaggiare in Perù, richiami in qualche modo una certa atmosfera turistica ed un poco esotica, essendo il Paese circa alla latitudine dell’equatore, le montagne del Huayhuash sono l’esatto opposto: selvagge, remote e fredde. Penso che questo sia forse l’unico posto al mondo dove si trovino pareti di calcare compatte (che sembrano rubate a Ratikon o Wendenstocke) oltre i 5000 metri di quota, in un ambiente alpinisticamente molto complesso.
Fin dall’inizio le cose non sono andate così lisce come avremmo sperato. Dopo circa una settimana dalla partenza, raggiungiamo il nostro campo base, nelle vicinanze della Laguna Siula a circa 4300 metri di quota; un luogo idilliaco con una spettacolare vista sullo Yerupaja
(6635 m) e sul Jirishanca (6094 m). Dal momento del nostro arrivo Filip inizia a sentirsi male, e nei giorni successivi le sue condizioni non fanno altro che peggiorare. Purtroppo deve rientrare a Lima, e dopo circa un paio di settimane, in Italia.

Stefano, Ale, Majo ed io iniziamo il ripetitivo, ma necessario, processo di acclimatamento. Dapprima individuiamo il modo migliore per raggiungere lo scudo di roccia; una cosa che sembra scontata, ma che invece ci aveva già causato problemi e ritardi 5 anni fa. Quindi, dopo aver passato una notte a 5300 metri, durante una giornata nebbiosa e fredda, iniziamo ad aprire i primi 100 metri dello scudo stesso.
La temperature ben al di sotto dello zero, non invogliano certo ad infilare i piedi nelle scarpette, ma a volte in montagna sappiamo bene tutti che bisogna mettere da parte la pigrizia, bisogna andare e… si va!
Non senza difficoltà, in svariate ora di arrampicata, riesco ad aprire i primi tre tiri dello scudo fino a quando il freddo mi svuota di ogni energia, i miei compagni in sosta sono intirizziti, e l’acqua calda che avevamo preparato in tenda è completamente ghiacciata nelle nostre bottiglie.
Torniamo così al nostro accampamento e discutiamo sui piani futuri. Siamo tutti un po’ preoccupati, ma non per il freddo - quello è un problema momentaneo che speriamo di non avere nelle giornate di sole - piuttosto ci attanaglia il pensiero delle scariche di sassi, che abbiamo sentito
66
Il gruppo della SMAM in fase di acclimatamento, da sinistra a destra: Matteo Della Bordella, Stefano Cordaro, Marco Majori, Alessandro Zeni
cadere sulla porzione di parete che dovremmo scalare la volta successiva.
Dopo alcuni giorni di riposo al campo base, torniamo ai piedi della parete: le nebbie hanno lasciato il posto a un cielo terso e limpido, l’aria è sempre tagliente e fredda, ma il sole caldo cambia decisamente la percezione della temperatura. Capiamo subito che quest’ultima non è per noi una buona notizia: le scariche di sassi in parete si sono intensificate, ed ora, anche solo al nostro accampamento, posizionato a circa 80 metri dalla parete, ci sentiamo minacciati dai fischi dei sassi che cadono.
“Si sta come d’autunno” dice Ale per stemperare la tensione, parafrasando la famosa poesia di Ungaretti. Dopo una breve discussione, sforzandoci di trovare un risvolto positivo a questa situazione, siamo tutti dell’avviso che non vogliamo prenderci il rischio di tornare in parete ed essere esposti alla caduta di sassi. Non è mai facile rinunciare a priori senza nemmeno averci provato, ma in questo caso specifico, è senza dubbio la decisione più saggia, dopotutto sappiamo bene che basta un singolo sasso per non avere una seconda possibilità.
È forse ancora più difficile, quando l’obiettivo preparato e sognato per mesi svanisce, non lasciarsi andare a mollare tutto. In questo caso il nostro desiderio di scalare il Siula Grande è troppo forte, vogliamo e dobbiamo trovare una soluzione alternativa!
Un lungo silenzio e poi Majo se ne esce con una proposta:
“perché non scendiamo giù sul ghiacciaio fino al grande seracco, saltiamo su sul pilastro di sinistra e quindi proviamo a salirlo per una nuova via?”
Sapevo che quel pilastro offriva il calcare più compatto e solido che un climber possa immaginare. Era stato salito per la prima volta dai colleghi alpinisti francesi Max Bonniot e Didier Jourdain nel 2016 (membri del Groupe Militaire de Haute Montagne) e sicuramente c’era spazio per aprire qualcosa di nuovo. Majo ed io verifichiamo che effettivamente sia possibile raggiungere il pilastro direttamente dal ghiacciaio, senza dover trasportare nuovamente tutto il materiale fino giù al campo base, ed una volta trovato il passaggio, decidiamo di ridiscendere tutti quanti al campo base, per riposare alcuni giorni prima del tentativo finale.
Optiamo per una scalata in stile alpino, portando con noi materiale e cibo per 5-6 giorni. Stefano ed Ale, fino all’ultimissimo momento sono indecisi se venire in parete con noi o meno. Alla fine propendono per non venire ed aiutarci con il trasporto a valle di tutti i materiali per essere pronti in caso di necessità. Una decisione difficile, che denota grande umiltà e spirito di squadra; una rinuncia alle ambizioni personali per aumentare le possibilità di successo della cordata composta da me e Majo, e di conseguenza di tutto il gruppo… respect! Lasciamo il campo base il 20 luglio, e risaliamo ancora per una volta a fianco della monotona e ripida pietraia,

67
Dal pilastro si vede bene l’avvicinamento glaciale percorso in direzione dello scudo del Siula Grande e sullo sfondo la cima del Jurau (5674 m) - foto Marco Majori
quindi un lungo traverso, ed infine lo zoccolo di roccia, che offre già passaggi di quarto grado, ci porta al primo ghiacciaio pensile. Dopo averlo attraversato, con una calata di 70 metri raggiungiamo il ghiacciaio principale, dove un impressionante, ma rapido attraversamento in discesa, sotto dei seracchi poco stabili, ci porta fino all’attacco del pilastro a circa 5100 metri di quota.
Qui inizia la vera scalata, con alcuni facili tiri su placche appoggiate, ma estremamente compatte. Majo sale da primo, mentre io risalgo da secondo con il saccone pesante.
A un certo punto non posso più né vedere, né sentire il mio compagno. Le corde sono ferme immobili, per un tempo indefinito, fino a quando mi decido ad agganciare la mia jumar ed iniziare timidamente a tirare. Nessun rumore, nessun segnale. La corda tiene, io sono tranquillo e prendo questo silenzio come una conferma sul fatto che posso iniziare a risalire. D’altronde con un sacco di 30 kg in spalla, gli scarponi doppi ai piedi ed un piccolo strapiombo davanti, non è che abbia grandi alternative, se non quella di appendermi alla corda e risalirla. Dopo una quarantina di metri di jumarata, il mio compagno mi intima di togliere immediatamente il peso dalla corda e di arrampicare. Lo guardo stupito con la faccia di chi pensa: “ma che diavolo stai dicendo? Ho risalito la corda fino adesso, perché proprio ora non potrei più farlo?”
In qualche modo riesco a raggiungere Majo in sosta e depositare il mio pesante fardello, quando scopro che in realtà il mio amico non era riuscito a mettere nemmeno una singola protezione nel calcare compatto. Era aggrappato su due appigli con i piedi puntati in mezzo a sabbia e detriti. Praticamente aveva retto tutto il mio peso (più quello del saccone) direttamente su sé stesso, con la sola forza delle sue dita!
“Bella sosta vecchio! Proprio ben bilanciata!” gli dico cercando di stemperare la tensione di un grande pericolo scampato, del quale non mi ero nemmeno reso conto. Majo avanza ancora 5-6 metri e pianta un chiodo. Ancora un tiro di corda e siamo alla cengia di neve, dove possiamo montare la nostra tenda e riposare. È normale che in questa regione delle Ande, a queste quote, di notte la temperatura si abbassi anche a -20 gradi, tuttavia solitamente di giorno, il sole riscalda velocemente l’ambiente. Questo riscaldamento non avviene però la mattina del nostro secondo giorno in parete, dove una brezza costante fa sentire ancora il freddo pungente sulle dita, nonostante il sole sia ormai alto nel cielo. È il mio turno ad andare da primo, ma a causa delle basse temperature e degli svariati strati di vestiti che ho addosso, la mia progressione è lenta. Dopo aver perso ulteriormente tempo per un tentativo non andato a buon fine, riusciamo a salire tre lunghezze di corda, tecnicamente non difficili, ma che
A destra: Marco Majori sulle compatte placche della prima parte del pilastro, calcare perfetto con poche possibilità di piazzare protezioni

68



70
Marco e Matteo in cima al Siula Grande (6344 m)
Marco impegnato sulla parte alta del pilastro, dove Valore Alpino si unisce alla via dei Francesi
offrono un’arrampicata psicologica, su placche di calcare estremamente compatto. Non appena il sole fa capolino dietro la parete, non ci resta altra scelta che fissare le nostre due mezze corde su questi tiri e ridiscendere alla tenda per passare la notte, se non vogliamo congelarci. Fortunatamente quella notte il vento cala e il giorno seguente riusciamo a sfruttare al massimo le condizioni favorevoli per procedere il più velocemente possibile verso la cima del pilastro. Tiro dopo tiro saliamo spediti, la scalata è entusiasmante e la roccia compatta e aderente; sempre avara di protezioni la progressione richiede un po’ di intuito, esperienza e tecnica di piedi; le difficoltà non sono mai estreme. Verso la fine del pomeriggio, raggiungiamo la cima del pilastro. Qui ci aspetta una impressionante calata, su placche lisce ricoperte di neve fresca, dove lasciamo fissata una delle nostre due corde per facilitare il rientro. Arriviamo a un piccolo colle situato a circa 5650 metri di quota, dove posizioniamo la nostra tendina per passare la notte. Nonostante la stanchezza di 3 giorni di arrampicata su roccia, la parte più massacrante deve ancora arrivare. Dopo una notte di riposo, lasciamo alle spalle tutto il materiale da bivacco e partiamo con l’idea di raggiungere la cima e tornare alla tenda la sera stessa. La neve inconsistente appiccicata ai pendii ripidi, rende la nostra progressione uno sforzo costante e senza tregua: in un punto siamo costretti a scavare una sorta di “trincea” in mezzo al pendio, una cengia che ci permetta di scaricare il peso sui piedi, visto che le piccozze non fanno alcuna presa nella neve farinosa. Si tratta di un terreno facile dal punto di vista tecnico, ma dove occorre sempre tenere la concentrazione al massimo, perché piazzare protezioni nella neve è praticamente impossibile e una singola disattenzione potrebbe avere conseguenze fatali per la cordata.
Dopo ore di lotta in cui io e Majo ci supportiamo a vicenda con una sinergia perfetta, alla 1 di pomeriggio del 23 luglio, raggiungiamo la cima del Siula Grande.
Per entrambi è una soddisfazione enorme poter portare idealmente con noi su questa cima i nostri compagni di squadra, gli amici e i colleghi che hanno creduto in questo progetto, ed anche tutto il corpo degli Alpini, a cui decidiamo di dedicare la salita.

In realtà non abbiamo neanche il tempo di grandi festeggiamenti e dopo aver comunicato a Stefano ed Ale via radio il nostro arrivo in vetta, iniziamo a prendere la via di discesa. La storia ci insegna che su queste montagne le discese possono essere ancora più impegnative delle salite ed il pensiero corre inevitabilmente all’avventura vissuta svariati decenni prima dagli alpinisti inglesi Simpson e Yates su quella stessa cima e ben raccontata nel libro “La morte sospesa”.
Di fatto in certi punti è impossibile piazzare qualsiasi forma di protezione, e quindi non ci resta che affrontare in discesa disarrampicando gli stessi passaggi superati in salita. Altre volte siamo più fortunati e, scavando per metri e metri nella superficie nevosa del pendio riusciamo a trovare delle bolle di ghiaccio, sulle quali calarci con la tecnica “abalakov”.
Riusciamo a raggiungere la nostra tendina la sera stessa, percorrendo l’ultimo tratto con le pile frontali, quindi il giorno successivo (quinto in parete) scendiamo in corda doppia lungo il pilastro ed infine ripercorriamo a ritroso il ghiacciaio.
Stefano ed Ale, nel frattempo hanno già portato a valle tutto il materiale, e ci aspettano al lago, per festeggiare insieme la salita, con bottiglie di Coca- Cola e trote appena pescate.
La degna conclusione di questa grandiosa avventura in Perù ed anche di questa mia prima esperienza all’interno della Sezione Militare di Alta Montagna – che ringrazio di cuore per aver sempre creduto in questo progetto e per averci messo nelle migliori condizioni per portarlo a termine - dalla quale mi sono congedato a fine settembre (come già era stato stabilito ancora prima della mia entrata nel gruppo), ma con la prospettiva di poter rientrare in futuro per un altro bel progetto assieme!
71
Alessandro Zeni indica lo scudo di roccia della Est del Siula Grande

LA SOLITUDINE SULLA VIA DEGLI INGLESI – PIZ BADILE
Mi ritrovo nuovamente in cammino con il mio pesante saccone sulla schiena, questa volta in direzione del Passo del Cengalo, sulle Alpi Retiche. Sono stato abbastanza oculato nella gestione dei pesi, ciononostante tutta l’attrezzatura si fa sentire sulle mie spalle. Arrivo la sera di lunedì 11 luglio 2022 nei pressi di un piccolo nevaio. Uno dei pochissimi rimasti in questo anno di siccità. Riesco a posizionare l’amaca che ho portato con me tra due grossi massi e, per giunta, in prossimità di un rivolo d’acqua, così mi addormento; l’indomani sveglia alle 4:30.

Terminati i preparativi raggiungo il colle del Cengalo. Davanti a me vedo la maestosa parete nord-est del Piz Badile. Imponente. Voglio compiere la salita in solitaria della famosissima Via degli Inglesi, ma a quella vista la parete incute un certo timore e mi mette in soggezione. La ritirata dalla via è problematica: dal colle si effettuano una serie di doppie che portano all’attacco, così giunti ad un certo punto, risulta sicuramente più semplice uscire dalla via che ritornare indietro.
Rimango fermo una decina di minuti a guardare la parete, in quello che era il mio “punto di non ritorno”.
73
A sinistra: la parete NordEst del Badile all’alba - Sopra: poco prima dei tiri chiave di Dario Eynard




74
Progressione nella parte bassa della via Recupero del saccone
Saccone, sotto
il
colle del Cengalo
Sezione sommitale della fessura
Le perplessità non riguardavano tanto la difficoltà della via, comunque per me gestibili, ma l’ostacolo mentale importante che avrei dovuto affrontare: è la mia prima salita in solitaria che compio fuori dalle montagne di casa, su una parete che conosco poco, e su una via che non abbia precedentemente percorso.
Dopo un po’ prendo coraggio ed effettuo le doppie. Il terreno è estremamente precario, durante il recupero della corda smuovo un masso che precipita sul lasco sottostante, appoggiato poco più a valle. Ritrovo la corda rotta in tre punti, tutti a livello superficiale: fortunatamente l’anima non è stata intaccata. I due danni più esterni si trovano vicino al capo della corda: posso fare a meno di utilizzare qualche metro su una corda da 70. Il terzo strappo, fortunatamente il più lieve, è proprio a metà e cerco di proteggerlo con qualche giro di tape.

Termino le doppie: manca una sosta dallo schizzo che possedevo ma considerando il terreno non mi sarei stupito se fosse franata via; o semplicemente non l’ho vista. Lascio un chiodo con la maglia rapida e così raggiungo l’attacco della Via degli Inglesi
La prima parte della via si svolge su difficoltà classiche:
effettuo lunghi tiri da 40-50 metri che non superano il VI+. Arrivo al punto in cui la parete si impenna: non è tardi, avrei a disposizione ancora qualche ora di luce. Ho tre opzioni davanti a me: fermarmi in quel punto, tutto sommato abbastanza comodo per effettuare un bivacco; proseguire fintantoché c’è luce, ma al costo di bivaccare in posizioni estremamente scomode, specie per cucinare, o tirare dritto ed uscire dalla via in giornata. Non ho fretta, ho cibo e acqua a sufficienza per permettermi di dilatare un pochino i tempi: decido così di anticipare il mio bivacco e fermarmi in prossimità della piccola cengia. Il sole non era ancora tramontato e mentre cucino la cena mi godo le ombre del Badile che si proiettano sulla parete nord ovest del Cengalo, illuminato da un rosso acceso.
La luna è piena: la parete illuminata si distingue perfettamente anche in piena notte. Per tutto il bivacco faccio perfino a meno di accendere la mia torcia frontale.
Il mattino seguente riparto senza fretta. Quando ne abbiamo la possibilità è bello prendersi il tempo che desideriamo, la vita è già abbastanza frenetica di suo. Affronto i tiri sommitali della via, la roccia è un pochino sporca ma ci si protegge bene. Sul tiro chiave presto attenzione a qualche lama instabile, una di queste mi si
75
Doppie nel canale sotto il colle del Cengalo


76
Progressione sui primi tiri
Tramonto
al Bivacco
Radaelli, immerso
nel
silenzio
stacca e precipita sul saccone sottostante, verifico che non abbia causato danni alla corda e procedo la mia salita. Esco sul catino sommitale, vi sono una serie di tiri semplici sul III-IV grado. In solitaria sono sempre i più problematici: arrampico a tratti slegato con il saccone in spalla, altre volte risalgo dopo aver fissato una sosta più in alto, riesco così ad uscirne.
Arrivo in vetta al Badile nel tardo pomeriggio. Non capita di frequente di trovarsi sulla vetta di questa montagna da soli, dopo aver vissuto un’esperienza così intensa. Il Bivacco Radaelli era lì, immerso nel silenzio. Ancora una volta desidero dormirci: non per necessità ma per fascino. Devo comunque fermarmi da qualche parte, poiché ai Bagni di Masino non ho la macchina per rientrare a casa, a Bergamo, dove abito. Il giorno seguente sarebbe stato altrettanto lungo, considerando la rocambolesca avventura di un rientro “ecologico”: con tre autostop e due treni sono riuscito a rincasare.

Al bivacco Radaelli ho avuto modo di riflettere ed apprezzare molto la dimensione della solitudine. Una solitudine che non è stata sofferta ma è desiderata. Penso alle parole che scrive Christopher McCandless nel film, tratto da una storia, “Into the Wild”: “la felicità è tale solo se
condivisa”. La frase viene scritta dopo aver cercato nella sua vita un ideale estetico estremo, finito per diventare una prigione. Non è quello che ho cercato io: l’uomo è in generale un animale sociale. È importante ritagliarsi dei momenti di solitudine poiché bisogna essere in grado di apprezzare prima di tutto sé stessi, anche per star meglio con gli altri. Si impara così a considerare gli altri non solo per colmare la paura della solitudine. Credo che in misura diversa ognuno di noi senta quest’esigenza di ritagliarsi dei momenti, poiché ciascuno sta compiendo il proprio viaggio personale. Tuttavia, la “felicità è tale solo se condivisa” ed attimi di così forte emozione possono trovare un valore anche per mezzo della condivisione; piccola o grande che sia, a seconda del carattere di ciascuno. Un ringraziamento ad Ande Outdoor
Pizzo Badile via degli inglesi

Apritori:
Difficoltà:
Esposizione:
Sviluppo:
Isherwood e J. M. Kosterlitz l’8 e 9 luglio
m
77
Sezione sommitale della fessura
Uscita dalla fessura, manca un tiro al catino terminale
R. J.
1968
VI+ e A2
Nord-Est
600

DOLOMITI DI BRENTA, UNA TRAVERSATA A QUOTA 3000
di Carlo Piovan
Il piccolo sasso colorato nascosto tra i tanti che costituiscono l’ometto di cima colpisce subito la mia curiosità. Cosa ci farà lì solo in un mare di pietre grigie e bianche? Lo prendo in mano e d’istinto lo giro e leggo: Breathe (respira).
Già! Respira. Quanti ne avremo fatti, di respiri, per arrivare in fondo a questa cavalcata attraverso le principali cime che superano i 3000 m di quota nel gruppo delle Dolomiti di Brenta?
Respiri corti, lunghi, affannati, profondi o sospiri; respiri in cui l’espiro è il doppio dell’inspiro e a cui abbiamo agganciato i nostri pensieri per farli rotolare a fondo valle.
Il numero esatto non lo sapremo mai, ma di certo in questi tre giorni di “grand course” tra creste, pinnacoli e cenge il respiro è stato il nostro miglior compagno di cordata. Un compagno fidato a cui affidare la reattività dei muscoli e il rilassamento della mente.
Jahn, A.Huter, E. Merlet, estate 1917 650 m di sviluppo, diff. IV p. V), la traversate delle torri est della Civetta – ramo nord del Coldai - (H. Hintermeri e T. Sporre il 30 e 31 luglio del 1939) o la lunga cresta della Val d’Inferno nelle Alpi Carniche (Ettore Castiglioni e Gino Pisoni il 13 luglio 1939, 2000 m ca. di sviluppo, diff. III, pp. IV).
Nulla di nuovo sotto il sole, quanto una riscoperta di percorsi noti da almeno centocinquant’anni e rivisti con l’approccio del viaggiatore “alpinistico”. Si tratta, in buona sostanza, di cogliere l’opportunità di poter trascorrere intere giornate in quota a cercare, metro dopo metro, il passaggio per la cima successiva, senza preoccuparsi troppo presto di imboccare la via per il fondo valle. Chi è abituato agli schemi più classici - che prediligono la salita di una singola parete piuttosto che lunghi concatenamenti, tipici dell’alpinismo orientale - scoprirà che Il tempo non sarà più un ostacolo da superare ma diventerà, usando le parole di Rehinard Karl(1), un tempo per respirare.
Le Dolomiti di Brenta - che si caratterizzano per accoppiare la grandiosità d’ambiente delle Alpi Centrali con l’arditezza di forme e con la ricchezza dei colori del paesaggio dolomitico(2) - sono particolarmente adatte a questo tipo alpinismo, oltre che uniche per il loro ambiente. L’hanno capito le Guide Alpine del collegio Trentino, che a quasi un secolo di distanza dalla creazione della Via delle Bocchette, hanno ideato un percorso chiamato la via delle normali del Brenta. Una traversata che sale nell’ordine: Cima d’Ambiez, Cima Tosa, Crozzon di Brenta, Campanile Alto, Torre di Brenta, Cima Brenta, Cima Falkner, Cima Grostè, Cima Pietra Grande e Vagliana. Le guide hanno voluto riattrezzare le soste esistenti e sostituire i chiodi di passaggio con chiodi resinati inox, così da dare nuovo lustro alle vie dei pionieri promuovendo la cultura delle traversate alpinistiche. Tutti gli itinerari sono stati saliti tra il 1871 ed il 1897 da guide, valligiani, esploratori stranieri e pittori (E.T. Compton), ricordiamo Tuckett, Lauener, A sinistra: l’autore sul camino sopra la cengia sulla Torre di Brenta.
Nel linguaggio corrente con il termine grand course si fa riferimento a delle traversate, spesso di più giorni, che prevedono il concatenamento di più cime al fine di completare un percorso. Questo tipo di salite si compiono spesso in alta quota e son caratterizzate da dislivelli significativi. Le difficoltà tecniche possono variare da percorso a percorso, ma solitamente non sono particolarmente elevate proprio per permettere di superare distanze significative in poco tempo. Molto diffuse nelle Alpi Centrali ed Occidentali - grazie anche alle caratteristiche che ben si adattano ad itinerari che solcano creste nevose o rocciose - lo sono molto meno nelle Alpi Orientali seppur non mancano percorsi adatti a questo tipo di alpinismo. Tra le più celebri ricordiamo: la traversata dei campanili della Val di Roda nella Pale di San Martino (G. Langes e K. Hennemann nel 1921, 1250 m ca. di sviluppo, diff. IV), la traversata delle Cinque Dita nel Sassolungo (G.
79


80
Mattia De Grandis e Carlo Piovan in cima alla Torre di Brenta
Mattia De Grandis e Carlo Piovan sulla Cima Brenta
Siorpaes (Cima Brenta 1872), Dallagiacoma, Nicolussi, Compton (Torre di Brenta, Crozzon di Brenta 1883), Gaskell, Holzmann, Lacedelli (1888 Cima d’Ambiez). A distanza di circa centocinquant’anni il valore esplorativo e sportivo di queste salite non è mutato, lo testimoniano i passaggi in camino sulla Torre di Brenta o le difficoltà di orientamento nell’ampia parete sud della Cima Brenta. Queste salite rappresentano tutt’oggi piccoli capolavori nella storia dell’esplorazione.
L’itinerario di seguito proposto, inserito nella più lunga “via delle normali”, ha come fil rouge il tema della quota di 3000 m e impegna 4 giorni per completare un percorso ad anello. Le difficoltà tecniche sono contenute nel limite del III+ e la traversata è affrontabile con una corda singola da 60 m, 6 rinvii, cordini ed eventualmente qualche dado o friend di piccole dimensioni. Utili i ramponi a seconda dell’innevamento. Le relazioni complete delle ascensioni sono ritracciabili nella bibliografia citata.
Il percorso in breve
Val d’Ambiez – Rif. Agostini 2405 m – Cima d’Ambiéz 3102 m – Cima Tosa 3136 m – Crozzon di Brenta 3135 m - rif.

Pedrotti 2491 m -Torre di Brenta 3014 – rif. Alimonta 2580 m - Cima Brenta 3151 m – bocca di Tuckett 2648 m – rif. Pedrotti 2491 m – forcolotta di Noghera, Val d’Ambiez. 3100 m circa di dislivello positivo.
Bibliografia
E. Castiglioni – G. Buscaini. Dolomiti di Brenta. CAI – TCI 1977 ; AA.VV. Dolomiti di Brenta – La Via delle Normali. Idea Montagna 2020.
Note
(1) Rehinard Karl alpinista, fotografo e scrittore tedesco è autore di un famoso libro autobiografico intitolato: Montagna vissuta tempo per respirare.
(2) G.B. Trener. Cenni generali in Dolomiti di Brenta. Ettore Castiglioni, CAI – TCI 1949.
Verso la cima d’Ambiez - foto di Mattia De Grandis

PROFUMO DI CAFFÈ E LUCE CALDA
lungo la trilogia d’Agnèr
Roccia 4 Gatti
Giovedì 11 agosto, Marco Toldo e Diego Dellai, del Gruppo Roccia 4 Gatti di Arsiero (VI) hanno realizzato un importante concatenamento nel gruppo dell’Agnèr. Partendo alle prime ore del mattino e terminando alle 22 hanno salito in sequenza la via Susatti allo Spiz Nord d’Agnèr (Armando Aste, Josve Aiazzi e Franco Solina dal 22 al 24 agosto 1960 – 1000 m, VI), lo Spigolo Nord dell’Agnèr (Celso Gilberti e Oscar Soravito il 29 agosto 1932 – 1600 m, V+ e un passo di VI-) e la via Tissi alla Torre Armena (Attilio Tissi, Giovanni Andrich e Francesco Zanetti il 4 giugno 1931 – 500 m, IV e V). Un’impresa che assomiglia più che altro a un viaggio colmo di avventura, passione e soprattutto amore per queste immense montagne. I racconti che seguono sono due “occhi diversi” delle stesse ore ma che hanno un unico denominatore comune: l’emozione intensa di una grande giornata.

GRAZIE AGNÈR
di Marco Toldo
È da qualche anno che consiglio, a chi un po’ se lo merita, di entrare almeno una volta nella valle di San Lucano, recarsi nella piccola frazione di Col di Prà, voltarsi indietro e lasciarsi trasportare dall’ondata di forza ed energia che quelle pareti riescono a trasmettere, anche a chi, ne sono sicuro, di alpinismo se ne intende gran poco.
E c’è uno scorcio in particolare, che mi ha sempre catturato. Basta parcheggiare la macchina sulla strada asfaltata in prossimità dell’imbocco del sentiero che porta al bivacco Cozzolino, superare la breve radura per trovarsi sulla riva del Tegnàs. Sarebbe da tenere gli occhi chiusi fino a quel momento, per aprirli di colpo, guardare in alto e lasciarsi portare da quella sensazione di maestosità e potenza che credo pochi posti al mondo riescano a dare. Siamo davanti al versante settentrionale dell’Agnèr; ho
83 a cura del Gruppo
Emozioni
A sinistra: verso i tiri finali dello Spigolo Nord dell’Agnèr - Sopra: al termine della Via Susatti
passato ore a guardare quelle pareti, pensare alle vie percorse, quelle che vorrei salire e magari anche a qualche linea che aspetta ancora i primi cavalieri. Ho passato ore a sognare e fantasticare nuove avventure su quelle grandi pareti, ma c’è stato un momento in particolare in cui tra quelle enormi torri di roccia ho visto qualcosa in più, ho visto una possibilità nuova, come una visione, qualcosa di logico in realtà ma che probabilmente non aveva ancora catturato l’interesse di nessuno.
Quel giorno ero stato stregato da un sogno come altre volte mi era accaduto in questa magica valle... Davanti a me il gigante con i suoi satelliti: da sinistra lo Spiz Verde, all’apparenza esile e insignificante, poi lo Spiz d’Agnèr Nord, alto e slanciato come una freccia appuntita verso il cielo. Dietro, un po’ nascosto e quasi insignificante lo Spiz Sud. Poi il grande Agnèr, in tutta la sua mole con il lunghissimo spigolo dritto davanti a me. A destra la Torre Armena, distante e isolata da sembrare irraggiungibile. Infine la catena continua verso ovest con grandi montagne che sembrano svanire sempre di più...
Quel giorno, e son passati un bel po’ di anni, mi ero chiesto se mai sarebbe stato possibile concatenare quelle 3 affascinanti montagne in un solo giorno... Nel frattempo combinammo tante cose in Agnèr, tra cui una sventurata discesa con gli sci per il Vallon delle Scandole. Quanta


neve c’era, e che abisso quel canale! La mia testa tornò sul concatenamento; in effetti quella era una discesa che una volta veniva usata come rientro dalle vie in estate... Siamo tornati in quel luogo, l’anno scorso ad inizio estate per avvicinarci alla ovest della Torre Armena per percorrere la via Maliarda, capolavoro dei grandi Renato Pancera e Gianpaolo Galiazzo. Quel giorno con Diego abbiamo accennato qualche considerazione a quella cavalcata, dato che di lì saremmo per forza dovuti scendere.
Quest’anno la poca neve presente nei canali di discesa ci ha portato a pensare che probabilmente era arrivato il momento di tentare quel concatenamento. L’organizzazione è venuta spontanea... L’idea iniziale era: dormire al Cozzolino, salire lo Spigolo Nord, scendere per le Scandole e a circa metà raggiungere la base della Torre Armena dove avremmo salito la Tissi. Tornare sulle Scandole e scenderle fino in fondo, passare per il Cozzolino e poi attaccare lo Spigolo Susatti allo Spiz Nord.
A fine luglio sono salito da solo al bivacco Biasin per depositare acqua e cibo per poi scendere per il Vallon delle Scandole, attrezzando alcune doppie e ragionando su come poter essere il più rapidi possibili. Al di là dell’euforia alimentata dalle forti sensazioni provate durante tutta la discesa, sono arrivato a valle con la netta sensazione che
84
Cena al bivacco Cozzolino
All’attacco della Via Susatti allo Spiz Nord d’Agnèr
1. Spiz Nord d’Agnèr - Via Susatti
2. Agnèr - Spigolo Nord
3. Torre Armena - Via Tissi
la nostra idea era praticamente impossibile, perché le Scandole richiedevano troppo tempo. Dovevamo per forza scendere a nord per essere veloci, così abbiamo spostato l’attenzione sul lato opposto del Gigante: lì, tra lo Spiz Nord e l’Agnèr scendono due grandi spaccature divise in alto dallo Spiz Sud. Diego programmò un tentativo di discesa dal grande e spaventoso canale a sinistra dell’Agnèr, per fortuna mai neanche iniziato, cosi abbiamo deciso di tentare una discesa tra lo Spiz Nord e lo Spiz Sud. Giovedì 4 agosto dormiamo a malga Agnèr. Quel giorno Diego ed Erika (Reniero n.d.r.) avevano salito la Via Andrea Oggioni. Il giorno seguente Erika sarebbe scesa a valle mentre io e Diego saremmo saliti verso lo Spiz Nord per la via Normale e, raggiunta la forcella Parissenti, avremmo depositato acqua e cibo e tentato questa nuova discesa alternativa. La cosa andò meglio del previsto e con 8 doppie da 50 metri e qualche tratto da arrampicare in discesa, arrivammo al Cozzolino e poi giù in valle con la consapevolezza che quel sogno era forse realizzabile. Cambiamo la sequenza delle vie e quindi la logistica, ma rimanevano grandi dubbi... tempistiche sulle discese, la Susatti mai percorsa prima, l’avvicinamento alla Tissi dalle Scandole sconosciuto...
Giovedì 11 agosto usciamo dal Bivacco Cozzolino alle 3.53, saliamo veloci e attacchiamo lo spigolo Susatti. La via è
bellissima, la percorriamo senza neanche renderci conto di essere veloci e quando arriviamo alla forcella Parissenti, poco sotto la cima, non sono ancora le 8. Cominciamo a scendere la nuova linea di doppie. Difficile pensare di essere veloci perché lì c’è anche da stare attenti ma tutto fila e poco passate le 10 entriamo al bivacco Cozzolino. Ricorderò sempre il piacere, in una giornata così frenetica, di concederci dieci minuti di stop, mettere su la moca e bersi il caffè più buono che io abbia mai bevuto...
Tocca allo spigolo Gilberti-Soravito, via che non ha bisogno di presentazioni, che scorre veloce. Arriviamo al bivacco Biasin sotto la cima dell’Agnèr che l’orologio segna le 16.30. C’è tempo, c’è ancora energia e c’è tanta motivazione. Scendiamo le Scandole e raggiungiamo l’attacco della Torre Armena in modo inaspettatamente semplice. La Tissi è una bellissima via, logica e non troppo difficile che, nonostante la stanchezza, percorriamo veloci e anche in maniera piacevole. Alle 20.30 manca l’ultimo tiro, poi la cima, tutta quella cresta affilata per poi scendere e risalire al bivacco Biasin. Accendiamo le frontali ed inizia a piovere... attorno a noi si sta manifestando un bel temporale, i tuoni si sentono decisi anche se ancora lontani. La cima della Torre Armena penso sia uno dei peggiori posti delle dolomiti dove trovarsi in caso di temporale!

85
Il concatenamento realizzato
Monte Agnèr
Spiz Nord d’Agnèr Bivacco Cozzolino Bivacco Biasin Torre Armena
Vallon delle Scandole 1 2 3

Sento un po’ d’ansia salirmi, acceleriamo, speriamo non succeda un casino!
Neanche il tempo di bagnarci le spalle che smette di piovere, riprenderà alle 23 quando noi saremo già distesi sulle brande del bivacco sotto qualche bel strato di coperte...
Più di 18 ore trascorse praticamente senza pause; 18 ore concentrati, veloci e determinati; 18 ore esposti agli inevitabili pericoli oggettivi che tre grandi montagne come queste possono creare sia durante le salite sia nelle discese; 18 ore immersi nei dubbi dovuti a una preparazione semplice, dove avevamo scelto di non essere troppo meticolosi per lasciare comunque spazio all’avventura.
E quando tutto finisce ti chiedi semplicemente: è possibile che sia andato tutto così incredibilmente bene? E allora anche se può sembrare un pensiero un po’ astratto, mi sento di rispondere che ancora una volta il Gigante ha in qualche modo contribuito per fare andare tutto per il verso giusto in cambio della grande ammirazione che proviamo per questa montagna. Non volevamo fare un record, né tanto meno “utilizzare” l’Agnèr come una pista d’atletica. Volevamo semplicemente entrare a fondo in questa montagna, conoscerne i segreti e provare a trasformare in realtà quel sogno che quel giorno mi aveva trasmesso sulla riva del Tegnàs.
Ci siamo riusciti. Grazie Agnèr!
5 SENSI di Diego Dellai Profumo di caffè e luce calda, apro la porta del bivacco, è buio. I passi vanno in salita le mani iniziano a toccare roccia conosciuta, il chiarore della pila frontale concentra tutta l’attenzione su quel metro quadro davanti a faccia e piedi, il resto è superfluo e buio.
Rumore di ferraglia e moschettoni, Marco inizia a salire legato, la corda fila veloce poi finisce. Indosso le scarpette e via! Le dita afferrano roccia e prese bellissime. Adatto la velocità a quella del mio compagno, se va piano so che fra cinquanta metri troverò un passaggio più impegnativo o un friend da rimuovere.
Ci ritroviamo in sosta, spegniamo la frontale, passo il materiale e poi riparte, prima piano, poi veloce su è ancora su. Non sono ancora le otto, quando a Forcella Parissenti sentiamo le voci di una cordata poco sopra, probabilmente hanno dormito fuori.
“Che via avete fatto?” chiedono. Quasi in imbarazzo lascio la risposta a Marco: “La Susatti, questa mattina presto!” Iniziamo a scendere, corde doppie e tratti di arrampicata in
discesa dove la concentrazione è al massimo. “Tonf!” Un sasso mi cade sopra il piede, faccio un rapido controllo togliendo la scarpa, è tutto ok ma fa male! La discesa riprende mi sento vulnerabile ma all’altezza, in un ambiente severo ma che conosco. Ci si sente piccoli giù per quei budelli!
Poche parole, quasi nessuna, riprendiamo a parlare quando anche l’ultima doppia fila liscia, e veloci ripassiamo al bivacco Cozzolino per la merenda, panino con prosciutto e caffè!
Sono quasi le 11, sullo Spigolo Nord riparte Marco, i primi tiri legati poi liberi e veloci tra il profumo dei mughi e il pizzicore dei suoi aghi. Le mani sono sporche di terra, non sento rumori, solo quel movimento di braccia e piedi perfettamente sincronizzato, veloce e leggero, che continua a salire ed aggrapparsi. Marco è veloce, quasi non riesco a stargli dietro. Una breve sosta al grande larice e via, su per i canali e diedri mentre giù sotto a destra arrivano le voci di una cordata. Maniche corte, è caldo e mi sento stanco, cerco di dosare le forze, di procedere il più costanti possibile sino alla parte alta.
Lui non fa una piega e continua a fare il suo compito, sale su roccia bellissima e io seguo, le soste ci sono... ma non per noi! All’uscita nemmeno un minuto, dritti verso il Bivacco Biasin dove abbiamo acqua e cibo. Sono quasi le cinque, un po’ in ritardo sui piani ma in tolleranza, non sono pienamente convinto di continuare ma Marco lo chiede con una frase a senso unico: “Ne hai ancora vero? Siamo in orario e fermarsi adesso sarebbe un vero peccato!” Avanti!
I piedi scendono tra le ghiaie del Vallon delle Scandole, una doppia, roccia levigata, un buco d’acqua, tolgo gli occhiali e beviamo.
Poi ancora giù su rocce esposte e l’incognita di trovare una soluzione veloce per raggiungere l’attacco della via Tissi Più su? Più giù? Proviamo là!
Una cengia, 80 metri di traverso su roccia magnifica, sopra la testa la Torre Armena e il cielo grigio. Sento una nuova energia dentro, è il Diego determinato che potrebbe andare avanti per giorni perché sa che tutto è possibile. Inizio a salire i piedi fanno male ma passano in secondo piano, penso a quanto forti erano quei pionieri con gli scarponi e l’attrezzatura pesante, su fessure impegnative e quarti gradi difficilmente proteggibili. Arriva il buio, accendiamo le frontali mentre in lontananza rimbombano tuoni e fulmini. Alcune gocce iniziano a cadere e sembra quasi grandine da quanto grosse sono, poi fortunatamente smette, poco sotto la cima togliamo corda e scarpette iniziando il saliscendi in
87
A sinistra: lo Spigolo Susatti allo Spiz Nord d’Agnèr



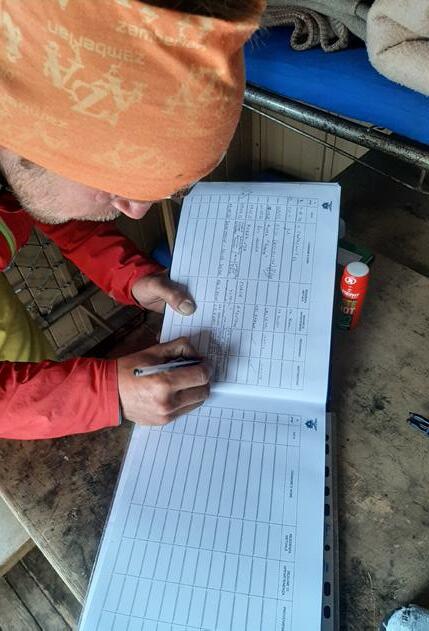
88
Lungo le doppie Lungo lo Spigolo Nord all’Agnèr
La cresta sulla
Torre Armena
Al bivacco Biasin compiliamo il registro
cresta sempre concentrati, sotto i piedi la pila illumina ma a sinistra è il buio più totale.

Sono le 22 quando riapriamo la porta del Bivacco Bedin, un abbraccio, un semplice abbraccio atteso da ore è la dichiarazione che ora possiamo rilassarci, che quell’idea pazza nata qualche anno prima è diventata realtà. Penso all’inutile senso di questa intensa giornata, i palmi delle mani sono dolenti come la pianta dei piedi, potrebbe sembrare una performance da atleti ma non è così. Discutiamo un po’, confido a Marco che con questo “tour” ho la paura di svilire queste bellissime salita alpinistiche. È stata una sfida dentro di noi, un gioco di strategia, un dover conoscere a fondo queste pareti per poter passare sicuri, leggeri e veloci. Un piacere possibile grazie ad un amico con il quale tutto sembra normale e il parlare alterna la voce al silenzio.
Il rumore della pioggia accompagna il sonno dentro il bivacco, prima avevo voglia di terminare e ritrovarmi tra le luci in qualche festa di paese, ora la sensazione è strana, è come se avessi letto un libro fantastico, una sola copia tutta per me, potrei raccontarlo ma pochi riuscirebbero a capirne la bellezza.

89
Foto di rito prima di scendere
Il grande larice

PRIMA TORRE DEL MILLER VIA CRISTINA E CARLO
di Federico Canobbio
Itinerario d’arrampicata aperto dal basso con il solo utilizzo di chiodi e friend da Federico Canobbio e Elena Bigi nel giugno 2022. La via parte a destra di “Prigionieri del sogno” sotto ad un evidente tetto con una fessura diagonale. Alla base c’è una targhetta col nome della via che parte su una comoda cengia. Via in stile alpinistico, richiede buona abilità nell’utilizzo di friend e martello, spesso possibile proteggersi con chiodi a lametta. La via si sviluppa su fessure e placche divertenti sempre su ottima roccia fino a congiungersi all’ultimo tiro della via “Prigionieri del sogno”, possibile salire sulla I° torre del Miller salendo da quest’ultima via l’ultimo

tiro di 20 metri. Calata su fix e spit della via “Prigionieri del sogno” in quanto scendere dalla via sarebbe moto complesso poichè si sposta di molto verso destra lungo il tragitto.
Accesso
Raggiungere la media Valle Camonica, poi da Sonico o da Malonno seguire le indicazioni per le frazioni Rino/ Garda e per la Val Malga (sono presenti anche indicazioni per i rifugi Baitone/Gnutti/Tonolini). La strada - a tratti stretta ma ben transitabile - si addentra nella profonda e selvaggia Val Malga fino all’evidente parcheggio (nei
91
A sinistra: lungo il diedro del primo tiro - Sopra: I primi metri della via

92
Il tracciato della via pressi di un ponte sul torrente) a quota 1540 m. È possibile parcheggiare anche un poco più avanti (a pagamento), al parcheggio del ristoro/rifugio Ponte del Guat (tranne che nei mesi invernali). Dal parcheggio gratuito comunque in pochi minuti si perviene a questo rifugio e poi alla successiva Malga Premassone (1585 m), dove si attraversa il torrente Remulo.

Qui proseguire lungo il sentiero n. 23 fino a giungere alla Malga Frino (1695 m) per poi continuare verso la testata della valle dove il sentiero diviene decisamente più ripido e si superano numerosi gradoni di granito (scale del Miller) che conducono sulla sommità del salto roccioso dov’è presente un bellissimo pascolo. Il sentiero è ora decisamente meno impegnativo e conduce alla diga del lago del Miller dove, sulla sinistra, si trova il rifugio Gnutti (2166 m).
Dal rifugio si supera l’ex cabina elettrica (simile a una chiesetta (è il locale invernale della struttura) e si attraversa un ponticello per proseguire lungo l’agevole mulattiera che sovrasta il lago Miller. Ignorare il bivio con il sentiero n. 1 (Alta Via dell’Adamello) che conduce al rifugio Baitone e proseguire rimontando delle balze erbose fino a giungere nei pressi di un grosso masso, dove una targa commemorativa ricorda il capitano Terzulli. Continuare in piano procedendo sulla copertura
in cemento della condotta che trasporta le acque del torrente Miller al lago del Baitone.
Poco prima di raggiungere una presa d’acqua, che si trova più o meno al centro della valle, imboccare il sentiero che sale a sinistra lungo la fiancata erbosa. Poco dopo, ignorare la deviazione a sinistra (sentiero n. 31) che sale al passo del Cristallo e quindi alla Cima Plem, per continuare verso Est, sempre lungo il sentiero n. 23. In breve si guadagna il piccolo e grazioso laghetto del Miller. Abbassarsi leggermente e riprendere a salire lungo il ripido sentiero che conduce al vasto ripiano acquitrinoso del Pantano del Miller (2423 m, 1 ora dal rifugio).
Abbandonare ora il sentiero principale che continua in direzione della Ferrata Terzulli per prendere a destra (numerosi ometti) lungo una costa erbosa. Dopo averla raggiunta continuare a seguire gli ometti a forma di lance che, sfruttando i passaggi più agevoli, conducono alla conca nevosa dalla quale è possibile vedere le Torri del Miller nella loro integrità (1 h. 45’ dal rifugio Gnutti).
Attacco
L’itinerario attacca a destra della via “Prigionieri del sogno”, a destra di un cono di neve (presente fino a stagione inoltrata), su di una cengia diagonale verso destra sotto un evidente tetto.
93
B A
A - VIA CRISTINA E CARLO B - VIA PRIGIONIERI DEL SOGNO




94
Terzo tiro Quarto tiro
Quinto tiro Sesto tiro
Salirla fino a incontrare un diedro diagonale verso sinistra. Qui una targhetta con il nome della via darà la certezza del giusto attacco.
Relazione
L1: salire il diedro sopra la placchetta sfruttando la fessura, stando all’inizio a sinistra della stessa (chiodo). Superare un friend incastrato e poi seguire a sinistra un’esile fessurina protetta con 2 chiodi (possibilità di azzerare il passo). Nuovamente in verticale seguendo la fessura e il diedro fino a un chiodo (non utilizzare il chiodo sulla destra). In breve, sempre seguendo la fessura, raggiungere il comodo terrazzino di sosta (2 chiodi). 45 m, VI, 5 chiodi e 1 friend incastrato.
L2: ancora in verticale lungo il diedro superando una facile pancia. Raggiunto un tetto, aggirarlo sulla destra con un passo fisico (diversi chiodi - possibilità di azzerare). Una placca conduce alla sosta (2 chiodi). 55 m, VI+, 6 chiodi.
L3: salire le facili placche stando a sinistra del diedro (chiodo). Proseguire qualche metro stando a sinistra di una grossa lama e poi traversare delicatamente a destra per rimontare delle facili balze fino a un cordino incastrato. In breve si guadagna la sosta (2 chiodi). 57 m, IV+, 2 chiodi, 1 cordino incastrato.
L4: continuare per facili placche e lame. Superare una
grande cengia puntando a un chiodo sotto una fessura. Aggirare una bella lama e raggiungere una comoda cengia dove si sosta (chiodo da rinforzare con friend). 53 m, V, 2 chiodi.
L5: attraversare qualche metro a sinistra puntando a una bellissima fessura (chiodo ben visibile). Salirla interamente e poi spostarsi dapprima a destra e poi a sinistra puntando al grande spigolo. Si sosta su di una comoda cengia (2 chiodi). 50 m, V+, 2 chiodi.
L6: salire l’evidente ed estetica fessura (buone possibilità di proteggersi) fino a un pulpito. Da qui è possibile andare a destra, lungo una facile rampa, che porta alla base della Prima Torre e continuare lungo delle creste, oppure, si può continuare lungo lo spigolo (esposto), arrivando alla sosta (1 fix 8 mm+1 fix 10mm) della via “Prigionieri del sogno”.
Da qui si può salire l’ultimo tiro della via “Prigionieri del sogno” (20 m circa).
Discesa
La discesa avviene in corda doppia lungo la via “Prigionieri del Sogno” (1h30’).
Con corde da 60 m è possibile effettuare queste calate: 1a. calata: dalla S8 alla S7; 2a. calata: dalla S7 alla S5;
3a. calata: dalla S5 alla S4; 4a. calata: dalla S4 alla S3 ; 5a. calata: dalla S3 alla S2; 6a. calaa: dalla S2 alla base della parete.
PRIMA TORRE DEL MILLER
VIA CRISTINA E CARLO
Gruppo montuoso: Adamello
Difficoltà: VI+
Dislivello via: +290m
Ore di salita: 5h la via
Ore di discesa: 1h30’ le doppie; 1h20’ dalla base della parete al rifugio Gnutti
Roccia: tonalite (granito)

Esposizione: Sud-Ovest
Apritori: Federico Canobbio ed Elena Bigi nel giugno 2022
95
Sesto tiro, sotto la prima Torre del Miller

PLACCHE DEL PANTANO VIA LE PLACCHE DI MANGO
di Federico Canobbio
Itinerario d’arrampicata aperto con il solo utilizzo di chiodi, spit a mano e friend da Federico Canobbio ed Elena Bigi nel giugno 2022. La via parte in un evidente canale subito a destra del primo laghetto del Pantano. Via in stile alpinistico che richiede buona abilità nell’utilizzo di friend e martello. La via si sviluppa in diedri, fessure e placche divertenti sempre su ottima roccia.

Accesso
Raggiungere la media Valle Camonica, poi da Sonico o da Malonno seguire le indicazioni per le frazioni Rino/ Garda e per la Val Malga (sono presenti anche indicazioni
per i rifugi Baitone/Gnutti/Tonolini). La strada - a tratti stretta ma ben transitabile - si addentra nella profonda e selvaggia Val Malga fino all’evidente parcheggio (nei pressi di un ponte sul torrente) a quota 1540 m. È possibile parcheggiare anche un poco più avanti (a pagamento), al parcheggio del ristoro/rifugio Ponte del Guat (tranne che nei mesi invernali). Dal parcheggio gratuito comunque in pochi minuti si perviene a questo rifugio e poi alla successiva Malga Premassone (1585 m), dove si attraversa il torrente Remulo. Qui proseguire lungo il sentiero n. 23 fino a giungere alla Malga Frino (1695 m) per poi continuare verso la testata
97
A sinistra: lungo il secondo tiro - Sopra: in sosta alla S3


98
Panoramica di accesso
La via
V
V
IV
III
attacco
Torri del Miller
Corno MillerPasso dell’Adamello
verso il sentiero CAI
sentiero di accesso alle Torri del Miller
della valle dove il sentiero diviene decisamente più ripido e si superano numerosi gradoni di granito (scale del Miller) che conducono sulla sommità del salto roccioso dov’è presente un bellissimo pascolo. Il sentiero è ora decisamente meno impegnativo e conduce alla diga del lago del Miller dove, sulla sinistra, si trova il rifugio Gnutti (2166 m).
Dal rifugio si supera l’ex cabina elettrica (simile a una chiesetta (è il locale invernale della struttura) e si attraversa un ponticello per proseguire lungo l’agevole mulattiera che sovrasta il lago Miller. Ignorare il bivio con il sentiero n. 1 (Alta Via dell’Adamello) che conduce al rifugio Baitone e proseguire rimontando delle balze erbose fino a giungere nei pressi di un grosso masso, dove una targa commemorativa ricorda il capitano Terzulli. Continuare in piano procedendo sulla copertura in cemento della condotta che trasporta le acque del torrente Miller al lago del Baitone. Poco prima di raggiungere una presa d’acqua, che si trova più o meno al centro della valle, imboccare il sentiero che sale a sinistra lungo la fiancata erbosa. Poco dopo, ignorare la deviazione a sinistra (sentiero n. 31) che sale al passo del Cristallo e quindi alla Cima Plem, per continuare verso Est, sempre lungo il sentiero n. 23. In breve si guadagna il piccolo e grazioso laghetto del Miller. Abbassarsi leggermente e riprendere a salire lungo il ripido sentiero che conduce al vasto ripiano acquitrinoso del Pantano del Miller (2423 m). Abbandonare ora il sentiero principale che continua in direzione della Ferrata Terzulli per prendere a destra in direzione di un canale (vedi fotografia - 1 h dal Rifugio Gnutti).
Attacco
Portarsi nel canale. L’attacco è identificato dalla presenza di un cordino blu collegato ad un rurp.
Relazione
L1: attaccare la via seguendo il facile diedrone (ottime possibilità di proteggersi con friend e cordini). Superato il primo salto su dei grossi massi si vede un chiodo sullo spigolo che si risale montando su di una placchetta a destra. Salendo si trova un rurp e subito dopo un chiodo con un moschettone sotto la placchetta a sinistra. Si sale ancora qualche metro, superando delle lame e si arriva a una cengia erbosa. 3 m sopra, a destra, si trova un diedro alla cui base si sosta (3 chiodi). 30 m, V, 2 chiodi, 2 rurp.
L2: spostarsi a sinistra nel diedro e seguire inizialmente una fessura e poi, salendo diagonalmente, continuare sul lato sinistro del diedro per placchetta sempre molto divertente e su roccia generosa. Dal secondo chiodo cercare di salire a sinistra rimontando la placchetta fino ad arrivare ad una comoda cengia erbosa. Qui si sosta (chiodo+spit). 45 m, V, 2 chiodi.
L3: salire a sinistra su facile placchetta e poi continuare tenendo sempre lo spigolo. Salire per facili placchette cercando il “facile” fino ad arrivare ad un pulpito su cui si sosta (2 spit). 60 m, IV, 2 chiodi, 1 rurp.
L4: dalla sosta scendere 2 metri su cengia erbosa a destra (ometto) e andare a destra verso un estetico ma facile diedro in cui si identifica un chiodo. Salire inizialmente in diedro e poi per facili e appoggiate, ma divertentissime placchette, salendo una fessurina (chiodo) fino ad arrivare alla sosta (2 spit). 60 m, III, 2 chiodi.
Discesa
È possibile scendere in corda doppia in quanto tutte le soste sono attrezzate con cordone e moschettone. In alternativa salire il crinale per qualche metro in direzione del Monte Adamello fino a incontrare degli ometti, che segnano l’accesso alle Torri del Miller). Da qui scendere il costone erboso a sinistra e rientrare ricongiungersi al sentiero d’avvicinamento. Attenzione: scendendo a piedi non si ripassa dall’attacco.

placche del pantano VIA le placche di mango
Gruppo montuoso: Adamello
Difficoltà: V
Dislivello via: +195m
Ore di salita: 2h la via
Ore di discesa: 1h30’ sia in doppia che a piedi
Roccia: tonalite (granito)
Esposizione: Sud-Ovest
Apritori: Federico Canobbio ed Elena Bigi nel giugno 2022
99
Quarto tiro



100
IL GIGANTE BUONO
di Giorgio Pozzoni
Il 23 dicembre 2017, a causa di un male incurabile, ci lasciava il nostro caro amico Enrico Crippa. Sin dagli arbori della sua carriera alpinistica decise di iscriversi e frequentare la Sezione di Cisano Bergamasco del CAI. Qui aveva anche ricoperto la carica di consigliere e si era adoperato nell’organizzare numerose gite sezionali, dalle semplici escursioni alle ferrate. Dalle dolomiti alle cime di tutto l’arco alpino. Enrico era anche istruttore sezionale nella Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Valle San Martino che ha sede presso la Sezione CAI di Calolziocorte. Persona squisita e affabile, era sempre pronto a dare una mano e a condividere la sua esperienza con tutti. Numerosi sono i ricordi che ha lasciato a tutto il corpo istruttori della Scuola e alle persone che ha incontrato lungo la sua strada. All’interno della nostra Scuola è subito balenata l’idea, quasi come se fosse una sorta di necessità, di fare un qualcosa di importante per ricordarlo. Se lo meritava.
In breve, Cristian, Jack ed io ci siamo trovati d’accordo sul fatto che il modo migliore fosse quello di arrampicare nel suo ricordo. Ovvero aprendo un nuovo itinerario su roccia per poi dedicarglielo. Durante i ripidi avvicinamenti, lungo le verticali pareti che percorrevamo, eravamo sempre impegnati a scovare una linea non ancora battuta. La scelta inizialmente è caduta sulle pareti a noi più care, quelle di casa: Antimedale, Medale e San Martino. Impossibile trovare uno spazio libero dalla Valsassina al Resegone. Per questo motivo, il nostro sogno è rimasto chiuso in un cassetto per diverso tempo, anche se non abbiamo mai accantonato l’idea e non ci siamo mai scoraggiati. Ogni volta che ci si ritrovava per un’arrampicata, l’occhio cadeva sempre su ogni potenziale fessura, diedro o placca…. Finchè un giorno, Jack e Cristian, salendo al Monte Alben per ripetere la via Gocce di rugiada sulla parete nord-ovest del Monte Croce, notano in lontananza una fessura che dalla base della parete, sale dritta per una quindicina di metri. Eccola! È lei, netta e interessante!
Subito mi mettono al corrente, ma restava ancora da capire se qualcuno, prima di noi, ci aveva già messo mano ma ancora di più se, oltre alla fessura basale, c’era la possibilità di proseguire verso la vetta. Trascorso un periodo di tempo passato a reperire informazioni sulla parete e a consultarci con una guida alpina della zona, abbiamo deciso che era giunto il momento di tentare la salita. Quale posto migliore di una bella parete Orobica per ricordare un bergamasco puro come lo Zio Enri?
Prepariamo il materiale, una ventina di chiodi, 20 fix, 5 soste con catena e recuperato un trapano a batteria, sabato 18 giugno 2022 saliamo alla base della parete pronti per inseguire il nostro sogno.
Con l’idea di alternarci sui tiri, tocca a me ad aprire le danze. Dopo aver risalito la fessura e superato un muretto verticale, riesco ad attrezzare la prima sosta. Recupero Cristian e Jack che mentre salgono, provvedono anche a ripulire dai massi instabili il tiro.
La seconda lunghezza spetta a Jack. Qui la roccia è ottima e la progressione avviene lungo una sottile fessura verticale. Un muretto permette di accedere a una fascia erbosa oltre la quale è possibile attrezzare la sosta. In fretta risaliamo, puliamo e… il gioco è fatto! Anche il secondo tiro è alle spalle.
Ora è il turno di Cristian. Insieme cerchiamo di capire quale linea della parete è meglio seguire. In breve lascia la sosta, supera un primo muretto, guadagna una cengia erbosa, pochi metri a destra e via nuovamente in verticale fino ad un piccolo pulpito. Qui rientra a sinistra e prosegue per la parete verticale fino a un grande balcone erboso. L’ora è tarda, bisogna scendere ma decidiamo di tornare l’indomani dato che secondo le nostre valutazioni potremmo raggiungere la vetta con altre tre lunghezze di corda.
La domenica mattina siamo alla base della parete di buon’ora, e risaliti i primi tre tiri, Jack inizia a superare la quarta lunghezza. Un breve camino, un chiodo per proteggere il passo e via lungo il successivo spigolo aereo
101
Enrico Crippa (30 gennaio 1961 - 23 dicembre 2017)
“Chi più lontano sale, più lontano vede, chi più lontano vede, più a lungo sogna” Walter Bonatti

102 VI V V+ V+ II VI IV
che
porta ad una zona più appoggiata. Un cespuglio di mughi e il successivo canale che conduce alla base di un diedro, dove decide di attrezzare la sosta. Mentre lo risaliamo capiamo che la cosa migliore è spezzare il tiro in prossimità dei mughi.
La sesta lunghezza di corda viene superata da Cristian che sale lungo il diedro proteggendosi con un friend blu nel tratto più impegnativo.
Ora è il mio turno. Risalgo un primo facile muretto e poi proseguo comodamente lungo lo spallone sino al suo termine e qui mi accorgo di aver incrociato la via Clipper.
La seguo per gli ultimi metri e sulla cresta sommitale che porta alla croce di vetta, attrezzo la sosta. Recupero il soci e… la via è ormai alle spalle.
L’emozione è enorme. Siamo stanchi ma soddisfatti; quasi non ci rendiamo conto. Risaliamo la breve cresta e alle 16 tocchiamo la vetta. È il momento degli interrogativi e iniziamo a chiederci se la nostra esperienza è realtà o frutto di un lungo sogno. L’itinerario è interessante? Abbiamo sbagliato qualcosa? Una raffica di domande ci colpisce. Del resto siamo totalmente inesperti nell’aprire nuovi itinerari. Iniziamo a scendere lungo il sentiero che riporta alla base della parete pensando al nome da dare alla nuova via. La mente riporta al quotidiano locale che aveva annunciato la morte del nostro amico. L’articolo riportava questo titolo: “Ci ha lasciati Enrico Crippa, addio gigante buono”.
LA VIA
Via di considerevole impegno globale con itinerario vario in ambiente alpino. Da non sottovalutare le difficoltà dei tiri.
Accesso
Dal parcheggio delle vecchie funivie “Conca dell’Alben” (Oltre il colle, BG) ci si incammina sulla pista, si recupera l’evidente traccia che verso destra sale in direzione della parete già ben visibile dal parcheggio. Seguire il sentiero con bolli rossi che sale ripido nel bosco sino all’altezza degli attacchi delle vie. Si devia su di una debole traccia che verso sinistra (faccia a monte) porta alla base della parete.
Attacco
La via attacca sulla verticale dell’ evidente placconata Gialla. Targa alla base.
Relazione
L1: salire lungo la fessura per poi spostarsi a destra oltrepassando un mugo, poco sopra a sinistra, si trova la sosta. 35 m, V+, VI.
L2: salire verticalmente sino a delle balze erbose oltre le quali si trova la sosta. 30 m, V.
L3: per breve fessura sino alla cengia, piegare a destra raggiungendo un piccolo pulpito, seguire le nette fessure per poi raggiungere la sosta su cengia erbosa. 35 m, V+.
L4: salire il camino a sinistra della sosta dove al suo termine si prosegue sullo spigolo sino ad uscire su balze erbose e raggiungere la sosta, posta sotto un grande mugo. 40 m, V+.
L5: raccordo (allungando bene le protezioni si puo unire al precedente tiro). 20 m, I.
L6: seguire l’evidente diedro sino al suo termine, piegare a sinistra e salire per facile terreno sino alla sosta. 35 m, VI.
L7: salire i primi metri sopra la sosta, spostarsi a destra e superare un facile muretto, proseguire sull’evidente spigolo sino alla sosta. Gli ultimi 15 metri sono in comune con la via Clipper. 45 m, IV.
Proseguire per facili balze sino alla croce di vetta.
Discesa
Dalla vetta scendere verso ovest (destra - viso a monte rispetto alla salita) sino a raggiungere la sella che separa la Punta della Croce dalla Cima della Spada. Qui scendere verso destra (viso a valle) entrando nuovamente nella Conca dell’Alben. Raggiunto l’attacco rientrare alla macchina percorrendo a ritroso i sentieri d’avvicinamento. Una discesa in corda doppia diviene difficoltosa dopo la S6.
punta della croce via gigante buono
Prima salita: Giorgio Pozzoni, Mariano Giacalone, Cristian Previtali il 18 e 19 giugno 2022
Esposizione: Nord-Ovest
Difficoltà: V+, VI
Sviluppo: 220 m
Discesa: a piedi
Materiale: soste attrezzate per le calate. Lungo i tiri si trovano fix e chiodi. Portare 10 rinvii, friend medi fino al #2 della BD.
103

IL VALORE DEI PASSI
Saverio D’Eredità
Preambolo – una cosa piuttosto personale 9 luglio 2021, non so bene se mattina o pomeriggio
“Bene. Adesso prova a fare un passo”. Cerco di rimanere ben piantato sulle gambe, sforzandomi di concentrare su queste l’attenzione senza alzare la testa. È solo un passo, mi dico. La fisioterapista mi controlla con le mani, come a cercare di parare una mia eventuale caduta. Man mano che acquisisco equilibrio indietreggia leggermente, allontanandosi da me. “Così, ancora avanti” – mi dice. Al primo passo segue un secondo, poi un terzo, poi tocco le sue mani protese verso di me. Sorride. “Molto bene! Prova un paio di volte da solo e riposati. Ora vado. E mi raccomando la respirazione!” conclude spostando lo sguardo sul piccolo spirometro che mi ha portato come regalo. Mentre si avvia verso la porta osservo le mie gambe che mi sembrano vertiginosamente alte e incerte, come quelle di un cerbiatto appena nato. Non è mica così facile da fare, un passo, penso tra me. Appoggiato con la mano al muro riprovo a muovermi. Sento un leggero stordimento, la testa che gira e fatica a trovare un equilibrio, il respiro mozzato dai dolori alle costole. Mi concentro sulle gambe e sul respiro. Immagino di piantarle nel pavimento come fossero dei tronchi. Penso solo alle gambe. Solo al respiro. A fare un passo. Il gioco funziona di nuovo. Alzo la testa e vedo la porta del bagno. Mi esce una smorfia a metà tra un ghigno e un sorriso disperato. Fuori l’estate domina un cielo che ho visto solo per ritagli, nell’alternarsi di giorni e notti senza senso del tempo. Fuori, oltre la finestra e il filare di pini che delimita il cortile e quel cubo grigio del padiglione 5, oltre tutto questo, ci sono le montagne. Non mi sono mai sembrate così distanti ed alte come oggi. Ma intanto oggi è il 9 luglio, sono passati 12 giorni dall’incidente e finalmente posso andare a pisciare da solo.
Un anno dopo – 9 luglio 2022, ore 11 È solo un passo, mi dico. Dopo spiana leggermente e sono abbastanza sicuro che in cima al pendio vi sia la sosta.
Un passo, ed è anche facile. O meglio, so che è facile, ma lo so perché una parte di me riconosce questo basso muretto di gneiss rugoso come un semplice movimento di innalzamento. Un me che è il risultato di una stratificazione di anni, di vie percorse, movimenti effettuati. Prospettive osservate. Quel me sa che basterà, appunto, fare un passo e che il rischio di scivolare è molto basso. Che questo punto è esposto, ma non pericoloso. Che la protezione è vicina e sicura. Ma faccio difficoltà a mettermi in contatto con quel me. A capire cosa dice o cosa pensa. A riconoscere le sue prospettive.
Certe ferite si possono anche rimarginare, puoi finire per non vederle. Ma si sentono lo stesso. Scoprono le parti più sensibili di noi stessi. Ci fanno sentire esposti. Fragili. Cerco di mettermi in sintonia con l’altro me e mi fido di lui. Di quello che semplicemente alza la gamba, appoggia la mano sul bordo del muretto e passa oltre. Mi fido della traccia che imprime nella neve, del compromesso stipulato tra gli attriti e le paure. Che la sosta, come pensavo, era proprio lì, in cima al pendio e che la cima ora sembra proprio vicina.
Mi assicuro e inizio a recuperare la corda. Il primo comando urlato mi rimane strozzato in gola da un filo di emozione. Da quanto tempo?
Vedo il filo colorato della corda risalire come un vermiciattolo lungo la mia traccia, sulle rocce sporche di neve, verso le mie mani. E con lo sguardo torno indietro, verso la cresta percorsa, l’alternanza dei torrioni che paiono solo pile di sassi in bilico sulle due pareti e mi sento come loro. Lì per cadere, esposto, eppure in piedi. Mi riapproprio della prospettiva. Era questo che mi mancava? Sotto di noi, la Stüdlgrat si distende come una spina dorsale a sostenere la piramide del Grossglockner e mi rammarico di essere venuto qui solo oggi e dopo tanti anni. Forse distratto dal fatto che fosse “solo” una delle tante classiche, prevenuto dalla fama di montagna affollata (quale effettivamente è) e – perché no – un po’per un certo snobismo che finisce per prevalere sulle scelte, avevo
105 di
A sinistra: Carlo Piovan affronta il primo tiro impegnativo dopo la Fruhstuckplatze, sulla Studlgrat - foto S. D’Eredità
sempre declassato questa salita. Eppure devo riconoscere che, come al solito, se è una classica un motivo c’è. E difficilmente potrà deludere. La componente estetica di una cresta affilata ed elegante, l’ariosità dell’ambiente e i passaggi caratteristici e mai ripetitivi non sono gli unici aspetti che fanno della Stüdlgrat una delle creste più belle delle Alpi Orientali. Nel succedersi dei passaggi lungo la cresta, infatti, si respira un’aria di alpinismo d’altri tempi, che verrebbe da dire lento se non suonasse banale. Quell’alpinismo che era fatto, essenzialmente, di passi. Si misurava, in passi. Oggi il Garmin mi aggiorna in tempo reale sui passi compiuti, raggiungendo cifre che mi restituiscono poco del valore della salita. In quell’alpinismo, invece, era il singolo passo a contare. L’accortezza, la cura nel mettere un piede, l’importanza del camminare, del salire, della scelta da fare. Che è poi il motivo per cui questa cosa qui, che ogni volta non so se definire sport, arte o psicoterapia che è l’alpinismo ha ancora un senso.

Si tratta di avere una possibilità di scelta. Poter vagliare opzioni. Quindi decidere. In definitiva, esporsi. In ogni passo, oggi, ho potuto riaggiornare il catalogo dei timori, i pensieri che vanno e vengono, le tempeste emozionali che si scatenano ad ognuno di quei passi. Aggiungere uno strato ulteriore a quella conoscenza che si fa consapevolezza.
Ritrovare, infine, i movimenti collaudati, le posture apprese, che quella cosa te la facevano cercare di continuo. Scoprire che rimangono, come quei compagni di cordata che fanno cordata anche quando la corda non c’è. Vedo Carlo sbucare da dietro lo spigolo e affrontare rapidamente quel muretto su cui mi sono fermato a pensare. Lo passa agevolmente e mi raggiunge. Credo di volere piangere, ma mi limito a sorridergli e porgergli il materiale. “La cima è lì” - gli dico. Ripenso ad un anno fa, a quel primo passo compiuto verso le mani della fisioterapista, mentre fuori imperava l’estate e a me mancava maledettamente una porzione di cielo come il fiato nei polmoni. Come un anno fa, mi esce un sorriso. Forse la Stüdl non sarà una salita così impegnativa o prestigiosa. Ma oggi ho capito il valore dei passi. Che poi, banalmente, è il principio di base per scalare ogni montagna. E, in generale, ogni cosa nella vita.
106
Il versante sudovest del Grossglockner, all’inizio del Teischnitzkees. Foto S.D’Eredità
Attraverso il tempo: uno sguardo alla storia alpinistica del Gross Glockner Siamo su una montagna che non chiede grandi presentazioni e rientra certamente nella più classica iconografia alpina. Il Gross Glockner, o “Gran Campanaro” (se tradotto letteralmente), è non solo la cima più alta dell’Austria e delle Alpi Orientali, ma un simbolo dell’alpinismo classico. Questa piramide di gneiss dalla forma elegante è facilmente riconoscibile da moltissime cime delle Dolomiti, delle Carniche o delle Giulie: con i suoi quasi 3800 metri (mancano appena 2 metri) svetta sulle montagne circostanti, avvolta da un’aria regale. Non solo montagna caratteristica del paesaggio, ma anche passaggio obbligato nella storia alpinistica austriaca e non. Se le vicende legate alla sua prima ascensione ricordano quelle del Monte Bianco o del Cervino (con le spedizioni finanziate dai magnati dell’epoca, i ripetuti tentativi e l’inevitabile corsa che si crea per aggiudicarsi il primato), la storia successiva rimane interessante, anche se spesso ignorata dal grande pubblico, eccetto forse gli austriaci stessi.

La Stüdlgrat, ad esempio, deve il suo nome al magnate praghese Johan Stüdl (fondatore, tra le altre, del club alpino tedesco, un po’come Quintino Sella per il CAI, e noto anche come “Signore del Glockner” in ragione del suo amore per la montagna che lo spinse a finanziare la costruzione del rifugio a lui intitolato), ma fu salita per
la prima volta da Joseph Keherer e Peter Groder il 10 settembre 1864 seppure con l’aiuto dall’alto di Thomas e Michael Groder. Una scalata anomala, quindi, non proprio “by fair means”. Ma dietro questa salita, come tante dell’epoca pionieristica, si nascondevano infatti interessi altri da quelli prettamente sportivi. La via infatti doveva servire alle guide di Kals per fare concorrenza a quelle di Heiligenblut che avevano l’esclusiva della normale classica dal versante nord. Tanta fu la volontà delle guide di Kals (il cui gruppo fu fondato proprio da Johan Stüdl) di aprire una via che avesse come punto di partenza la propria vallata, che non risparmiarono affatto in termini di attrezzature ed organizzazione, tanto da costruirvi una “proto-ferrata” (con tanto di cavi e fittoni), poi rimossa. Oggi la cresta si presenta con numerose attrezzature (soprattutto golfari) e solo qualche cavo metallico e fittoni che agevolano passi altrimenti “fuori scala” per una via che generalmente si mantiene sul II/III grado. Nel complesso è un itinerario d’alta montagna di un certo impegno per esposizione, lunghezza ed ambiente da non sottovalutare. Come frequentazione, la Stüdlgrat è seconda solo alla inflazionatissima via normale, indifferentemente approcciata tanto dalla Luckner Haus (lato Kals am Glockner) che dal Erzherzog Johann Hütte Adlersrue e il Pasterze, dalla parte di Heiligenblut. Ma basta spostarsi di poco per scoprire come il Glockner rimanga montagna severa e banco di prova di alto livello. Approcciando ad
107
esempio la cresta ovest, altrimenti conosciuta come Glocknerwand (per vie della pala rocciosa da cui si diparte questa importante dorsale), per innalzare il livello tecnico e guadagnare in solitudine. Poche cordate infatti percorrono questa lunga cresta, dove si arrampica fino al IV grado e si passano diversi torrioni, collegati da doppie aeree (come quella del Teufelhorn, o corno del Diavolo). Approcciabile anche tramite la Glocknerscharte (in condizioni sempre più precarie nelle ultime estati) per accorciare dislivello ed impegno, la cresta ovest può essere annoverata come una “Grande Course” alpina, pari alle note salite in Occidentali. Ma è il versante nord, senza dubbio, quello di maggiore interesse storico ed alpinistico. Se è difficile stabilire con esattezza il momento in cui le difficoltà classiche vengono superate per entrare nell’epoca del quinto o sesto grado in arrampicata, lo è altrettanto per il complesso mondo del ghiaccio dove i progressi sono molto più lenti e condizionati dalle mutazioni ambientali. Di sicuro, però, abbiamo alcune figure chiave che nella storia ben rappresentano le diverse evoluzioni. Tra queste vi è quella di Willo Welzenbach, un nome che ritroviamo scolpito nella storia alpinistica. Promotore della scala di difficoltà (che prima di essere adottata da UIAA fu appunto la “scala Welzenbach”), questo alpinista tedesco è stato uno dei maggiori innovatori nella
scalata su ghiaccio. Ideatore dei chiodi da ghiaccio (che usò nella storica salita del 1924 sulla Nord del Grosses Wiesbachorn, non lontano dal Glockner, negli Alti Tauri), pochi anni dopo (1926) Welzenbach realizza la prima salita della nord del Glockner, un itinerario audace per l’epoca che già si colloca nella dimensione moderna delle scalate di questo tipo: una sorta di direttissima dalla base alla vetta, testimonianza di una padronanza tecnica davvero notevole. E notevole determinazione: pensiamo al fatto che Willo col compagno Karl Wien, parte di notte in treno da Monaco, scende a Bruck e pedala per ore lungo la valle di Fusch. A notte fonda saranno alla base della parete che scaleranno in giornata e in tempo per riprendere l’ultimo treno per Monaco! Se giustamente viene ricordata l’impresa di Buhl sul Badile, non va dimenticato che questo massacrante triathlon alpinistico era pratica diffusa tra gli squattrinati tedeschi degli anni ’30, come appunto Welzenbach, Ertl o i fratelli Schmidt. Tenacia che Willo avrebbe dimostrato anche poco dopo, nel 1927 e sempre in coppia con Wien. Willo è solo secondo, perché una misteriosa malattia lo ha inibito nell’uso del braccio destro. Ciononostante non si lascia demoralizzare e pur senza piccozza quel giorno “raddrizza” il celebre canalone Pallavicini (600 mt, 50° e IV), un tubo regolare ed esteticamente imbattibile che si origina all’intaglio tra il

108
Carlo Piovan affronta alcuni passaggi di misto nella parte alta della cresta - foto S. D’Eredità
Klein e Gross Glockner. Un canalone noto come una delle scalate più impegnative e temute dell’epoca pionieristica, aperto a suon di gradini (ben 2500!) e con strumenti rudimentali nel 1876 dalla guida Tribusser a capo della cordata promossa dal conte Albert Von Pallavicini. Tragica la sorte del nobile austriaco: nel 1886 egli trovò infatti la morte proprio qui, quando a seguito di una terrificante caduta durante la quale i 3 compagni morirono, il conte fu ritrovato dopo giorni, alla base, probabilmente dopo aver vagato tra i crepacci in cerca di aiuto. Oggi questa via è sempre più in declino a causa degli stravolgimenti climatici, come molte vie della Nord, che pure portano altre firme d’autore. Pensiamo alla ripetuta Mayerlrampe, aperta da Sepp Mayerl nel 1967 (600 mt, 70°) o alla difficile Aschenbrenner (altro protagonista dell’alpinismo di lingua tedesca di quegli anni), aperta nel 1930, una via che può essere considerata come una introduzione alle grandi nord alpine (IV+, misto e pendenze di 70°). Oggi la Nord è sempre meno “in condizioni” cosa che rende sempre più selettive queste vie e al tempo stesso ridonano fascino e mistero a questo versante e al profilo tagliente che spicca dall’ormai smagrito Pasterze.
Se quella storia ha le tinte seppiate dell’alpinismo cosiddetto eroico, oggi l’esplorazione continua in maniera se vogliamo inedita: è solo di pochi anni fa (2018) l’apertura
di una via dal carattere moderno come la difficile “Power of Love” sul fianco della Stüdlgrat (VII e A1) e di “Südwandwächter” (M5, WI4+, 600m), una via di misto moderno tracciata nel 2016 da Vittorio Messini e Matthias Wurzer: incredibile trovare ancora oggi spazi del genere su una montagna così famosa!
Il Glockner, al pari del Monviso, del Monte Bianco o del Cervino, resta una montagna-simbolo, archetipo della vetta alpina nobile cui tutti aspirano prima o poi a calcarne la cima. Il Gross Glockner è senza dubbio una delle vette più frequentate delle Alpi Orientali: la via sua normale (semplice, ma non del tutto banale, che si svolge lungo la cresta est) è infatti meta di un costante pellegrinaggio di alpinisti, escursionisti e persino turisti con guida, che a tutte o quasi le ore del giorno si incrociano sulle esposte roccette della cresta, provando l’emozione di uno sguardo vertiginoso sulle pareti nord e sud. Ma la gioiosa, talvolta rumorosa, quasi devota processione a questa vetta è del resto in linea con la sua storia. All’epoca della prima salita, infatti, fu organizzata una spedizione di ben 62 componenti. Contadini, falegnami, uomini di chiesa, nobili e scienziati unirono le loro forze e conoscenze per abbattere il muro di mistero, superstizione e terrore che avvolgeva le alte quote: era il 28 luglio del 1800, l’alba dell’alpinismo.

109
STÜDLGRAT
Materiale
Corda da 30 m., imbraco, caschetto, ramponi, piccozza, 5 rinvii, qualche moschettone, alcuni cordini, occhiali da sole.
Accesso
Da Lienz seguire la statale 108, fino al bivio per Kals. Arrivati a Kals, proseguire in direzione Burg fino ad un incrocio dove è posizionato un pannello di legno con cartina della zona. Prendere la strada che sale a destra del cartello Kalser Glocknerstraße. Proseguire fino al gabbiotto di pagamento posizionato 2 km circa prima del parcheggio dove lasciare la macchina.
Avvicinamento
Lasciata la macchina a quota 1920 Mt. si hanno due possibilità di salita: o per la comoda strada sterrata a sinistra del torrente o per il sentiero alla sua destra. Entrambe portano al primo rifugio che si incontra (Luckner Hütte 2241 Mt.) unendosi poco prima di
raggiungerlo. Da lì si prosegue per sentiero segnato con bolli rossi e bianchi fino a raggiungere il rifugio Stüdl Hütte (2801 Mt.). Se la meta fosse la via Normale è possibile proseguire (se si hanno ancora fiato e gambe) raggiungendo il rifugio Erzherzog-Joahann Hütte (3454 Mt.).
Lo Stüdl Hütte offre alcune possibilità di svago: all’interno c’è una piccola palestra di roccia, mentre all’esterno una slackline. Inoltre è possibile salire al Freiwandspitze (2920 Mt.); una vetta che offre una bella veduta sul Großglockner, raggiungibile in circa 30’ con facile sentiero.

Relazione
La mattina seguente colazione dalle ore 5:00. La prima parte del sentiero è abbastanza ripida, si deve salire su un “panettone” proprio davanti al rifugio arrivando alla base del ghiacciaio Teischnitzkees. Si prosegue ora sul ghiacciaio stando vicini al bordo destro fino sotto alla parete (al nostro passaggio le condizioni erano ottime e c’era una discreta traccia, non è servito utilizzare ramponi e nemmeno legarsi). Per trovare il giusto punto d’attacco individuare un paletto metallico sulle rocce iniziali. Salire per roccette semplici di I e II (meglio slegati) seguendo i paletti metallici che ogni tanto si trovano
110 GROSSGLOCKNER
Relazione di Luca Galbiati.
Ultimi passaggi impegnativi per Carlo Piovan sulla Studlgrat - foto S. D’Eredità
lungo la cresta fino a raggiungere il Frühstücks-platzl. Attenzione alla roccia iniziale con massi instabili e, al nostro passaggio, con un po’ di vetrato. Fin qui pochissimi golfari ed alcuni paletti metallici. Il Frühstücks-platzl (3550 Mt.) è indicato da una targa gialla che consiglia di scendere, se il tempo impiegato per giungere lì dal rifugio
è stato superiore alle 3 h., poiché da lì in poi le difficoltà aumentano. Da qui fino al traverso, che rappresenta l’ultima difficoltà, i fittoni ed i paletti metallici sono più frequenti. Presenti anche tre tratti attrezzati con corde fisse.
Dal Frühstücks-platzl conviene legarsi e procedere in conserva tranne che nei 4 punti più difficili.
1- Subito dopo la targa c’è un canalino con cordone.
2- Un muretto fessurato con cavo metallico a metà cresta circa.
3- Una breve placchetta molto liscia sul filo dello spigolo con 2-3 golfari.
4- Uno strapiombino con successivo traverso verso la fine. Anche qui con cavo metallico. Dopo il traverso le difficoltà scemano notevolmente fino a raggiungere la vetta (3798 m).

Discesa
Dalla vetta si scende dalla via Normale con passaggi di II. Si può anche scendere slegati, però prestare attenzione perché alcune persone, non molto pratiche, potrebbero urtarvi e farvi cadere... Si seguono i paletti metallici che vengono utilizzati per l’assicurazione. Si supera una sella e poi si continua a scendere fino ad un’altra sella meno marcata. Qui si abbandona la Normale che continua sulla cresta per entrare nel canale ghiacciato a sinistra (viso a valle). Si scendono i primi metri più ripidi (alcuni golfari per eventuali calate o assicurazioni) poi, per terreno più facile si continua fino al rifugio Erzherzog-Joahann Hütte (3454 m., circa 2 h). Tolti i ramponi e riposta anche la piccozza si scende per roccette (ferrata) fino al ghiacciaio/ nevaio Ködnitzkees. Al nostro passaggio il ghiacciaio non presentava alcuna difficoltà, tantè che siamo scesi senza ramponi e piccozza (la parte più ripida si può evitare stando sulle rocce dov’è presente ancora una ferratina). Al termine del ghiacciaio (1 h. dal rifugio) si prosegue puntando ad una specie si sella con 2 grossi ometti. Da qui, per ripido sentierino, si scende fino a ricollegarsi col sentiero percorso salendo allo Stüdl Hütte. Lo si segue a ritroso fino al parcheggio (1h. 50’ dal termine del ghiacciaio).
Grossglockner Stüdlgrat
Gruppo montuoso: Alpi Orientali - Alti Tauri
Quota di partenza: 1920 m
Quota di arrivo: 3798 m
Località di partenza: Kals, ristorante Lucknerhaus (Austria)
Difficoltà: AD+ (III+, A0)
Dislivello: +881 m per lo Stüdl Hütte; +997 m dal rifugio alla vetta
Ore di salita: 2 h. 15’ dal parcheggio allo Stüdl Hütte; 1 h. 30’ dal rifugio all’attacco; 5 h. 20’ la via Ore di discesa: 4 h. 50’ fino al parcheggio
Esposizione: Sud-Ovest
111
Carlo Piovan affronta i primi canali di misto nella parte iniziale. Foto S.D’Eredità

OLDIES BUT GOLDIES UNA “BIG WALL” IN VALDADIGE
LA PRIMA INTEGRALE
di Christian Confente
Le idee diventano bei ricordi solo in relazione a quanto decidiamo di investirci: in altri termini la chiamerei più serendipità anche se il significato non è lo stesso - tuttavia l’effetto che ne esce è il medesimo. Ho conosciuto Lodovico per puro caso per via di alcuni chiodi da roccia e abbiamo iniziato a sentirci per i vari “scambi di roccia” fino a che nel luglio 2021, abbiamo fatto la prima via assieme in Dolomiti che, tra l’altro, si è condita con mille peripezie. Di lì a qualche mese ci ritroviamo in Falzarego dal momento che anch’io ero libero in zona. Queste due occasioni sono anche il pretesto per parlare di progetti e nuovi itinerari, nuovi “cantieri” più o meno aperti, più o meno chiusi. Così Lodo mi racconta di una nuova
linea in Valdadige che sfiora i 30 tiri. Il mio viso non poteva che comparire un’espressione sorpresa... 30 tiri, inizio a pensare, ma come sarà mai possibile?!
A inizio novembre, la via viene finita da Lodovico e dalla compagnia dei Cinghiali in Parete e ricevo la relazione verso marzo. Ne parlo subito con Manuel e ci confrontiamo: la lunghezza è notevole, nonostante le cenge intermedie, l’ambiente non è addomesticato e le difficoltà non sono proprio una passeggiata. Il tempo passa e tra i mille impegni i giorni papabili per una ripetizione scorrono sotto alle lancette del tempo, fino a che non riusciamo a identificare una data a inizio aprile: preventiviamo due giorni dato che non facciamo tutti i giorni questo tipo di vie. In caso di necessità abbiamo sempre l’opzione del bivacco programmato viste anche le previsioni di pioggia tra il pomeriggio e la notte. Pronti, partenza e via!
 A sinistra: Christian Confente nel tratto di artificiale del 14° tiro durante la prima ripetizione - Sotto: Manuel Leorato all’attacco del diedro di L3
di Christian Confente e Manuel Leorato
A sinistra: Christian Confente nel tratto di artificiale del 14° tiro durante la prima ripetizione - Sotto: Manuel Leorato all’attacco del diedro di L3
di Christian Confente e Manuel Leorato
L’8 aprile ci troviamo ben presto al casello e si parte: l’avventura ha inizio. Materiale già pronto sugli imbraghi, zaini a posto, fuoco alle polveri! L’avvicinamento non ci pone problemi se non quasi una trentina di zecche che ci camminano sui pantaloni, ma grazie alle provvidenziali pause regolari abbiamo modo di togliere. Arrivati all’attacco ci si lega e Manuel parte per la prima lunghezza non prima di aver gestito bene i pesi ed aver fatto lo zaino leggero per il primo e lo zaino carico per il secondo. Il sole deve ancora arrivare a bussare sulle nostre spalle ma la temperatura è più che gradevole. Alterniamo i tiri come è buona norma per essere veloci nella progressione e ci gustiamo questa esperienza. La prima cengia ci fa sentire un po’ sotto attacco perché regolarmente dall’alto qualche simpatico ungulato si diverte a fare le scorribande sui detriti instabili ma tutto fila liscio facendoci fare ogni tanto qualche balletto in sosta per schivare la minaccia. Notiamo dopo qualche lunghezza il diverso stile di apertura dei vari componenti del gruppo, ma ce la godiamo assaporando bei passaggi su roccia compatta e abbastanza obbligata a tratti più delicati e di ricerca. D’altronde quando si parte per un’avventura è giusto avere una quota parte del tutto celata dal velo sconosciuto no?! Arriviamo alla fine della prima cengia non prima di aver affrontato l’ultimo tiro su un diedro entusiasmante condito da quel giusto pizzico di esposizione.
Il primo terzo -circa- è nel sacco, piccola pausa ristoratrice e si va all’attacco della seconda fascia che ha anche lei la così detta “medesina” (medicina in dialetto veneto) con il tiro di artificiale. La difficoltà non è in sé il tiro sulle staffe, quanto l’uscita dove si devono abbandonare i gradini e girare la manopola nella testa da “artif” a “libera” oltretutto in piena esposizione e con difficoltà non banali. Non ci lasciamo certo intimorire, anzi ce la godiamo tutta; il meteo è dalla nostra, ci stiamo divertendo e soprattutto respiriamo l’aria leggera di questo ambiente ruspante, estetico balcone affacciato sulla Valle dei Mulini. Alla fine della seconda fascia troviamo una placca veramente straordinaria di calcare compatto con rigole ed erosioni carsiche che non poteva aver miglior posto se non alla fine di una delle fasce principali, come ciliegina sulla torta. Altra sosta ristoratrice, continuazione alla vetta, oppure bivacco svacco? Intanto passiamo le corde, le avvolgiamo e beviamo un sorso; facciamo una pensata se vale la pena forzare l’ascesa oppure non rendere vana tutta quella fatica a portarsi appresso il materiale da bivacco. Decidiamo di dare un senso ai nostri sforzi e visto che il secondo giorno è a piano mandiamo a quel paese lo spirito di competizione che assilla costantemente l’alpinismo dei giorni nostri e andiamo a goderci l’avventura di una notte a cielo aperto. Non potremmo aver fatto cosa migliore, il piacere di scoprire un luogo magico dove poter bivaccare

114
Il team di apritori durante l’apertura del tiro in artificiale.
con le amache appese a chiodi e friend, la semplicità di un fuoco scoppiettante che ancestralmente ci fa capire che è lui il vero primo Netflix della storia, il canto della civetta nella notte fonda, l’odore del fumo della legna che diventa aria, che essenza!
All’indomani, svegliati di buonora non dalla sveglia ma dal freschetto che filtrava sotto all’amaca riaccendo Netflix per scaldarmi un po’ e attendo Manuel che nel mezzo della notte si era trasferito a terra per non idoneità dei mezzi. La colazione non è di lusso ma abbiamo molto altro intorno a noi ma soprattutto siamo ancora dentro alla nostra avventura. Partiamo verso l’attacco della terza fascia che avevamo identificato la sera prima e velocemente prendiamo quota. Sappiamo bene che anche qui ad un certo punto incontreremo una lunghezza ostica, la “medesina”, ma avanziamo serenamente con le articolazioni che pian piano si risvegliano, il sangue che inizia a pompare nelle vene e scaldare i motori. Non mancano anche qui tiri molto belli, con gocce e roccia di soddisfazione alternati a tiri più “selvatici” ma che per quel che ci riguarda non danno alcun fastidio, anzi. Tocca a Manuel il crux pitch stavolta ma se la cava bene e con nonchalanche mi da il comando di partire non appena arriva in sosta; lo raggiungo con lo zaino che, sebben più leggero del giorno precedente, è sempre un buon alleato con la forza di gravità e si oppone al mio avanzare. Di lì a
poco siamo investiti da un vento micidiale ed un cielo che non promette nulla di buono. La cosa peggiore è che noi stiamo andando sempre più in alto e siamo su un pinnacolo esposto, isolato, non un bel posto insomma se dovesse peggiorare. Tuttavia sembra solo un fuoco di paglia che lascia spazio poi a una buona finestra di tempo bello e raggiungiamo così il “cappello” della via. Controllino zecche e qualcosa si cava sempre dai pantaloni, poi via per le ultime tre lunghezze. L’acqua è ormai finita ma sappiamo che i metri dalla vetta non sono ancora molti. Anche qui, come sulle altre fasce, notiamo la differenza di stile nell’apertura dei tiri e nonostante le difficoltà non siano cruciali la stanchezza inizia a farsi sentire. Dalla nostra abbiamo comunque il morale che è alto, iniziamo a sentire l’aria frizzante della prima ripetizione integrale, la soddisfazione di aver vissuto un’avventura facendo quello che più ci piace, con lo spirito che più ci rappresenta, la passione, gli elementi, l’amicizia. Scambiamo un cinque di vetta su una bellissima cengia panoramica invasa di escrementi di “becco”, machissenefrega, siamo noi gli ospiti qui.

Si torna alla macchina attraversando un bellissimo bosco sommitale di conifere, un paesaggio veramente bucolico. La missione ora è trovare acqua perché siamo a secco in tutti i sensi; finalmente dopo aver lungamente percorso la valle del torrente Aviana tra alte pareti, incrociamo una

115
La via
Durante l’apertura
fontana che lenta fa sgorgare un filo di acqua fresca, ci abbeveriamo. Qualche timida goccia inizia a scendere dal cielo, sembra che la meteo stia facendo le prove. Dalla regia a casa, ci dicono, è un diluvio ma noi ormai siamo sereni e di lì a poco arriviamo all’auto. Provvidenzialmente avevo preparato dei panini con marmellata e formaggio e portato due Lasko. Inevitabile il banchetto con brindisi e qui Manuel, puntando il dito verso valle, se ne esce con una delle sue reali ma pungenti domande “Ora sei pronto a tornare alla civiltà che sta dietro a quel monte?”
DUE CHIACCHIERE CON LODOVICO GASPARI
di Manuel Leorato
1. Ciao Lodovico, tu che sei la chiave di volta e l’ideatore dell’apertura di questa linea, dicci un po’ di te e del tuo percorso alpinistico.
I primi rudimenti li ho avuti durante il corso roccia nel servizio di leva negli alpini, prima per me la montagna erano solo le piste innevate e le gare sugli sci. Ho lasciato trascorrere inutilmente alcuni anni poi, il ritorno di fiamma per la roccia e per la parete, incalzante e ancora ardente dopo trent’anni. Ma il mio approccio vero e proprio è stato da autodidatta, passo-passo a scornarsi con l’inesperienza e la mancanza di una benché minima cognizione di cosa potesse essere l’alpinismo, con gli amici, pochi ma fidati, e rigorosamente solo di sabato, famiglia e lavoro permettendo.
2. Parlaci un po’ della genesi di questa nuova salita, perché avete pensato di avventurarvi proprio su quello sperone così lungo ed ingaggioso?
È nato tutto per caso, in una soleggiata mattina di novembre, al termine di un giro ad anello inventato li- perli la mattina stessa per un Trek in famiglia. Nel punto in cui il sentiero esce dal bosco ed inizia a scendere nella val dei Molini, lungo la forestale, è lì che il pilastro mi apparve all’improvviso arrogante in tutta la sua interezza e maestosità annullando ogni altro mio pensiero. La via ideale di salita si è manifestata evidente, ogni diedro, ogni fessura o cengia si sono uniti nella ipotetica linea di ascesa che da subito si è creata nella mia testa e che da quel momento e fino alla fine della prima ripetizione, non riuscirò che a immaginarmi per i sabati a seguire a vagare su di essa. Verificata la verginità della parete, ho realizzato con sorpresa di avere per le mani un biglietto per il luna park. Ancora incredulo e frastornato era giunto il momento di trovare altri sognatori per condividere questa nuova avventura e renderla ancora più bella. Fortunatamente
troverò nei miei amici di corda i “Cinghiali in Parete” l’entusiasmo, la disponibilità ma anche la generosità necessaria per affrontare l’impresa. Il resto è venuto da sé.
3. Chi sono i componenti del Gruppo Cinghiali? Quando sono nati?
Il gruppo “Cinghiali in Parete” nasce nel dicembre del 2018 con l’intento di riunire non solo idealmente un ristretto gruppo di amici per condividere la stessa passione, nonché per trovarsi goliardicamente attorno ad un tavolo imbandito non appena possibile. Oltre agli stessi autori della via, ne fanno parte Alessandro Griggio, Antonello Puddu, Erica Preosto, Fabio Bullio, Fausto Dalla Rosa, Francesco Biscardo, Sara Guerreschi e le new-entry Luca Chelini e Ludovico Anderloni.
4. Visto il notevole sviluppo come avete affrontato l’apertura delle tre diverse sezioni? Percorrendola si nota il tocco e lo stile dei diversi apritori sui tiri. L’intento principale era ed è rimasto fino alla fine quello di godere del piacere di rimanere in parete e di trovare tra le sue pieghe una logica di salita senza eccessive forzature. Fortuna ha voluto che la natura stessa della struttura permettesse di poter frazionare le puntate senza l’uso delle noiosissime risalite su corde fisse. Questo non ha però escluso la fatica di dover riconquistare ogni volta il punto precedentemente raggiunto, cosa che toglieva tempo prezioso alle già corte e avare giornate a disposizione. In tali occasioni si rivedeva, migliorandola, la scarsa chiodatura lasciata in apertura. Questo aspetto legato anche alle generosità della roccia e, come da te citato, dal personale stile dell’apritore, ha in alcuni casi creato una discontinuità ma tale da non disturbare il piacere della salita.
5. Abbiamo letto che avete trovato un chiodo proprio sui tiri finali, di chi pensate possa essere?
Si, in effetti abbiamo trovato un chiodo a poca distanza dal punto in cui ora si trova la sosta del 22° tiro, poi più nulla, probabilmente frutto di una precedente perlustrazione proveniente dalla cengia… Una idea di chi possa trattarsi, personalmente c’è l’ho, ma non sono sicuro, pertanto non posso fare nomi a casaccio.
6. Quanti chiodi avete utilizzato per l’apertura?
A parte il tratto aimé con gli spit, in media non più di 5 per tiro. Pertanto, considerati i 25 tiri effettivi di arrampicata, direi tra i 120 ed i 125, chiodo più, chiodo meno.
7. L’80% di questi chiodi utilizzati sono artigianali, presumo per una questione di budget, parlaci del rapporto con i tuoi
116
amici “artigiani” che te li hanno prodotti, in particolare del “Moeca”.
La chiodatura classica di produzione industriale ha raggiunto in questi anni dei prezzi a dir poco assurdi. Solo attrezzare una via di poche centinaia di metri, significa affrontare costi proibitivi. Da alcuni anni a questa parte, sono alla ricerca del modo migliore di autoprodurli a basso costo sottraendo mio malgrado tempo prezioso ad amici del settore lavorativo. In questo specifico caso i chiodi sono stati per lo più prodotti e offerti dal ns socio Alessandro, al secolo Moeca, a cui va tutta la mia profonda riconoscenza. Una partita di chiodi artigianali sono stati anche acquistati da un’altra fonte, arrampicatore pure lui e sensibile verso un sistema alternativo di produzione e simile per stile di arrampicata.
8. Avete avuto degli sponsor o è tutto materiale acquistato di tasca vostra?
A parte i chiodi artigianali del Moeca, tutto il materiale rimanente è stato autofinanziato. Va anche detto che non è mai stato nelle nostre ambizioni cercare dei sostenitori esterni. Posso solo che immaginare la sensazione di libertà nel disporre senza limite di materiali ed attrezzatura.
9. La presenza di numerosa selvaggina provoca continue scariche, specialmente dal bosco, sul diedro della prima
fascia, questo vi ha creato problemi?
In realtà non più di tanto. Solo un breve tratto del V tiro rimane esposto al passo pesante e forse infastidito dei camosci in transito sulla cengia tra la prima e la seconda fascia utilizzata come punto di collegamento tra una parte e l’altra della valle. Siamo noi gli estranei.


10. Quali sono i punti salienti della prima ascesa? Raccontaci un paio di aneddoti o quello più curioso.
Nonostante il notevole sviluppo tutto è filato abbastanza liscio. Non sono mancati però dei momenti critici in cui la certezza della salita ha vacillato, come per contro, dei momenti di ilarità. Uno di questi che mi diverte ricordare, è quello del “tiro del trapano volante”. Dopo aver faticosamente risalito il tratto di parete fino al punto massimo raggiunto con tutto il materiale occorrente per l’apertura, riusciamo finalmente a finire il 24°tiro lasciato incompleto per aver fatto cadere la sacchetta con tutto l’occorrente per la sosta.
Così rincuorato, riparto fiducioso per il tiro successivo e dopo un primo tratto in traverso, sto per attaccare l’ostica fessura, quando d’un tratto sento il mio amico in sosta che comincia a smadonnare. Istintivamente mi volto verso di lui e lo vedo guardare il trapano che in versione Rolling Stones sta per vincere il record di caduta libera. Si è cosi,
117
Relazione fotografica - prima parte
Relazione fotografica - seconda parte
il moschettoncino che lo teneva agganciato all’imbrago si è accidentalmente aperto e ciao trapano. Dopo un primo attimo di smarrimento, una fanculata e una risata chiudono la faccenda e la giornata. Termino la fessura e alla prima occasione possibile improvviso una sosta con quel poco che mi rimane e mi faccio calare, si va a casa. Torneremo con le armi meglio affilate.
11. C’è stata una visione univoca e compatta sulla lettura della parete o ci sono stati dei momenti di divergenza tra i tanti apritori lungo il percorso?
No, devo dire che c’è stata condivisione sulla linea che avevo inizialmente individuato. A chi è capitato di vivere l’esperienza di apritore, sa benissimo che la linea ipotetica di salita viene via via adattata sulla base di ciò che si incontra strada facendo. Questo è ovviamente capitato anche a noi e di fronte all’incertezza ci siamo consultati tra i presenti lasciando comunque l’ultima parola a chi toccava in quel momento il ruolo di capo cordata.
12. Perché Oldies but Goldies?
Qui lo ammetto è colpa mia. È un modo di dire per significare che con la passione e la giusta tenacia, anche i diversamente giovani possono ancora poter dire qualcosa.
13. Quale deve essere la spinta per avventurarsi su una parete ignota, dal basso con tutti i rischi annessi e connessi?
Oggettivi ma anche relativi al fatto di trovare precedenti tracce di passaggio.
A livello personale, ma penso di parlare per una più vasta platea di arrampicatori, ritengo che il primo passo deve essere quello di innamorarsi letteralmente della parete e di quella linea che la tua sensibilità individua su di essa. Salirla diventa quindi una necessità, che ti porta ad affrontare l’incognita come un ingrediente essenziale per vivere con soddisfazione un’avventura in piena regola. Questa festa può però subire un pesante schiaffo morale nel momento in cui scopri che la tua creazione è già stata notata e calcata da qualcun altro.

A questo punto si tratta di capire quanto del tuo nuovo giochino sia stato compromesso e comportarsi di conseguenza, cercando la soluzione migliore che consenta di rispettare chi ci ha preceduto e non stravolgere, se possibile, la nostra linea ideale di salita.
14. Non avete avuto problemi con le zecche come abbiamo avuto noi durante la ripetizione?
La parete, con le sue cenge e tutto l’ambiente circostante, è la casa stabile di una numerosa popolazione di ungulati, camosci in primis, che con la loro presenza si portano appresso questo fastidioso insetto parassita. Di avanti ed indietro, per circa un anno, per quanto framezzato dalle chiusure covid, ne abbiamo fatti numerosi, ciononostante le zecche riscontrate si possono contare sulle dita di una mano tra tutti i partecipanti lungo tutto il periodo.
15. Sappiamo che hai già dei nuovi cantieri in mente, sarai sempre con lo stesso team di apritori?
Il nostro sodalizio non è che la semplice formalizzazione di un sincero rapporto di amicizia e di stima reciproca, motivo per cui per i nuovi progetti, in questo come per altre ambientazioni, saranno sicuramente condivisi con i miei amici se di loro interesse.
16. Punterai ancora al massimo sviluppo possibile o alla difficoltà? Non nego che la lunghezza di una via sia per me un dettaglio di un certo fascino, mentre al contrario la difficoltà non è necessariamente un elemento fondamentale. Ritengo invece che sia il magnetismo che ha su di me una linea rispetto ad un’altra quello che motiva prioritariamente un nuovo progetto.
17. Come avete effettuato la prima ripetizione parziale delle varie sezioni? Si vede una foto con le frontali indossate. Come oramai noto, la via è stata ultimata verso la fine di
118
Relazione fotografica - terza parte
novembre. Per una corretta valutazione e verifica delle difficoltà avevamo necessità di una prima ripetizione. Dato il poco tempo a disposizione unito alla ridotta illuminazione diurna durante la stagione ancora in veste invernale, non potevamo che puntare ad un approccio frazionato per singola sezione di parete, che comunque non ci ha risparmiato di uscire al buio.
18. Una scalata con uno sviluppo così lungo e passami il termine, anomalo, per una via di fondovalle, si va a scontrare con le esigenti richieste di pulizia e qualità della roccia. Il lato sicurezza alle soste sappiamo bene che è stato affrontato ricorrendo giustamente agli spit, ma come penserai che verrà accolta dalla comunità degli esigenti climbers locali? Negli ultimi anni si è visto diffondere un sistematico addomesticamento delle vie a più tiri. È verosimilmente possibile che questo atteggiamento stia per condurci ad una sorta di omologazione alla quale non vorrei proprio si arrivasse poiché snaturerebbe il concetto stesso di alpinismo. Questa via, se vista sotto questo aspetto, sarebbe corretto definirla anomala. Non dimentichiamo però che, pur trovandosi a bassa quota, mantiene parimenti spiccate caratteristiche di una salita alpinistica di montagna a tutti gli effetti, con i pregi e difetti che questo comporta compresa la pulizia sistematica. La scalata è
pertanto indicata e dedicata a chi cerca e accetta questo tipo di esperienza. Al netto dei reali pericoli oggettivi già eliminati dagli apritori quali ad esempio massi in bilico, detrito ecc., a mio avviso l’integrità della parete, da alcuni definita con il termine selvaggia, costituisce il vero valore aggiunto ormai perso nel tempo e che unito alle altre componenti della via, permettono di vivere appieno e con estrema soddisfazione l’esperienza di questa ascensione. Nella relazione si avverte appunto di questo aspetto e ne viene sconsigliato l’utilizzo a cordate poco esperte su questo tipo di terreno.
LA VIA
Salita alpinistica e selvaggia, dall’arrampicata classica lungo le linee naturali della parete, alla riscoperta del puro spirito d’avventura che sta all’origine di questa disciplina.

Aperta interamente dal basso a comando alternato a più riprese, chiusure Covid-19 permettendo, privilegiando sistemi di assicurazione tradizionali, ricorrendo alla foratura solo quando non poteva più essere garantito un accettabile margine di rischio. Tutto il materiale usato è rimasto in parete e successivamente integrato, pertanto la via risulta ora sufficientemente attrezzata per una

119
Sul quinto tiro durante la prima ripetizione
Manuel Leorato sul 25° tiro, il chiave della terza fascia
linee che riprese, assicurazio più materiale pertanto la ripetizione in dalla sale sopra abbandona traccia alla più sentiero ritroso comunque Attenzione: la poco ore a per durante anche Baldo presso il Sega lungo la allo tornan una alto quasi al alla scarpata normalmen Da una esile pilastro più nuovo dove pilastro. una raggiungere gruppo di Passi di attraver Dalla seguire la n.685), Neve. Al primo per Cordino in traccia Salire a a sx un in del per base spigolo Possibilità di sopra il spigolo potabi un
ripetizione in relativa sicurezza. Soste generalmente su fix. Caratterizzata dalla successione di tre fasce rocciose interrotte da cenge, la via sale quella sorta di prua protesa nel mezzo della Val dei Molini sopra Avio. In caso di necessità, dalla prima cengia è possibile abbandonare la salita uscendo a destra per una stretta cornice poi, per traccia con ometti, traversare lungamente a destra per fare ritorno alla forestale utilizzata per l’accesso. Dalla seconda cengia, la più grande, si esce invece verso sinistra (faccia a monte) su sentiero n.685 utilizzato per l’accesso alla ferrata Gerardo Sega, che a ritroso
riporta comodamente a valle. Da ogni sezione di parete è comunque possibile una eventuale ritirata lungo le linee di calata. Attenzione: la salita risulta impegnativa e caldamente sconsigliata a cordate poco esperte. Per una ripetizione integrale calcolare almeno 10-15 ore a seconda della capacità della cordata. Evitare in piena estate per caldo, lunghezza e mancanza punti acqua. Molte zecche durante l’avvicinamento per la grande presenza di selvaggina che può anche smuovere sassi, soprattutto dal bosco della prima fascia.
Accesso
Dall’abitato di Avio (TN), direzione S. Valentino/Montete Baldo SP208, percorrere la Val dei Molini fino al primo tornante presso il parcheggio utilizzato come partenza per la ferrata Gerardo Sega dove si lascia l’auto. Proseguire a piedi per pochi metri lungo la strada asfaltata e poi per traccia a sinistra (bolli arancio fluo), salire allo slargo presso il cartello chilometrico VIII-3 poco oltre il terzo tornante. Salire il pendio lato monte oltre la strada, accedendo ad una vecchia mulattiera (ponticello in traversine di legno), che più in alto immette su una forestale. Risalire lungamente per questa fin quasi al suo termine per poi abbandonarla presso un ometto appoggiato alla base di un albero posto sul lato sinistro della strada. Scendere la scarpata seguendo gli ometti attraversando il letto di un ruscello normalmente in secca e proseguire verso sinistra fino ad una radura del bosco. Da qui ancora pochi metri a sinistra in piano (ometti), si perviene ad una piccola dorsale erbosa. Non abbassarsi ma salire in obliquo per esile traccia quasi sul bordo della depressione in direzione del pilastro fino ad un nuovo ometto da cui scendere a sinistra per traccia, ora più evidente, alla valletta sottostante. Si sale ora a margine di un nuovo canale di scarico fino a dove altri ometti indicano il punto dove poterlo attraversare ed in breve raggiungere la base del pilastro.
Attacco
Continuare a sinistra fino ad un grosso ometto per salire da ultimo una corta paretina, tramite la quale in traverso a sinistra (ometti), raggiungere l’attacco della via posto in corrispondenza di un piccolo gruppo di alberi poco sopra una zona gradinata (cordino in clessidra). Passi di II-III, circa 40 min.
Discesa
Dall’uscita della via raggiungere la vetta del Corno attraverso la stretta fenditura che divide i due grandi blocchi sommitali. Dalla cima boscosa scendere sul lato opposto fino ai prati e seguire la strada forestale verso
120
40 m Secondo Muro Terzo Muro Primo Muro No! Fuga Biv. Biv. Fuga Il Cappello IV/ppV II V+/ppVI VI+ VI+ VI+ VII V pVI IV+ pVI IV IV V ppVI A1 VII V+ ppVI V+ ppVI V+ V+ VI+ VI V VI+ VII+ (VI+A0) V+ ppVI V+ ppVI VI+ II II L1 25 m 30 m L3 L2 20 mL4 30 mL5 15 mL6 30 mL7 30 mL8 25 mL9 30 mL10 30 mL11 20 mL12 30 mL13 25 mL14 25 mL15 30 mL16 150 mL17 25 mL18 25 mL19 25 mL20 25 mL21 25 mL22 30 mL23 30 mL24 30 mL25 50 mL26 60 mL27 40 mL28 25 mL29 15 mL30
sinistra in direzione sudovest (sentiero n. 685), transitando per la chiesetta dedicata alla Madonna della Neve (possibilità di lasciare preventivamente un’auto). Al bivio prendere a sinistra il sentiero n. 652, il quale riporta a valle al primo tornante della SP208 ed al parcheggio. 2h30’
Note
Dall’uscita del primo muro (7° tiro), salire verticalmente per traccia fino alla base della parete della sezione mediana. Cordino in clessidra all’attacco (bolli arancio fluo).
Dall’uscita del secondo muro (16° tiro), salire nel bosco e per traccia a sinistra raggiungere il sentiero di accesso della ferrata Gerardo Sega. Salire a destra e portarsi sotto lo spigolo della parete superiore. Traversare a sinistra alla base della parete fino all’ometto che segna l’attacco presso un terrazzino erboso subito dietro uno spigolo. Visibile cordino in fessura a circa 7m da terra.

Per raggiungere la parete finale del ”cappello”, dall’uscita del terzo muro (26° tiro), seguire la traccia per una decina di metri a sinistra, poi salire verticalmente fino alla base della parete. Attacco a circa trenta metri a sinistra dello spigolo presso una placchetta compatta. Visibili chiodi di via. Possibilità di comodo bivacco alla grande nicchia
La discesa
della sosta n. 22 oppure sopra il sentiero di accesso alla ferrata Gerardo Sega in prossimità dello spigolo della terza fascia, grotta con spazio per fuoco e legna. Acqua potabile presente nella fontana all’altezza della grande cascata circa ad un terzo della Valle di Mulini.
CORNO GALLINA
OLDIES BUT GOLDIES
Prima salita: Lodovico Gaspari, Stefano Zampini, Gianluca Bellamoli, Massimo Caloi, Francesco Vinco - ultimata il 20 novembre 2021
Prima ripetizione integrale: Manuel Leorato e Christian Confente
Seconda ripetizione (in giornata): Walter Polidori e Ivan Moscardi
Esposizione: SudEst
Difficoltà: VII e A1 (VI+ obblig.)
Tempo: 10-15h
Sviluppo: 965 m (755 m su roccia)
Discesa: a piedi (2h30’)
Materiale: nda, 15 rinvii, 2 staffe, buona dose d’acqua

UNA VERA VIA INVERNALE?
Prima salita invernale della via Architettura gialla alla Punta Emma
di Walter Polidori
Ci stavo pensando da parecchio tempo. L’avevo proposto ad Alessandro, sapendo bene che avrebbe accettato con entusiasmo. In realtà non sarebbe stata la prima volta per me, ma ora l’idea era mia. Quanto conta avere progetti personali, scaturiti dalla propria fantasia, voluti dal proprio intimo? Tantissimo per me. Un progetto può essere meno intrigante di quelli proposti da altri, ma se l’idea è personale, allora acquisisce un significato più forte. È come aprire una via disegnata nella propria testa, quando ancora non esiste, in confronto al partecipare ad una apertura ideata da altri. L’idea è la parte più bella di tutto il gioco.
Le mie esperienze precedenti si limitavano a salite di roccia invernali di bassa quota, mentre l’unica vera salita alpinistica in ambiente si riconduceva ad una salita invernale sui satelliti del Monte Bianco. Massimo l’aveva proposta, io ed Alessio avevamo accettato di buon grado. L’idea era quella di arrivare all’attacco della via con gli sci da scialpinismo ma io, non sapendo sciare, tanto meno fuoripista, temevo più questa parte che non la salita vera e propria. Gli sci me li aveva regalati l’amico Vecchio (Olivotto Bruno), scelti tra quelli utilizzati nella sua carriera di sciatore. Con gli scarponi da alpinismo ai piedi, mi ero barcamenato in malo modo nell’approccio alla parete del Pic Adolphe Rey, soprattutto nella discesa dal Col des Flambeaux al Ghiacciaio del Gigante dove, a causa della mia incapacità di sciare, avevo tenuto sugli sci le pelli di foca. Quanto avrei desiderato le odiate ciaspole in quel momento. La salita aveva avuto un iniziale problema di tempistica, perché la parete non avrebbe preso il sole presto come pensavamo, data l’esposizione apparentemente favorevole. In realtà il Grand Capucin stava impedendo al sole di irraggiarla. Così avevamo dovuto aspettare un po’ e poi Massimo, il più motivato, aveva iniziato ad arrampicare con la parete ancora gelida, in ombra. Poco dopo era arrivato il sole, cambiando completamente la situazione e permettendoci di salire senza problemi sulla bella roccia rugosa, con
Se non avessimo l’inverno, la primavera non sarebbe così piacevole: se qualche volta non provassimo le avversità, la prosperità non sarebbe così gradita. Anne Bradstreet
tanto di occhiali da sole. La salita era entusiasmante, si vedevano in giro solo scialpinisti e ghiacciatori. In realtà l’unica differenza rispetto ad una salita estiva stava nelle minori ore di luce disponibili, e nella temperatura molto bassa se non si stava al sole. L’ambiente non era granché differente, visto che a quella quota di solito la neve è sempre presente. Solo si vedevano poco i crepacci sul ghiacciaio, nascosti per gran parte dalla neve che li copriva. Poche ore di luce… questo è il problema maggiore se una parete in inverno è esposta al sole e non è sporca di neve. Infatti, le lancette dell’orologio continuavano ad andare avanti velocemente e, a poca distanza dalla fine della via, avevamo deciso di calarci, per evitare di farci sorprendere dal buio. Il resto dell’avventura si era ridotto solo ad una grande faticaccia nel gestire gli sci fino al rifugio. Era stata una bella esperienza, salire la Bettenbourg in inverno, ma non mi aveva colpito più di tanto, nonostante il panorama grandioso e la bella roccia. Forse davvero avevo bisogno di un mio progetto.
Ora, dopo tanti anni da quella salita, era il momento di mettere in pratica cosa avevo in testa. Niente di pretenzioso in realtà, avevo solo voglia di arrampicare su roccia in Dolomiti in inverno, cercando una parete pulita, con un avvicinamento e una discesa fattibili. Perché non scalare lì anche nella stagione invernale? Ci eravamo ripromessi di aspettare almeno che le giornate si allungassero un po’, senza però sconfinare nella primavera. Un po’ di dubbi in testa li avevo. Le condizioni della parete erano buone, la webcam che inquadra il Catinaccio dava immagini rassicuranti. Ma la parte alta più facile, e soprattutto la discesa a nord, che soprese ci avrebbero riservato? Pian piano nella mia testa mi stavo dirigendo verso un obiettivo con meno incognite, dove la discesa fosse in doppia. La comodità e la sicurezza sono sempre lì, a tentarci. Ma Alessandro ormai aveva fatto anche suo il progetto, e mi aveva riportato al piano iniziale. Così l’avventura stava prendendo piede. Verso
123
A sinistra: il quarto tiro
metà febbraio avevamo concordato di salire al rifugio per pernottare prima della salita, ma una piccola nevicata del venerdì sera ci aveva fatto decidere di rimandare. Forse era stato meglio così, perché avevamo avuto modo di arrampicare sulla calda roccia della Valle del Sarca su una via impegnativa, togliendoci un po’ di ruggine. Nel giro di due settimane era arrivato il momento. Dopo una notte al rifugio ci eravamo diretti alla Punta Emma, con l’obiettivo di salire la via Architettura gialla in prima invernale. Eravamo ben carichi di materiale, compresi martelli e una buona dose di chiodi da roccia, che in qualche modo ci avrebbero permesso di scendere dalla cima anche se l’avessimo trovata impestata di neve o ghiaccio. In aggiunta avevamo portato una piccozza a testa, che sarebbe risultata assolutamente indispensabile, e un paio di ramponi a testa. La strategia prevedeva di salire a comando alternato, con lo zaino più pesante sulle spalle del secondo di cordata. L’approccio all’attacco non era stato difficile, ma assolutamente da non sottovalutare: si trattava di fare un lungo traverso ascendente su neve ripida e dura. Alessandro, con i ramponcini “da passeggio” era stato comunque bravo a procedere, mentre io avevo ai piedi, sulle pedule leggere, dei vecchi ramponi, di quelli da legare con le fettucce. Ormai all’attacco, il casco di Alessandro si era sganciato dallo zaino, rotolando giù per
il lungo zoccolo. L’amico si era messo a inveire contro la sfortuna, tanto da farmi spaventare. Era dovuto scendere a recuperarlo, accorgendosi che fortunatamente si era fermato ben più in alto della base dello zoccolo. La scalata ora stava finalmente iniziando. Dopo una prima facile lunghezza su roccia e neve con pedule e ramponi, era arrivato il momento di calzare le scarpette. La via, lo dice il suo nome, passa astutamente tra zone strapiombanti gialle, tanto da rimanere completamente asciutta e pulita. Salire da primi era impegnativo, la via è ben protetta ma serve scalare bene su tratti difficili lontani dalle protezioni. Forse scalare da secondi era però ben peggio, a causa dell’opprimente peso dello zaino, che conteneva la maggior parte dell’attrezzatura pesante. Certo che la consapevolezza di fare una via desiderata, in inverno, con un ambiente molto diverso da quello estivo, su un balcone naturale che spazia su tutta la valle, mi stava galvanizzando. Però il dubbio sulle condizioni della discesa sarebbe stato un tarlo per tutta la salita. Come l’avremmo trovata? Le incertezze, alla fine, sono il sale di questo approccio alla scalata. Poco prima del termine del tratto difficile della via, avevo sbagliato seguendo un vecchio chiodo e un cordino visibile più in alto. Un tratto difficile e friabile mi avrebbe dovuto fare capire che ero fuori via, su un altro itinerario, ma la testa certe volte è talmente concentrata da far pensare solo al metro che si

124
Catinaccio, a destra la Punta Emma e ancora più a destra Torri del Vaiolet
ha davanti. Già, serve pensare, occorre seguire il tracciato logico o quello che secondo lo stile degli apritori può avere senso. Arrivato al cordino, avevo avuto l’amara sorpresa di vedere che era infilato in una clessidra tanto sottile da non poter reggere neanche parte del mio peso. Poco sopra un chiodo mi aveva rincuorato, anche se brutto, ma era ora di scendere. Avevo dovuto arrampicare in discesa, protetto da quel chiodo di cui non volevo fidarmi. Poi un paio di metri più a sinistra ero arrivato alla via corretta. Finito il tratto difficile, ci aspettava una lunga salita su rocce facili, che con nostra sorpresa avevamo trovato ben pulite e divertenti. La discesa? Probabilmente avevamo sbagliato, calandoci da una sosta che non era quella prevista, dopo averla rinforzata perché non ci piaceva. Poi un canale nevoso e un’altra calata improvvisata su uno spuntone ci avevano portato alla base della parete nord. Qui solitamente si scende su un sentiero ripido, ma il pendio ora era colmo di neve, a tratti molto dura. Lentamente eravamo scesi, piccozza e ramponi ancora una volta erano serviti. La soddisfazione era stata grande, non tanto per la salita invernale, che di invernale aveva visto solo l’avvicinamento e la discesa, ma per la consapevolezza di aver potuto fare una salita in Dolomiti anche se la stagione non era quella predefinita dal calendario e dal buon senso. Eravamo stati in compagnia di tanta gente, che si vedeva sul sentiero
sotto la parete; scialpinisti ed escursionisti andavano avanti e indietro, ma allo stesso tempo eravamo stati soli, su una via da cui non è facile tornare indietro. L’amore per l’ambiente, l’incertezza del risultato, la compagnia di un amico, mi faranno per sempre ricordare questa salita come una delle più belle di sempre. La chiusura forzata di ogni attività, che sarebbe seguita a causa del virus Covid-19, non avrebbe fatto altro che rafforzare questo mio ricordo e rendermi consapevole di quanto fortunati fossimo stati.
LA VIA
La salita descritta costituisce la prima ripetizione invernale. Dato il clima mite del periodo e le scarse precipitazioni nevose, l’arrampicata non è stata disturbata da neve/ghiaccio, anche nella zona facile superiore. Da segnalare, alla data della nostra ripetizione:
• Neve dura nel traverso per arrivare all’attacco, necessari i ramponi;
• Primi metri della rampa obliqua sporchi di neve, saliti con scarpe da avvicinamento;
• Nel canale dove ci siamo calati tra la Punta Emma e il Catinaccio presenza di neve;
• Neve anche scendendo dalla forcella e nel grande canale che scende al Rifugio Vajolet.


125
La via Architettura gialla
L’attacco della via
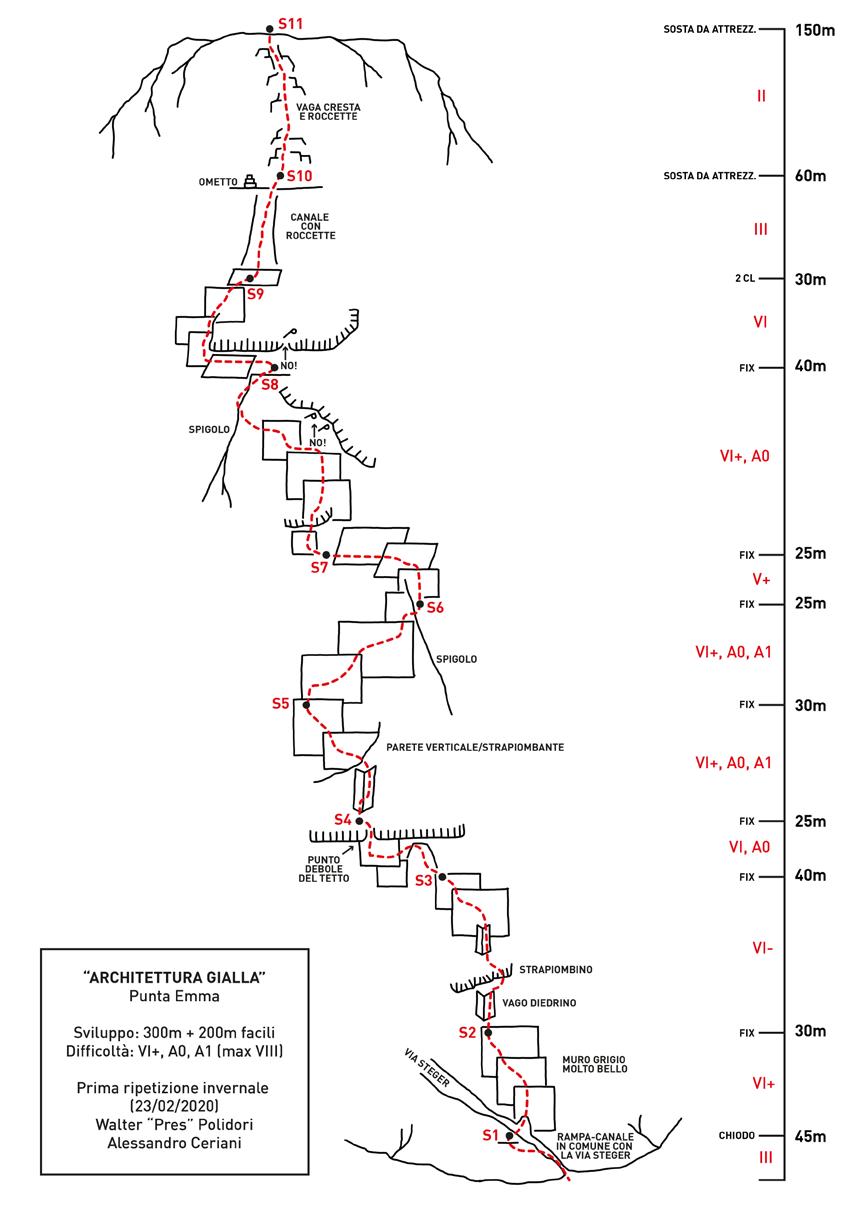
126
Accesso
Raggiungere Pera di Fassa, nella valle omonima. La navetta che portava al Rifugio Gardeccia è stata interdetta. Quindi ora ci sono due possibilità: - Andare in macchina fino alla frazione di Munciòn (parcheggio poco dopo il paese, prima del cartello di divieto di transito), e da lì raggiungere il Rifugio Gardeccia seguendo la strada asfaltata, in circa 1h. - Parcheggiare alla seggiovia di Pera di Fassa e salire con essa per due tronconi (in stagione estiva probabilmente aperto anche il terzo troncone). Dal secondo troncone un comodo sentiero porta al Rifugio Gardeccia in circa 30’.

Avvicinamento
Dal Rifugio Gardeccia seguire l’evidente strada sterrata che sale ai rifugi Vajolet e Preuss (sentiero n. 546). Arrivati ai rifugi salire per il sentiero n. 542 che va verso il rifugio Re Alberto, ma lasciarlo poco sopra, seguendo tracce che vanno a sinistra verso la cengia che sta alla base della Punta Emma.
Tempo circa 1h dal Rifugio Gardeccia, 10’ dal Rifugio Vajolet.
Attacco
Si trova alla base della evidente rampa obliqua che sale da destra verso sinistra.
Materiale
Serie di friend fino al #3 BD, abbiamo usato un paio di volte il #4, ma non è indispensabile. Necessaria una staffa. Eventualmente un martello e un paio di chiodi se dovessero esserci problemi con dei chiodi fuoriusciti. Soste attrezzate con un fix + cordone in clessidra, oppure due fix. Lungo i tiri cordoni in clessidra, chiodi, un paio di fix. Per la ripetizione invernale abbiamo usato una picozza a testa, per avvicinamento e discesa, e un paio di ramponi a testa per l’avvicinamento.
Relazione
L1: salire la rampa ascendente verso sinistra, che presenta un primo saltino più dritto. Si può stare all’interno del canalino oppure sulle roccette di sinistra. Si sosta su un ripiano a sinistra, in corrispondenza di un chiodo, sosta in comune con la classica Steger, da rinforzare. 45 m, III.
L2: la via Steger continua a salire nella rampa, invece traversare a destra, rimontare un pilastrino e salire per muro grigio molto bello. Si sale dritto e poi leggermente verso sinistra. 30 m, VI+.
L3: salire sopra la sosta per vago diedrino, verso uno strapiombino. Affrontarlo sulla destra. Si continua per altro diedrino e poi si sale verso sinistra. 40 m, VI-.
L4: salire a sinistra della sosta, verso un tetto, poi traversare a sinistra, quindi scendere leggermente e portarsi sotto la direttiva di un cordone, posizionato nel punto debole del tetto. Salire e superare il tetto, sosta a sinistra. Attenzione, roccia delicata. 25 m, VI, A0.
L5: su per diedro con fessura, per poi spostarsi su parete verticale-strapiombante a sinistra. Si continua a traversare, in ascesa, con alcuni passi obbligati, fino alla sosta. 30 m, VI+, A0, A1.
L6: salire sopra la sosta e poi spostarsi verso destra. Proseguire nel tiro in obliquo verso destra, fino all’ultima protezione, dalla quale si traversa a destra a doppiare uno spigoletto, oltre il quale c’è la sosta. 25 m, VI+, A0, A1.
L7: salire per muretto e poi traversare a sinistra su placca, fino alla sosta in una nicchia. 25 m, V+.
L8: salire a sinistra della sosta, superare uno strapiombo e continuare abbastanza verticalmente. Si arriva ad un muro sotto ad un tetto. NON salire verso un cordino e due vecchi chiodi visibili a destra, ma puntare ad un cordino a sinistra. Salire poi verso sinistra fino allo spigolo. Lo si doppia e si sale facilmente su rocce grigie ammanigliate, fino alla sosta sotto un grosso tetto, leggermente a destra. 40 m, VI+, A0.
127
Il terzo tiro

L9: traversare a sinistra sotto il tetto, quindi al suo termine salire per il suo spigolo di sinistra. Si continua su muro verticale, fino ad una zona adagiata al termine delle difficoltà. Sosta su due clessidre cordonate. 30 m, VI.
L10: salire per canale con roccette, sopra la sosta, fino ad arrivare ad un terrazzino con ometto, sosta da organizzare. 60 m, III.
L11: su ancora per roccette, seguendo poi una vaga cresta senza percorso obbligato, fino ad arrivare in cima alla Punta Emma. 150 m circa, II.
Discesa
Dalla vetta seguire un crestone in direzione rifugio Re Alberto (qualche ometto).
• Soluzione classica consigliata ma non verificata: scendere verso la parete nord-ovest fino a incontrare una sosta a fix che permette, con una calata in corda doppia, di raggiungere il canale sottostante. Da qui scendere al sentiero che da Rifugio Re Alberto porta verso il Rifugio Vajolet;
• Seguendo un ometto a sinistra (faccia verso il Rifugio Re Alberto), siamo scesi in un intaglio a sinistra con facile arrampicata, fino ad un piccolo terrazzino attrezzato con due chiodi e cordini, che abbiamo rinforzato con un cordone su spuntone. Ci siamo calati nel canale tra la Punta Emma ed il Catinaccio e siamo risaliti brevemente alla forcella. Da li siamo scesi nel canale verso il Rifugio Re

Alberto, sfruttando ancora la corda doppia (60m, qualche difficoltà di recupero). Dopo circa 10 m, visto il terreno repulsivo per neve ripida, abbiamo doppiato uno spigoletto a destra (faccia a valle), raggiungendo un cengetta rocciosa. Dopo circa 10m abbiamo attrezzato un grosso spuntone con cordone e ci siamo calati per 60 m fino al grande canale dove passa il sentiero. Scendere poi verso il Rifugio Vajolet.
PUNTA EMMA
VIA ARCHITETTURA GIALLA
Apritori: Heinz Grill, Florian Cluckner, Barbara Holzer, giugno 2018
Gruppo montuoso: Catinaccio
Difficoltà: VI+, A0, A1. In libera massimo VIII
Sviluppo: 300 fino alla fine delle difficoltà + 200 m alla vetta
Ore di salita: 5-6 h la via (in invernale)
Ore di discesa: 1h50’ fino al rifugio Vajolet (in invernale)
Roccia: dolomia, ottima nei primi tiri grigi, poi gialla e ripulita ma con zone ancora friabili a cui bisogna fare attenzione.
Esposizione: Sud-Est
129
A sinistra: in uscita dall’ottavo tiro - Sopra: il sesto tiro


130 Foto 1 Foto 2
Weissmies 4017m
Lagginhorn
4010 m
Mischabelhütte 3335 m
NADELHORN 4327 m per la via Normale
di Diego Filippi
Il Nadelhorn è di certo tra le più belle e frequentate vette del circo di Sass Fee. Con la vicina Lenzspitze, forma un unico corpo montuoso di spettacolare eleganza, soprattutto se ammirato da est. Da questa prestigiosa vetta si dipartono tre creste principali: con la prima, quella verso sud, il Nadelhorn si unisce alla vicina Lenzspitze. Verso nord invece, si allunga la celebre Nadelgrat, collegando in sequenza le cime dello Stecknadelhorn, dell’Hobärghorn e del Dirruhorn. Infine verso est, scende al valico del Windjoch, la lunga e facile dorsale della via Normale. Dalla vetta bellissimi ed istruttivi sono i panorami: dalla Nadelgrat fino al vicino e maestoso Dom de Mischabel. Prima ascensione: J. Zimmermann, A. Supersaxo, B. Epiney, F. Andermatten, 16 settembre 1858.
La via Normale o Cresta Nord Est
Bellissima ascensione, sempre divertente perché molto varia nei terreni e di grande soddisfazione per i vasti panorami godibili dalla cresta e dalla vetta. Dal rifugio, l’itinerario parte subito deciso lungo un ripido ma facile sperone roccioso. Arrivati al ghiacciaio, una bellissima traversata in quota e un erto pendio portano all’importante valico del Windjoch. Dal valico, una lunga e spettacolare cresta, porta direttamente alla piccola croce di vetta. La salita non pone mai grosse difficoltà, attenzione solo ad alcuni grandi crepacci per salire al Windjoch, e ad alcuni affioramenti rocciosi lungo la cresta. Altro problema potrebbe sorgere sulla esile e minuta cuspide di vetta, in caso di affollamento di cordate.
131
DOM DE MISCHABEL 4545 m Sass Fee 1796 m LENZSPITZE 4294 m NADELHORN 4327 m HOBARGHORN 4219 m DIRRUHORN 4035 m Hannig 2350 m P STECKNADELHORN 4241 m N Car�na Mischabelhü�e 3335 m Ulrichshorn 3925 m Windjoch 3850 m


132 Foto 3 Foto 4 Mischabelhütte 3335 m
Lenzspitze 4294 m Nadelhorn 4327 m
Difficoltà: PD, alcuni passi su roccia lungo la cuspide finale
Dislivello: 1000 m dal Mischabelhütte alla vetta. Tempo medio: 4 ore dal Mischabelhütte alla vetta. Materiale necessario: corda da 40 metri, alcuni cordini e fettucce per spuntoni, alcune viti da ghiaccio.
Relazione salita
Primo giorno
1 – dal parcheggio di Sass Fee, attraversare il paese e prendere l’impianto di Hannig. 2 – dalla stazione di arrivo (foto 1) seguire le indicazioni per il Mischabelhütte. Una lunga traversata in quota tra verdi pascoli porta alla base di un ripido sperone roccioso, lungo il quale si sviluppa il sentiero attrezzato (foto 2) che porta all’incantevole Mischabelhütte. (foto 3). Totale: da Hannig al Mischabelhütte sono circa 1100 metri di dislivello, da fare in 3-4 ore.
Secondo giorno
3 – alle spalle del rifugio, salire lungo lo sperone roccioso, che risulta essere la continuazione di quello seguito il giorno prima e che porta, in un’ora di cammino (circa 300 metri di dislivello) al vasto pianoro glaciale dell’Hohbalmgletscher. Nessuna difficoltà lungo questo
tratto; il percorso è ben segnato ed evidente fino al grande ometto di pietra.
4 – dal grande ometto di pietra, abbandonare la dorsale rocciosa per iniziare la lunga traversata in quota che, sotto le incombenti pareti della Lenzspitze e del Nadelhorn (foto 4), porta al Windjoch (foto 5), l’ampio colle che separa la modesta cima dell’Ulrichshorn dalla cresta nord-est del Nadelhorn (foto 6). Circa due ore di cammino dal rifugio.

5 – dal colle, dove si aprono magnifici panorami verso le cime della Nadelgrat (foto 7), seguire fedelmente la lunga cresta nord est che, senza possibilità di errore, porta direttamente alla cuspide rocciosa della vetta (foto 8-9-1011). Lungo la cresta si trovano alcuni modesti affioramenti rocciosi, che possono essere superati direttamente (passaggi di II grado) oppure evitati: sulla sinistra per friabili cenge rocciose, oppure sulla destra per pendii nevosi. A seconda delle condizioni, occorre valutare la scelta migliore.
6 – raggiunta la vetta, ampi panorami si aprono verso la Lenzspitze (foto 12), verso le spettacolari vette della Nadelgrat (foto 13) e soprattutto verso il maestoso Dom de Mischabel (foto 14).
Totale: dal Mischabelhütte alla vetta sono 1000
dislivello, da fare in circa 4 ore.
133
metri di
Foto
5
- nella pagina successiva Foto 6
Windjock 3850 m Ulrichshorn 3925 m

Windjoch 3850 m
Ulrichshorn
3925 m



136
Foto
7 Foto 8
Stecknadelnorn 4241 m Hobärghorn 4219 m Dirruhorn 4035 m
Stechnadelnorn 4241 mNadelhorn 4327 mLenzspitze 4294 m
Discesa:
NADELHORN




137
La lunga discesa avviene per il medesimo itinerario. Calcolare gli stessi tempi o poco meno. Foto 9 Foto 11
Quota: 4327 m Difficoltà: PD, alcuni passi su roccia lungo la cuspide finale Dislivello: 1000 m dal Mischabelhütte alla vetta. Tempo di salita: 4 ore dal Mischabelhütte alla vetta. Foto 10 Foto 12 - nelle pagine successive Foto 13 e 14 Nadelhorn 4327 m Stecknadelnorn 4241 m Hobärghorn 4219 m Nadelhorn 4327 m Nadelhorn 4327 m Lenzspitze 4294 m

Hobärghorn 4219 m Stechnadelnorn 4241 m

Dirruhorn 4035 m
 Punta
Punta
Dufour 4634 m Dom
De Mischabel
4545 m

Cervino 4478 m Dent D’Herens 4174 m

PENSIERI CORSARI DI UN ALPINISTA
di Fabrizio Manoni
Iniziai ad andare in montagna sopra casa quando andavo ancora alle elementari, seguendo mio padre che andava a caccia di coturnici sulle creste prealpine più impervie. La mia prima vera montagna fu il Pizzo Proman (2098 m) che si erge ad imponente divisione tra la selvaggia Valgrande e la piana della Bassa Ossola. Avevo undici anni. In quella nitida giornata estiva vidi in lontananza le immacolate vette del Monte Rosa e gli altri 4000 vallesani. Credo fu lì che nacque una curiosità che mi ha portato a scalare le grandi montagne. Anche quelle che vidi quel giorno con gli occhi estasiati di un bambino. Negli incontri sul muretto della chiesa con aspiranti alpinisti un po’ più grandi di me, ascoltavo i loro progetti. La via di ghiaccio sul seracco dell’Hosand, l’Arbola, il Pizzo Bianco, il canalino Ferrari al Cervandone. Erano tutte vie di ghiaccio e neve che attiravano di più poiché non richiedevano doti tecniche particolari come quelle necessarie per salire una parete di roccia. Ricordo durante un campo estivo a Macugnaga di essere rimasto affascinato dal bianco scintillante dei ghiacciai “perenni”. Era il mese di luglio ma alcuni alpinisti si preparavano per scalare il canalone Marinelli. Impensabile oggi. Nel 1979 a sedici anni in piena estate scalai la via degli Svizzeri sulla parete nord delle Courtes nel gruppo del monte Bianco. Era considerata una delle vie di ghiaccio più belle. Non difficile come la vicina nord delle Droites o come Il couloir nord dei Drus. Ma comunque impegnativa. Ma la cosa che oggi mi appare straordinaria è appunto la scalata estiva di una simile linea. Allora e non parlo di un secolo fa, ma della fine degli anni 70, era cosa normale. Occorreva solo curare le temperature ed effettuare le scalate rigorosamente di notte quando il rigelo bloccava tutto. Ormai da almeno un trentennio e progressivamente sempre peggio, il periodo per salire vie di ghiaccio famosissime tra gli alpinisti si è ridotto drasticamente. Si può dire che tutte le linee anche ad altissima quota, anche sui versanti più freddi, possono essere scalate solo in inverno fino all’inizio della primavera. Poi non solo diventano pericolose a causa delle scariche ma letteralmente si dissolvono sciolte dalle altissime temperature. Alcune vie famosissime si sono dissolte per sempre. Almeno per i tempi umani. La Meringa
del Gran Zebrú che rese celebre Kurt Diemberger ancora prima che scalasse gli 8000, ma anche il più modesto seracco dell’Hosand al quale furono rivolte le mie ormai lontane aspirazioni giovanili. Si è sciolto completamente il seracco sulla nord del Fletschorn sulla quale con Mauro Rossi aprii la bella linea dei “Puffi Magici” nel 1989. Così anche il seracco della Nordend dove avrei voluto realizzare una linea diretta. Il grande seracco costeggiato dalla via dei Francesi alla punta Gnifetti è ora appena accennato mentre quello sulla nord del Ciarforon se ne è andato ormai da anni. Il periodo di scalata invernale delle cascate di ghiaccio da quattro mesi si è ridotto a poche settimane e solo nelle valli più in quota. Potrei andare avanti con molti altri esempi limitandomi alle pareti delle montagne. Quelle che interessano noi scalatori. Più in basso le lingue glaciali hanno subito la stessa sorte. Provate ad andare sulla mitica Traversata dei Camosci che unisce il Monte Moro al Rifugio Sella sopra Macugnaga. Oppure sul ghiacciaio delle Locce con il suo omonimo lago dove solo 30 anni fa galleggiavano piccoli iceberg. Questa estate io e Claudio Schranz vi abbiamo fatto una nuotata. Impensabile qualche decennio fa. Escursionisti ma anche alpinisti esperti dell’ultima generazione colgono a fatica questo processo distruttivo. Guardano con stupore ed ammirazione il ghiaccio presente.
Io lo guardo con stupito dispiacere. Un amico alpinista settantenne mi raccontava che salendo ad un rifugio d’alta quota e guardandosi attorno gli scendevano le lacrime. Noi alpinisti siamo stati i primi ad accorgerci in maniera tangibile degli immensi cambiamenti climatici. E allora che fare?
In attesa che il Sapiens trovi una soluzione per limitare al minimo la sua influenza sul pianeta e sul clima personalmente mi sono dedicato maggiormente alla parte più solida delle montagne. Quella che sta subendo “meno” gli effetti del surriscaldamento globale. La roccia. Pur con il dispiacere per il disgregarsi dei ghiacciai e dei vertiginosi couloir di ghiaccio estremi, la roccia è un elemento che amo e che mi si addice e dal punto di vista alpinistico, sportivo ed esplorativo mi permette ancora di realizzare i miei sogni d’alta quota.
143
A sinistra: Fabrizio Manoni in arrampicata

PERCHÈ NO?
di Luca Danieli
Anno 2014, tramite un collega di lavoro mi avvicino a quello che per me è “un nuovo aspetto” della montagna, calzo per la prima volta i ramponi, faccio le mie prime ascensioni su montagne sopra i 3000 m e raggiungo addirittura la Capanna Margherita, il mio primo 4000!
Sento di aver trovato qualcosa di diverso nelle fatiche richieste dalle levatacce mattutine e dall’incessante proseguire nel freddo, nella neve e con uno zaino pesante. Il tarlo ha iniziato a scavare nella mia testa.
In quello stesso anno Lecco è scossa da una tragedia, anzi direi il mondo alpinistico lo è: Marco Anghileri detto Butch perde la vita durante una scalata al Monte Bianco. Personalmente non lo conoscevo bene Marco, se non come gestore del ristorante 2184 e fratello di due amici. Quando vengo a conoscenza della notizia inizio ad informarmi su

chi realmente fosse e la prima domanda che mi pongo è: cosa spinge un uomo ad andare da solo in inverno al Pilone Centrale del Freney con tutti i rischi e le fatiche che comporta, “solo” per compiere una prima solitaria invernale?
Oggi, con il senno di poi, la mia domanda mi fa pensare ai “Conquistatori dell’inutile” di Terray... e senza accorgermene, il tarlo sta ormai scavando una galleria. Decido che è giunto il momento di scoprirne di più sull’alpinismo, voglio capire cosa motiva a tal punto le persone da lanciarsi in questo tipo di imprese. Cerco dunque un corso che mi permetta di conoscere le basi del mondo verticale e trovo quello organizzato dal Gruppo Gamma. Il corso mi apre un mondo elettrizzante ed oltre a un gruppo di forti alpinisti, trovo anche degli amici e il desiderio di
145
A
sinistra: in disceda dal Mont Blanc du Tacul dopo aver
salito
il
Pilier Gervasutti - sopra: in vetta al Campanile Basso dopo aver ripetuto la via Maestri




146
Bivacco sulla Cresta Ovest del Salbitschijen In Grignetta con Sara
Sulla Via che non c’è in Brenta
Crozzon
di
Brenta
- Via delle Guide
entrare a farne parte diventa subito prepotente. Muovendo i primi passi sulle pareti intorno a casa, la voglia di scoperta e avventura è ormai diventata una passione che non riesco a controllare, ogni momento libero lo passo a leggere libri di alpinismo o a scalare, conosco tante persone con le quali stringo grandi legami di amicizia che poi diventa cordata. Sto iniziando piano piano a comprendere cosa fosse il fuoco che bruciava dentro al Butch. Altro che conquistatori dell’inutile, l’appagamento e le emozioni che si provano in cima a una salita sono una cosa indescrivibile, senza prezzo. A un anno dal corso sento il bisogno di andare oltre alle semplici scalate fatte fino a quel momento e comincio a interessarmi anche alla stagione invernale. Con due compagni decido di andare a fare la via Molteni sulla parete sud del Badile nei giorni successivi al Natale: una piccola avventura che mi permette di conoscermi meglio e capire cosa mi piace di più in montagna: mettermi alla prova sulle grandi classiche insieme agli amici!
In breve inizio a frequentare un po’ tutto l’arco alpino, dalle Dolomiti al Monte Bianco, ovviamente passando dalla Val Masino che è solo ad un’ora di macchina da casa ma che offre infinite possibilità! Scelgo vie che mi mettano a confronto con chi ha fatto la storia dell’alpinismo: Cassin alla Torre Trieste, Bonatti al Pilastro Rosso del Brouillard, via Lecco al Grand Capucin, Tofane, Cima Ovest di Lavaredo... tutte vie considerate impegnative ai tempi ed oggi ritenute delle grandi classiche! Ovviamente da buon lecchese frequento anche le falesie locali ed inizio ad alzare un po’ il livello, non che ne faccia una malattia ma sicuramente è un valido aiuto per poter ampliare le possibilità in montagna! Nel 2018 finalmente sono riuscito a costruirmi un curriculum, seppur breve, considerato sufficiente per poter entrare a far parte del Gruppo Gamma: un momento sognato a lungo diventa finalmente realtà!
Ora lo stimolo è se possibile ancora più grande e ci tengo a far bella figura con il gruppo, quindi organizzo con Luca Gargantini (altro futuro Gamma) una salita in inverno che cullo da un po’ di tempo, frutto di un progetto pensato con Giovanni “Charlie” Giarletta, uno dei miei più grandi compagni di cordata e amico purtroppo deceduto. Il momento giusto si presenta a febbraio 2019 dove ci dirigiamo in direzione spigolo nord-ovest del Sasso Manduino, una montagna della Val Codera che fa da trono sopra il paese di Chiavenna. In due giorni riusciamo a portare a casa il nostro obiettivo non senza qualche difficoltà imprevista, ma che detto francamente ha reso il tutto più emozionante e ci ha permesso di aggiungere qualche “pezzetto” al nostro bagaglio di conoscenze. Nel frattempo porto avanti il compito di istruttore sezionale all’interno del gruppo, l’attività di insegnamento mi piace e mi permette anche di crescere a livello personale in funzione delle mie uscite!
Con il lavoro e gli impegni quotidiani non posso che definirmi un “alpinista della domenica” che cerca di cogliere il più possibile dal tempo a disposizione, sono ancora innamorato delle classiche, in particolare di quelle che si definirebbero “dolomitiche” dove non conta tanto il grado che fai in falesia, quanto più la capacità di orientamento, il sapersi proteggere su terreno difficile e mantenere la concentrazione a lungo. Proprio in questi giorni (settembre 2022 n.d.r.) mi è capitato di ripetere una via storica delle Grigne (pensa te che paradiso ho sopra casa!): la Panzeri ‘37 al Sasso dei Carbonari. Si trova vicina alla Moss-Ruggero percorsa qualche anno fa. Una salita quasi dimenticata e sicuramente non molto frequentata! Una scalata quasi banale sulla carta ma decisamente impegnativa una volta che ci sei dentro, direi di sicura soddisfazione per gli amanti del genere! Purtroppo non ho ancora avuto la possibilità concreta di partecipare a una spedizione extraeuropea, anche se confesso che mi piacerebbe molto! Chiaramente la prerogativa sarebbe di poterlo fare con un gruppo di amici e nella maniera più serena possibile. Spesso mi è capitato di sentire di spedizioni organizzate tra alpinisti che si conoscono appena e vissute male… Oggi posso dire di avere una risposta alla mia domanda: ho finalmente capito cosa motiva le persone a sopportare sveglie improbabili, freddo, bivacchi imprevisti, fatica, e infortuni...

Amicizia, fiducia, coraggio e soddisfazione sono solo una piccola parte di quello che si può ricevere dalla montagna, il resto, per quanto mi riguarda, resta semplicemente indescrivibile.
E nonostante tutto, il tarlo continua a scavare!
147
Con Sara in vetta alla Cima della Madonna dopo aver ripetuto lo Spigolo del Velo

NON È UNO SPORT, È MOLTO DI PIÙ
La pandemia ha cambiato drasticamente le nostre abitudini e la nostra vita. Siamo rimasti chiusi nella nostra cerchia sociale, limitando le nuove conoscenze ed esperienze. In questo periodo anche le nostre scuole, per più di due anni, sono rimaste pressoché ferme con le attività e ricominciare con il nostro corso di alpinismo è stato molto impegnativo. Per la prima volta mi sono trovato dirigere un corso e ho dovuto anche rimettere in moto l’intera macchina della scuola. Non è stato facile, ma di sicuro è una gran soddisfazione vedere dei giovani allievi, allegri e raggianti nelle uscite pratiche ma anche interessati e partecipi alle lezioni teoriche. Ho potuto riprovare la bellissima sensazione di trasferire esperienza ed emozioni a persone

che, come spugne, prendevano qualsiasi goccia di ciò che noi istruttori gli trasmettevamo.
Dopo tante belle giornate assieme, vivendo le nostre piccole avventure sulle pareti, è bello fermarsi e leggere queste parole che ripagano pienamente dell’impegno di organizzare e dirigere un corso. Speriamo di aver fornito loro la chiave per aprirsi un mondo di avventure, esperienze e amicizia come solo l’alpinismo, vissuto con umiltà e consapevolezza può dare; come dice Giulia nell’articolo che state per leggere il nostro “non è un sport, è molto di più”.
Buona lettura.
Il direttore del corso
149 di Giulia
A sinistra: Albigna, sosta a fine via - sopra:
Grignetta,
calata in
corda
doppia dal Fungo


150
Arrampicando in Albigna
Calata in corda doppia dallo Spazzacaldera
Vorrei trovare delle parole poetiche e d’effetto per raccontare di questo corso di alpinismo ma scrivere non fa per me. A volte però serve anche fermarsi un attimo e ripensare a quello che è stato, per vedere come sono cambiate le cose e stupirsi di dove si è ora. Quando ho iniziato il corso di alpinismo il mio spirito inguaribilmente ottimista mi ha portato ad avere grandi aspettative: mi immaginavo di imparare le basi per muovermi in montagna in sicurezza e autonomia così da “conquistare le vette più alte”; mi immaginavo di trovare dei compagni con cui condividere queste avventure; mi immaginavo di incontrare istruttori carichi di esperienze pronti a trasmettere il loro sapere. E così è stato. Fin da subito si è creato un clima familiare che si è rafforzato sempre di più.
Ripercorro nella mente le varie uscite e mi rendo conto di come ogni volta sia stato aggiunto un piccolo tassello. La prima uscita in falesia a Courtil in cui per tanti c’è stato il primo incontro con imbrago, scarpette, corda e moschettoni; poi ci sono state le Placchette di San Martino dove sotto un sole cocente abbiamo provato le varie manovre in parete. Poi lei, la Grignetta. La palestra di ogni alpinista lecchese. Una delle uscite che più mi è rimasta a cuore. Non vi ero mai stata ed è stato sorprendente vedere quelle guglie di roccia su cui sono state immaginate moltissime vie di salita.
Ho provato un senso di rispetto e soggezione nel muovermi su quella roccia, nonché attimi di adrenalina nel calarmi dal fungo e sentirmi totalmente nel vuoto. Poi c’è stata l’uscita a Scalaro, alla Parete delle Stelle. Un’altra occasione per perfezionare la tecnica e le manovre. Abbiamo fatto anche un 4000!! Il Breithorn Occidentale che, per quanto facile possa essere, le condizioni meteo hanno reso la salita un’impresa dai toni un po’ patagonici. E poi l’Albigna… un paesaggio mistico in cui immense pareti di granito perfetto fanno da cornice ad un lago dai toni smeraldo. Qui abbiamo sperimentato un’arrampicata diversa: placca spietata, che richiede una buona dose di decisione e fiducia. Ora il corso è terminato e spetta a noi mettere in pratica ciò che abbiamo imparato. Oltre a tutto ciò, abbiamo imparato che l’alpinismo non è un semplice sport, ma molto di più. È curiosità e voglia di avventura. È amore e rispetto per la natura. È amicizia, condivisione, fiducia. È voglia di mettersi in gioco, conoscere i propri limiti, le proprie paure. È scoprire di avere capacità e risorse che neanche noi pensavamo di avere. È totale onestà con sé stessi e con gli altri. Quando si è in parete cadono tutte le maschere e può emergere chi siamo realmente. Non possiamo mentire. Tutto questo è molto più di una prestazione fisica. L’agitazione la sera prima di una salita. Preparare lo zaino, leggere la relazione, accordarsi con i compagni sull’orario. Il viaggio in macchina verso la destinazione carico di aspettative. E poi la salita. Un’avventura travolgente, in cui ti dimentichi ogni cosa. Tornare alla macchina colmi di soddisfazione, fermarsi a bere e mangiare, ripensare alla giornata.

Non è uno sport, è molto di più. E il giorno dopo, chi in ufficio, chi in università, ti ritrovi a pensare al giorno prima e vorresti tornare lì. Allora inizi a fantasticare sulla prossima avventura perché non puoi fare a meno di quelle emozioni. Quelle emozioni che solo l’alpinismo ti può dare. Questo corso è concluso ormai ma non si tratta di una fine, ma di un inizio. L’inizio di un percorso in cui potremmo sfruttare gli strumenti che ci sono stati forniti in questi mesi e contribuire anche noi, in minima parte, alla storia dell’alpinismo. E magari, perché no, tra un po’ di tempo potrebbe anche succedere di ritrovarsi a condividere delle avventure proprio con chi ci ha trasmesso il proprio sapere.
Grazie.
151
Giornata di manovre, risalita della corda

CENTO MENO UNO versi sparsi ben allineati
di Matteo Bertolotti
Pasqua 2022. Sto arrampicando con Silvano Arrigoni alla Cima alle Coste e all’improvviso, con la coda dell’occhio, riconosco un omino che si muove lentamente qualche centinaio di metri sotto di noi. Dai movimenti, simili a quelli di chi toglie la polvere dal proprio mobilio, riconosco Luca Pilati, che con Pino Moser è impegnato nella ripetizione e pulizia del suo itinerario preferito: la via Dinosauri. Un veloce saluto e dopo qualche ora ci appostiamo al Bar delle Placche Zebrate per parlare di progetti sorseggiando birre. Non ricordo quante ne ho bevute e nemmeno se il caldo della giornata fosse tale da giustificare un simile apporto idrico. Il clima è festoso e ripaga delle fatiche lavorative della settimana. Ad un certo punto, Luca mi guarda e con gli occhi di un orsacchiotto che chiede un po’ di miele, sottovoce mi sussurra una frase: sto per farti una domanda alla quale devi assolutamente rispondere con un sì. Conosco Luca dal 2012 e so benissimo che certi sguardi, accompagnati da una tonalità di voce simile a quella del peccatore penitente, sono il preludio di una proposta alpinistica piuttosto intensa. Resto sorpreso quando, anziché parlarmi di ripide pareti, mi confida il desiderio di correre con me e altri amici la prossima edizione del Dolomiti di Brenta Trail. La gara si sarebbe corsa il 10 settembre partendo e arrivando al Lago di Molveno. Capisco che qualcosa non torna. Una proposta indecente l’avevo messa in cantiere, ma quella di correre su e giù per le crode, collezionando dislivello, proprio non me la sarei mai aspettata. Luca, di fronte al mio sguardo, quello di una persona che sa di aver esagerato con le birre, aggiunge: sai, il Franz poco dopo l’operazione alla testa e alle terapie aveva corso la versione lunga del trail (n.d.a. 64 chilometri - 4200 metri di dislivello positivo)
Una sberla a doccia fredda. Luca “Franz” Franceschini, trent’anni appena compiuti, da due anni non è più con noi per colpa di una fottuta malattia che l’ha portato via troppo presto.
L’invito, che in realtà vivo più come un dovere, viene
alleviato dal fatto che avremmo corso la versione X-Terra, che prevede 45 chilometri di sviluppo e un dislivello di 2850 metri.
Non avevo ancora partecipato a gare di nessun tipo e da lì a pochi mesi avrei corso, insieme a Davide Martini e Alessandro Ferrari, la storica gara del Passatore. 100 chilometri ininterrotti che da Firenze conducono a Faenza. Certo, correre sui sentieri è ben diverso dal gareggiare sull’asfalto ma, a conti fatti, penso che sarà un buon allenamento.
Guardo il monte Brento cercando un po’ di silenzio e penso che è il modo migliore per ricordare il Franz. Nessuna serata pubblica, con foto e brindisi, ma solo tanta fatica da condividere con un gruppo ristretto di amici, anche loro impegnati a vivere la mia stessa fatica. Sono convinto che ognuno di noi, durante la corsa, dialogherà in intimità con i propri ricordi.
Estate. Il caldo atroce dei mesi più importanti per un alpinista allontana da me la voglia di allenarmi, tuttavia capisco che non posso prendere sottogamba il trail che lentamente si sta avvicinando a me. È grazie all’ospitalità e amicizia di Susanna Martinelli e Alessio Guzzetti, che prendo il coraggio di percorrere in solitaria e in giornata il Sentiero Roma seguendo la variante Risieri che, partendo da Predarossa, coincide con il tracciato del celebre Trofeo Kima.
Settembre – La settimana della gara. Lentamente si avvicina il weekend della gara e il venerdì pomeriggio prendo una mezza giornata di ferie, una delle ultime che mi rimane da consumare in questo strano 2022. L’idea è quella di salire a Molveno per evitare una sveglia antelucana e ritirare per tempo il pettorale. Data la vicinanza a Pinzolo, approfitto per organizzare una pizza con Mirko Ferrari. È l’occasione per dare una voce ai diversi messaggi scambiati negli ultimi tempi. L’incontro parte con uno spritz, poi un altro e poi un altro ancora, per finire con una birra media e una pizza. Le parole si susseguono disordinate come se fossero il filo di una
153
A sinistra: in direzione del passo del Grostè
grande matassa ingarbugliata. Sogni, viaggi, progetti e tanta semplicità quotidiana. Poi, la spiazzante domanda: ma sei davvero sicuro di voler correre il trail dopo tutto quello che hai bevuto? Rispondo all’amico dicendo che il mio obiettivo è quello di arrivare e che, come spesso Davide Martini mi ricorda, noi siamo alpinisti e non podisti. Prima di congedarci, Mirko mi offre la possibilità di dormire sul suo divano. Dopo una breve titubanza, accetto di buon cuore l’invito. Certamente alla gara arriverò più riposato.

10 settembre – ore 7.30. Dopo aver spillato sui pantaloni il mio pettorale con il numero 99 (porca paletta! un numero in più e avrei potuto avere il 100), e superato il controllo zaini, ha inizio la gara. Corro con la spensieratezza di un bambino, ben consapevole dell’intensa giornata che mi appresterò a vivere.
Intorno a me ci sono tante altre persone e mi interrogo sul perché della loro presenza a questa fatica. È incredibile guardarli negli occhi. Una comunità di sconosciuti, che si muove, anzi corre, insieme. Raggiunto Andalo iniziano salite importanti e per me e tante altre persone, è impossibile continuare a correre. Qui si “macinano” i metri di dislivello più importanti e la fatica non lascia abbastanza spazio alla testa per elaborare le emozioni. È dopo aver superato il ristoro di Malga Spora
che la mente inizia a mettere da parte la fatica e lasciare lo spazio alle emozioni, ed è così che il primo ricordo va al Franz e alle nostre, poche per la verità, giornate trascorse in parete. È la sua tenerezza ad alleviare la mia fatica, resa ancora più fastidiosa dai pesanti crampi che mi colpiscono e che non mi abbandoneranno per il resto della giornata. Chi passa a fianco a me riconosce il dolore che sto sopportando e tutti, chi con un cenno, chi fermandosi, mi chiedono se ho bisogno di qualcosa, di un aiuto. Prendo definitivamente coscienza che non sto partecipando a una competizione dove la rivalità corre alla velocità della luce. Sento il calore di una comunità che sta condividendo fatiche, emozioni, sorrisi. Mi accorgo di essere parte di un gruppo di amici, anche se è la prima volta che il mio sguardo incrocia quello di una ragazza di Helsinki che parla benissimo l’italiano o quello di Donato, un simpatico signore di Bergamo, con il quale condivido un tratto del percorso.
Una comunità unita che si muove per un obiettivo comune. Come dicevano i latini: Citius, Altius, Fortius. Communiter. Più veloce, più in alto, più forte. Insieme… Sarebbe davvero una grande cosa se si riuscisse a traslare questo semplice concetto da un trail alla vita quotidiana del mondo intero. La mente mi porta alla schifosa campagna elettorale che stiamo vivendo, alla guerra in Ucraina e alle Durante la discesa nella Val delle Seghe
mille altre ingiustizie che ci sono nel mondo e che spesso non appaiono sulle strisciate dell’ANSA. Penso che forse, tutti, dovrebbero partecipare almeno una volta ad un trail, ma penso anche che forse, ho messo in fila dei pensieri un po’ assurdi. Certo è che, sotto il sudore di questa corsa, riscopro l’importanza del concetto di comunità: dell’essere piuttosto che dell’apparire e del tendere piuttosto che del chiedere.

Poi riprendo a faticare nel ricordo del Franz. Al rifugio Tucket il cielo si scurisce. Le previsioni norvegesi di YR, alle quali solo Luca Pilati non crede, erano ben chiare: rovesci isolati a metà mattina e nelle prime ore del pomeriggio. Alcune persone che da tempo stanno marciando con me, approfittano del tetto del rifugio per mettersi un guscio impermeabile. Io, essendo molto sudato, preferisco continuare con gli abiti che ho addosso e, mentre scambio un saluto al povero fotografo costretto a rimanere appostato sotto l’acqua qualche decina di metri sotto al rifugio, penso che il cielo stia piangendo di tristezza. Quanto mi manca il Franz! Sono pensieri stupidi, insensati eppure tremendamente forti e vivi ancora adesso che, nella mia incapacità, sto cercando di tradurre delle emozioni in parole. Trovo il coraggio di superare l’ennesimo attacco di crampi e proseguire verso il rifugio Brentei e l’ultima ripida salita alla Bocca di Brenta. Mentre a fatica arranco sul ghiaione a sinistra del tratto attrezzato, che normalmente è seguito dagli escursionisti, sento un gruppo di ragazzi tifare per me con l’aiuto fracassoso di alcuni grossi campanacci. Effettivamente manca poco al rifugio Pedrotti, dove avrò la possibilità di mangiare qualche pezzetto di cioccolato e ricaricarmi prima dell’infinita discesa verso Molveno. Improvvisamente l’occhio ricade sul pettorale e questa volta leggo “cento meno uno”. 100 è a tutti gli effetti un numero bello tondo e penso che possa rappresentare la “perfezione assoluta”
delle persone, ma tutti gli esseri umani sono imperfetti e fallibili. Serve un po’ di umiltà e una buona dose di coraggio per ammetterlo, ma è assolutamente così. Un mancare che ci rende diversi, e la diversità, spesso è una ricchezza. La discesa prosegue lungo la Val delle Seghe, supero il rifugio Croz dell’Altissimo e con un lungo districarsi in mezzo ai boschi arrivo a Molveno. Oltrepasso il centro storico e mi porto in riva al lago, a poche centinaia di metri dall’arrivo. Ora c’è il sole e guardando il cielo ringrazio Dio, quello in cui credo a periodi alterni, per questa giornata. Ultimamente sto riscoprendo i Vangeli. Non durante una messa, ma per i cavoli miei a casa. Si può credere o non credere, ognuno di noi può fare come vuole, ma in quelle parole sono contenuti messaggi universali che possono migliorare (o forse addirittura salvare) il mondo intero. L’indomani scopro che il Papa aveva pronunciato durante l’Angelus queste parole: Chi ama si preoccupa di chi manca, ha nostalgia di chi è assente, cerca chi è smarrito, attende chi si è allontanato. Perché vuole che nessuno vada perduto. Varco il traguardo dopo undici ore e una manciata di minuti. Intorno c’è festa, intorno ci sono persone sconosciute che applaudono e intonano canti. Intorno c’è una comunità e la famiglia di Luca Franz Franceschini. Sono felice e dalla vita non ho bisogno di altro. Buon cento meno uno a tutti.

155
Il pettorale All’arrivo

MARMOLADA

di Eugenio Maria Cipriani
Dopo la sciagura sulla Marmolada del 3 luglio, niente in alta quota sarà più come prima. Né su quel che resta dei ghiacci della cima più alta delle Dolomiti né su qualsivoglia altro ghiacciaio montano. Andrà riscritta la storia dell’alpinismo poiché anche “vie normali” in ambiente glaciale solitamente ritenute mansuete è ormai dimostrato che possono trasformarsi da un momento all’altro in trappole mortali. E andrà rivisto pure il modo di affrontare l’alta quota, dalle vie di ghiaccio a quelle di misto. Revisione che per queste ultime, di fatto, era divenuta necessaria già da diversi anni un po’ ovunque a causa dello scollamento estivo di grossi blocchi di roccia con conseguenti interdizioni (spesso disattese dagli alpinisti) da parte delle amministrazioni comunali sia di qua che di là dalle Alpi. Esaminando nello specifico le Dolomiti, sono sotto gli occhi di tutti i principali effetti del cambiamento
climatico in corso: inverni siccitosi, temperature estive sopra la media per lunghi periodi, eventi metereologici estremi (vedi Vaia) e rapido ritirarsi degli ultime zone glaciali (o glacio-nivali).
A parte il ghiacciaio della Marmolada, tipico ghiacciaio di “calotta” ma, un tempo, dotato di un discreto sviluppo vallivo, gli altri ghiacciai dolomitici erano (l’uso di un tempo passato ormai è d’obbligo) prevalentemente di canalone e di conca. Facevano eccezione solo i ghiacciai sommitali di Cima Tosa, di Cima Brenta (che presentava pure un seracco pensile) e della Fradusta, sulle Pale, nonché numerosi nevai pensili minori come, tanto per fare un paio di esempi, il Pian del Lezuò, sull’Antelao, o il Cristallo sulla nord-ovest del Civetta. Purtroppo gran parte di essi non esiste più e anche i ghiacciai di canalone sono oggi ridotti, d’estate, a rock-glaciers assolutamente impraticabili
157
Un evento imprevedibile che riscrive le regole del muoversi in alta quota
A sinistra: Cannoni sparaneve in versione estiva a Pampeago - Sopra: Bacino di raccolta idrica spuntato durante la pandemia sul Monte Agnello (Pampeago)
sul piano alpinistico. Possono essere risaliti quindi solo in pieno inverno o all’inizio della primavera ma sempre accollandosi grossi rischi per il pericolo di crolli di roccia dalle pareti laterali.

Condizione fondamentale per la formazione e lo sviluppo di un ghiacciaio è l’esistenza, al di sopra del locale limite delle nevi permanenti, di superfici adatte alla raccolta, all’accumulo, alla conservazione e alla trasformazione della neve in “nevato” e poi in ghiaccio. I guadagni (accumulo) derivano soprattutto dalle precipitazioni in forma nevosa (alimentazione diretta), ma anche dalla neve trasportata dal vento e dalle valanghe, processo, quest’ultimo, di particolare efficacia nell’ambiente topografico e morfologico dei ghiacciai dolomitici. Luoghi deputati all’accumulo di neve destinata poi a diventare ghiaccio sono sempre stati, almeno sino a una quarantina di anni or sono, i canaloni esposti a settentrione e le sottostanti conche di accumulo. Rinserrati fra pareti verticali, spesso impostati su profonde diaclasi, raramente lambiti dai raggi del sole, essi rappresentano i siti dove più facilmente, anche a quote non elevate, può prodursi un bilancio di massa positivo. Sono luoghi strani e contraddittori: basti dire che in diversi di essi la zona di ablazione, cioè di scioglimento del ghiaccio, spesso si trova
a quote più elevate rispetto a quella di alimentazione. Ciò a causa della particolare morfologia dei versanti entro cui s’insinuano queste lingue di ghiaccio e neve, ampi (e più “caldi”) verso l’alto, cioè verso lo sbocco superiore, stretti e incassati (e di conseguenza più “freddi”) nella parte inferiore.
In questi imbuti di raccolta nivo-glaciale, a partire dalla prima metà degli anni Novanta il bilancio ha iniziato a trasformarsi da positivo a tendenzialmente negativo. Molti di questi canaloni, infatti, si presentano oggi in palese fase di ritiro, se non addirittura “morti” o trasformati in rockglaciers a forte pendenza.
Parlare di rock-glaciers non è casuale e introduce un altro aspetto tipico delle zone interessate dai percorsi in questione: quello del consistente incremento dei fenomeni franosi sulle pareti che rinserrano gli imbuti ghiacciati. Il riferimento non è solo ai fenomeni erosivi conseguenti al passaggio e al successivo ritiro dei ghiacci, ma a macroscopici esempi di quarring, cioè di sradicamento di blocchi anche di ciclopiche proporzioni, uniti a una accentuata tendenza ai fenomeni clastici di disfacimento specie nelle pareti dove maggiore è l’escursione termica durante il giorno e dove corre la linea di demarcazione fra ghiaccio e roccia, buio e luce, umido ed asciutto.
158
La Marmolada vista dal Passo Valparolo tre giorni dopo il crollo del ghiacciaio
Al di là dell’ormai trascurabile interesse alpinistico dei ghiacciai dolomitici di canalone, essi potrebbero tuttavia rappresentare, tanto nel loro insieme quanto considerati singolarmente, un interessante laboratorio di studi. Certo non sarebbe uno studio facile, né comodo e nemmeno del tutto esente da rischi. Però si tratterebbe di un orizzonte, per quanto piccolo e geograficamente limitato, ancora da studiare e che potrebbe essere utile per prevenire fenomeni analoghi a quello del 3 luglio scorso.

Che cosa è accaduto sulla Marmolada Come giustamente ha osservato Reinhold Messner subito dopo il tragico evento, lo scollamento di parte della calotta sommitale del ghiacciaio di Punta Rocca è stato con buona probabilità dovuto al ruscellamento della neve di fusione (abbondante a causa delle prolungate alte temperature) che ha letteralmente scollato il ghiaccio dalla superficie rocciosa su cui la calotta poggiava da millenni.
Un ghiacciaio, soprattutto se di calotta, può essere paragonato a una glassa di cioccolato sopra a un dolce. Se la temperatura esterna si alza, la glassa da compatta diventa viscosa e, se i bordi della torta sono spioventi, poco a poco si frattura e si scolla trascinando nella caduta anche qualche pezzo superficiale di torta. In Marmolada è
successo esattamente questo solo che, anziché cioccolato, sono precipitati a valle circa trecentomila metri cubi di ghiaccio che hanno trascinato con sé enormi blocchi di roccia con le conseguenze drammatiche che tutti conosciamo.
Un fenomeno assolutamente imprevedibile ma che dal 3 luglio in poi dovrà comunque essere tenuto in debita considerazione come monito nella programmazione di qualsiasi escursione su un ghiacciaio. A rendere l’evento del 3 luglio ancora più imprevedibile concorre il fatto che la massa che si è staccata non poggiava su una superfice convessa e ripida come era un tempo quando la calotta ghiacciata si estendeva da Punta Rocca sino a poco sopra il Pian dei Fiacconi confluendo con il ramo nordorientale di ghiaccio proveniente da Punta Penia lungo il quale corre la “via normale” alla vetta della Marmolada. Da tempo la calotta ghiacciata di Punta Rocca, infatti, si era annidata dentro una sorta di enorme conca sospesa sopra l’ex scivolo ghiacciato, divenuto da anni una parete di roccia. In altre parole, quindi, non vi erano più né lo scivolo ghiacciato né la crepaccia terminale ma solo una sorta di “cappello” glaciale solcato da alcuni larghi crepacci, cappello che poggiava sull’ampio circo roccioso che ne faceva da basamento. Circo oggi ben visibile in quanto la
159
Frana recente sulla parete sud del Vernel
metà settentrionale è emersa dopo il crollo di parte della calotta.
In conclusione, quindi, se la calotta glaciale fosse stata appoggiata su una superfice convessa, forse si sarebbe potuto ipotizzare un crollo. Poggiando invece dentro una gigantesca conca sospesa, tutto faceva pensare che il livello del ghiaccio si sarebbe ridotto poco a poco senza eventi catastrofici. L’opposto di ciò che è accaduto. Tutto ciò a riprova, se mai ce ne fosse bisogno, che la montagna non solo è imprevedibile ma che non si può mai dire di conoscerla a fondo e che quindi per affrontarla oltre all’esperienza, peraltro indispensabile, occore anche una buona dosa di fortuna.

“Vie di ghiaccio in Dolomiti”: la testimonianza editoriale della fine di un modo di fare alpinismo sulle Dolomiti. Sul finire degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, affascinato sia dal mondo dolomitico che dall’arrampicata su ghiaccio, mi dedicai all’esplorazione dei principali itinerari glaciali di arrampicata sui Monti Pallidi, intendendo col termine “itinerario glaciale di arrampicata” un percorso su terreno ripido nevoso e\o ghiacciato effettuabile anche e soprattutto durante la stagione estiva, scalabile solo con l’uso di appositi attrezzi (piccozze e ramponi) e con una appropriata tecnica di
progressione. Il censimento degli itinerari glaciali mi portò all’identificazione di una ventina di percorsi in diversi gruppi dolomitici dal Brenta alle Dolomiti di Sesto passando ovviamente per la Marmolada(1). Condensai queste mie esperienze in una guida (oggi esaurita) che venne pubblicata nel 1986 e che riscosse un insperato consenso di pubblico. A distanza di pochi anni dalla pubblicazione iniziarono a giungermi testimonianze, da parte dei ripetitori di questi percorsi, che riferivano di situazioni di fatto ben diverse da quelle descritte nella guida in quanto andava via via scemando ovunque la presenza del ghiaccio mentre, in parallelo, cambiava la morfologia stessa delle pareti che rinserravano i percorsi. Oggi la maggior parte di essi non esiste più o è diventata impraticabile - se non a prezzo di altissimi rischi - non solo d’estate ma anche d’inverno. I due scivoli nord e nord-ovest di Punta Penìa, ad esempio, da tempo erano stati messi nel dimenticatoio alpinistico mentre sino agli anni Ottanta erano vie di ghiaccio molto frequentate anche e soprattutto a inizio estate. Pure il versante da dove si è staccata parte della calotta glaciale il 3 luglio scorso (Marmolada di Rocca) era sino a trentacinque-quaranta anni fa totalmente ghiacciato e, essendo meno ripido di quello di Punta Penìa, veniva non solo salito anch’esso con piccozza e ramponi ma persino sceso da chi voleva impratichirsi con lo sci
160
Gru e lavori in vista della prossima stagione invernale a Pampeago
ripido. La fusione di ghiaccio che sicuramente è presente all’interno (cioè nelle fessure o diaclasi) dell’enorme massa calcarea (non dolomitica!) di cui è composta la Marmolada potrebbe inoltre favorire il distacco di fette di roccia anche dal compatto versante meridionale della “Regina delle Dolomiti” analogamente a quanto è avvenuto pochi anni fa sulla parete sud del fratello minore della Marmolada, il Gran Vernel. La grande nicchia di distacco, biancastra, è ben visibile in Val Rosàlia dal sentiero (Alta Via n. 2) che collega i rifugi Contrin e Falier attraverso il passo d’Ombretta.

Vecchie polemiche e nuove prospettive Spettacolare e tragico, l’evento del 3 luglio ha avuto una vastissima eco mediatica non solo in Italia ma anche all’estero. Nel nostro Paese, in particolare, sono stati versati fiumi d’inchiostro e girate ore ed ore di servizi televisivi per analizzare la catastrofe in ogni dettaglio. Il bilancio complessivo di undici morti ha poi dato adito a considerazioni non solo in merito alla prevedibilità o meno dell’evento ma anche se non fosse stato e se non sia in genere opportuno interdire l’attività alpinistica almeno in quota.
Circa la prima questione glaciologi, professionisti della montagna ed esperti locali hanno giudicato all’unanimità l’evento come assolutamente non prevedibile. Quanto alla
seconda, ovvero l’opportunità o meno di vietare in qualche modo la pratica dell’alpinismo, come era prevedibile è nato un dibattito tanto clamoroso quanto inutile. Vecchie storie, che si ripetono da quando è nato l’alpinismo. Quando il 14 luglio del 1865, dopo aver raggiunto per la prima volta la vetta del Cervino ben quattro dei sette componenti della cordata precipitarono lungo la parete nord il fatto, gonfiato ad arte dalla stampa inglese, suscitò un tale clamore che per qualche mese la regina Vittoria stessa rimase in dubbio se vietare o meno ai sudditi della Corona la pericolosa moda delle scalate che stava diffondendosi a macchia d’olio. In tempi più recenti, nel luglio del 1961, la tragedia del Pilone del Freney in cui persero la vita anche in questo caso quattro dei sette protagonisti (viene da pensare che scalare un cima in sette porti un tantino sfiga! N.d.A.) diede fuoco alle polveri mediatiche e puntualmente si scatenarono i soliti opinionisti da salotto che invocarono la messa al bando dell’alpinismo. In entrambi i casi alla fine non se ne fece nulla e gli alpinisti continuarono imperterriti a scorrazzare su e giù dalle cime. La storia si è ripetuta anche dopo la sciagura del 3 luglio scorso (viene da pensare che pure scalare in luglio, oltre che in sette, porti un tantino sfiga! N.d.A.) ma di nuovo, per fortuna, non è stato posto alcun veto alla pratica alpinistica se non limitatamente al versante nord della Marmolada a
161
Ghiacciaio della Marmolada nel 2011


162
Ghiacciaio della Marmolada
- 2014 Ghiacciaio della Marmolada - 2015
causa dell’incombenza, questa volta più che evidente, del pericolo di nuovi crolli.
Si è però continuato a cercare un capro espiatorio e un noto quotidiano nazionale, titolando a caratteri cubitali “Siamo tutti colpevoli!”, sembra averlo trovato. Soluzione geniale perché incolpando tutti si finisce per non dar la colpa a nessuno. Così si salvano i proverbiali capra e cavoli. In realtà il giornalista, come è ovvio, non attribuiva colpe specifiche ma con quella dichiarazione di colpevolezza generale sottendeva che i Sapiens, per dirla alla Mario Tozzi, non stanno facendo abbastanza (in alcuni casi aggiungerei che stanno facendo proprio il contrario) per limitare la crisi climatica, il riscaldamento globale, etc.
Il giornalista non ha tutti i torti, anzi. Entrando un po’ più nello specifico, ovvero considerando l’ambiente montano e in modo particolare le Dolomiti, a me sembra che lo sfruttamento del territorio in molti, anzi troppi, casi venga spinto oltre la soglia di sostenibilità per favorire un tipo di turismo dannoso e palesemente obsoleto. A costo di risultare noioso e ripetitivo nei confronti di chi è solito leggere questa rivista, torno a puntare l’indice contro lo sci da discesa e contro la cieca e pervicace politica degli amministratori locali di continuare a promuoverlo e incentivarlo nonostante i fatti, vale a dire il cambiamento climatico unito alla crisi energetica e a quella idrica, ne segnalino l’evidente insostenibilità sia sul piano economico che ambientale. L’innevamento artificiale, unanimamente ritenuto indispensabile dagli specialisti del settore sciistico almeno sino ai 2500 metri di quota, è una delle pratiche più energivore sia in termini di fabbisogno idrico che elettrico. Inoltre stravolge il territorio che, laddove sono presenti le piste da sci, viene contraddistinto da enormi totem metallici che definire orrendi è far loro un complimento e costellato da bacini di raccolta di una risorsa che in un futuro purtroppo non molto lontano diventerà più preziosa, e conseguentemente più costosa, dell’oro nero: l’acqua.
L’obiezione più ovvia a questa considerazione verte sull’enorme indotto economico che gira attorno allo sci alpino. Il turismo invernale legato allo sci oggettivamente porta molti soldi nelle casse di albergatori, impiantisti, ecc. Ma occorre tenere presenti due elementi non trascurabili.
Anzitutto che i costi di esercizio sempre più elevati trasformeranno definitivamente lo sci alpino in uno sport d’elite e quindi vi è da chiedersi se vale la pena sperperare soldi (in parte pubblici e quindi anche di chi non scia), per garantire un futuro a un’attività riservata a pochi e che arricchisce solo alcune zone dell’arco alpino. In secondo luogo l’inverno pandemico 2020-2021 con i suoi impianti di risalita chiusi (fatta eccezione per i Mondiali di Cortina) ha registrato comunque ogni fine settimana il tutto esaurito in montagna con gente felice di passeggiare, ciaspolare e fare scialpinismo in piena tranquillità.
Un turismo invernale alternativo è dunque possibile, ancorché auspicabile. Così come sarebbe auspicabile tagliare una buona volta i finanziamenti pubblici adibiti a opere che, per motivi climatici ed energetici, diventeranno inutilizzabili nel volgere di un paio di decenni al massimo. Non parliamo poi della pista olimpica da bob di Cortina che sarà utilizzata da uno sparuto manipolo di praticanti solo per qualche giorno per fare la fine poi di quella piemontese realizzata a Cesana per le Olimpiadi del 2006 o di quella, sempre a Cortina, realizzata per le Olimpiadi del 1956 e abbandonata da oltre mezzo secolo alle ortiche.
A ben guardare le uniche strutture che tutto sommato, pur impattando sul territorio, potrebbero rivelarsi utili – sia chiaro, utili socialmente, non economicamente –sono i bacini idrici. Certo non per essere usati allo scopo di sparare la neve sulle piste ma come riserve di un bene destinato, anno dopo anno, ad acquistare sempre più valore specie quando, in un futuro ormai non molto lontano, tutti i ghiacciai si saranno liquefatti.
Note
1 Ecco i percorsi, qui di seguito distribuiti in ordine di gruppo dolomitico di appartenenza. Dolomiti di Brenta: 1) canalone nord (Neri) di Cima Tosa; 2) canalino sud di Cima Tosa; 3) scivolo nord di Cima Brenta. Gruppo delle Pale di San Martino: 1) scivolo nord del Travignolo; 2) canalone della Beta. Gruppo del Civetta: 1) via del “Giazzèr”. Gruppo del Pelmo: 1) la “Fisura”. Gruppo dell’Antelao: 1) canalone nord (Oppel) all’Antelao; scivolo nord (Menini) di Forcella Menini. Gruppo del Sorapìss: 1) canalone Comici-Brunner alla Fopa di Mattia; 2) canalone Nenzi-Pianetti alla Cacciagrande. Gruppo del Cristallo: 1) canalone Innerkofler. Gruppo dei Tre Scarperi: 1) canalone Comici-Fabjan-Brunner. Gruppo del Popera: 1) canalone “omicida” (canalone Schuster) del Monte Popera; 2) via del ghiacciaio pensile. Marmolada: 1) scivolo nord alla Punta Penìa; 2) scivolo nord-ovest alla Punta Penìa.

163
Ghiacciaio della Marmolada - 2017

IL GENERALE ANTONIO CANTORE: INCHIESTA SU UNA MORTE MISTERIOSA
di Fabio Cammelli
“Anima eroica degli alpini, salda come le rupi che lo videro cadere colpito in fronte, ardente come la fede per cui morì”: queste parole stanno scritte sulla lapide posta alla base del monumento eretto in sua memoria a Cortina d’Ampezzo. Numerosi i soprannomi dati al generale Antonio Cantore: El vecio, El Colonèl, Toni (così lo chiamano gli alpini veneti), Tognin (per gli alpini piemontesi), Babo Tòne (per gli ampezzani).
Autoritario ed intransigente, rude nei modi e brusco nei rapporti interpersonali, di carattere difficile ed introverso, molto pignolo e rancoroso, dal rimprovero facile ed anaffettivo con i subalterni, è però sempre e comunque presente laddove maggiore è il rischio. Apostrofa con durezza i suoi soldati, ricorrendo se necessario anche alle bestemmie (i suoi biografi sono concordi nell’affermare che il linguaggio di Cantore fosse spesso ricco di espressioni ed imprecazioni “da caserma”). Nonostante la balbuzie, incita ogni attacco contro il nemico con il suo “Avv-vanti!! Avv-vanti pp-per Dio!! Avv-vanti Dio Cr-Cristo”
Appare instancabile, burbero nei confronti della truppa, inflessibile con i suoi ufficiali da cui pretende, al pari di se stesso, coraggio e sprezzo del pericolo (procurandosi in questo modo non pochi nemici). La sua audacia, unita alla mancanza di paura nell’esporsi in prima persona al fuoco del nemico, esercita uno straordinario ascendente sui soldati, esaltandone l’entusiasmo, l’emulazione e l’eroismo.
Con la sua morte in prima linea, il 20 luglio 1915, Antonio Cantore è entrato nella leggenda, ma a tutt’oggi la ricostruzione degli ultimi istanti di vita del Generale non appare univoca, tanto d’aver dato origine a diverse versioni.
Abbiamo una versione cosiddetta “ufficiale”, secondo cui la sua morte sia avvenuta per mano di un soldato austriaco (questa tesi, con lievi varianti, è riportata nel testo come prima, seconda, terza e quarta versione).
C’è poi una versione che sostiene la tesi opposta, cioè che l’uccisione di Cantore sia stata opera di un soldato o di un ufficiale italiano: versione basata solo su voci circolate all’epoca e riprese anche successivamente, ma sempre senza alcun supporto documentato (questa tesi è riportata nel testo come quinta versione).
Abbiamo infine una versione apparentemente di pura fantasia, che immagina l’uccisione del Generale avvenuta altrove, con macchinosi ed inverosimili sistemi per occultare la verità (questa tesi è riportata nel testo come sesta versione).
PRIMA VERSIONE
(versione cosiddetta “ufficiale”) Luogo della morte: Forcella Fontananegra. Causa della morte: colpito in fronte da una pallottola sparata da un cecchino austriaco. L’ora della morte viene fatta corrispondere tra le ore 17.30 e le ore 19.30. Attendibilità: elevata.
Elementi a favore: si tratta di una versione fornita da tre diversi testimoni oculari, le cui versioni collimano sostanzialmente fra loro.
Elementi a sfavore: una delle testimonianze, quella del soldato Bossi, è stata raccolta a più di cinquant’anni di distanza dall’episodio; ciò potrebbe spiegare qualche piccola incongruenza rispetto alle altre due testimonianze. Fonti: fante Giuseppe Bossi (attendente del capitano Comucci), capitano Pio Comucci e maggiore Pietro Ottina
Testimonianza del soldato Giuseppe Bossi (lettera inviata il 1° gennaio 1969 ad Alessandro Lancedelli di Cortina d’Ampezzo):
«… Quel giorno, come in precedenza, andavo giù dove erano piazzate le tende e le cucine per prendere la mensa del mio capitano [Comucci], e trovai il generale Cantore con quattro alpini che lo accompagnavano; stava sgridando
165
A sinistra: Giovedì 22 luglio 1915: il funerale di Antonio Cantore, generale degli Alpini
un tenente del 54° fanteria perché si trovava lì e non lassù; poi proseguì a piedi fin lassù [a Forcella Fontananegra]. Io lo seguivo con la mensa del mio capitano. Arrivati lassù, il Generale si è messo a rapporto con il maggiore [Ottina] e con il mio capitano [Comucci], chiedendo informazioni e dicendo che quella notte avremmo dovuto conquistare il rifugio [Tofanahütte]. La nostra posizione era sistemata con un muricciolo formato da piccoli blocchi di roccia, alto 70 cm circa e 20 m di lunghezza, affiancato da alte guglie, e guardava proprio in faccia al rifugio, a circa 300 m in linea d’aria, tutto scoperto.
Finito il rapporto, il Generale è salito in piedi sul muricciolo, allo scoperto, guardando con il suo binocolo la posizione nemica; arrivò un colpo di fucile sparato dal rifugio, la pallottola finì contro la roccia; allora i due
ufficiali lo supplicarono: “Signor Generale, vede che sparano già, è molto pericoloso”. Il Generale rispose loro con queste parole: “Non sono un passerotto, la mia pallottola non è stata ancora fabbricata”. Appena finito di dire queste parole, un secondo colpo di fucile l’ha colpito alla testa, forandogli la visiera e il cranio, uscendo dietro dalla serpentina dei gradi del berretto. Il Generale cadde all’indietro, due metri più in basso, senza più profferire parola. Avvolto in una coperta e deposto su una barella, quattro alpini l’hanno portato giù a valle, dimenticando lassù il berretto. Venne due giorni dopo un portaordini a prenderlo; io l’avevo portato nella tenda del mio capitano; lo consegnai io».
Rapporto del capitano Pio Comucci: «… Verso le ore 17.30, mentre io mi trovavo in trincea, venne il generale Cantore, comandante la Divisione, ad osservare le posizioni nemiche; più precisamente, quando con il binocolo cercava d’individuare le feritoie delle trincee avversarie, ed io lo pregavo di non scoprirsi perché tiratori infallibili colpivano chiunque esponesse la testa, egli incurante del pericolo, continuò a puntare il binocolo sulle posizioni avversarie. Fu allora che venne colpito alla testa da un proiettile che lo fulminò. Il Generale non pronunziò una sola parola, rotolò immerso nel suo sangue. Dai soldati presenti si resero gli onori e la salma, avvolta in un telo da tenda, fu trasportata via».
Rapporto del maggiore Pietro Ottina: «… Verso le ore 17.30 il generale Cantore, comandante la 2ª Divisione, venne ad ispezionare le nostre posizioni che trovò logiche ed appropriate. Che, anzi, alla proposta di fare ritirare i plotoni avanzati che correvano pericolo di un colpo di mano da parte nemica, si oppose dicendo che la notte avrebbe dovuto favorire il rifornimento, ed intanto si trincerassero. Mentre egli, non curando del pericolo, ispezionava con il binocolo le posizioni avversarie, sebbene avvertito che tiratori infallibili colpivano chiunque si affacciasse, continuava sprezzante le sue osservazioni, quando improvvisamente veniva colpito in piena fronte da una fucilata nemica».

SECONDA VERSIONE
(variante della versione “ufficiale”)
Luogo della morte: Forcella Fontananegra. Causa della morte: colpito in fronte da una pallottola sparata da un cecchino austriaco.
Attendibilità: media.
Elementi a favore: si tratta di una versione che trova riscontro nella concessione di una medaglia d’argento al capitano Adolfo Argentero con la seguente motivazione: “Accompagnando il proprio comandante di Divisione, dava
166
La leggendaria figura di Antonio Cantore
prova di coraggio e di calma, riuscendo di valido aiuto al proprio superiore, portando ordini in zone efficacemente battute e recandosi in posti pericolosissimi per l’osservazione. Caduto il proprio Generale sotto il fuoco nemico, benché ferito egli stesso, aiutava a ritirarne in trincea la salma”. Elementi a sfavore: è una versione di seconda mano, riferita dal capitano Argentero al capitano Gatti, e da quest’ultimo riportata nel suo libro “Sulle vie dell’epopea”; trattasi di una testimonianza che mostra alcune incongruenze e che si differenzia in molti particolari dalla versione “ufficiale”, tanto da giustificare il sospetto che il capitano Argentero non fosse affatto accanto al Generale nel momento in cui venne colpito a morte. In effetti la sua presenza in loco non è mai accennata né dal soldato Bossi né dal capitano Comucci né dal maggiore Ottina: è pertanto verosimile che il capitano Argentero si sia fermato prima di arrivare al fatidico avamposto, e che vi sia accorso solo dopo l’uccisione di Cantore. Fonte: Angelo Gatti, ufficiale di Stato Maggiore, che riferisce un racconto di Adolfo Argentero, capitano dello Stato Maggiore del generale Cantore. L’Argentero espose tale versione dei fatti al raduno A.N.A. di Cortina d’Ampezzo nel settembre 1921.
«… Alla Forcella Fontananegra, una piccola guardia nostra, di pochi uomini comandati da un caporalmaggiore, non avendo potuto scavarsi una trincea, stava appiattita dietro alcuni macigni. Ma il riparo, che sbarrava una valletta, improvvisamente cessava, per riformarsi dopo qualche passo; il tratto scoperto era battuto dai “cecchini” appostati benissimo dall’altra parte, a non più di 400 metri. Con il fucile serrato in una morsa, non avevano se non da premere il grilletto, quando il bersaglio italiano compariva, per colpirlo; la stessa mattina della visita di Cantore, due nostri soldati erano rimasti fulminati, mentre tentavano di passare da un lato all’altro.
Il Cantore giunse sul luogo e, ritto, guardò verso il nemico; poi accennò ad attraversare la valletta; non aveva l’impermeabile. Il comandante della guardia gli disse: “Signor Generale, non vada” e lo informò della morte dei due compagni. Fu come se avesse detto: “Si accomodi” Non solo il Cantore proseguì il cammino, ma giunto allo scoperto, tirò fuori il binocolo dalla custodia e, secondo abitudine, piantandosi bene sulle gambe, lo portò agli occhi. Mormorò ancora una volta: “Questi stupidi”, segno del suo sprezzo per il nemico e della fiducia nella propria fortuna. Era uno stupendo bersaglio, intagliato netto nel cielo; una pallottola lo colse proprio nel mezzo della fronte, come apparve dalla visiera del berretto forata. Senza una parola il Cantore si abbatté al suolo; dalla nuca, la ferita versò tanto sangue, che la giubba se ne inzuppò; io la
Antonio Cantore in uniforme da generale di brigata

portai a Verona, alla moglie e al figlio; pesava come se fosse diventata di ferro».
TERZA VERSIONE
(variante della versione “ufficiale”)
Luogo della morte: Forcella Fontananegra.
Causa della morte: colpito in fronte da una pallottola sparata da un cecchino austriaco.
Attendibilità: buona.
Elementi a favore: si tratta di una versione che, fatta eccezione per alcune inesattezze, è perfettamente compatibile con la versione “ufficiale”.
Elementi a sfavore: è anche questa una versione di seconda mano, raccolta da Renzo Boccardi nel 1917 (a 2 anni quindi dall’avvenimento), quando giunse con il suo battaglione in
167
Tofana, raccogliendo le testimonianze dirette ed indirette di fanti ed alpini presenti in zona il giorno dell’uccisione di Cantore.

Fonte: Renzo Boccardi, che riporta questa versione nel suo libro “Uomini contro montagne”.
«… Cantore, per condurre la nuova azione, volle come il solito vedere e conoscere uomini e terreno. C’era dovizia di relazioni, rilievi, schizzi, ma volle salire ugualmente in prima linea. Così, il pomeriggio del 20 luglio, il presidio in Forcella Fontananegra lo vide giungere accompagnato dal suo Capo di Stato Maggiore, il capitano Argentero, e da un graduato. Era di umore tempestoso, nero. Gli erano giunte notizie inquietanti sulle condizioni morali e materiali dei reparti del 45° Fanteria, che presidiavano la posizione e vi si trovavano in grave disagio per l’inclemenza della montagna, per l’insufficienza delle dotazioni e per l’insidia dei tiratori nemici annidati fra le rupi circostanti. Sapeva che ancora nella mattinata c’era stato un nostro tentativo contro due piccoli posti nemici e che era stato respinto sanguinosamente. E non era quello il primo attacco. Bisognava farla finita. Giunto sulla posizione, non si accontentò di parlare con il comandante del Reggimento, per avere da lui le informazioni desiderate e dargli gli ordini necessari, ma volle vedere, sapere e
rendersi personalmente conto di tutto. Cominciò a girare, interrogando, e man mano che avanzava fra i soldati verso le prime linee, si scorrucciava, come quei cieli della sua Liguria che, da coperti, ad un colpo di vento si fanno sereni. Volle mettere il naso ovunque: cosa avessero i soldati nelle giberne (cicche o cartucce) e quanti caricatori e come fosse il rancio. Scherzò anche. La vetta della Tofana Prima gli parve “una piazza d’armi”. I cecchini – terribile errore! –“tiratori principianti”. Poi volle spingersi fino ai piccoli posti, sulle guglie fronteggianti il Passo che era lontano poco più di 200 metri. Sapeva che il nemico cecchinava infallibile, ma volle ugualmente vedere e volle che i soldati vedessero il loro Generale salire dove erano essi. Si sporse, con il binocolo agli occhi, dalla cintola in su dalla breve trincea. Invitato a ritrarsi da un soldato che gli ricordò come, alzando per scherzo un berretto su di un bastone, i tiratori nemici non lo sbagliassero mai, non si curò del consiglio e continuò la sua osservazione.
…
Egli considerava il rischio come un’inevitabile necessità di comando; ed anche con il gesto, forse inutile, di Forcella Fontananegra volle sottolineare lo sprezzo del pericolo che sempre il superiore deve saper insegnare all’inferiore. Si disse, e se fu leggenda è degna di poesia, che anzi, all’avvertimento rispondesse bravando: “Non è ancora stata fusa la pallottola per me”. Inquadrato da due successivi
168
Ecco ciò che apparve al generale Cantore il 20 luglio 1915 quando, allo scoperto, si mise ad osservare le postazioni nemiche; in primo piano i Rifugi Cantore e Tofana
colpi vicinissimi, non si mosse di un palmo: un altro lo centrò, a due terzi della visiera del berretto, e lo rovesciò indietro fulminato».
QUARTA VERSIONE
(variante della versione “ufficiale”)
Luogo della morte: Forcella Fontananegra. Causa della morte: colpito in fronte da una pallottola sparata da un cecchino austriaco.
Attendibilità: scarsa, legata essenzialmente alle voci raccolte tra gli abitanti di Cortina d’Ampezzo.
Elementi a favore: non è una versione faziosamente italiana ma, al contrario, dà voce alla parte austriaca dei contendenti (dato che gli abitanti di Cortina, all’epoca dei fatti, erano sudditi della monarchia asburgica).

Elementi a sfavore: vi sono alcuni particolari che non trovano corrispondenza nelle versioni fornite dai testimoni oculari (ad esempio la presenza di un medico accanto al Generale e la sua frase di scherno).
Fonte: don Pietro Alverà (sacerdote cortinese ed attento cronista della storia ampezzana, ma con chiare e decise simpatie per l’Austria), che riporta tale versione in “Cronaca di Ampezzo nel Tirolo dagli antichi tempi fino al XX secolo”.
«… L’avvenimento più memorabile della conquista di questa montagna [Tofana] fu la tragica morte del generale Antonio Cantore avvenuta il 20 luglio 1915. Nel pomeriggio di detto giorno egli andò in automobile a Pocòl e di là salì a piedi per Campo di Fedaròla verso Col dei Bois [confuso con Forcella Fontananegra]. Ivi, in una trincea, esaminava con un binocolo le posizioni austriache. I suoi compagni lo ammonirono di stare più nascosto. Rispose che bisognava andare avanti e che per lui non era stata ancora gettata (fusa) una palla austriaca. Appena pronunciate queste parole fu colpito in mezzo alla fronte, morto, senza nemmeno pronunciare una parola. Il medico, che era con lui, non si poté trattenere dal dire: “Ora, signor Generale, vada avanti!”. Gli ufficiali italiani divulgarono che era stato ucciso da un tiratore ampezzano, sotto il comando di un vecchio ampezzano austriacante».
Nei registri della canonica di Cortina d’Ampezzo venne annotato: «20 luglio 1915: oggi il Maggiore Generale Cantore commendatore Antonio di Sampierdarena (Genova), sulla selletta tra la I e la II Tofana, decedeva colpito alla fronte da pallottola nemica. Fu sepolto nel recinto dei sacerdoti, nel cimitero di Cortina d’Ampezzo».
QUINTA VERSIONE
Luogo della morte: Forcella Fontananegra. Causa della morte: colpito in fronte da una pallottola sparata da un soldato o da un ufficiale italiano, quale estrema rappresaglia nei confronti di una presunta durezza ed arroganza del generale Cantore. Attendibilità: scarsa, legata a dicerie raccolte tra i soldati. Quelle stesse dicerie che diffusero anche la notizia secondo cui al funerale di Cantore, tenutosi il 22 luglio 1915, l’unico davvero triste fosse il suo cavallo bianco e che gli alpini, alla notizia della morte del Generale, fecero festa per una settimana. Alcune di queste “voci di popolo” vengono riportate da Paolo Giacomel nel libro “ArrivederciAufwiedersehen Cortina d’Ampezzo”: - una signora ampezzana, a quei tempi bambina e che viveva all’Hotel Posta, ricordò di aver sentito un tenente degli alpini dire: “Siamo stati noi ad uccidere il Generale, perché mandò un plotone sulle Tofane a morte sicura”; - un altro soldato, che scendeva da Passo Tre Croci, raccontò a sua volta ad una cortinese, addetta alla biancheria degli ufficiali: “Signora, stavolta abbiamo mirato giusto”; - e che dire di don Angelo Frena, uno dei cappellani della parrocchia di Cortina, che così raccontò la morte del comandante la Divisione: “Venne il generale Cantore, rimproverò i soldati di non saper fare la guerra. Entrò imprudentemente nella zona neutra tra i due eserciti e si ebbe
169
Il berretto del generale Cantore; al centro della visiera il foro del proiettile che lo colpì in fronte (foto-archivio Lancedelli)
una pallottola che gli trapassò il capo attraverso il berretto; i soldati dissero che fu colpito da pallottole anche alla schiena, da parte di soldati esasperati”.
Elementi a favore: l’analisi del diametro del foro sulla visiera del berretto di Cantore farebbe pensare alla misura di un proiettile sparato da un fucile italiano piuttosto che da un fucile austriaco.

Elementi a sfavore: non si tratta mai di testimonianze dirette ma solo di dicerie.
Fonti: voci popolari.
Note a riguardo la versione secondo cui il Generale sia stato ucciso da un soldato o da un ufficiale italiano, quale vendetta per una presunta crudeltà nell’imporre alla truppa attacchi frontali contro il nemico, oppure quale ritorsione ad una punizione dura od ingiusta.
a) a tal proposito appare facile obiettare ricordando che Cantore si adoperò in mille modi affinché le proprie truppe non fossero esposte a rischi inutili (basti pensare che nei 20 giorni del suo comando alla 2ª Divisione si ebbero 20 morti, 89 feriti e una cinquantina di dispersi; cifre che risultano assai lontane dai massacri dei nostri soldati obbligati ad andare all’assalto nello stesso periodo sul fronte dell’Isonzo, dell’Ortigara e del Carso). Per quanto riguarda invece le punizioni di cui Cantore era famoso,
queste si manifestarono pressoché esclusivamente con violenti scatti d’ira, numerosi giorni d’arresti, talora qualche legnata sulla testa del malcapitato con il suo abituale rustico bastone: sappiamo comunque che il Generale non fece mai fucilare alcun soldato; b) secondo la versione “ufficiale”, il generale Cantore, una volta giunto all’altezza di un avamposto di prima linea, si erse in piedi per guardare con il suo binocolo le postazioni nemiche. Ne deriva che i nostri soldati fossero alle sue spalle o tutt’al più ai suoi fianchi: praticamente impossibile quindi poterlo colpire in piena fronte. In realtà, ad essere precisi, questa convinzione, sostenuta ed argomentata da molti, non corrisponde al vero: in effetti, davanti alle linee italiane, a ridosso delle postazioni austriache, erano ancora acquattati gli uomini del plotone Calamida che avevano tentato invano un attacco la mattina stessa e che non avevano potuto ritirarsi perché, alla luce del giorno, sarebbero stati facile bersaglio dei cecchini austriaci; c) il diametro del foro sulla visiera del berretto di Cantore è di circa sei millimetri e mezzo, corrispondente ad un fucile italiano mod. 1891 con cartucce in calibro 6,5 mm, mentre il fucile austriaco Mannlicher M. 95 utilizzava cartucce in calibro 8 mm (o in calibro 7,92 mm nel caso del Mauser tedesco). Da ciò si è dedotto che a sparare fosse stato un italiano. Conclusione apparentemente logica ma molto superficiale se la si analizza in maniera critica. E vediamo il perché: - il colpo che uccise in fronte il generale Cantore potrebbe essere stato sparato sì da un fucile italiano ma usato in realtà da un soldato austriaco quale preda bellica; - non soltanto, ma è stato provato che i soldati tedeschi ed austriaci impegnati a difendere Forcella Fontananegra disponessero anch’essi di fucili con cartucce in calibro 6,5 mm (come dimostrato dal rinvenimento di tali cartucce inesplose nelle posizioni austriache di Vallón Tofana); - la visiera bucata dal proiettile era di cuoio e quando il cuoio viene perforato da una pallottola si hanno delle slabbrature che si aprono al passaggio del proiettile, ma che tendono poi a richiudersi nel tempo, determinando un restringimento del diametro del foro provocato. È questo un fenomeno che ben conosce qualsiasi calzolaio che, per bucare il cuoio di una scarpa o di una cintura, usa un apposito perforatore che asporta un dischetto di cuoio, perché qualora usasse un punteruolo provocherebbe un buco che nel tempo si restringerebbe. Per cui, sapendo di questo fenomeno, il fatto che il diametro di oggi sia di circa sei millimetri e mezzo dimostra che il “foro reale”, al momento della morte di Cantore, dovesse essere più largo, e pertanto prodotto da una pallottola di calibro maggiore, come appunto l’8 mm austriaco o il 7,92 mm tedesco. d) sempre a proposito del foro sulla visiera del cappello
170
Il giovane Antonio Cantore in uniforme da tenente
di Cantore, sembra priva di qualsiasi fondamento l’ipotesi secondo cui il Generale sarebbe stato giustiziato da un colpo di pistola alla fronte sparato a bruciapelo da un ufficiale italiano, sostenuto dai compagni esasperati dall’eccessiva durezza del Generale. Tale ipotesi non trova riscontro nei due tipi di pistola in dotazione agli ufficiali del nostro esercito nel corso di quei primi mesi di guerra: la rivoltella Bodeo modello 1889 (calibro 10,35 mm) e la più moderna pistola automatica Glisenti modello 1910 (calibro 9 mm). Qualora a sparare fosse stata una delle due pistole, il diametro del foro sulla visiera sarebbe stato inequivocabilmente ancora maggiore; e) i quattro alpini che, quel 20 luglio, hanno accompagnato il generale Cantore fin all’avamposto di Forcella Fontananegra (trasportando poi il suo corpo a valle) non sono mai stati rintracciati né si hanno notizie che siano stati mai interrogati. Non se ne conosce addirittura il nome. Eppure, appare logico pensare che se ci fosse stato un minimo sospetto circa la morte del Generale, visto che un delitto del genere avrebbe comportato la fucilazione, qualcuno di loro sarebbe stato quanto meno sentito ed interrogato.
SESTA VERSIONE
Luogo della morte: imprecisata; molti, tra civili e soldati, sostennero che il Generale fosse stato ucciso altrove, in località Ponte Óuto in Val di Fànes o forse nello stesso villaggio di Vervéi, ai piedi delle Tofane, o anche a Val o a Fiàmes (dove alcuni anziani ampezzani sostennero di aver visto un corteo con la salma del Generale); in un secondo tempo il corpo sarebbe stato portato alla Forcella Fontananegra, per coprire la verità e rendere plausibile la messinscena della morte di Cantore da eroe, ucciso da un cecchino austriaco.
Causa della morte: colpito in fronte da una pallottola sparata da un soldato o da un ufficiale italiano. Attendibilità: scarsa.
Elementi a favore: pochi.
Elementi a sfavore: anche questa versione è supportata soltanto da dicerie popolari, non provate da alcun elemento concreto e probante.
Fonti: “voci di popolo”, riportate da vari storici nei loro testi. - Giovanni Fabbiani (in “Il generale Antonio Cantore in Cadore”): “Circolò in quel tempo a Cortina la voce che il generale Cantore fosse rimasto ucciso in altro modo [rispetto alla versione “ufficiale”] e che l’episodio di Forcella Fontananegra non fosse altro che una messa in scena per nascondere qualcosa di più grave accaduto nelle nostre linee”. - don Pietro Alverà (in “Cronaca di Ampezzo nel Tirolo dagli antichi tempi fino al XX secolo”): “I semplici soldati [italiani] sbravazzavano pubblicamente in Ampezzo che il Generale
era stato ucciso da uno di loro perché imponeva tanti sacrifici onde andar avanti”
- Mario Ferruccio Belli (in “Cortina d’Ampezzo, 1914-1918: dall’Austria all’Italia”): “Mercoledì, 21 luglio. Il generale degli alpini Antonio Cantore è morto ieri mentre dirigeva gli assalti. L’emozione in paese è grandissima. Si odono le più strane dicerie. Qualche soldato, in confidenza, afferma che era eccessivamente severo e che perciò non era ben visto dai sottoposti”.
- Dino Dibona (in “Leggende e storie insolite delle Dolomiti”): “Si tratta di una versione attribuita alla testimonianza di un autista anonimo che assistette al presunto fatto di sangue. Da premettere che in questa versione Cantore non viene mai esplicitamente nominato, anche se risulta facilmente identificabile in quanto si parla di un Generale medaglia d’oro, che ha un monumento a Cortina d’Ampezzo. Secondo tale versione Cantore sarebbe stato ucciso da un maggiore dell’esercito che lo accompagnava in automobile e che si sarebbe ribellato all’ordine del Generale di fucilare un soldato ferito che intralciava la strada”.
Chi uccise veramente il generale Cantore?
Numerose nel corso degli anni le rivendicazioni postume circa l’identità di colui che uccise il generale Cantore, anche se gli storici sono ormai pressoché d’accordo nell’attribuire il fatto o ad un soldato austriaco o ad un tiratore scelto, quest’ultimo appartenente forse ad una provincia italiana (si ricorda a questo proposito che ladini, ampezzani, tirolesi e trentini, vivendo in territori sotto il dominio asburgico, vennero arruolati nell’Esercito austriaco e si trovarono pertanto a combattere contro i nostri soldati).
Curioso sottolineare che non esistano versioni da parte degli Austriaci sull’uccisione di Cantore. Il motivo è semplice: per un lungo periodo il nemico non venne a conoscenza della morte di un alto ufficiale a Forcella Fontananegra, né tantomeno che si trattasse del generale Antonio Cantore. Fonti austriache confermarono la presenza in prima linea, nella zona dove avvenne l’uccisione, di Landsturm, Standschützen e Kaiserjäger bavaresi, rinforzati da elementi irregolari, tra cui uomini della Gendarmerie Assistenz di Cortina d’Ampezzo (una specie di polizia municipale), al comando del maresciallo maggiore distrettuale Gotardi.
Questi comunque i possibili autori materiali dell’uccisione di Cantore: a) un cecchino austriaco rimasto anonimo. Heinz von Lichem, nel suo libro “La guerra in montagna 1915-1918”, così scrive: “Il 20 luglio il generale Antonio
171
Cantore, spintosi fino in prima linea ed alzatosi in piedi per osservare le trincee nemiche e dirigere personalmente l’assalto, fu colpito in fronte dalla pallottola di un cecchino della bassa valle dell’Inn che volle restare anonimo”.
b) Attilio Berlanda, trentino di Susà di Pergine. Il giornalista Tino Corradini nel 1969 riuscì a intervistare un certo sig. Attilio Berlanda (classe 1886) che asserì di essere stato lui, all’epoca dei fatti inquadrato come tiratore scelto in un reparto di Kaiserjäger, a uccidere il generale Cantore con una carabina di precisione modello 95: il tristemente famoso Mannlicher dei cecchini, con cannocchiale Zeiss. Confessò anche che per quell’importante “bersaglio”, centrato da circa trecento metri di distanza, aveva ricevuto una medaglia d’argento dall’Imperatore d’Austria. Il Berlanda non rivelò mai a nessuno questo suo gesto, per la paura di essere processato dal Governo Italiano come criminale di guerra. Sempre Corradini, sul Gazzettino del 26 novembre 1973, scrisse un articolo dal titolo “Fui io a sparare al generale Cantore”, in cui veniva riproposta l’intervista fatta all’ex Kaiserjäger Berlanda che, ancora sul letto di morte, avvenuta nel 1973 presso l’Ospedale di Trento (a 87 anni di età), confermava di essere stato lui a uccidere il Generale.
Indagini successive appurarono che il Berlanda
aveva sì guadagnato una medaglia d’argento, ma per tutt’altra azione e in un altro luogo, così come riportato nell’Almanacco Austro-ungarico, anno 1919, che riporta nome, cognome e motivazione dei soldati trentini ed ampezzani decorati con medaglia al valor militare: “Berlanda Attilio di Mansueto di Susà, era caposquadra dei Cacciatori Imperiali di speciale bravura. In gennaio 1915 egli assunse spontaneamente il compito di tagliare i reticolati dei russi sul loro fronte nonostante veemente fuoco nemico e di aprire così una breccia per la propria truppa. Sotto formidabile fuoco egli levò da un albero la bandiera di segnale dei nemici, mostrò pure rimarchevole bravura nelle ricognizioni contro il nemico e nel salvataggio del proprio comandante di compagnia ferito. Medaglia d’argento al valor militare di 1ª classe”.
c) un abitante di Cortina d’Ampezzo. In una lettera apparsa sul Gazzettino del 12 agosto 1998, a firma di Francesco Gregnanin di Padova, si legge tra l’altro: “Il generale Cantore fu fatto fuori dal comandante della Gendarmerie Assistenz di Cortina [una specie di polizia municipale], con un Mauser Swedish modello 1896 e con cartuccia 6,5x55 senza cannocchiale. Riporto quanto mi disse personalmente un signore di Borca di Cadore di cognome Sala e del cui figlio Attilio ero fraterno amico. Nel frangente indicato, mi disse anche nome, cognome e soprannome di questo cortinese”. Tale rivelazione sarebbe stata fatta nel 1955: pur trattandosi di una testimonianza indiretta e priva di documentazione, ci sono in essa alcuni aspetti che la rendono più plausibile rispetto ad altre. Il primo aspetto da tener conto è che, effettivamente, nel settore Tofana c’erano 60 uomini della Gendarmerie Assistenz di Cortina, il cui comandante potrebbe essere stato, secondo questa testimonianza, il responsabile della morte di Cantore. D’altra parte vale la pena ricordare che, immediatamente dopo la sua uccisione, circolava tra i soldati la voce secondo cui il cecchino del Generale fosse stato un tiratore scelto di Cortina. Questi tiratori scelti erano in genere volontari inquadrati in reparti di Standschützen, che a loro volta provenivano dai circoli di tiratori civili presenti nei vari paesi e villaggi del Tirolo, e quindi anche da Cortina d’Ampezzo (si trattava in genere di ragazzi tra i 15 e i 18 anni, ed uomini di età compresa tra i 45 e i 70 anni). Specie nelle prime settimane di guerra non sempre indossavano un’uniforme regolare, per cui i nostri soldati si trovavano in alcuni casi a fronteggiare civili in borghese, soprannominati in modo sprezzante con il nomignolo di “Gigetto”: erano temuti quasi più di un bombardamento o di un attacco frontale perché questi micidiali cecchini, riparati in genere in posti inaccessibili, sparavano con

172
La prima tomba del generale Cantore, nel cimitero di Cortina d’Ampezzo (archivio Museo della Guerra di Rovereto)
estrema precisione su chiunque giungesse loro a tiro, mietendo un gran numero di vittime.
d) un cacciatore di camosci, tale Cecchet, tiratore scelto dell’Esercito asburgico. Un quotidiano milanese dell’epoca, il “Secolo”, riporta la cronaca del passaggio a Longarone, il 22 luglio 1915, di un gruppo di prigionieri austriaci, catturati dai soldati italiani ai piedi delle Tofane. Le parole del cronista, pur dovendo essere prese con beneficio d’inventario, sono le seguenti: “Tra di essi si trovava il famigerato franco tiratore Cecchet, famoso cacciatore di camosci, postosi al servizio dell’Austria; costui, annidatosi con un fucile speciale fra le rocce dolomitiche, si accaniva contro le nostre vedette: egli millantò 180 vittime. Fu affermato che anche il generale Cantore fosse caduto sotto i suoi colpi… sono frequenti questi tirolesi, cacciatori di camosci, dislocati sulle rocce con fucili a cavalletto per colpire infallibili bersagli”.

e) nel corso degli anni altre voci si aggiunsero a quelle sopra riportate: si parlò di un soldato del Cadore, di un militare di Agordo e, addirittura, di un gruppo di soldati italiani.
CONCLUSIONI
Nel complesso mosaico della vicenda in questione, possiamo aderire all’una o all’altra delle numerose versioni riguardanti la morte del generale Antonio Cantore: probabilmente non arriveremo mai ad una “ verità storica assoluta“... ed è bello pensare che, forse, è proprio per questo che la sua figura leggendaria continua ad aleggiare, severa e paterna, tra le aspre rocce e i valloni più reconditi delle Tofane.
Fotografie personali, di autori vari (con riferimenti presenti nel testo) e tratte dal libro “Antonio Cantore”, di Oreste Bruno Ongaro (Gaspari, 2007)
173
L’avamposto italiano da dove si affacciò il generale Cantore per scrutare il nemico; a sinistra spicca in nero il cippo presso cui il generale cadde colpito in fronte

IL MIO NOME È DOLOMIEU
Un’originale opportunità culturale che potrebbe fare gola a molte Sezioni del CAI. E non solo...
Nostro collaboratore ormai da alcuni numeri, Eugenio Maria Cipriani, ha scritto e sta ora interpretando in diverse località sia di montagna che di pianura un monologo teatrale di circa 80 minuti durante i quali, indossati i panni dello scienziato Dieudonné Guy Silvain Tancrède de Gratet de Dolomieu (1750-1801), studioso e viaggiatore francese vissuto nella seconda metà del Settecento, racconta la vita e le avventure del noto naturalista alle prese da un lato con lo studio dei vulcani e dall’altro con il mistero allora inspiegato della nascita delle montagne. Una vita avventurosa che vide Dolomieu due volte in prigione ma anche ospite dei più importanti salotti culturali europei. Fu il primo naturalista a visitare le Piramidi d’Egitto dove scampò alla morte per pura fortuna. Amato dalle donne e molto apprezzato dai contemporanei, alla sua morte tanta notorietà si dissolse nel giro di pochi anni e oggi nessuno si ricorderebbe più di lui se non avesse dato il nome alle montagne più belle del mondo. Egli è noto infatti per aver compreso la matrice chimica delle rocce dolomitiche che proprio da lui prendono (peraltro del tutto casualmente) il nome. Studioso attento e capace di creare una “rete” scientifica, fu uno dei padri fondatori di una scienza nata da poco: la geologia. Dolomieu, inoltre, visse in prima persona l’annosa “querelle” scientifica dell’epoca fra chi sosteneva l’origine ignea delle rocce (Plutonisti) e chi ne affermava di contro l’origine idrica (Nettunisti). Una controversia che infiammò gli animi di cattedratici di fama mondiale e che ebbe riscontri importanti anche nella letteratura e nelle arti. La Rivoluzione francese cambiò il corso della sua vita che, nell’ultimo decennio, fu tutto un susseguirsi di campagne esplorative e guai personali. Eugenio Maria Cipriani
Giornalista, uomo di lettere, scrittore e scalatore attivo da oltre 40 anni con particolare inclinazione per l’alpinismo esplorativo (oltre 800 vie nuove fra Alpi nordorientali, Grecia e Balcani), il veronese Eugenio Maria Cipriani ha sempre nutrito un vivo interesse sia per la storia dell’alpinismo sia per quella della geologia. È autore di oltre 60 volumi fra guide escursionistiche e alpinistiche e saggi storici. In gioventù ha frequentato due scuole di recitazione ed ha interpretato diversi ruoli recitando durante la stagione estiva teatrale veronese negli anni 1984 e 1985 e successivamente esibendosi in letture pubbliche con la compagnia del Teatro Nuovo di Verona.
Il mio nome è Dolomieu di e con Eugenio Maria Cipriani Spettacolo teatrale per info eucip@libero.it
175 di MB

IVO IORI
Una figura dimenticata dell’alpinismo reggiano degli anni ’70
di Gianpaolo Montermini
Ero ancora un ragazzino quando per la prima volta accarezzai l’arenaria della Pietra di Bismantova. Un mio amico, che dopo avere frequentato un corso di speleologia si vantava di avere imparato qualche nodo, mi volle portare in sella ad una Vespa in Pietra per insegnarmi a scendere in corda doppia. Mi ricordo ancora l’emozione di imparare a muovermi in verticale vincendo la paura del vuoto sotto i piedi. Da allora non ho più smesso di arrampicare. L’alpinismo è stato importante nella mia vita e mi ha permesso di conoscere tante persone che negli anni si sono avvicinate all’arrampicata. Alcune sono state delle meteore, altre con la volontà e la passione sono diventate parti dell’arredo della Pietra; poche erano dotate e hanno lasciato un segno nella storia alpinistica di Bismantova. In questo breve articolo vorrei parlare dell’alpinismo reggiano della fine degli anni ’70 e di uno dei più forti alpinisti che abbia conosciuto: Ivo Iori. Oggi pochi sanno chi era Ivo; non ci sono sue foto, le uniche informazioni sono sulle guide alpinistiche di Bismantova dove il suo nome compare come apritore di alcune vie tra cui la più famosa e difficile è la via degli Amici. All’inizio degli anni ’70 l’alpinismo a Bismantova era praticato da poche persone che come una setta si conoscevano tutte. Olinto Pincelli per anzianità si era fermato non lasciando eredi del suo livello; nessuno a Reggio aveva preso il testimone. Gli alpinisti di Bologna (Gian Carlo Zuffa), di Parma (Andrea Pandolfo) e Ginetto Montipò continuavano l’esplorazione delle pareti della Pietra e aprivano vie sempre più difficili sulle sue pareti di arenaria, mentre l’alpinismo reggiano navigava sulle vie di quarto grado con qualche passaggio di quinto. Posso dire che sono stato io a portare Ivo per la prima volta ad arrampicare. Ero uno studente e durante le vacanze estive lavoravo nel suo laboratorio di elettronica e parlando del più e del meno gli raccontai che avevo appena frequentato il corso CAI di alpinismo. Mi fece tante domande e mi chiese di portarlo in Pietra e insegnargli ad arrampicare. Bastarono poche giornate per trasmettergli
quel poco che sapevo e per vedere che era molto più bravo di me. Allora non esistevano palestre per allenarsi e ognuno si arrangiava con quello che aveva. Mi ricordo che per allenarsi sulle staffe attrezzò il soffitto del suo laboratorio con chiodi, che un corridoio divenne una prova per l’arrampicata in opposizione in camino e che scendemmo dal secondo piano del suo appartamento con una corda doppia fissata al termosifone.
Di quei primi tempi, dopo avere salito le vie classiche della Pietra, mi ricordo che mi disse che voleva aprire una via nuova e mi chiese dove ci fosse una parete vergine dove salire. Gli proposi la parete sotto la scaletta d’uscita della Ferrata degli Alpini (adesso sono state tracciate delle vie in artificiale). Quel giorno arrivare in Pietra fu un’avventura. Era nevicato: la strada non era stata spalata dalla neve e la macchina si piantò sulla prima salita dopo Castelnuovo. A piedi nella neve con zaini enormi raggiungemmo la parete che era tutta bagnata da colate d’acqua. Mi ricordo che Ivo mi disse: “Non nevica più. Proviamo. Fammi sicura”. Non so ancora come fece a salire in libera una decina di metri su roccia bagnata e friabile piantando un paio di chiodi; poi anche lui si arrese dicendomi che si poteva passare e che saremmo tornati. In lui si era accesa la passione per l’arrampicata e per apprendere le tecniche dell’alpinismo si iscrisse a un corso di alpinismo del CAI. Al corso conobbe Lino Battilani, Gianni Pavarini e Gabriele Bernazzali che diventarono i suoi compagni abituali di arrampicata nelle vie più difficili. Me lo ricordo ancora con due occhialini tondi alla Trotsky. Lo sguardo un po’ glaciale, di poche parole, era leggermente più basso di me ma molto più prestante fisicamente anche perché aveva giocato a basket a livello semiprofessionistico. Come arrampicatore era freddo, calmo, sapeva valutare a priori la difficoltà e prendere la decisione migliore compresa la ritirata quando il rischio era troppo elevato. Ivo era un figlio del ‘68, contestatore delle regole scritte da altri. In particolare non accettava di essere giudicato da coloro che riteneva
177
A sinistra: Ivo Iori all’uscita del tetto della via degli Svizzeri (foto Iori)
meno capaci ma che avevano l’aquila sul maglione. Con Lino e Gianni si consolidò un’amicizia fondata su un comune spirito verso l’arrampicata. Dopo avere percorso le vie classiche si posero l’obiettivo di ripetere tutte le vie aperte in Pietra. Allora le informazioni era scarse e ancor meno i mezzi per salirle. Su alcune vie venivano narrati racconti terrificanti di chiodature da brivido e di salvataggi dei primi salitori rimasti bloccati in parete. Si arrampicava con le pedule rigide e per proteggersi si utilizzavano, con parsimonia, soprattutto i chiodi sia a fessura che a pressione; non c’erano ancora gli spit, cominciavano a essere utilizzati i primi nuts che molto spesso erano autocostruiti ricavandoli da profilati di alluminio aggiungendo un cordino. Settimana dopo settimana tutte le vie della Pietra vennero ripetute. Alcune furono salite facilmente, altre richiesero oltre alle capacità tecniche una certa dose di rischio. Mi ricordo in particolare le salite della Zuffa Lenzi alla parete est e della via del GAB sopra l’eremo. Quando tornavano al bar della Pietra, allora gestito da Polo, ho ancora in mente i racconti delle salite. Allora era consuetudine scrivere su un quaderno presente nel bar le salite fatte e i commenti. Ricordo che i commenti di Gianni erano sempre pungenti ma veritieri
(peccato che quel quaderno con tutte le salite e la cronaca dell’alpinismo degli anni ’70 sia andato perduto). Ritengo che Ivo fosse il più completo della cordata, dotato di una buona tecnica e di una discreta forza, capace di muoversi bene sia in libera che sulle staffe; non l’ho mai visto azzardare un passaggio e non ricordo che sia mai volato. La sua via più importante aperta in Pietra fu la via degli Amici. Da poco era stata stampata una guida aggiornata con tutti gli itinerari alpinistici, anche se per molte vie, in mancanza di ripetizioni, le informazioni erano incomplete. Sono stato io a indicargli una linea di camini e diedri strapiombanti che non erano ancora stati saliti. In esplorazione salimmo slegati il primo tiro per scoprire che c’erano dei chiodi di un precedente tentativo. Mi ricordo ancora lo scoraggiamento di Ivo ma Ginetto Montipò ci confermò che era un tentativo di Zuffa ormai abbandonato. Ivo partì deciso. Il secondo tiro ci vide impegnati per alcuni giorni. Sempre rigorosamente dal basso, pulendo e chiodando per realizzare una salita impegnativa possibilmente in libera e ricorrendo all’artificiale solo quando la roccia diventava sabbiosa su scaglie che suonavano a vuoto. Toccò a me superare da primo l’ultimo strapiombo e arrivare alla cengia a metà parete. Ricordo


178
Ivo Iori in apertura sul secondo tiro della via degli amici (foto Iori)
Ivo Iori e Gianni Pavarini di ritorno da un’arrampicata con la tipica attrezzatura degli anni ’70 (foto Iori)
Gianni Pavarini, Gabriele Bernazzali, Ivo Iori e Lino Battilani (accovacciato) (foto Bernazzali) che guardai in su e mi venne un groppo alla gola vedendo il seguito e quanto strapiombava la parete. Per la seconda parte della via utilizzammo la stessa tecnica, salire dal basso un metro alla volta. Ivo quasi sempre saliva per primo, solo quando era stanco chiedeva il cambio. Mi ricordo il mio primo volo da primo quando usci il chiodo che avevo piantato e a cui mi ero appeso con una staffa: anche se non ebbi traumi fisici ne avevo abbastanza e dissi a Ivo che per finire la via doveva cercarsi un altro compagno. Gabriele sollecitò Ivo a finire la via. A comando alternato e dopo un bivacco sulle staffe arrivarono sul pianoro. La via fu subito annoverata tra le più difficili della Pietra e fino a che non fu richiodata, veniva ripetuta molto raramente anche perché da certo punto in poi la ritirata in corda doppia era impossibile. Penso che con la ripetizione di tutte le vie da parte della cordata Battilani-Iori-Pavarini e con l’apertura della via degli Amici si sia concluso il periodo dell’alpinismo

classico in Pietra dove la regola era di salire dal basso con solo le protezioni che si riuscivano a mettere; dove una via aveva senso solo se arrivava sulla sommità. Negli anni ’80 arrivarono nuove idee portate da gruppi di giovani come “La pace con l’alpe” e “Il Nuovo mattino”. L’importante non era salire ma come si saliva. L’andare in montagna non doveva essere conquista e sofferenza ma ci si poteva anche divertire. L’arrampicata in libera, senza l’aiuto dei chiodi per progredire, divenne il nuovo comandamento.
L’evoluzione tecnologica come l’uso delle scarpette e degli spit insieme ad allenamenti mirati aprirono nuovi orizzonti e innalzarono moltissimo il livello di difficoltà.
L’avere ripetuto tutte le vie della Pietra poteva essere l’inizio di un percorso per andare a confrontarsi con le vie più famose e difficili delle Dolomiti. Le premesse c’erano tutte: affiatamento della cordata, capacità tecniche, esperienza su vie di più tiri. Ma… mancò la voglia di andare a esplorare e confrontarsi con altre montagne più famose ma non certo più difficili di quello che avevano saputo salire in Pietra.
Certamente Ivo ripeté la Dibona al Croz dell’Altissimo, lo spigolo Fiames al Pomagagnon e la Micheluzzi al Piz Ciavazes non esiste un elenco ma solo poche fotografie ingiallite che non sempre permettono di identificare dove sono state scattate. Di questo periodo mi ricordo che la sera, tornando dall’università mi fermavo nel suo laboratorio; lui era curioso e voleva sempre essere aggiornato sulle ultime novità della Pietra e su che cosa avevano fatto e quali vette erano state calpestate dagli altri alpinisti reggiani. Poi “come qualche volta succede” la passione cala, nella mente cominciano a nascere le paure e viene il tempo di appendere le scarpette al chiodo. Decise di vivere gli ultimi anni della sua vita lontano dall’arrampicata, sempre più isolato, fino alla sua improvvisa morte a soli 49 anni.
179

SULLE TRACCE DI MARIA FAßNAUER, LA GIGANTESSA DELLA VAL RIDANNA
di Fabio Cammelli
Questa storia abitava poco distante da casa mia, nei ricordi dei montanari dalla barba bianca. È una storia che si è scritta da sola… poi si è trasferita in un computer e ora rivive nelle pagine di questo breve racconto. Si tratta di una storia vera, triste come molte verità che si nascondono nelle valli d’alta montagna, bella come il cuore della sua protagonista.
Alcune persone sembrano uscite da uno scherzo della natura. Nella maggior parte dei casi queste persone desiderano semplicemente un’esistenza anonima, lontana dai riflettori: nella loro diversità recano in sé l’anima di un fanciullo, un fanciullo che chiede soltanto un piccolo spazio vitale per sorridere a un sogno. Questo racconto vuole essere una semplice fiaba, e le fiabe non costano nulla. In fondo è un po’ come sognare.
La storia che andiamo a raccontare è quella di Maria Faßnauer, “la gigantessa della Val Ridanna, la più grande femmina che sia mai vissuta”: così veniva presentata, a squarciagola, nei teatri di mezzo mondo.
A noi piace invece ricordarla in un modo totalmente diverso: una donna che ha trascorso tutta la sua vita con l’anima grande di una bambina in un corpo da gigante.
La vita nel maso
Maria Faßnauer nasce il 28 febbraio 1879 allo Staudnerhof, un vecchio maso appollaiato come un nido d’aquila a 1566 m sul livello del mare, in alta Val Ridanna/Ridnauntal (Alto Adige). I suoi genitori, Josef Faßnauer e Theresia Faßnauer Eder, coltivano la terra e allevano qualche animale, vivendo tuttavia in condizioni molto modeste. Maria è la prima di sei figli (quattro femmine e due maschi): in paese viene chiamata Moidl o Moidele. Apparentemente è una bimba normale, ma dall’età di tre anni comincia a crescere a dismisura. Quando inizia ad andare a scuola è molto più alta rispetto ai suoi compagni di classe, che non si fanno scrupoli a prenderla in giro, con quella spontaneità tipica dei bambini. Mentre a casa Maria è protetta dalla curiosità della gente, ora che frequenta la scuola viene bersagliata
per questa sua diversità, che diventa via via sempre meno gestibile e sempre più ingombrante. È proprio di questi anni il primo aneddoto che riguarda la sua vita: un giorno, terminate le lezioni, s’incammina verso casa con altri compagni. Vedendola così alta e così dimensionalmente grande rispetto ai suoi coetanei, qualcuno l’apostrofa con questa frase fuori luogo: “Mamma, torni a casa con i tuoi bambini?”. Al che, ingenuamente, lei risponde con una voce già molto roca e profonda: “Sono anch’io una scolaretta che va a scuola!”. A questa e ad altre battute offensive dei compagni potrebbe rispondere in malo modo o con uno schiaffone ben assestato dalle sue grandi mani, ma Maria non ne è capace: ha un carattere dolce e remissivo, ben educata, timorata del Signore, premurosa e ubbidiente. Non si tira mai indietro nei duri lavori del maso e corre voce che possieda una forza straordinaria. Ma questa forza di cui si favoleggia in realtà non la possiede affatto: un tumore all’ipofisi (si tratta dell’ipotesi più verosimile) determina un’incontrollata secrezione dell’ormone della crescita che la rende gigantesca, ma non per questo altrettanto forte, anzi la sua salute in realtà risulta e risulterà sempre cagionevole. A 11 anni la bambina è alta ormai quasi due metri, non riesce più a stare in piedi nella piccola stube del maso e quando va a dormire si deve raggomitolare nel letto come un gatto. Cresce ingobbita, così incurvata sulla schiena da destare pena tra i ricchi villeggianti che frequentano la valle durante la stagione estiva. E sono proprio loro che, grazie ad una colletta, le regalano un letto gigante su misura (lungo poco meno di due metri e mezzo), che viene portato al maso di famiglia in processione, non prima di essere benedetto davanti alla chiesa del paese. A 17 anni Maria è alta 2 metri e 27 centimetri (all’epoca l’altezza media di una donna è di circa 1 metro e 50 centimetri) e pesa circa 172 chili. Le sue scarpe sono lunghe circa 37-38 cm (pari a una taglia 56), mentre la misura dei suoi guanti varia tra le taglie 14 e 16 a seconda delle fonti.
181
A sinistra: Maria posa tra i villeggianti della Val Ridanna; alla sua sinistra la sorella Anna
Le poche volte che si allontana dal paese, vive la dolorosa esperienza di essere oggetto di curiosità, tanto che il papà si lamenta più volte del fatto che quando sono in giro insieme, gli occhi della gente sono tutti puntati su quella sua figlia così alta. Le voci corrono di valle in valle e presto i media tirolesi non tardano a scoprire la ghiotta notizia e a darla in pasto all’opinione pubblica. Uomini e donne, bambini e adulti, fotografi e giornalisti si appostano dappertutto per vedere la “donna più alta di tutto il Tirolo” e farle mille domande, alcune decisamente umilianti e cattive. A tutti però, nessuno escluso, appare simpatica e mite: il viso è allungato e relativamente stretto, strano ma non brutto, ha uno sguardo malinconico ma gentile, con un sorriso sereno, capelli scuri e una voce decisamente rauca, quasi maschile.
Fenomeno da baraccone Impresari e proprietari di numerosi teatri della Vecchia Europa arrivano in Alto Adige e fanno la fila davanti al suo maso: implorano i genitori di Maria di lasciarla andare con loro per poterla mettere in mostra nelle principali capitali europee insieme ad altri “fenomeni da baraccone”, in spettacoli molto in voga a cavallo del secolo. In cambio la famiglia avrebbe ricevuto una considerevole somma di denaro, con la quale si sarebbe potuta comprare magari un paio di mucche o anche un pezzo di terra da coltivare a granoturco. Mamma e papà, nonostante la povertà che imperversa sul povero maso di montagna, non cedono a queste lusinghe finanziarie, anche perché Maria non vuole allontanarsi dalla sua terra natale, dai suoi affetti e dalle sue poche certezze. Alla fine però la ragazza capisce che è giunto il momento di ricambiare l’amore dei genitori, dando alla famiglia una possibilità in più per uscire dalla miseria. Sono ormai tante le bocche da sfamare nel piccolo maso e le condizioni economiche stanno diventando via via sempre più precarie. A 21 anni Maria va a servizio, con la sorella Rosa, da una signora benestante dell’alta borghesia di Berlino, che in realtà la utilizza come “capriccio e giocattolo personale” per stupire i propri ospiti. Passa solo poco tempo e la signora di Berlino si stanca del suo “gioco”: Maria e la sorella tornano a casa, alla semplice vita della valle, dove tutto è scandito dal susseguirsi regolare delle stagioni. Presto però i soldi guadagnati a Berlino finiscono e la famiglia ripiomba nell’incubo dei debiti contratti per sopravvivere, in un vortice senza fine di sofferenza, stenti, fatica e preoccupazioni. Sono ormai passati sei anni dal suo ritorno a casa da Berlino e la ragazza, dotata di una sensibilità certamente fuori dal comune, capisce che è giunto il momento di sacrificarsi ancora una volta per il bene di tutti i suoi cari. Nel 1906, a 27 anni, vengono accettate le
vantaggiose offerte d’ingaggio di un impresario ed ecco che Maria, accompagnata la prima volta dalla sorella Anna e poi sempre dalla sorella Rosa, inizia un viaggio di ben setti anni attraverso le più importanti città dell’Impero austro-ungarico, della Germania e di tutta Europa. Diventa per tutti Mariedl, nome d’arte più commerciabile: una gigantessa è già qualcosa di spettacolare, ma una gigantessa con il fascino e il nomignolo di una bambina di montagna riesce a commuovere. Anche il suo appetito, definito “pantagruelico”, serve per incuriosire ed attirare un numero sempre maggiore di spettatori. Ed è così che in un volantino pubblicitario distribuito al pubblico si favoleggia, ad esempio, sulle sue colazioni “normali”: 18 uova, una dozzina di panini, 3 bricchi di caffè, un piatto di prosciutto e una grande ciotola di marmellata. La realtà è ben diversa: non c’è dubbio che Maria abbia avuto un buon appetito durante la fase di crescita, ma questo appetito si stabilizza intorno ai 16-17 anni, quando peso e altezza cessano di aumentare. Colazioni, pranzi e cene diventano allora, per quantità, simili a quelli delle persone comuni, e ciò nonostante le sue dimensioni e il suo peso. Rimane invece inalterato il suo amore per il latte: ne beve circa 2 litri al giorno. Quando è di buon umore ed allegra, si concede anche un quarto di litro di buon vino rosso. Negli spettacoli si presenta e si presenterà sempre vestita con

182
Mariedl, tra la sorella Rosa e un impresario
un costume tradizionale tirolese (in parte modificato per renderla più “attraente”). La sua altezza, già di per sé incredibile per l’epoca, viene accentuata ad arte tramite un alto cappello a cilindro e degli stivali o delle scarpe “modificate” con una suola molto molto spessa: questo fa sì che i suoi movimenti sul palco siano oltremodo impacciati e lenti, così come ci si aspetta da un gigante.
La gigantessa del Tirolo Mariedl, la gigantessa del Tirolo” tocca il cuore della gente e la gente accorre allo spettacolo della “donna più alta del mondo”. Folle di curiosi si accalcano nei teatri per “sezionare” con lo sguardo la sua “diversità”, vederla da vicino, studiarla e farle delle domande, dalle più banali a quelle più intime (cui, per contratto, deve cercare di rispondere). La prima esibizione avviene a Berlino, per poi far tappa in numerose altre città: Francoforte, Amburgo, Praga, Lipsia, Bruxelles, Manchester, Londra. Mariedl si esibisce in ogni genere di festa e di mercato, dal Kohlmarkt di Vienna all’Oktoberfest di Monaco, venendo presentata persino alla corte dell’imperatore Francesco Giuseppe. Di tutto questo mondo, così apparentemente affascinante ma completamente estraneo alla sua anima, Mariedl vede e gode ben poco, rintanata e “rinchiusa” nel suo camerino e nella sua stanza, pronta ad essere “data in pasto” esclusivamente al momento dello spettacolo sul palcoscenico, assieme ad altre “anomalie umane viventi” (tra cui soggetti microcefali, nani e giganti provenienti da tutto il mondo, donne barbute, grandi obesi, contorsionisti, gemelli siamesi, ermafroditi). Il lavoro quotidiano è faticoso, ripetitivo, ossessionante e certamente malinconico: ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 21, si presenta in scena e al pubblico ogni mezz’ora, seguita da un’altra mezz’ora di pausa, scendendo dal palco per offrire cartoline illustrate e volantini pubblicitari, rispondendo a qualsiasi domanda da parte degli spettatori. Con questi ritmi e con questi orari giornalieri, appare chiaro che di tempo libero ne ha veramente poco. Pur viaggiando tanto da un paese all’altro per tutta Europa, è infatti costretta ad un isolamento forzato: ne deriva che le città d’arte e il tessuto socio-culturale delle stesse rimangono a lei completamente estranee ed oscure. Nelle lunghe ore in cui non appare in scena e nei momenti di libertà si limita a lavorare a maglia (nonostante le sue grandi mani, con dita grosse e goffe, Mariedl è assai abile nel maneggiare i ferri, con cui confeziona soprattutto calze, guanti e cappelli per i ragazzi e le ragazze del suo paese natale) e ad andare in chiesa per pregare. La sua è una fede sincera e profonda: non appena possibile, ovunque faccia tappa la sua troupe, trova il tempo per allontanarsi dal turbinio del mondo dello spettacolo attraverso la lettura del suo libro di preghiere,
con la recita di due-tre rosari al giorno, durante i quali conta sistematicamente i grani di legno del rosario portato da casa. La sua necessità di partecipare appena possibile alla Messa crea non pochi problemi agli impresari, che si trovano costretti non solo a prendere accordi con le autorità religiose affinché venissero organizzate delle funzioni apposta per lei in orari inusuali (riservandole un posto particolare in sacrestia, lontano da occhi indiscreti), ma anche a condurla in chiesa all’interno di un’automobile chiusa, onde evitare che la sua figura gigantesca fosse vista dal pubblico prima della sua esibizione in scena. In alcuni teatri le sue apparizioni sono meno impegnative, con solo 2 o 3 spettacoli al giorno, soprattutto quando i suoi movimenti diventano più lenti, meno fluidi, con rigidità del corpo ed un evidente impaccio nel muoversi sul palco. Queste limitazioni le consentono di avere più tempo per sé: Mariedl possiede una cultura probabilmente superiore alla media, è curiosa e intelligente, parla il tedesco in maniera disinvolta, sa scrivere, ama la musica, adora i bambini (nonostante questi provino paura delle sue dimensioni), si aggiorna sulle vicende del mondo e rilegge mille volte quei pochi ritagli di giornali locali che riceve da casa.
Il suo stipendio mensile è più che ragguardevole per l’epoca (intorno alle 300 corone), con l’aggiunta di una piccola paga anche per la sua fedele accompagnatrice, la sorella Rosa. In una lettera indirizzata alla famiglia, Mariedl si lascia andare ad una rara confessione di carattere economico, scrivendo di aver guadagnato in 17 giorni più di quanto avesse potuto guadagnare in 2 anni di lavoro a casa come contadina.
Risparmia soldo su soldo ad ogni esibizione e a fine mese, con la nostalgia nel cuore per la sua terra lontana, invia parte dei suoi guadagni ai genitori, affinché possano finalmente estinguere i debiti di casa, in modo tale che la loro vita nel maso possa diventare più decorosa e umana. Una parte di questi risparmi li tiene invece per sé: di questa quota, una certa percentuale la dona ad organizzazioni ecclesiastiche e ad istituti per bambini bisognosi, una parte la trattiene per dar vita ad un sogno mai realizzato (acquistare un maso tutto per sé, vicino alla casa dei genitori, dove andare a vivere con la sorella Rosa) e una certa quota la investe imprudentemente in titoli di guerra (diventati, nel giro di pochi anni, carta straccia). Mantiene e manterrà sempre i contatti con la famiglia, in particolare con la mamma (cui è molto legata): scrive ogni settimana ai suoi, su carta d’albergo, utilizzando tutti gli spazi possibili (anche sopra l’intestazione dell’albergo stesso) e raccontando tutto quello che succede a lei e alla sorella, la loro vita giornaliera, la nostalgia di casa, la bellezza di una fede ancora trattenuta nell’intimo. Con una calligrafia molto fine e ordinata chiede le novità di casa, si
183
preoccupa dello stato di salute di tutti i familiari, consiglia alla madre una particolare tisana con fiori di tiglio e miele per curare la sua tosse, s’interessa del paese natio e dei suoi abitanti. Ogni settimana riceve una lettera di risposta. Sono lettere molto brevi e scarne: i genitori sono analfabeti e dettano qualche parola a uno dei figli, rendendo partecipe Mariedl della raccolta delle patate, del nuovo vitello nato e delle piccole novità del paese. In questo modo il filo con la propria terra non si spezza: non appena le è possibile abbandona le tournées e torna a casa, anche perché le sue condizioni di salute cominciano a deteriorarsi. Nonostante la fatica, Mariedl sente comunque il dovere di aiutare la famiglia e continua a partire per le sue esibizioni all’estero.
La malinconia di un amore perso
Nella primavera del 1907, all’età di 28 anni, Mariedl (accompagnata sempre dalla sorella Rosa) viene ingaggiata per una tournée in Inghilterra, dove si esibisce in vari teatri e fiere, per poi approdare a Londra. Qui, all’Ippodromo londinese, vengono allestiti due spettacoli al giorno e Mariedl condivide il palcoscenico con equilibristi, giocolieri, trapezisti, attori vari e numerosi artisti unici nel loro genere (dall’uomo più forte del mondo alla donna più grassa mai esistita).
Allo scopo di aumentare la corsa ai botteghini ed
accentuare ancora di più la fama di Mariedl, in Inghilterra le ritagliano “ad hoc” una storia d’amore con un altro gigante, l’australiano Clive Darril, in viaggio di piacere in Europa. La sua altezza, in base a fonti diverse, varia da 2 metri e 31 centimetri a 2 metri e 56 centimetri. Pare che il “colpo di fulmine”, da parte di Clive nei confronti di Mariedl, sia avvenuto già l’anno prima a Vienna, con un corteggiamento discreto ma insistente, tanto che il gigante australiano segue Mariedl nei suoi spostamenti da Vienna a Berlino e a Londra. L’avversione degli impresari nei confronti di Clive è inizialmente netta (la paura è che la gigantessa, rispondendo a queste avances, potesse rompere il contratto ed abbandonare la tournée). Le lettere di Clive a Mariedl non hanno alcuna risposta, costringendo lui ad una plateale dichiarazione pubblica: durante uno spettacolo, preso coraggio, si alza e, rivolgendosi a lei, esprime i propri sentimenti. Gli spettatori presenti, allora come oggi, si commuovono davanti a questa dichiarazione d’amore, ma Mariedl rimane interdetta, anche perché non conosce la lingua inglese, per cui le parole dell’innamorato non arrivano al suo cuore, anche se giungono, inequivocabili, gli sguardi e la veemenza dell’eloquio di quell’uomo innamorato. E allora la gigantessa si lascia corteggiare, superando l’ostacolo della lingua grazie all’aiuto di un interprete. La più alta coppia

184
Maria e la sorella Rosa, vestite a festa, posano nei pressi del loro maso
del pianeta viene fotografata al mare, a braccetto lungo le vie del centro di Londra, in automobile e in carrozza. Clive è un uomo pratico e deciso, non perde ulteriore tempo e la chiede subito in moglie. Mariedl tentenna, non si capacita, ha paura, scrive a casa per chiedere il permesso dei genitori. La risposta degli stessi, preoccupati ed increduli che quella loro figlia così “diversa” possa trovare qualcuno disposto ad amarla, la lascia ancora più preoccupata e indecisa. Quando poi Clive le propone di andare a vivere in Australia, nella fattoria del padre (ricco proprietario terriero), Mariedl prende la sua decisione e gli risponde che non se la sente di seguirlo dall’altra parte del mondo. L’amore e la responsabilità per i suoi genitori e per tutta la sua famiglia hanno senz’altro un ruolo importante nella decisione di respingere quella proposta di matrimonio. Ed è così che la storia più importante e delicata della vita di Mariedl si esaurisce nell’arco di soli pochi mesi. I due giganti si salutano, lui s’imbarca per l’Australia e lei riprende la vita del palcoscenico, portando tuttavia nel cuore una nuova e soffocante ferita: la malinconia di un amore perso.
Figlia dello Staudnerhof
All’inizio del 1908, Mariedl e la sorella Rosa tornano in patria per qualche mese: è un periodo di grande gioia e relax, il ritorno a una vita tranquilla, ritmata non più dagli orari degli spettacoli e dai faticosi viaggi di spostamento da una città all’altra, ma solamente dal lento trascorrere delle giornate in valle. La vacanza e il riposo a casa durano però molto poco: con l’arrivo della primavera, la ritroviamo nuovamente nei cartelloni teatrali prima di Berlino e poi di Amburgo (dove viene pubblicizzata come una gigantessa alta non meno di 2 metri e 50 centimetri, con un peso di 360 chili!!). Sul palco di quest’ultimo teatro, sicuramente per attirare ancora più pubblico e aumentare gl’incassi, fa il suo ingresso anche Clive Darril, che viene presentato come lo sposo di Mariedl: è l’ultimo tentativo del gigante australiano di far breccia nel cuore della gigantessa della Val Ridanna. Dopo Amburgo, Maria e la sua troupe si esibiscono ad Hannover sino all’inizio del 1909, per poi far tappa, nel 1910, all’Esposizione Internazionale di Bruxelles. A fine anno si rendono evidenti alcuni disturbi circolatori agli arti inferiori, che causano una sintomatologia dolorosa e invalidante alle gambe e ai piedi. Una volta rimessasi in salute, Mariedl viene nuovamente ingaggiata in altri spettacoli itineranti e, nel 1912, la ritroviamo a Brema dove, come al solito, viene presentata tra le “anomalie viventi”. Seguono altri teatri, altri spostamenti lunghi e travagliati in molte altre città della Germania. Con il passare degli anni, tuttavia, si fanno sentire sempre di più la solitudine interiore e una malinconia struggente, cui si associano sia una stanchezza diventata cronica sia un lento degrado della sua salute.
L’ultimo viaggio
Arriviamo così alla vigilia della Prima Guerra Mondiale: la gente ha altre preoccupazioni per la testa che interessarsi di una gigantessa. Gli spettacoli teatrali, cui finora ha partecipato come “artista di punta”, richiamano sempre meno spettatori e tutto il settore entra in una profonda crisi. Mariedl, afflitta d’acuta nostalgia, ormai malata e sfinita da una vita così scombinata e frenetica, nel 1913, prende definitivamente la via di casa e torna ad essere Maria. Le sue gambe sono sempre più malate, si ulcerano facilmente e le ferite fanno fatica a rimarginare e a guarire. Anche il cuore fa le bizze: una cardiopatia congestizia incomincia a dar segno di sé, con gonfiori, edemi, difficoltà respiratorie, tachicardia, debolezza, affaticamento e tosse. Questi ultimi anni della sua vita, lontano dai clamori del mondo e del palcoscenico, li trascorre aiutando la famiglia nelle faccende domestiche anche se, data la salute ormai segnata dalle fatiche, riesce a fare ben poco. Si affida ancora di più alla fede, trascorrendo molte ore della giornata in preghiera, nella cappella costruita accanto al maso di famiglia. Le restrizioni legate alla guerra e il razionamento progressivo dei viveri, indeboliscono sempre più la sua salute, compromettendo ulteriormente il suo vivere quotidiano.
Maria muore, dopo lunga malattia, il 4 dicembre 1917, all’età di 38 anni compiuti.
Trascorrono poco più di tre settimane e, il 30 dicembre, muore anche l’amata mamma Theresia, colpita da una brutta polmonite Causa della morte di Maria? Idropisìa. Si tratta di un accumulo di liquidi nella cavità peritoneale e nel tessuto sottocutaneo, con conseguenti gonfiori che possono essere generalizzati o localizzati (solitamente alle braccia e alle gambe). Non si tratta di una vera e propria malattia, ma di un disturbo che accompagna altre patologie, come l’insufficienza renale o malattie dell’apparato circolatorio. Questa ritenzione di liquidi altera progressivamente il corretto funzionamento di organi vitali, quali cuore, fegato, reni e polmoni: ciò succede perché l’accumulo di questi liquidi esercita una certa pressione su questi organi, riducendo lo spazio a loro disposizione e compromettendone la funzionalità.
La terra natia mi coprirà con leggerezza”: pare abbia detto prima di spirare. La sua preoccupazione era infatti di morire lontano dalle sue montagne. Desiderò che la sua tomba, nel piccolo cimitero di Ridanna, fosse piccola (come quella delle persone apparentemente “normali”) e che sopra, accanto al nome, vi fosse scritta soltanto la frase: Figlia dello Staudnerhof
Note
Le fotografie
sono tratte in massima parte da Internet e dal libro di Samantha Schneider e Inga Hosp “Die Riesin von Ridnaun” (Edition Rætia, 2001)
185



186
Emilio Comici Matteo Della Bordella - Poncione d’Alnasca, Via Leap of faith (T. Lamantia)
Immagine 1: prove di confronto “massa-manichino” alla
Torre di Padova
UN NUOVO STUDIO SULLE LONGE: massa rigida e manichino a confronto
di Giuliano Bressan, Massimo Polato e Cristiano Zoppello
Nel 2012, il Centro Studi Materiali e Tecniche pubblicava un articolo a proposito delle longe [1], a seguito di un’indagine avviata qualche anno prima dal compianto Oskar Piazza, che prendeva spunto da un incidente avvenuto ad un arrampicatore francese, nel quale si verificava la rottura di una longe in Dyneema® a causa di un volo a fattore di caduta (FC) pari a 2. Questo fatto, che all’epoca suscitò molto scalpore, diede il via a una serie di studi e approfondimenti per capire cosa fosse successo, e si arrivò a definire meglio le caratteristiche di resistenza di alcuni materiali e, soprattutto, a chiarire alcune modalità di impiego, per far in modo che si ponesse attenzione al loro corretto utilizzo. Oltre ad un’indagine riguardante questi materiali da un punto di vista speleologico che portò alla scrittura di vari articoli (vedi note [2] e [3]), si diede il via ad una campagna di prove per indagare su quale fosse il materiale migliore per costruire una longe per uso alpinistico.
I risultati di quel lavoro portarono sostanzialmente ad avvalorare da un punto di vista scientifico che il materiale dinamico si prestava meglio per la costruzione delle longe e che le diverse tipologie di Daisy Chain allora nel mercato e di longe costruite con materiali statici portavano in sé delle potenziali criticità se utilizzati in determinate situazioni: ovvero quando venivano sollecitate da un carico dinamico piuttosto che statico [1].
All’epoca, la struttura principale di cui disponeva il CSMT per poter eseguire le prove e verificare l’entità delle forze che sollecitavano i materiali, era il “Dodero”; oggi, a distanza di anni, il CSMT ha potuto dotarsi di altri strumenti che possono aiutare ad approfondire meglio tutti gli aspetti già sottoposti ad indagine quali un manichino ed un accelerometro wireless a tre assi.
Grazie all’ausilio di questi strumenti, abbiamo potuto misurare una serie di parametri (forza e decelerazione), distinguendo (e quindi confrontando), tra l’utilizzo di una massa d’acciaio e il manichino sopra citato che meglio si presta a simulare l’anatomia di un corpo umano.
Ma prima di riprendere il lavoro sulle longe… Con l’acquisizione di questi nuovi strumenti, prima di intraprendere un lavoro di “revisione” sull’argomento longe abbiamo voluto concentrarci su una questione ad esso “propedeutica”: determinare da un punto di vista sperimentale, quali differenze vi siano nell’eseguire le prove sui materiali alpinistici, utilizzando la consueta massa d’acciaio, indeformabile, piuttosto che il manichino che risulta decisamente più deformabile.
Premettiamo subito che quanto abbiamo fatto e che vi proponiamo a breve, è il rifacimento in chiave più aggiornata di uno studio eseguito nel 2006, in cui però, mancando il manichino, ci si era dovuti “accontentare” dei dati derivanti dalle cadute di alcuni volenterosi e coraggiosi stuntmen e questo aveva significato, per evidenti questioni di sicurezza, doversi limitare nell’entità delle cadute. Immaginate cosa significa per una persona cadere da quattro metri anche “solo” a fattore di caduta 1…
Ma entriamo nella questione e vediamo come sono stati eseguiti i test.
La prima cosa che sottolineiamo è che, per ragioni di ripetibilità dei risultati, tutte le prove sono state eseguite a corda bloccata e utilizzando una corda dinamica singola di diametro 9,8 mm con una forza di arresto pari a 810 daN (nota); inoltre, tutti gli spezzoni di corda erano chiusi alle estremità con tre morsetti (avvitati con chiave dinamometrica). Questo è stato fatto, per evitare che l’effetto di strizione del nodo entrasse come “effetto spurio” nelle prove (visto che sarebbe stato più difficile fare e pretensionare tutti i nodi allo stesso modo). Inoltre, lo spezzone di corda veniva sostituito dopo ogni prova. Come per le prove eseguite nel 2006, sono state individuate tre lunghezze di corda (1, 2 e 4 m) e due valori di fattore di caduta (0,5 e 1), su cui concentrare l’indagine. All’epoca il fattore di caduta 2 non era stato nemmeno preso in considerazione visto che a eseguire le prove c’erano delle persone; inoltre, eseguire delle prove in questa
187
situazione (FC = 2) implica giocoforza un effetto di pendolo della massa che cade e questo instaura tutta una serie di problematiche pratiche e di complessità nei risultati.
Abbiamo quindi eseguito i seguenti test:
• 9 prove a FC = 0,5: 3 con spezzone lungo 1 m, 3 con spezzone lungo 2 m e 3 con spezzone lungo 4 m.
• 9 prove a FC = 1, con le medesime lunghezze e quantità di campioni delle precedenti.
Queste prime 18 prove sono state eseguite utilizzando una massa di acciaio di circa 80 kg (vedi immagine 2).

Successivamente ne sono state fatte altre 18 esattamente come le precedenti però utilizzando il manichino (immagine 3), anziché la massa di acciaio. Le immagini 4 e 5 mostrano in dettaglio la configurazione di prova. L’immagine 4 fa vedere la tipologia di prova eseguita con la massa (in azzurro lo spezzone di corda dinamica chiuso con i morsetti, in bianco la corda di sicurezza). Nell’immagine 5 si vede la massa in caduta collegata alla cella di carico fissata sotto il traliccio della torre.

La tabella 1 riassume i risultati ottenuti dai 36 test effettuati. Una prima considerazione che possiamo fare, osservando i dati riportati, riguarda la loro buona ripetibilità: e questo ci consente di affermare che le procedure adottate nella preparazione dei campioni e nell’esecuzione delle prove si sono rivelate di buona qualità e in grado per poter arrivare ad effettuare delle misure che ci consentono di trarre delle conclusioni oggettive sul fenomeno misurato, validando anche la procedura sperimentale adottata.
Per cercare di comprendere un po’ di più questi dati, vi riproponiamo i dati della tabella 1 utilizzando il grafico a punti rappresentato dalla figura1 e l’istogramma a barre di figura 2.
Nel grafico si possono distinguere bene tutte le prove eseguite divise per tipologia di grave (massa e manichino), fattore di caduta e lunghezza dello spezzone di corda utilizzato; la prima terna di punti corrisponde ad una lunghezza dello spezzone pari ad 1 m, la seconda a 2 m e la terza a 4 m. La stessa considerazione sulla lunghezza degli spezzoni di corda vale anche per le prove a FC = 1. In
188
Immagine 2: prove di confronto “massa-manichino” alla Torre di Padova fc L spezzone [m] Forza [daN] Media F [daN] fc L spezzone [m] Forza [daN] Media F [daN] 397,4 326,80 401,9 328,70 401,5 338,70 416,9 381,50 406,1 392,80 410,5 392,90 478,4 379,70 470,9 418,30 469,0 424,10 672,0 528,40 669,6 540,50 658,7 548,50 630,4 592,80 632,7 594,20 632,0 601,40 631,9 616,80 630,2 614,30 633,8 615,70 1 331,4 2 389,1 4 407,4 1 539,1 596,1 4 615,6 4 472,8 2 631,7 MASSA MANICHINO 0.5 11 1 666,8 4 632,0 2 411,20.5 1 400,3 2 Tabella 1 Immagine 4
Immagine 3
particolare, si evidenziano due aspetti:
• Il primo è che, come ci si aspettava, i valori di forza registrati nelle prove di caduta della massa sono, in generale, più elevati di quelli misurati col manichino.
• Il secondo è che questa differenza diviene più marcata con l’aumentare del fattore di caduta e per brevi lunghezze di caduta, ma tende a diminuire con l’aumentare di quest’ultime.
Come spiegato precedentemente, non sono stati eseguiti voli a fattore di caduta due, ma confrontando i dati con quelli trovati nelle prove del 2006 possiamo affermare che le prove eseguite nel 2020 hanno confermato quanto già era emerso e cioè che la differenza di sollecitazione della corda, utilizzando la massa piuttosto che un manichino, tende ad annullarsi al raggiungimento di circa 4 m di volo. Questo fatto, che sembra di poco conto, in realtà riprova, da un punto di vista sperimentale, due osservazioni:
• la prima è che si conferma il fatto che sia corretto utilizzare la massa di acciaio, per esempio, nelle prove al Dodero per eseguire i test di certificazione delle corde dove la caduta della massa supera i quattro metri.

• La seconda è che sia stato corretto, alla luce dei risultati ottenuti, investire nell’acquisizione di un manichino per “ristudiare” il comportamento delle longe, dove nella realtà i potenziali voli dovrebbero essere, di modesta entità

189
Immagine 5

190
Emilio
Comici in
corda
doppia
sulla Guglia Giuliana a Misurina
e le differenze che ci possono essere con l’utilizzo della massa di acciaio, possono essere importanti. Questo ultimo punto risulta ancor più chiaro se prendiamo in considerazione il grafico di figura 1 e lo modifichiamo inserendo i dati relativi ai test eseguiti con gli stuntmen nel 2006 (riferiamoci alle prove a FC = 1). Così facendo otteniamo il grafico di figura 3, dal quale si evince come il manichino rispecchi, con buona approssimazione, il comportamento del corpo umano. Quanto appena esposto si rivela essere il punto di partenza per poter riprendere e aggiornare il precedente studio fatto sulle longe, avendo la possibilità di eseguire test che simulino in modo ancor più realistico il comportamento di questi dispositivi che saranno analizzati nell’articolo “Un nuovo studio sulle longe: le evidenze più recenti”.
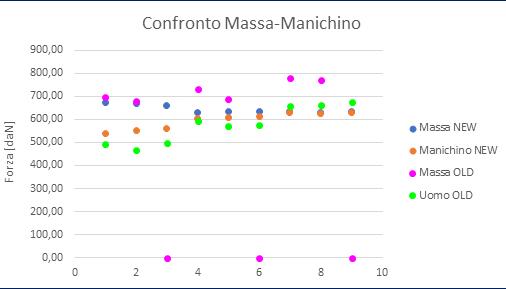
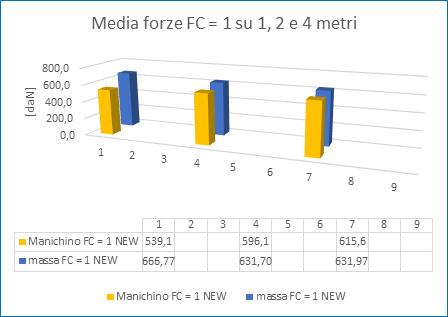

Nota
Il newton - “N” - è un’unità di misura della forza nel Sistema Internazionale; un N è la forza che applicata a una massa di 1 kg le imprime l’accelerazione di 1 m/s² ed equivale a circa un ettogrammo peso.
Un decanewton - “daN” (10 newton) viene spesso usato perché equivale a circa 1 kg peso.
Un kilonewton “kN” (1000 newton) equivale quindi a circa 100 kg peso.
Ringraziamenti
Un ringraziamento va alle persone che hanno partecipato a questa sessione di prove e che hanno reso possibile l’esecuzione, la preparazione della struttura e dei campioni e le riprese: Massimiliano Avalle (anche per i puntuali e preziosi suggerimenti dati nella fase di rilettura dei testi), Sandro Bavaresco, Vittorio Bedogni, Cristian Cesaro, Simone Maratea, Claudio Melchiorri, Davide Rogora e Nicola Tondini. In modo particolare, si ringrazia Federico Bernardin per l’aiuto dato, oltre che per l’esecuzione dei test anche per l’analisi dei risultati e la stesura di questo articolo.
Bibliografia
[1] Bressan G., Polato M., Longes e daisy Chain: impieghi, Annuario CAAI, 112-2012 ‘13
[2] Zoppello C., La longe in speleologia, Le Alpi Venete, 1-2011
[3] Antonini G., Piazza O., Test sui materiali: le longes, Il Soccorso Alpino, 4-2012
191
Figura 1 Figura 2 Figura 3



192
Maurice Herzog, il prezzo della vittoria
Passaggio della Miristi Khola in piena (dal libro Uomini sulla Annapurna di M. Herzog)
TANTI PASSI VERSO L’ANNAPURNA 100 anni di avventure sulla catena himalayana
Dal 13 settembre 2022, il Corriere della Sera si propone con la collana ‘La Storia dell’Alpinismo’ curata da Alessandro Gogna. 25 volumi che iniziano con ‘La conquista del primo Ottomila’ scritto da Marco Berti che racconta l’esplorazione alpinistica della catena himalayana dal 1854, con il primo tentativo al Kamet (7.756 m) ad opera dei fratelli Schlagintweit, fino alla vittoriosa ascensione di Herzog e Lachenal sull’Annapurna nel 1950. Fatti nei quali si narra di personaggi noti, di altri poco conosciuti e alcuni completamente dimenticati. L’intento del volume, come si legge nell’introduzione firmata da Gogna e dallo stesso Berti, è quello di spiegare che i risultati di oggi, anche per i più grandi exploit, sono frutto di un percorso che parte da lontano, poiché, come in ogni disciplina sportiva, scientifica o culturale in genere, è la conoscenza, l’accumularsi delle esperienze di chi ci ha preceduto che permette al singolo di spostare il proprio limite, di andare oltre raggiungendo obiettivi la cui strada è già stata segnata e in parte percorsa da altri.
Berti, come nel suo precedente ‘La conquista dell’Everest’, sempre con il Corriere della Sera per la collana ‘Le Grandi Imprese della Storia’, racconta prestando attenzione anche agli alpinisti autoctoni, silenziosi e anonimi protagonisti delle prime esplorazioni, con l’intento di dar loro luce e farli risorgere da un immeritato anonimato.
Tra tanta esplorazione, quotidiane difficoltà e incognite appaiono i nomi di Mallory, Shipton, Tilman, ma anche del kalashi Lor Khan che nel 1895, vestito di abiti tradizionali, accompagnò Mummery sullo sperone che ora porta il nome dell’alpinista inglese, di Merkl e di tutta l’ossessione tedesca nel ripetersi di tragedie sul Nanga Parbat, di Kellas e della sua salita sul Pauhunri (7.128 m) nel 1911, rimasta sconosciuta fino a poco tempo fa e che raggiunse la vetta con due sherpa dai nomi improvvisati: ‘Sony’ e ‘Il fratello di Tuny’.
Tra gli italiani troviamo Mario Piacenza, il duca degli Abruzzi e un certo Alcesti Rigo de Righi che nel 1905 accompagnò Aleister Crowley sul Kangchenjunga.
Il volume è arricchito da ottanta immagini storiche che accompagnano il lettore nel profumo dell’epoca delle immagini color seppia.
100 anni di un alpinismo praticato con attrezzature rudimentali e pesanti, conoscenze limitate, in un vissuto fatto di sogni e caparbietà e come scrive Gogna nella presentazione della collana «La montagna, nel suo essere zona estrema, è protagonista nella storia delle idee perché vi si radicalizzano ed emergono, in modo talora simbolico talaltra caricaturale, le espressioni più tipiche di ogni periodo storico».
Il piano dell’opera
1) Alla conquista del primo Ottomila (Marco Berti)
2) Le grandi imprese solitarie (Serafino Ripamonti)
3) Sulle cime delle Alpi (Simone Bobbio)
4) In vetta agli Ottomila (Gianluca Gasca)
5) Le grandi pareti alpine (Massimo Bursi)
6) Gli Ottomila d’inverno (Gianluca Gasca)
7) Sulle Dolomiti (Lorenzo Carpané)
8) Il Sesto grado (Sara Sottocornola)
9) Le grandi imprese invernali (Fabrizio Rossi)
10) Le vie più difficili degli Ottomila (Roberto Mantovani)
11) Le grandi prime femminili (Sara Canali)
12) Patagonia (Valentina d’Angella e Luca Maspes)
13) La Scuola di Monaco (Paolo Ascenzi)
14) Senza Guida (Paolo Ascenzi)
15) La grande tradizione slava (Luca Calvi)
16) Stile Alpino (Davide Scaricabarozzi)
17) Alle origini: guide e clienti (Paolo Ascenzi)
18) Alpinismo sovietico (Sara Fagherazzi)
19) Il ‘68 dell’Alpinismo (S. Ripamonti e S. Sottocornola)
20) L’artificiale (Fabio Elli)
21) Scialpinismo (Carlo Crovella)
22) L’evoluzione dell’attrezzatura (Elio Bonfanti)
23) Dal Nuovo Mattino alle scalate libere (Andrea Giorda e Fabio Palma)
24) Alpinismo americano (S. Ripamonti e S. Sottocornola)
25) Sci e snowboard estremi (Giorgio Daidola)
Alla conquista del primo Ottomila di Marco Berti
Il Corriere della Sera, 2022 120 pp., 19x23 cm,
foto a colori - 65 foto in b/n,
Euro
193 di MB
10
9.90

MULTIPITCH NELLE
VALLI TORINESI
di M.B.
Multipitch nelle Valli Torinesi
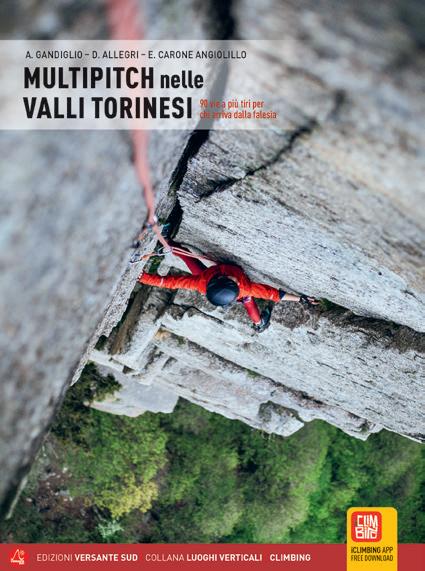
di A. Gandiglio, D. Allegri, E. Carone Angiolillo
Versante Sud, 2022
288 pp., 15x21 cm.
137 foto a colori, 1 foto in b/n, 1 cartina 32.00 Euro
Una delle ultime proposte in ambito di itinerari multipitch di Versante Sud è dedicata alle Valli Torinesi. A firmare questa guida sono tre giovani autori: Alberto “Gandi” Gandiglio, Davide Allegri ed Enea Carone Angiolillo. Il risultato è una guida che appare come una nota stonata all’interno del grande spartito di questa storica casa editrice milanese. È infatti abitudine di Versante Sud presentare ai lettori delle monografie complete e non una raccolta di itinerari scelti. Occorre riavvolgere il nastro temporale e tornare all’unica eccezione del catalogo: la guida “Vie e vicende in Dolomiti” di Ivo Rabanser e Orietta Bonaldo edita nel 2005. La guida presentava, anzi raccontava, 50 itinerari alpinistici correlandoli, oltre allo schizzo di salita, anche di testimonianze. La guida, oggi introvabile e mai ristampata nonostante le numerose richieste, si distinse certamente per originalità di proposta.
Questa “Multipitch nelle Valli Torinesi” sembra destinata a seguire il medesimo successo anche se la struttura è decisamente diversa e la grafica completamente rivista. Vale la pena riportare i brevi paragrafi scritti dagli autori per presentare il proprio lavoro.
Alberto “Gandi” Gardiglio: Arrampicata come mezzo, non come fine. Questo l’intento della guida che tenete tra le mani. Un lungo percorso tra i più bei itinerari arrampicatori del torinese. Se vi state chiedendo quale sia il fine di questo viaggio, beh, non possiamo rispondervi: per ognuno sarà diverso. Ma sappiate che più della metà dei ricordi che avrete di queste scalate non saranno appigli o gesti atletici, ma paesaggi, tramonti, albe, nuvole, discorsi con il vostro compagno di cordata, brindisi a fine giornata, luci, forme, suoni e colori. Insomma, il fine è vivere quanto più intensamente possibile, aspirare all’infinito, superare sé stessi sempre un po’ di più, sentire il proprio cuore battere come mai aveva fatto. Percepire, condividere, crescere, ascoltare. Un insieme di sensazioni che assaporerete non solo attraverso i vostri polpastrelli sulle nude rocce. Riconoscerete nella natura il vostro miglior interlocutore, un compagno fidato, sempre nuovo e pronto a stupirvi ogni volta. E ricordate: le cose belle richiedono attenzioni.

195
Per questo abbiamo scelto le 90 vie di arrampicata che vi proponiamo, sì come percorso di crescita tecnica, ma soprattutto interiore. A volte abbiamo prediletto l’estetica dell’itinerario, altre la bellezza del paesaggio, altre ancora il sentiero per giungervi. Arricchitevi di elementi, di momenti, di sensazioni. Arrivate in sosta e fermatevi un istante, uno solo. E respirate. Guardate la città lontana, il sole che compie il suo giro, la vita che scorre. Siete liberi. Sorridete. Buon viaggio. Davide Allegri: Una guida di arrampicata per chi non ne ha, pensata da chi (davvero) non ne ha. Spesso i progetti nascono da necessità. Io stesso, mentre sfogliavo guide di arrampicata alla Libreria della Montagna, avevo la sensazione che mancasse qualcosa tra tutte quelle pile di libri. Mancavano delle guide dedicate a chi vede l’arrampicata come un mezzo per stare a contatto con la natura insieme agli amici e liberare la mente dai pensieri quotidiani. Insomma, chi (come me) non vede il lato agonistico nell’arrampicata ma solo quello ludico. Chi non ne vuole sapere di gradi, tacche, prese di plastica e allenamenti specifici. Questa guida nasce quindi dalla necessità di creare un manuale di viaggio per l’arrampicatore a cui piace godersi le vie senza troppe pretese fisiche e, soprattutto, vuole sfruttare una guida di arrampicata appieno. Una raccolta di vie lunghe studiata per offrire una progressione lineare muovendosi tra roccia e storia. Descrizioni dettagliate, curiosità e foto di qualità sono i tre punti che soddisfano la necessità del lettore alla ricerca di una guida su gradi contenuti da sfogliare piacevolmente anche nei giorni lontani dalla roccia. Il vero plasir. Pur non appartenendo realmente al mondo dell’arrampicata mi piace avviare progetti sportivi e trovare idee innovative da applicare al mondo outdoor. “Multipitch facili nel torinese” non la reputo un’idea innovativa ma piuttosto un progetto trasversale sviluppato da me, Alberto ed Enea. Un team eterogeneo composto da tre
appassionati di sport e avventura che vedono l’arrampicata da tre punti di vista diversi. Il mio ormai lo conoscete. Enea Carone Angiolillo: Un tonfo secco sul materasso del fienilino (la nostra privata palestra di arrampicata nel fienile di Gandi), gli sbuffi soffocati sotto un tetto troppo pronunciato, le richieste serrate del compagno di cordata che sta salendo di metterlo in tiro su una corda e darne con un’altra, …tutti suoni che venivano immancabilmente seguiti dalla frase: “s’it en as pa dilu!” (“se non ne hai dillo!”). È così che siamo diventati quelli che non ne hanno. Quando è nata l’idea della guida per chi non ne ha, ci siamo più volte immersi in lunghe discussioni cosa volesse dire non averne. Il limite era dato da questo o quel grado? O dall’impegno della salita? O da mille altre variabili? E noi, davvero non ne avevamo? Durante la stesura le risposte non sono state sempre omogenee, ma a questo punto (poco prima della pubblicazione) mi sembra che la risposta sia chiara a tutti e tre noi. Non si tratta del livello arrampicatorio o alpinistico, ma di uno state of mind. Chi non ne ha è chi va in montagna non tanto alla ricerca di numeri, ma di esperienze. Per cui ecco la vostra guida di esperienze. Pronta a portarvi ad esplorare ed esperire tutti gli angoli verticali più belli delle nostre amate valli.

Ed ecco quindi una selezione scelta e ragionata di vie multipitch distribuite in Val Luserna, Val Pellice, Val Chisone, Val Noce, Val Chisola, Val Sangone, Val Susa, Valle Stretta, Val di Viù, Valli di Lanzo, Valle dell’Orco e la Valchiusella. Ce né per tutti i gusti e la tabella riassuntiva che precede ogni itinerario aiuta nella veloce scelta della via da ripetere. Una curiosità: oltre alle stellette che identificano la bellezza (soggettiva) di un itinerario, si aggiunge una scala a “ciucci” per indicare la facilità globale dell’itinerario (un ciuccio è più facile di tre).
Davvero una guida originale che oltre ad offrire dati tecnici, tenta (e sembra riuscirci) a proporre esperienze.
PARETE NORD
Piovan
Graphic novel autobiografica che nasce dall’esperta matita di Jean-Marc Rochette e ci regala la storia della sua scoperta della montagna e dell’alpinismo, attraverso il periodo di vita compreso tra i 14 e i 21 anni. La narrazione intreccia in modo equilibrato i momenti trascorsi in parete e la quotidianità adolescenziale tra la noia dei banchi di scuola, la conflittualità con la madre, i primi approcci con le donne, le proteste che caratterizzeranno la Francia a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 e le amicizie che si consolideranno grazie alla passione per l’alpinismo.

L’autore ci porterà alla scoperta di Grenoble e delle più importanti pareti del massiccio degli Ecrins grazie anche alle tavole grafiche che superano in emozioni l’asciutta
narrazione dei testi, regalandoci un libro da guardare più e più volte alla ricerca del dettaglio sfuggito.
Il finale non ci lascerà indifferenti e ci porterà a riflettere sulla scala dei valori in cui ognuno di noi pone la propria attività in montagna rispetto al mondo che ci circonda, agli affetti, alle passioni facendo così trascendere il titolo dal suo significato geografico ed elevandolo ad uno stato dell’anima; la “parete nord” che ognuno di noi porta dentro di sé.
Parete Nord
di Olivier Bocquet, Jean-Marc Rochette
Traduzione di Paolo Cognetti Ippocampo edizioni, 2021 298 pp., 19.5x27 cm.
25.00
197
di Carlo
Euro

PASSAGGIO A NORDOVEST
di M.B.
Passaggio a NordOvest

di Elio Cacchio
Versante Sud, 2021
480 pp., 15x21 cm.
146 foto a colori, 5 foto in b/n, 1 cartina 35.00 Euro
Con la fine del 2021 è approdata in libreria la nuova guida Passaggio a NordOvest edita da Versante Sud. Diverse sono le novità che la riguardano. Maurizio Oviglia e Fiorenzo Michelin, impegnati nelle prime due edizioni (2005 e 2011) lasciano il posto a Elio Cacchio, torinese classe 1973, che raccoglie l’eredità e confeziona un volume completamente rinnovato ed arricchito. La seconda grande novità riguarda la suddivisione del lavoro in due tomi: in questo primo volume vengono infatti trattate le falesie e le vie che si trovano nel Piemonte occidentale. Viene presa in esame l’intera Val di Susa dove recenti falesie vengono proposte a corredo di numerosi luoghi storici come la Cava di Avigliana, Caprie o la Cava di Borgone.
Il ricco capitolo dedicato alla storia dell’arrampicata piemontese permetterà al lettore di scoprire personaggi come Giusto Gervasutti, Guido Rossa, Gian Piero Motti, Ugo Manera, Gian Carlo Grassi, Franco Ribetti. La guida raccoglie ben 120 falesie e (purtroppo) solo 5 racconti.

Tutte le falesie sono presentate con una tabella riassuntiva che permette di identificarne velocemente le caratteristiche: dall’altitudine, al tempo di avvicinamento, alle difficoltà e all’esposizione. Un capitolo introduttivo presenta le caratteristiche della struttura; uno schizzo descrive dettagliatamente l’avvicinamento, infine la descrizione di ogni singolo tiro permette conoscere in anteprima i movimenti con i quali ci dovremo confrontare.
Insomma, un lavoro completo e dettagliato che ci consentirà di organizzare al meglio le nostre giornate in falesia. Nell’attesa del secondo volume, non resta che preparare lo zaino e andare ad arrampicare.
199



200
ALPINISMO FACILE IN TRENTINO ALTO ADIGE
di Matteo Bertolotti
Alpinismo facile in Trentino Alto Adige


di Diego Filippi e Fabrizio Rattin
Versante Sud, 2022
608 pp., 15x21 cm.
426 foto a colori, 148 cartine 38.00 Euro
Nel 2008 Ercole Martina dava alle stampe un piccolo volumetto per Nordpress dedicato alle Prealpi Lombarde nel quale presentava una selezione di itinerari di cresta non troppo impegnativi da percorrere. A cavallo tra gli anni ’80 e ‘90, l’instancabile Achille Gadler, a Trento, produceva a ritmi serrati volumi per Panorama dedicati alle vie Normali del Trentino Alto Adige.
Diego Filippi e Fabrizio Rattin probabilmente si sono ispirati a questi due autori e, raccogliendone l’eredità, hanno dato vita a quello che a tutti gli effetti è un lavoro titanico: una raccolta di gite e salite, che si sviluppano lungo bellissime vie Normali e itinerari di cresta. In questo primo volume vengono trattate le Valli Occidentali con un leggero sconfinamento in Lombardia e Veneto.
Vengono presentati ben 19 gruppi, tra i quali le Alpi Venoste, le Breonie, i Sarentini, l’Ortles, il Cevedale, l’Adamello, la Presanella e le bellissime Dolomiti di Brenta. Ogni capitolo è preceduto da un’accurata descrizione del gruppo dove vengono indicati i limiti geografici e le principali vette. Bellissima (e utilissima) la cartina che illustra il gruppo.
Ogni gita è un’avventura da vivere intensamente e l’accurata scheda aiuta il lettore a inquadrare sin da subito il terreno con cui si dovrà confrontare. L’offerta è varia, dalle semplici gite di poche ore a itinerari più impegnativi che richiedono un pernotto in quota e l’utilizzo di una corda e tecniche di arrampicata su roccia o ghiaccio. A fianco della descrizione è presente una cartina topografica che facilita l’orientamento sul campo.
Un libro per certi versi innovativo rispetto a quelli sinora pubblicati perché ricco di fotografie d’azione e panoramiche, con indicati i tracciati da seguire nonché la toponomastica delle vette con la relativa quota. 133 gite per (ri)scoprire la bellezza del Trentino Alto Adige.
201
Messner esplicita in modo ancora più chiaro il suo rifiuto a tornare sulla vicenda: “Posso perseguire l’inutile senza sentirmi la coscienza sporca e godermi la discesa adesso che sto invecchiando. Dunque non commenterò in futuro le menzogne, sempre diverse, che sono state fabbricate intorno a me e che sono circolate nel mondo”. Se gli altri non possono sopportare né la verità né se stessi, perché si vedono messi da parte, è un problema loro. Non porgerò il fianco a chi vuole essere applaudito come divulgatore di chiacchiere ed essere considerato al contempo “una persona perbene”. Mario Casella dal libro “Il peso delle ombre”


20420 euro - iban: IT58M0569611009CCI000308303 intestato a: MARCELLO NOSEDA-CAI REGIONE LOMBARDIA ABBONAMENTO CARTACEO 2023 - 2 numeri Supplemento a “Il Rosa – Giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca” n° 2/2022 - Via Monte Rosa 75, 28876 Macugnaga (VB) – www.ilrosa.info – direttore responsabile: Paolo Crosa Lenz – Registrazione Tribunale di Verbania n° 295 - 29 novembre 1999



























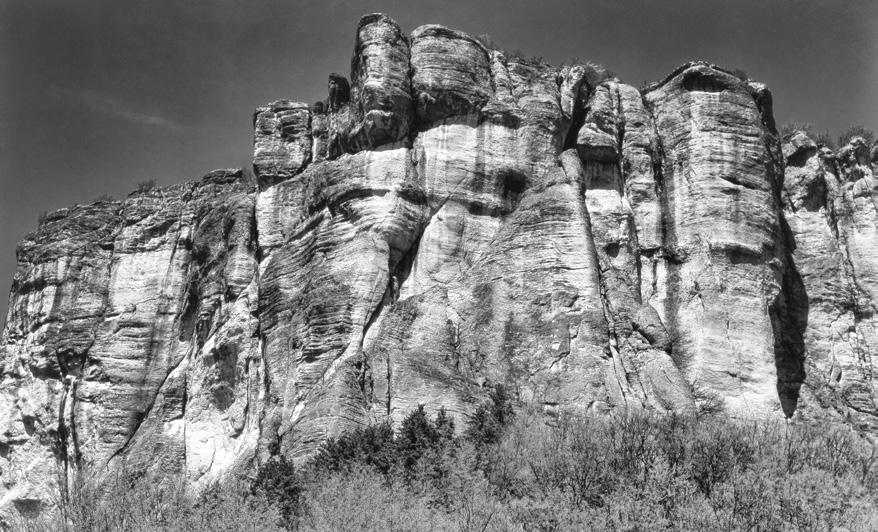































































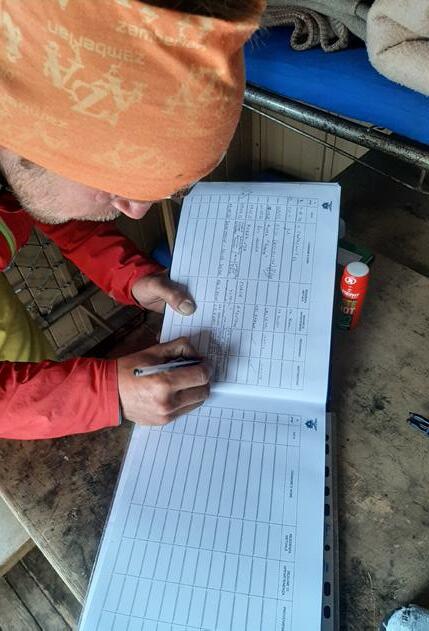




























 A sinistra: Christian Confente nel tratto di artificiale del 14° tiro durante la prima ripetizione - Sotto: Manuel Leorato all’attacco del diedro di L3
di Christian Confente e Manuel Leorato
A sinistra: Christian Confente nel tratto di artificiale del 14° tiro durante la prima ripetizione - Sotto: Manuel Leorato all’attacco del diedro di L3
di Christian Confente e Manuel Leorato













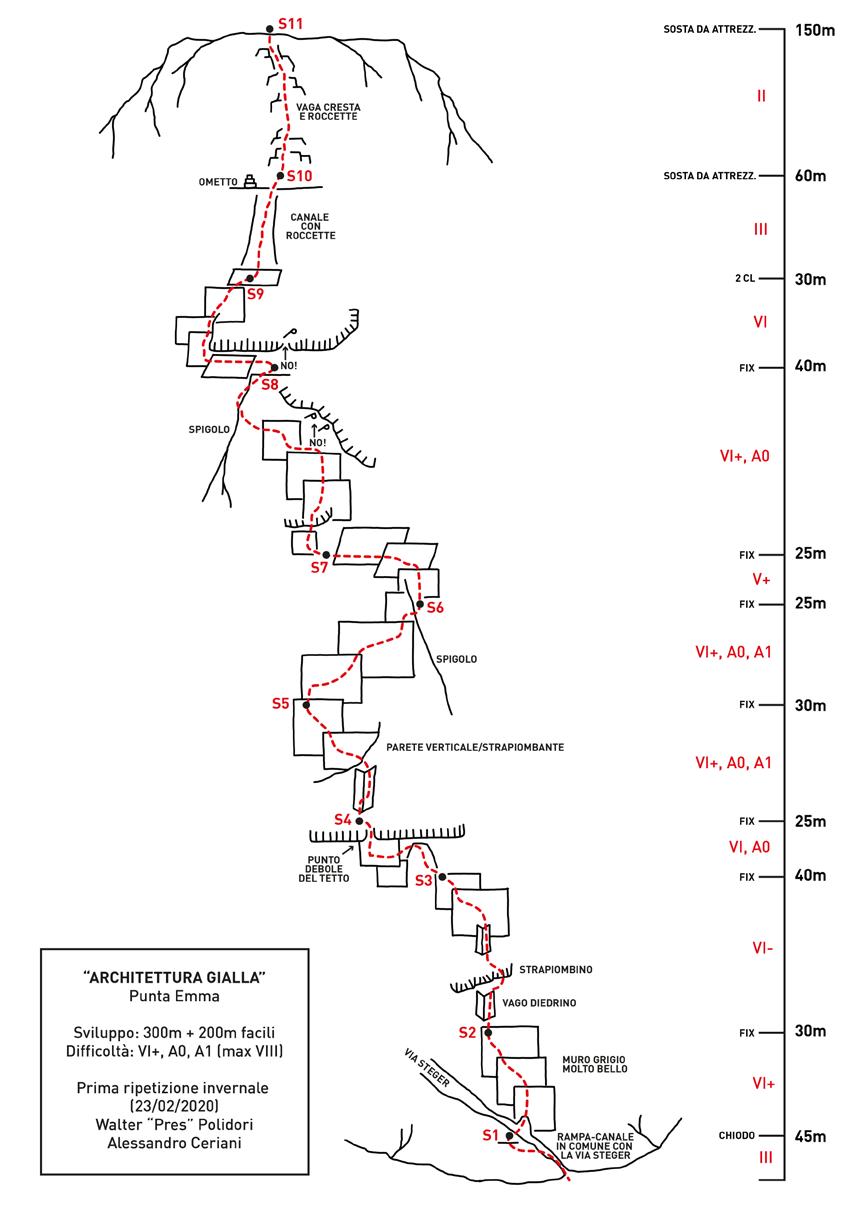


















 Punta
Punta